Tre storie di santità femminile tra parole e immagini
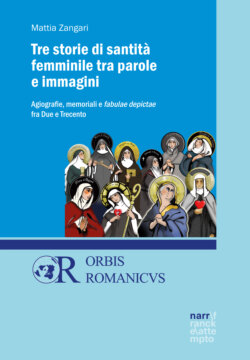
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
Оглавление
Mattia Zangari. Tre storie di santità femminile tra parole e immagini
Inhalt
Prefazione
Introduzione
«Hoc speculum cotidie intuere»: le «Vitae matrum» e la «fabula depicta» di Lutgarda d’Aywières (1182-1246)
La storia dell’«antefatto» della «Vita Lutgardis» ossia le altre «matres»: la reclusa, la folle, la svanita
Lutgarda: storia di una monaca
Da Tommaso a Baro le Roy: stile del testo, codici manoscritti e edizioni a stampa
Sibilla de Gagis ed Elisabetta de Wans: due testimoni per un’inchiesta
La struttura del testo
Le visioni. Sui metodi del racconto
Libri e immagini per Lutgarda
La griglia di «tòpoi» di Tommaso di Cantimpré
«Non amet absque pari»: i «volti» di Lutgarda «sponsa Christi»
Nel «secretaire» di un’agiografia: il romanzo cortese di Lutgarda
«Sicut pictor pingens»: il «Memoriale» di Angela da Foligno (1248-1309) e l’iconografia della basilica di Assisi. Un memoriale a quattro mani
La «scriptura obscura»
Il Codice 342 di Assisi
Angela e l’iconografia: i crocefissi della peste
Angela da Foligno e gli affreschi della basilica inferiore di San Francesco
Angela e l’iconografia della basilica superiore. Angela da Foligno e la crocifissione di Cimabue
La vetrata degli angeli
Angela interprete della teatralità francescana
«Dum puella devotius oraret coram immagine»: la «Legenda» di Agnese da Montepulciano (1268-1317) tra fonti classiche e santità femminile europea
Note linguistiche e indicatori di un classicismo «velato» nella «Legenda beate Agnetis»
La «Legenda» di Agnese da Montepulciano e i «tòpoi» di una santità femminile europea
Agnese Poliziana: rapporto fra testo e iconografia in due visioni
Conclusioni
Bibliografia. Testi
Bibliografia critica
Apparato iconografico
Fußnoten. Introduzione
«Hoc speculum cotidie intuere»: le «Vitae matrum» e la «fabula depicta» di Lutgarda d’Aywières (1182-1246)
La storia dell’«antefatto» della «Vita Lutgardis» ossia le altre «matres»: la reclusa, la folle, la svanita
Lutgarda: storia di una monaca
Da Tommaso a Baro le Roy: stile del testo, codici manoscritti e edizioni a stampa
Sibilla de Gagis ed Elisabetta de Wans: due testimoni per un’inchiesta
La struttura del testo
Le visioni. Sui metodi del racconto
Libri e immagini per Lutgarda
La griglia di «tòpoi» di Tommaso di Cantimpré
«Non amet absque pari»: i «volti» di Lutgarda «sponsa Christi»
Nel «secretaire» di un’agiografia: il romanzo cortese di Lutgarda
Un memoriale a quattro mani
La «scriptura obscura»
Il Codice 342 di Assisi
Angela e l’iconografia: i crocefissi della peste
Angela da Foligno e gli affreschi della basilica inferiore di San Francesco
Angela da Foligno e la crocifissione di Cimabue
La vetrata degli angeli
Angela interprete della teatralità francescana
«Dum puella devotius oraret coram immagine»: la «Legenda» di Agnese da Montepulciano (1268-1317) tra fonti classiche e santità femminile europea
Note linguistiche e indicatori di un classicismo «velato» nella «Legenda beate Agnetis»
La «Legenda» di Agnese da Montepulciano e i «tòpoi» di una santità femminile europea
Agnese Poliziana: rapporto fra testo e iconografia in due visioni
Conclusioni
Отрывок из книги
Mattia Zangari
Tre storie di santità femminile tra parole e immagini
.....
Come le altre tre agio-biografie, la Vita Lutgardis, che analizzeremo tra poco, sembra risentire molto dell’idea di santità che sottostà al modello femminile paolino. Le pagine di san Paolo dedicate alla santità non intendono, come sappiamo, quella costituita «populi credentis intuitu», stabilita dai processi istituzionali, dagli albi e dai codici; la santità della «letteratura» paolina fa fede alla testimonianza oculare e riguarda la condotta di chi, come le madri di Tommaso di Cantimpré, sta spesso ai margini della società.1 Lutgarda (come le altre protagoniste delle Vitae matrum) non è una nobile regina altomedievale di cui ci si appresta a trascrivere vita e miracoli,2 si tratta di una donna «normale», come nel caso «dei santi paolini, uomini e donne, ai quali il linguaggio apostolico di Paolo e della sua cerchia assegna originariamente questo attributo di aghios nella ferialità silenziosa o anche dimenticata della loro vita».3 Indagando le parole del Santo, ci si imbatte in quei famosi «divieti» imposti alle donne, veti che si rievocano qui per il motivo che stiamo per vedere. Paolo aveva affermato:
Come in tutte le comunità dei santi, le donne nelle assemblee tacciano perché non è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la Legge. Se vogliono imparare qualche cosa, interroghino a casa i loro mariti, perché è sconveniente per una donna parlare in assemblea (1 Cor 14, 33-35).
.....