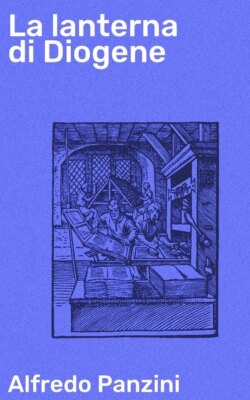Читать книгу La lanterna di Diogene - Alfredo Panzini - Страница 4
II. Effetti del Lambrusco.
ОглавлениеA dispetto della notte agitata, quando al mattino lasciai Piacenza, ancora immersa nel sonno, in me squillavano alcune allegre diane di forza e di speranza.
In che? e perchè?
In nulla e per nulla.
Sono effetti bizzarri che il sole sorgente produce sull'organismo quando i polmoni si dilatano all'aria mattutina.
Sino a Fiorenzuola d'Arda mi accompagnai con un ciclista tardigrado, che andava bene con me. Era un impiegato piacentino che si recava regolarmente ogni domenica mattina a trovare la moglie in cura a Salsomaggiore. Il suo pedale andava placido come la sua voce, la quale si compiaceva nello stendersi della gòrgia natia alla fine di ogni parola.
Egli mi parlò anzi tutto della sua signora e dei gran benefici che ella ritraeva da quei bagni salso-iodici; quindi intraprese la storia circostanziata dei conti decaduti di Piacenza. Giunti a Fiorenzuola, ne aveva passati in rassegna cinque, ma pareva che avesse materia per più lungo viaggio. Fortunatamente a Fiorenzuola egli sentì il bisogno di fare un primo spuntino; con la qual cosa non soltanto soddisfaceva ad una richiesta dello stomaco, ma — siccome era in anticipo — desiderava di perdere quel tanto di tempo che era necessario per arrivare a Salso all'ora precisa del pranzo. Doveva essere un uomo prudente costui, giacchè l'arrivare in anticipo non fu mai consigliabile ai mariti che sono buoni tutori della felicità coniugale.
Il ciclista invece che mi si accompagnò fino a San Donnino, apparteneva all'ordine dei treni direttissimi: era un giovanetto, commesso di negozio, il quale era partito il mattino stesso alla punta del giorno da Milano, e andava anche lui a Salsomaggiore.
— Non faccia complimenti, vada pure avanti, perchè il mio passo, come vede, non è da mettere col suo, — gli dissi.
— Ma no, — rispose, — andiamo insieme: io rallenterò un poco la corsa, tanto più che non ho fretta.
— E allora perchè si è presa questa scalmana di venir da Milano come un treno lampo? — domandai.
(Oh, stupida domanda la mia! Ma per i giovani l'andare in fretta è cosa naturale come per i vecchi l'andare adagio. Pare impossibile quanto spesso noi facciamo una questione morale di una questione puramente fisiologica!)
La proposta del viaggio insieme non mi sorrise molto: guardai quelle potenti leve delle sue gambe lunghe, quella moltiplica esagerata della sua bicicletta, e sospirai. Eppure, o fosse effetto dell'esempio — come avviene agli asinelli — o beneficio della strada che corre ondulando in lievi e lunghe discese e salite, o miracolo dell'ora e della stagione, il fatto è che percorsi anch'io di volata quei venti chilometri.
Era la dolce terra, erano i verdi colli, le ombrose ville, le borgate, i lontani castelli ammantati a festa come per farmi piacere e persuadermi sempre di più del grande amore della madre natura. (Rettorica! quando avrà bisogno per i suoi affari della tua morte, la proverai la buona madre natura!)
— Ma lei è un routier di prima categoria, — mi disse il giovane commesso, — e per un uomo di quarant'anni non è cosa comune.
— Trentanove, signore! — corressi (oh, vanità!) e augurataci buona fortuna, egli per Salso, ed io seguii per la mia strada.
*
Or dunque mi congratulai ancora con me stesso e con le umili membra che mi avevano serbata questa cara sorpresa fuori della loro primavera. Le lontananze del paesaggio sfumavano nel vapore dell'aria, già radiosa di sole; la strada sotto quel bagliore abbacinava la vista. Eppure che bell'andare! Presso la strada, qualche villa o castello, profondamente sommerso nel verde opaco del parco, mi faceva l'effetto che un sorbetto produce ad un assetato; e tuttavia non riposai a quelle ombre allettatrici, anzi mi fu piacevole il proseguire, e proseguii tutto solo in uno stato d'ebbrezza, che non proveniva da liquore o da vino, ma dal sole e dalla libertà, i due inebrianti che non fanno male. «Quanti bei nomi — andavo fantasticando — ebbero le antiche età per significare questa ebrezza dell'andare liberi, senza orario e senza legge: i romei, i cavalieri erranti, i clerici vagantes, i trovieri; e Iddio — o pensiero luminoso! — fece il mondo rotondo perchè uno può girar sempre e illudersi di andare avanti, anche se torna sui suoi passi.
I santi e i santuari nell'evo medio servivano a questo sport. San Giacomo di Gallizia, il tempio di Gerusalemme, la santa casa di Loreto, ecc., corrispondevano agli odierni Ostenda, Aix-les-Bains, Spa, Saint-Moritz, ecc.
Però anche allora non mancavano quelli i quali pigliavano per meta dei loro pellegrinaggi delle madonne di carne, invece che delle madonne di legno. Jaufré Rudel usò la vela e il remo per vedere il bel volto di Melisenda, di là dal mare; e messer Guido Cavalcanti si fermò a mezza via in Provenza presso la Mandetta. Oggi vi sono i globe-trotters; vi sono gli automobili. Troppa roba inamidata, troppa moda anglo-americana, troppo puzzo di benzina e di dollari. Preferibili le figure antiche «dai portamenti e dagli aspetti strani», figure confuse, tra il sogno e la realtà.
Ecco quei che le carte empion di sogni:
Lancilotto, Tristano e gli altri erranti,
Onde conven che 'l vulgo errante agogni.
Vedi Ginevra, Isotta e l'altre amanti
E la coppia d'Arimino che insieme
vanno facendo dolorosi pianti.
«Bravo! — dissi a me stesso, — eccoti a far ancora della letteratura».
«Sì, va bene, — risposi a me stesso, — se non che questa litania petrarchesca che pare così monotona, letta in una scuola, col registro delle classificazioni da vicino e gli scolari di fronte, recitata ad alta voce, fra i campi, correndo, fa un altro effetto! Questi sono fiori vivi!» Le alte piante assentivano. E così seguitai a cantare il Petrarca; e così vidi il sole girare tutto l'arco del cielo; così passò Parma, passò Reggio, dalle vetuste mura; e l'umile duro pane, spezzato presso qualche osteria di campagna, mi parve saporito più di ogni ricercata vivanda. Perchè io evitai le città, nè mi fermai in esse: le grige mura mi avrebbero ricordato le morte età, le vane opere delle generazioni umane. Oh, più sapiente tu, o Terra! Tu riassorbi ciò che, da te prodotto, si muore, e ne ricomponi le giovani primavere.
Passare attraverso un corso; veder la gente che ancora decifra il giornale; leggere le scritte della civiltà: «Ufficio del Registro», «Conservatoria delle Ipoteche», «Monte di Pietà», «Banco di Sconto», «Tribunale», «Provveditorato agli studi», ecc., avrebbe precipitato nel vuoto, disciolto tutta quella fiorita di fantasie.
E fu così che ad un certo punto m'accorsi che il sole andava perdendo nell'intensa sua luce, e la grande pianura Emiliana largamente si discopriva nel vespero riposato. Chi percorre la linea da Piacenza a Bologna, trasportato dal treno, non ha nè meno un'idea della bellezza maestosa e molle di quel paesaggio, da cui sorge, con l'insorgere dei colli e dei monti lontani, l'imagine della Patria.
Cadeva il sole dietro un gran piano verde, quando giunsi ad una borgata tranquilla. Sopra gli spaldi di un antico castello sorgeva una villetta moderna, circondata da oleandri. Dietro il castello si dilungava una mansueta fila di umili case, sorrette da portici.
— Che paese è questo? — domandai ad una donna che falciava l'alta erba presso la siepe.
— Rubiera!
«Qui è bene riposare la notte», dissi fra me.
*
Ora in quella dolcissima sera, così solo solo come era in quell'alberghetto di Rubiera, io mi sentii preso da un mio antico e nobilissimo male.
Questo male consiste in una specie di animazione del paesaggio materiale, da cui viene fuori la storia, la quale mi canta di dentro una certa nenia eroica, ed ha per effetto di farmi piangere.
Si badi bene che io parlo di lagrime autentiche, non di quelle lagrime che si mettono agli angoli dei capitoli dei libri (come gli accattoni di mestiere agli angoli delle vie) e fanno tanto piacere a molti lettori.
— Se è così, — dirà alcuno, — è molto probabile che voi abbiate bevuto quella sera: il vino fa cantare, e qualche volta anche piangere.
No: io me ne ricordo bene: io non aveva ancora bevuto. Bensì è vero che l'ostessa (una formosa donna) mi aveva messo davanti al piatto una bottiglia di Lambrusco; ma era ancora da sturare. Piuttosto la causa io attribuisco a due versi di Dante (lo so, ci siamo ancora con la letteratura!) che mi spuntano nella mente ogni tanto, in certe occasioni, ed operano in un modo strano, come già il canto pastorale del Ranz des Vaches su gli svizzeri del tempo antico, quando essi erano più sensitivi e meno albergatori.
I versi sono le semplici parole che Dante fa pronunciare a Pier da Medicina:
Se mai torni a veder lo dolce piano
che da Vercelli a Marcabò dichina....
Piangere per così poco è pazzesco, pur concedendo un'emotività patologica; eppure mi è avvenuto. La spiegazione del fenomeno dev'essere questa che sono per dire o qualcosa di simile: Pier da Medicina, che è nell'Inferno, vede tutto il paesaggio d'Italia e allora — benchè tardi — comprende che in questa dolce terra si poteva vivere un poco più da galantuomini. Pier da Medicina non è detto che pianga; ma è supponibile. Chi piange sul serio è Guido Dal Duca. Eppure lo aspetta il Paradiso! Ma più che il Paradiso non lo consoli, gli stringe il cuore il ricordo della sua dolce terra latina. Ma oltre alle ombre di Dante, ci furono ancora degli uomini vivi e veri che piansero vedendo che questa nostra patria non fu mai «senza guerra», vedendo che i «tiranni felli» sono ancora «tanto amati che non si porria contare», e che le brutte Arpie vanno pur sempre a far loro sporchizie sui più nobili conviti. Passarono i grandi vivi, come le ombre, ma il volo delle loro anime si libra tuttavia su questa dolce terra latina; l'aria ne è mossa, e fa vibrare l'anima nostra: e allora si piange per il desiderio di un futuro che non verrà mai, nel modo stesso che Guido Dal Duca pianse per un passato che non tornerà più!
Questo bizzarro fenomeno di sentirmi sorgere le lagrime per così poco mi accadde in modo più memorabile la prima volta che fui a Superga.
Ma conviene pur dire che io capitavo a Superga, arrivando direttamente dalla Svizzera.
Quivi avevo percorso molte terre sull'alto di quelle ammirevoli berline, davanti alle quali vorrei condannare in contemplazione i postiglioni e gli impresari dei compassionevoli trabiccoli cellulari, che col nome usurpato di diligenze, percorrono il nostro Appennino.
Viaggiavo per diletto, eppure una nostalgia infantile, insanabile, di bimbo staccato dalla madre, mi era penetrata nel cuore e cresceva sino ad intorpidire la volontà e ottenebrare ogni fantasia. «Ma che uomo sei tu? — domandavo a me stesso, — ma non hai tu vergogna?» Eppure non riuscivo a vincermi. «Questo, — dicevo, — è il mondo dei monti senza fine: scenario eterno, uguale: valli che sono baratri; falde di smeraldo che salgono a nascondere il cielo; selve di pini neri come funerali; falde di neve come sudari; abitanti grevi come un popolo di gnomi; case di larice nero, senza sorriso. Azzurro cielo, terra che palpiti fra i due mari, dove sei tu?»
E mi allontanavo sempre di più per l'acre diletto di sentir crescere questo spasimo puerile, e poter quindi godere tutta la voluttà del ritorno.
Con che gioia, a Goeschenen, scendendo giù dall'orrida Furca, scopersi in una sottile, impercettibile nera pianura, i binari della ferrovia! Dunque esiste la via del ritorno, la magica via che sprofonda, trapassa i fieri monti, digrada come volo d'aquila, e le terre ridenti le muovono incontro: oh! ecco un suono italico, ecco una pianta italica, ecco dei ferrovieri un po' sudici, ma che parlano, che ridono, che bestemmiano almeno!
Come si vede, la mia ammirazione per l'armonia e la disciplina teutonica era consumata, e tutti quei verboten, mi avevano inimicato alla legge. Popolo alquanto sudicio è il nostro, indisciplinato; ama, purtroppo! di portare il coltello in tasca come il garofano ed il basilico all'orecchio. Eppure ride e sorride così umanamente, e la sua parola talora è così gentile e bella, così vivo e ardito è l'aspetto che pare peccato il non aver fede nella sua purificazione e resurrezione.
Quando salii il colle di Superga cadeva il sole del luglio, anche allora.
Fra me e la cerchia cinerea delle Alpi correvano i fiumi come trame argentee di un abito di fata invisibile: invisibile la fata, ma il dolce piano — dall'alpestre roccia onde, Po, tu labi e su cui l'aquila stride — alla torre di Teodorico presso il dolce mare, tutto si discopriva; molto con gli occhi, molto più con la fantasia si discopriva: onde io cominciai a ripetere: «lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò dichina». E lo andava dicendo quel verso come una devota orazione.
E allora anche quella gran mole, lì presso, delle tombe dei re di Savoia mi si trasmutò in una bella e nobile fantasia; e confondendosi con i guerreschi monumenti che sono in Torino, io vidi una ferrea spada sopra a quell'Alpe per difesa di quel dolce piano che Dio sembrò aver creato per la pace e la felicità degli uomini, e gli uomini trasmutarono nel campo prediletto della loro sanguinosa guerra.
Così io era assorto e a stento chiudeva il varco alle lagrime, quando una voce, proprio di quelle inarmoniche voci tedesche a scala fonetica crescente, mi scosse da quel sogno, domandandomi:
— Questa è Dora Riparia?
Rivolsi gli occhi: un placido teutonico dalla barba dorata, stava vicino a me: una mano teneva il Baedeker, l'altra indicava i fili argentei dei fiumi, che oramai si perdevano nelle ombre del lento crepuscolo.
«Al diavolo te e il tuo Baedeker», dissi mentalmente: ma come meglio fissai il mio interlocutore vidi che due azzurrissimi occhi a fior di testa mi guardavano. Pensosa e nobile era quella fronte teutonica. Egli attendeva umilmente risposta alla sua domanda.
— Questa è Dora Riparia?
Supponendo che la Dora Riparia fosse per lui uguale alla Baltea, indicai quel fiume che meglio si distingueva.
Rispose con un crazie pieno di profonda riconoscenza.
— Grazie, — dissi io, correggendo per effetto di antica abitudine.
— Oh, grazie, signore; niente crazie, — mi replicò con profonda effusione, questa volta. — Io, — proseguì egli, — Rudolf Meyer, professore di Gymnasium, venuto in Italia anche per imparare italiano. Dimandare sempre: Come dicete voi questo?
— .... dite....
— Ah, sì, dite! Domandar sempre, ma nessuno correggere....
— .... quando sbaglio.... — suggerii.
— Oh, sì, quanto spaglio, ma dire tutti: «dicete come ti piace!»
(Onesto teutonico, — pensai fra me, — questa non è soltanto la terra degli aranci, ma anche del «dicete e facete come ti piace».)
Tuttavia proseguire più oltre nel discorso non era possibile, perchè il mio vocabolario tedesco era così ricco come il suo di vocaboli italiani. Fu egli allora che, appiccicatomisi per riconoscenza dell'indicata Dora, mi propose di parlare latino.
Questa proposta mi lusingò perchè evidentemente io dovetti sembrargli uomo erudito e per bene, benchè il mio abito fosse molto negletto. Veramente anche lui, con quel soprabito mezzo verde, dalle cui falde venivano fuori due piccoli calzoni, sospesi sopra due scarpe da montanaro, non era molto elegante. Lusingato dalla sua penetrazione, mi sentii indotto a considerarlo come uno degli ultimi rappresentanti di quei germanici azzurri, imbevuti ancora di filosofia e di ideologia, i quali vanno lasciando il posto ad altri nuovi germanici, mercanti e guerrieri: anima dell'antico Arminio, che risorge. E più mi persuasi che egli fosse un gentile teutonico quando mi disse che con la venuta in Italia scioglieva un lungo suo voto.
Il latino ci affratellò. Che latino fosse, non rammento. Merlin Cocaio rideva di gusto: il già mio maestro, G. B. Gandino — dall'Eliso ove ora dimora insieme con Cicerone — crollava il capo protestando; ma latino doveva pur essere giacchè ci intendevamo; anzi, accalorandosi il discorso, le parole vennero fuori dai nicchi chiusi della memoria più fluide che io non avessi mai supposto.
Fra i miei periodi ricordo questo: «Noli in isto ostrogotico Bèdeker quaerere Italiam, domine professor: hic nomina tantum continentur; anima rerum non continetur. Poetae nostri humanissimi erunt tibi handbuck optimi: Dante, Manzoni, Carducci».
Il buon teutonico, ricordo, aprì il volto ad un sorriso pieno, sereno, quasi infantile. Si discese in compagnia a Torino e si propose di cenare insieme.
Io, per cortesia, mi proffersi di andare all'albergo ove egli alloggiava; egli dove io alloggiavo. Curiosa insistenza da ambedue le parti! Infine egli chiaramente dichiarò:
— «Domine professor, caupona ubi sum hospes, admodum humilis et misera est. Non more divitum et publicanorum, sed more clericorum errantum iter in Italiam suscepi. Philosophia in Germania tenuem victum parat». Povera e nuda vai filosofia, «scriptum reliquit Petrarca vester humanissimus».
— «Domine professor», — risposi sorridendo, — «Minerva italica multo crudelior nam suis subiectis cibum ori appropinquat sed non satiat: bonos negligit, protervos adiuvat».
Dopo questa reciproca confessione acconsentì di venire al mio albergo, umile sì, ma con cucina e cantina meritevoli di ogni elogio. Eravamo soli in una discreta stanzetta, e, a marcio dispetto della «philosophia» teutonica e della «Minerva italica», si mangiò bene e si bevve meglio, e dopo cena io declamai del Manzoni la bella stanza:
Chi potrà della gemina Dora,
Della Bormida al Tanaro sposa,
con quel che segue, e del Carducci alcune strofe dell'ode al Piemonte.
Il tedesco era entusiasta e pareva capire benissimo.
Alla sua volta egli declamò alcune liriche tedesche che io intesi bene come egli intese le mie.
Suppongo, per altro, che anche le sue dovessero essere liriche patriottiche, giacchè la sua bocca, cinta dalla barba dorata, si apriva per mandar fuori certi boati solenni, certi rugghi di Vaterland, che in tutt'altra occasione mi avrebbero fatto ridere, e allora invece io lo stavo ad ascoltare pensosamente come se avessi compreso più che egli non dicesse.
Così parlammo a lungo con la lingua d'angelo de' nostri poeti e ci intendemmo come se, invece di recitare versi, avessimo cantato delle ariette musicali.
Non è però da nascondere che in quella osteria di Torino, ad aiutare la reciproca intelligenza di due linguaggi così diversi, molto giovò — oltre alla potenza della poesia — un raggio di sole che si era fatto Barolo entro il mistero di alcune bottiglie.
Il vino, inoltre, e l'amor di patria fecero sì che il tedesco ed io ci guardassimo fraternamente negli occhi.
Ciò non sempre avviene: questo nobile liquore e questo nobilissimo sentimento spingono sovente individui e popoli a guardarsi biechi come cani ed a picchiarsi senza pietà.
*
Ma lì, a Rubiera, con chi dovevo io aprirmi? Perciò tu mi tornasti alla mente, onesto teutonico: e infine, trovandomi solo, tutte le mie espansioni mi convenne rivolgere a quella bottiglia di Lambrusco, ed essa in contracambio versò in me tutta la piena del suo spumante liquore.
L'ostessa mi faceva osservare che un Lambrusco come quello non si trova certo a Bologna; e a Modena che è Modena, due lire e più bisogna pagarlo alla bottiglia, chi lo vuole.
Ma io pensavo ad altra cosa che a questioni di enologia e di prezzi: io pensavo alla bella abitudine che i Greci avevano di premiare i loro più benemeriti ed illustri personaggi col dono di una Dea o di una graziosa vergine, come accadde ad Ercole che ottenne in moglie Ebe, una moglie che doveva in certo modo compensarlo della terribile Deianira che ebbe in terra: una moglie che non invecchiava, appunto perchè era la Dea della giovinezza (e forse — sottilmente pensando — i Greci antichi vollero con questo mito significare il solo caso in cui il matrimonio può essere giustificato). Era una specie di premio Nobel, ma più confortevole. Io non pretendevo certo a nessuna qualità illustre; e quindi a nessuna Dea, e nè meno ad intatte vergini. Ma è certo che il mio alto sentire della patria non era da tutti e meritava qualche piccolo compenso. Se quella ostessa, invece di essere così esperta del prezzo e delle qualità del Lambrusco, avesse conosciuto la storia greca, io avrei osato farle qualche parola in proposito.
Ma non era il caso.
*
Tutti i galli del giardino dell'ostessa mi svegliarono all'alba, e poco dopo, il sole entrò nella camera così sfacciato, che mi convenne levarmi. Ma che mattino rugiadoso, silenzioso, ridente! Vi sono (è debito di giustizia confessarlo) dei momenti che è un gran piacere abitare in questo mondo! È una cosa di fatto, ed io, come positivista a mio modo, la constato. Non avviene spesso, ma avviene. Quando noi ci saturiamo di vita (nel modo stesso che un automobile elettrico si satura del misterioso fluido) noi godiamo. Me ne dispiace pel mio amico S.... Egli è un filosofo anarchico, ma mitissimo e dottissimo uomo; e mi venne in mente il suo nome quella mattina per il contrasto di questa mia con le sue affermazioni. Egli afferma dolcemente, ma con incrollabile convinzione, che la vita è un peso: che l'unica soluzione è quella di approfittare dei progressi chimico-scientifici e far saltare questo stupido satellite.
No! Amico S....! Vi sono dei momenti che la vita è bella, soltanto non basta profumarsi, come fate voi, amico S...., e vivere poi in mezzo alla folla. Allontanarsene ogni tanto bisogna.
Come io sentivo quella mattina la carezza, l'abbracciamento, quasi sensuale, femmineo, della materia!
Nel breve tragitto dalle Stiviere a Modena quante deliziose ville occultate nel verde dell'ubertosa campagna, come ninfe entro i boschi! Che lieto mattinare degli uccelli per i giardini silenziosi!
*
Giunsi a Modena senza avvedermene, ed erano le ore sei.