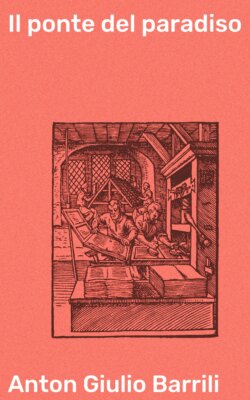Читать книгу Il ponte del paradiso - Anton Giulio Barrili - Страница 3
II.
ОглавлениеPentiti, don Giovanni!
San Silvestro era venuto, ma solo soletto, portando sul Canal Grande, nell'antico palazzo abitato dai signori Zuliani, una lettera di Belluno. La signora Livia ci aveva azzeccato; lettera o telegramma che fosse, la mamma, come si soleva chiamare in famiglia la vecchia signora Adriana, avrebbe scritto di non potersi muovere. Ragione, o pretesto? Pareva una ragione, poichè la lettera parlava di un nipotino che era a letto colla rosolia; pareva un pretesto, poichè la lettera soggiungeva non trattarsi di cosa grave, bensì di una forma benigna, assai benigna, di quella inevitabile malattia da bambini. Ma infine, pretesto o ragione che fosse, il piccino voleva sempre la nonna al suo capezzale, e non c'era modo di spiccarsene. Raimondo lesse, e sospirò, com'era il suo fare; ma non aggiunse parola.
Così, anche su d'un altro punto, aveva ragione sua moglie; avevano corso il rischio di essere in tredici per la cena del capo d'anno. Bisognava ad ogni costo mettere il sequestro, sulla persona del signor Brizzi; e il [pg!15] sequestro fu messo quella mattina, appena Raimondo ebbe fatto ritorno al suo banco.
Il signor Brizzi era il segretario del banco Zuliani, il braccio destro di Raimondo, quello che faceva andare la macchina, e diciamo pure la zecca, poichè era una macchina da far quattrini. L'onestà certamente è la base d'ogni commercio; e quantunque molti ne facciano senza, non bisognerà credere che sia utile imitarli, perchè allora si fabbrica sulla rena, e le case generalmente non durano. All'onestà, per cui la casa Zuliani era omai proverbiale, il signor Antonio Brizzi, grande scritturale nel cospetto del Signore, aggiungeva una diligenza scrupolosa, una prontezza mirabile, una esattezza esemplare, per cui la macchina bancaria andava come un orologio: s'intende, come un orologio che va, e che va bene; due cose che non sono di tutti gli orologi.
Compiamo il ritratto morale del signor Antonio Brizzi, soggiungendo ch'egli era un vecchio scapolo. Ad ammogliarsi prima gli era mancato il tempo; e di ammogliarsi poi non era più tempo. E non se ne doleva; che anzi! Era uomo di gusti semplici, che la compagnia d'una donna avrebbe sempre un po' contrariati; si contentava di poco, non ispendendo la metà di quel che guadagnava, tanto che gli amici lo accusavano di essere omai diventato milionario, o giù di lì. “Soprattutto giù di lì„, rispondeva egli ridendo; “tanto giù, che più sotto c'è il Canale„. Unico suo spasso e suo unico sfoggio era il fare un po' lunga la fermata serale al Cappello Nero, dove faceva i suoi pasti, in compagnia di quattro o cinque amici, stagionati e senza famiglia come lui, coi quali si [pg!16] cambiavano due chiacchiere sul più e sul meno, framezzandole con qualche sorso di Murano, o di Valpolicella.
Non si stava già sulle cerimonie, con loro. Le cerimonie lo seccavano a morte, e per questo non si ritrovava bene in casa del suo principale, in quei ricevimenti sempre un pochettino solenni, o che a lui parevano tali; dove bisognava star sulla vita, fare il bocchino, gesticolar poco o nulla, e parlare in punta di forchetta, fra giovinotti inamidati, vecchi incerettati e signore infarinate. I giovinotti inamidati lo mettevano in soggezione, i vecchi incerettati gli facevano rabbia, le signore infarinate gl'incutevano un religioso terrore. Si trattava poi di una soltanto; chè la signora Livia, salvo in circostanze singolari, e veramente costretta dal suo ufficio di padrona di casa, non ne sopportava di più. Ma quella c'era sempre, buon Dio, come obbligata in chiave, e gli pareva una stonatura. Povera contessa Galier di San Polo, così amena, così facilona, e la prima a ridere delle sue infarinature ostinate! Ma il signor Brizzi era fatto così; si ritrovava male con le dame. C'era quella sola? Pagava per tutte.
Conoscendo l'umore del suo segretario, Raimondo Zuliani aveva dovuto attaccarlo col solito preambolo.
— So che vi dò noia, mio caro Brizzi; ma voi mi scuserete, perchè non posso fare altrimenti. Mia moglie conta su voi, questa sera; ed io, poi, anche conoscendo le vostre inclinazioni, debbo contarci come lei. Alla cena del buon augurio non potete, non dovete mancar voi, che siete il mio amico migliore. E poi, che volete? Si resterebbe in tredici, senza di voi; è dunque necessaria la vostra presenza.
[pg!17] — Allora al fuoco, e senza risparmio, come a Malghera; — disse ridendo il signor Brizzi.
Ridendo, sì, ma a denti stretti, e perciò non di gusto, come faceva al Cappello Nero. Li aperse bene, quella sera sul tardi, per maledire la falda e tutto il resto dell'abbigliamento cerimoniale, che aveva dovuto cavar dall'armadio. E nondimeno, quando ebbe finito di vestirsi, non era più tanto feroce. Uscito dal suo quartierino in vicinanza dei Frari, venuto alla riva e sceso in gondola, dopo aver gittata al gondoliere la frase “al palazzo Orseolo„, le sue invettive cominciarono a condirsi di qualche amenità; segno che quell'ottimo signor Brizzi si veniva bel bello rassegnando al suo fato.
— Ebbene, vecchia mia, — diceva egli, abbottonando su quella povera falda i due petti del suo palandrano, — sei contenta d'essere uscita dall'armadio, ove meritavi di restare fino alla mattina del giudizio universale? Con tante grinze, farai la tua bella figura! E tu, piastrone di tela batista, lustro e sodo come un piatto di porcellana, le vorrai bere, le tue goccioline di caffè e di liquori, non è vero? Strano! — soggiunse il signor Brizzi, accomodandosi meglio che poteva sui neri cuscini del felze. — Ci sono quei cari giovinotti, che non si macchiano mai. Forse per questo portano i baffi tirati all'insù, che paiono tanti gatti arrabbiati. E noi.... e noi, poveri vecchi, li portiamo voltati all'ingiù, come tanti Cinesi. Ecco il guaio! —
Il signor Brizzi, come abbiamo sentito da lui, era stato tra i difensori di Malghera. Fedele ai ricordi del patrio risorgimento, portava baffi e pizzo all'italiana.
[pg!18] A piè della gradinata del palazzo Orseolo approdava un'altra gondola, donde smontarono dopo il signor Brizzi altri due invitati di casa Zuliani. Tutti e tre, scambiata una stretta di mano, salirono, giungendo proprio gli ultimi all'appello. Nel gran salotto della signora Livia era già adunata, disposta in crocchi, secondo il caso o le affinità elettive, una fiorita compagnia; “le donne, i cavalier, l'armi....„; sì, anche l'armi, rappresentate da Federico Cantelli, nella sua severa uniforme di sottotenente di marina. Quanto agli “amori„ potevano essi mancare? Dove son donne e cavalieri, è più facile azzeccar gli amori che l'armi.
— Così tardi? — chiese amabilmente la signora Livia, stendendo la sua bella mano al signor Brizzi.
— Padrona, — rispose l'ameno segretario, inchinandosi, — abbia la bontà di scusare un povero villano, che non ha voluto venire con le mani vuote. Come vede, ho portato questi due forestieri. —
E contento della sua barzelletta, si trasse da un lato, per lasciar passare alla cerimonia dello shake-hand il cavalier Lunardi e il maestro di musica.
Raimondo respirò per sua moglie. Coi tre ultimi arrivati si era quattordici in punto. Ma non respirò il signor Brizzi, trovandosi là in mezzo a tante persone elegantissime, specie davanti a signore, con le quali non poteva già bastargli una frase in burletta, come quella che aveva finito di dire alla padrona di casa, e sua. Conosceva le signore Cantelli; era anzi stato una volta all'albergo per ossequiarle e mettersi ai loro ordini, quando erano arrivate a Venezia: ma si sentiva impacciato [pg!19] con esse, particolarmente colla signora Eleonora, sempre così contegnosa e così avara di parole. Benedetta la contessa Galier di San Polo, che poteva essere infarinata più del convenevole, se non del necessario, ma infine, viva la faccia sua tinta e ritinta, parlava sempre lei, e non c'era altra noia che di starla a sentire. Noia, poi! Si dice così per dire. La contessa era amenissima; colla sua parlantina avrebbe messo di buon umore un convento di trappisti.
Più impacciato del nostro ottimo Brizzi appariva il signor conte Filippo Aldini. Che la presenza delle signore Cantelli mettesse in soggezione anche lui? Non era da credere. Filippo Aldini era un elegante inappuntabile, un giovinotto alla moda, rotto alla vita dei salotti; sebbene non frequentasse più molte case, come prima faceva assai volentieri, restava sempre quello di prima, nella bella padronanza di sè, dei suoi atti e delle sue parole, disinvolto e misurato ad un tempo, sobrio nel gesto, parco nella celia, ma pronto a scoccarla con aria tranquilla, che non pareva affar suo, come se avesse detta la cosa più semplice e più naturale del mondo. Non si confondeva mai; confondeva gli altri, piuttosto.
Perchè dunque appariva allora tanto diverso? Che fosse ammalato? Raimondo Zuliani, senza far tante indagini, notando solamente la novità della cosa, ebbe compassione di lui; e venutogli accanto, lo aveva tratto bel bello verso le signore Cantelli, a cui l'amico non si era ancora fatto vivo altrimenti, che con un rispettosissimo inchino.
[pg!20] — Posso io presentare il mio amico Aldini? — aveva detto Raimondo, facendo bocca da ridere.
— Ella sa bene, signor Zuliani, di averci già fatto questo regalo; — rispose la signora Eleonora con gran degnazione, e, cosa più insolita, abbozzando perfino un sorriso. — È vero nondimeno che incontriamo il signor Aldini piuttosto raramente.
— Lo incontrano! — esclamò Raimondo. — Non è egli dunque tornato a riverirle? Davvero davvero, non riconosco più il mio Filippo, il re dei cavalieri. —
Filippo Aldini sorrideva a stento, sudando freddo, e balbettando qualche frase scucita. La nessuna importanza sua.... il timore di essere importuno.... E frattanto si guardava attorno, come se cercasse soccorso. Da chi, povero Aldini, da chi? Ah, bene aveva pensato quel giorno di darsi ammalato! Sentiva allora che l'idea era buona. Peccato che gli fosse parsa ridicola, tanto che non ci si era fermato su, e non aveva scritto quel bigliettino di scusa a Raimondo, magari mettendosi a letto, per non esser colto in flagranti di bugia, dal più caldo, dal più prepotente degli amici! Si pentiva allora, si pentiva amaramente di non aver colta a volo l'idea, balenata nella mattina al suo spirito, come unica e vera àncora di salvezza che gli porgeva un buon genio.
Bisognava dunque discorrere; e Filippo Aldini si adattò a mettere qualche frase meno scucita di costa a quelle del suo amico Zuliani. Ma appena Raimondo non fu più là in sostegno, lasciò languire la conversazione, e ringraziò nel profondo dell'animo il cavaliere Lunardi, che si avanzava a riverire la signora Eleonora. Nè solamente [pg!21] lo ringraziò, ma subito ne prese occasione a ritirarsi in buon ordine, per andare a discorrere colla signora Galier. Là solamente si sentiva al sicuro.
La conversazione si era venuta animando. Ma qualche timido accordo al pianoforte ottenne il suo effetto. “Cascano i filinguelli al paretaio„, ha detto il poeta; tutti s'accostano al cembalo. C'è chi domanda una romanza dello Schubert, chi uno scherzo del Grieg, chi un minuetto del Boccherini. Il maestro di musica ha tutta questa roba sulla punta delle dita. Ma soprattutto c'è chi vuol sentire il re degli istrumenti musicali, la voce umana, specie se è voce di soprano, o di mezzo soprano. Del resto, in un salotto, son tutte voci di soprano sfogato. La padrona di casa non canta più, almeno così ella dice; e si capisce che dica così, per far figurare qualche graziosa invitata. Si pregherà dunque la signorina Cantelli. E la cara Margherita non si fece pregar molto. Pensava giustamente, la bellissima fanciulla, che tanto e tanto avrebbe dovuto dire di sì; il meglio era dunque di dirlo subito. Aveva una voce stupenda; cantò con metodo eccellente e con raro sentimento l'Ideale del Tosti, domandato dal cavalier Lunardi, il grande romantico della compagnia. La signora Livia si era appressata al cembalo per sentir meglio. Fu amabilissima; applaudì con ardore, e fece perfino un miracolo, simulando l'atto di abbracciare la gentil cantatrice.
— Tutto bene! — disse mentalmente Raimondo, stropicciandosi le mani in un angolo del salotto. — Così la mamma fosse venuta, che non avrei più nulla a desiderare! —
[pg!22] Ma non si può aver tutto, in questo povero mondo. E non potè aver tutto il cavaliere Lunardi, che dopo l'Ideale del Tosti, chiedeva già per grazia l'Amore, Amor del Tirindelli. Un uscio si era aperto, una portiera di broccato si era sollevata, ed appariva nel vano il colossale Giovanni in vistosa livrea, coi guanti bianchi come la neve; piacevole apparizione di granatiere rubizzo, che proferì poche parole, ma buone: “La signora è servita„.
La signora, la padrona di casa, doveva far l'obbligo suo. Fatto un cenno al marito, che offriva subito il braccio alla signora Cantelli, prendeva il braccio del signor Telemaco; un pezzo grosso della finanza, che siamo dolenti di non aver meglio specificato, ed ora, per far le cose a dovere, sarebbe un po' tardi. Poi volgendosi verso Filippo Aldini, gli disse a mezza voce:
— Signor Aldini, offra il braccio alla contessa Galier. —
L'Aldini s'inchinò col suo fare misurato, ed obbedì prontamente.
— Ah, che bel cavaliere! Ringiovanisco; — gridò quella graziosa matta della contessa, che non voleva esprimere a mezza voce il suo gradimento.
La signora Livia sorrise; poi si rivolse al Lunardi.
— Cavaliere, — gli disse, — offra il braccio alla signorina Cantelli. — E con un leggero ammiccar degli occhi ebbe l'aria di soggiungere: — È contento di me?
— A questo modo, — esclamò il cavaliere Lunardi, per fare il paio colla vecchia contessa, — ringiovanisco ancor io. —
[pg!23] La signora Livia fece un bel gesto d'invito a tutti gli altri, perchè volessero seguire la marcia come credessero meglio. Si era tutti amici vecchi di casa, perciò in gran confidenza; ed alcuni fecero l'atto, non ammesso dai manuali dell'etichetta, di offrirsi il braccio tra uomini. Il signor Brizzi, ad esempio, ci passò per signora, un po' stagionata a dir vero, accettando il braccio che gli offriva il Gregoretti, bel tipo di mattacchione, e alle sue ore anche poeta.
Si traversò un secondo salotto che già conosciamo, e si mosse di là verso la sala da pranzo, il cui uscio spalancato lasciava vedere tutto uno sfolgorìo di lampade di bronzo dorato e di candelabri antichi, tra i cui viticci venivano ad innestarsi, come frutti luminosi, le pere cristalline della luce elettrica. Al soffitto di legno, partito a cassettoni e rosoni, anch'essi dorati, si armonizzavano le credenze e le cristalliere di legno nero, intagliato a fogliami, a fiorami, a rabeschi, a mascheroni, a putti, a draghi, ad uccelli fantastici. Falso Cinquecento, sicuramente; ma anche falso sta bene, dà un nobile carattere alle case, parendo invecchiare con esse le famiglie troppo moderne, che si sono felicemente arrampicate a metterci il nido.
La tavola era uno splendore di cristallame, d'argenteria, di porcellana e di fiori. In vece del solito chemin de table, che è graziosissimo e può essere sommamente caro come lavoro di mani gentili, ma che è pure economico la parte sua, potendo andare in bucato, attraversava la tovaglia in linea diagonale un nastro enorme, artisticamente pieghettato e rigirato a onde, a staffe, a nodi, [pg!24] allacciando qua e là mazzi di rose fresche, di orchidee, di miosotidi, ed altre fioriture contro stagione. Quella era la novità ultimissima del buon gusto; così andava fatto, fosse pur condannato ad essere disfatto la mattina seguente. Buon lusso costoso delle cose destinate a perire! Ma la nave degli Zuliani aveva il vento in poppa, e dispiegava liberamente tutta la sua velatura.
Contegnosi da principio e parchi di parole, i nostri commensali si animarono gradatamente, al saltar dei turaccioli, all'acciottolìo dei piatti, al cozzar dei bicchieri. Il chiacchiericcio si diffuse da un capo all'altro della tavola: si stava bene, si andava anzi di bene in meglio; si aprivano i cuori, si snodavano le lingue. Il cavaliere Lunardi fu garbatissimo colla signorina Margherita, che con un interlocutore sessagenario poteva essere più loquace, mostrando tesori di senno, di cultura e di grazia. Amenissima poi la contessa Galier, tra l'Aldini, che non si mostrava più tanto impacciato, e il signor Brizzi, collocato suo cavalier di sinistra. Così aveva disposto la padrona di casa, per compensarlo di quel sacrifizio, di quel tradimento dovuto fare al suo Cappello Nero.
Intanto questo appariva in casa Zuliani, questo era evidente, tra tanti fumi del vin del Reno, di Borgogna, di Xères, di Caluso e d'altri siti; che i vecchi erano più animati, più allegri, perfino più arguti dei giovani. Nessuna maraviglia; forse è perchè i vecchi hanno meno tempo davanti a sè, in paragone dei giovani, e fanno profitto di quel poco che avanza. Quanto a dedurne che sia per maggiore esperienza della vita, non ne credete niente; e vecchi e giovani son tutti ragazzi ad un modo.
[pg!25] In mezzo al chiacchiericcio generale, che già pareva un principio della confusione delle lingue, che è che non è, salta un turacciolo con formidabile scoppio; ne salta un altro, ne saltan parecchi; il vino di Sciampagna gorgoglia, ribolle, sfavilla, spumeggia nei calici di mussolina fusa in cristallo, o di cristallo fuso in mussolina, come vi piacerà. Era quello il momento solenne dei brindisi. E si capì allora perchè il Gregoretti, quel grazioso mattacchione, non avesse dato alla conversazione tutto ciò che avrebbe potuto e dovuto. Il disgraziato aveva un brindisi in corpo, e in versi, per giunta, in versi veneziani, scoppiettanti, sfavillanti come il vin di Sciampagna, che gli stava dinanzi, e di cui aveva sorseggiata la prima spuma quasi per prenderne ispirazione.
Si era fatto silenzio, vedendo nell'atteggiamento e nel gesto del personaggio la promessa del brindisi. E il Gregoretti incominciò, celebrando in graziose strofe i meriti straordinarii dell'anno allora allora finito. Il che era contro l'usanza, per verità; ma si sapeva bene che il Gregoretti non faceva mai niente a modo degli altri. A suo giudizio, l'anno andato meritava ogni lode, non avendo recato nessun dispiacere a lui, nè agli amici suoi; e questo era molto, anzi poco mancava che non fosse tutto. Sì, buon Dio, si poteva anche ammettere che non fosse stato nè carne nè pesce. Ma il suo successore, il neonato, non si sapeva ancora che diavolo sarebbe riuscito.
E il vecchio, poi, era anche finito bene: ci pensassero un pochino, i signori commensali; era finito stupendamente per tutta una gentile brigata, sotto l'incanto della [pg!26] bellezza accompagnata alla grazia. Occhi soavi, amabil sorriso.... E più avrebbe detto il poeta, perchè c'erano da enumerare i pregi a centinaia. Ma siccome il ritratto sarebbe stato poi sempre inferiore all'originale, egli prendeva consiglio da quei pittori da dozzina, che dopo aver disegnata e colorita con tutta l'arte che possiedono la figura del committente, gli pongono in mano una lettera, colla soprascritta bene in vista, per istruzione del pubblico. Il nome, di quella bellezza, di quella grazia incantevole, doveva egli proferirlo? Non era già pronto a scoccare, sulle labbra di tutti? Animo, via, lo dicessero pur tutti con lui, senza timore di guastargli la chiusa, lo dicessero tutti a gara, quel nome grazioso, “quel nome caro ai Veneziani„ della signora.... E qui una sospensione, che permetteva a tutti di prorompere in coro: “Livia Zuliani„.
La signora Livia Zuliani, udendo quella enumerazione di pregi femminili, e indovinando che col suo nome sarebbe andata a finire, si era fatta via via d'un bel colore vermiglio; a suo vantaggio, senza dubbio, perchè prima d'allora, diciamolo pure, con tutta la sua risoluzione di fare a mala sorte buon viso, era stata un po' verde.
Tra gli applausi e gli evviva dei suoi convitati, la bella nervosa, atteggiate le labbra al sorriso, levò il suo calice, accostandolo cortesemente a quello del suo poeta. Ed anche, sorridendo sempre e ringraziando, dovette ripetere la cerimonia con tutti.
Raimondo era in estasi: vedeva tutto vermiglio, come il volto della sua Livia. Ma non poteva star sempre lì, [pg!27] in contemplazione della propria felicità; da buon padrone di casa, doveva darsi moto, tener desto il fuoco della allegrezza ne' suoi convitati.
— L'anno vecchio ha ottenuto il suo elogio; — disse egli; — chi farà l'elogio del nuovo?
— Tu; — gli rispose il Gregoretti.
— Io? Non son poeta; e dovrei tesserlo in prosa.
— In prosa, da bravo; purchè sia prosa robusta.
— Se non sarà, non vorrete mica accopparmi; — conchiuse Raimondo, che già sentiva venir l'estro ad una seconda versata che i servi facevano in giro.
Levò allora il suo calice, e così prese a parlare, con intenzione d'esser solenne:
— Signore e signori, onde questa casa è onorata, auguro a tutti voi che il nuovo anno sia lieto, come furono a me i sette che lo hanno preceduto. Esaudisca egli il voto che gli esprimo.... — soggiunse l'oratore, ispirandosi d'un subitaneo pensiero, e versando sulla tovaglia un mezzo dito del suo vino, — .... il voto che gli esprimo libando a lui, come un sacerdote antico, con questo roseo dorato liquore.
— Bene osservato; il roseo dorato è una particolarità della vedova Clicquot; — disse il Gregoretti, guardando contro la luce il suo calice.
— La vedova, — rispose Raimondo Zuliani, cogliendo quella volta l'ispirazione dalle parole dell'amico, — la vedova è stata moglie; parliamo dunque del matrimonio. Non senza ragione vi accennavo i miei sette anni felici. A voi, scapoli impenitenti! aiutate con buone risoluzioni l'adempimento del voto che io ho formato poc'anzi, e il [pg!28] nuovo anno vi colmerà delle sue benedizioni. Chi vorrà dare l'esempio? Voi, amico Brizzi, non è vero?
— Me ne guardi il cielo! — gridò il signor Brizzi, facendo un gesto d'orrore.
— E perchè? — domandò Raimondo. — Vi conosco e vi stimo da gran tempo, mio caro, e so che non fate e non dite mai cosa su cui non abbiate pensato due volte. —
Il signor Brizzi si avvide di non aver pensato neanche una a ciò che gli era uscito allora di bocca. Era stato un grido dell'anima; e bisognava attenuarlo con qualche spiegazione.
— Perchè? — rispose. — È presto detto, il perchè. Renderei infelice la donna che avesse la cattiva ispirazione di accettar la mia mano. Son vecchio, sapete? son vecchio.
— Ma che? — entrò a dire la contessa Galier, che non voleva sentir parlare di malinconie. — Vecchio è chi muore.
— Signora contessa, la prego di credere che ho passati i cinquanta. Il matrimonio non è più fatto per me, salvo il caso di voler saldare insieme due cocci scompagnati. Con che gusto, poi? con che utile per la società? Pensiamo alla società, miei signori; è anche di moda. E concludiamo; il matrimonio è fatto pei giovani. —
Raimondo avrebbe volentieri abbracciato il suo segretario. Senza volerlo, senza pensarci neanche, quell'ottimo signor Brizzi gli dava la mano, tirandolo dov'egli intendeva per l'appunto avviarsi.
— E allora rivolgiamoci ai giovani; — ripigliò. — Auguriamo per esempio al conte Aldini la felicità ch'egli [pg!29] merita. Sei al momento buono, mio caro Filippo. È perchè i voti del capo d'anno sono privilegiati su tutti, io ti auguro con maggior fede una sposa degna di amore e di stima.... perchè non lo direi? come la mia.
— Raimondo! — esclamò la signora Livia. — Mi farete arrossire. —
E più avrebbe detto, tanto era seccata. Ma le bisognava rattenersi, star lei in riga, se non sapeva starci il suo signore e padrone. Ah, quella benedetta varietà di vini dei pranzi e delle cene solenni! Manda i fumi alla testa, snoda le lingue, fa dir sciocchezze agli uomini serii, troppe sciocchezze; e con una insistenza, poi, con una insistenza degna di miglior causa.
A farlo a posta, il suo signore e padrone insisteva.
— Ebbene, sì, che c'è egli di male? Viva la sincerità. Son tutti amici, qui, d'antica data, e strettissimi; gradiranno ch'io parli come penso. Sarebbe ipocrisia in me il tacer loro che sono felice. Credi a me, dolce amico; — soggiunse, volgendosi all'Aldini; — segui l'esempio di chi ti vuol bene. Io bevo intanto alla tua fidanzata. —
Filippo era sulle spine; e doveva mostrarsi tranquillo, accogliendo lietamente gli augurii dell'amico Raimondo.
— Senza conoscerla! — esclamò egli, tanto per dire qualche cosa.
— Eh, pensiamo se tu, almeno tu, non te ne sarai formato un'idea! — incalzò Raimondo. — Nella mente d'un giovinotto, o nel cuore, la futura compagna della vita c'è sempre, immagine vaga, da principio, ma che a [pg!30] poco a poco va prendendo i precisi contorni di una giovine e conosciuta bellezza. Dico bene?
— Ottimamente! — gridò il Gregoretti. — Dopo la prosa robusta, ci dai la prosa elegante, la prosa poetica.
— L'argomento ne franca la spesa; — rispose Raimondo, i cui occhi andavano come per incanto verso la signorina Margherita.
La fanciulla teneva i suoi molto bassi, avendo l'aria di voler aggiustare una piega della sua sopravveste. Ma intanto si era fatta un po' rossa, dal sommo della fronte fino alla radice del collo. E stava bene così, era più bella che mai, mettendo in mostra il volume dei capelli neri, ondati e lucenti, che sull'incarnato del viso luccicavano due volte tanto, con mobili riflessi turchini. Bella e divina creatura! Un poema, l'aveva dichiarata il Gregoretti, quella medesima sera, vedendola per la prima volta nel salotto della signora Zuliani. Perchè poi un poema? Ci sono tanti poemi brutti! e tanti altri mediocri!
Ma il paragone, antico oramai, doveva essere stato fabbricato nel tempo che di poemi, in Italia, si conoscevano soltanto i divini, quei tre che tutti sappiamo; dopo i quali, chiudi e sigilla, che il conto è fatto.
— Dunque, — ripigliò il Gregoretti, tenendo bordone a Raimondo, — vogliamo bere alla futura sposa del nostro Aldini? Egli è qui l'unico scapolo in età da pentirsi. Péntiti, don Giovanni! —
Eh, don Giovanni nel profondo del suo cuore non avrebbe chiesto niente di meglio. Ma lì per lì sentiva corrersi un brivido per l'ossa.
[pg!31] — Anche tu? — diss'egli volgendosi al Gregoretti, con aria tra confusa e seccata.
— Anch'io, sicuro, e tutti quanti siam qui, a volerti bene. Péntiti, don Giovanni! —
Filippo Aldini guardò intorno a sè, con occhi smarriti, come d'uomo in punto d'affogare. Tutti, col calice in mano, gli ripetevano la medesima frase. “Péntiti!„ diceva il Ruggeri; “péntiti!„ il signor Telemaco, che in verità non diceva nulla, ma consentiva col gesto, e nel gaio concerto delle voci pareva aggiungere la sua. Ma era dunque una congiura? un colpo premeditato?
— Lo senti? Te lo dicono tutti in coro; — gridò Raimondo Zuliani, ridendo a più non posso. — Péntiti, don Giovanni! —
E si rivolgeva, ciò detto, alla sua Livia, come per invocarne l'aiuto.
— Ma sì, — aggiunse allora la signora Zuliani, con la sua vocina sottile, e accompagnandone il suono con un moto grazioso della sua testina bionda, — perchè non si pentirebbe, don Giovanni? —
Filippo Aldini era fuori di sè dalla stizza. Ma egli sentì che a durarla ancora un tratto, sarebbe diventato ridicolo, con quella cera da funerale, in mezzo a tanta allegria che pareva volersi rovesciar tutta su lui. A farlo a posta, anche la padrona di casa si metteva dalla parte dei canzonatori.
Accettò dunque l'invito, come se fosse stato un comando; levò il suo calice, lo vuotò fino all'ultimo sorso, e rispose con accento risoluto:
— Sia, poichè tutti lo vogliono; mi pentirò. —
[pg!32] Ebbe naturalmente un applauso da tutti; e dopo l'applauso un premio speciale dal Gregoretti.
— Così va bene; — disse il poeta mattacchione. — Fin da domani metto la Musa in molle, e ti preparo l'epitaffio. —
Voleva dire l'epitalamio. Ma già la lingua incominciava a tradirlo.
[pg!33]