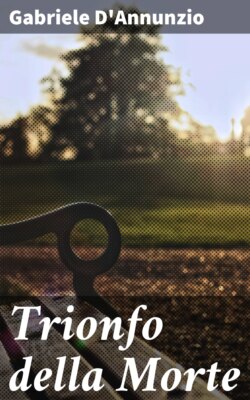Читать книгу Trionfo della Morte - Gabriele D'Annunzio - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Ippolita, quando vide contro il parapetto un gruppo di uomini chini a guardare nella strada sottoposta, esclamò soffermandosi:
—Che sarà accaduto?
Ella ebbe un piccolo moto di timore; e appoggiò involontariamente la mano sul braccio di Giorgio come per trattenerlo.
Giorgio disse, osservando i gesti di quegli uomini:
—Si sarà gettato giù qualcuno.
Soggiunse:
—Vuoi che torniamo indietro?
Ella esitò un poco, tra la curiosità e il raccapriccio. Rispose:
—No; seguitiamo.
Seguitarono pel viale estremo, lungo il parapetto. Involontariamente Ippolita accelerava il suo passo verso il gruppo dei curiosi.
In quel pomeriggio di marzo il Pincio era quasi deserto. Nell'aria grigia e sorda morivano i romori rari.
—È così—disse Giorgio.—Qualcuno s'è ucciso.
Ambedue si soffermarono, in vicinanza del gruppo. Tutti quegli uomini guardavano con occhi intentissimi il lastrico sottostante. Erano plebei oziosi. I loro volti diversi non esprimevano alcuna pietà e alcuna tristezza; l'immobilità dello sguardo metteva ne' loro occhi una specie di stupefazione bestiale.
Un giovinastro sopraggiunse, avido di vedere.
—Non c'è più—gli fece un tale, prima che colui si sporgesse; ed aveva nella voce un indefinibile accento tra di scherno e di giubilo, come rallegrandosi che lo spettacolo non potesse più da altri esser goduto.—Non c'è più. L'hanno già portato via.
—Dove?
—A Santa Maria del Popolo.
—Morto?
—Morto.
Un altro, un uomo scarno e verdiccio che portava intorno al collo una larga sciarpa di lana, si sporse molto; e, togliendosi di bocca la pipa, domandò ad alta voce:
—Che c'è rimasto?
La sua bocca era tòrta da un lato, rappresa come per una bruciatura, convulsa come se assaporasse una saliva amara di continuo rigurgitante; e la sua voce era profonda, come se uscisse da luoghi cavernosi.
—Che c'è rimasto?
Un carrettiere, giù nella strada, si chinava a piè della muraglia. I riguardanti tacquero, immobili, aspettando la risposta. Scorgevano soltanto, su le pietre, una chiazza nerastra.
—Poco sangue—rispose il carrettiere, ancóra curvo, cercando qualche cosa nella chiazza con la punta di una canna.
—E poi?—chiese di nuovo l'uomo della pipa. Il carrettiere si sollevò, tenendo in cima della canna qualche cosa che quei di sopra non vedevano.
—Capelli.
—Di che colore?
—Biondi.
Le voci, nel precipizio chiuso fra le due alte muraglie, avevano un rimbombo singolare.
—Giorgio, andiamo!—supplicò Ippolita, turbata, un poco pallida, scotendo l'amante che si sporgeva dal parapetto, in vicinanza del gruppo, attratto dall'atrocità della scena.
Oltrepassarono il luogo tragico, in silenzio. In ambedue persisteva il pensiero di quella morte, dolorosamente; e la loro tristezza era visibile.
Egli disse:
—Beati i morti perché non dubitano più.
Ed ella:
—È vero.
Uno scoramento infinito rendeva stanche le loro parole. Ella soggiunse, abbassando il capo, con un misto di amarezza e di compianto:
—Povero amore!
—Quale amore?—le chiese Giorgio, assorto.
—Il nostro.
—Tu lo senti dunque finire?
—Non in me.
—In me forse?
Una irritazione mal repressa inaspriva la voce di lui. Egli ripetè, guardandola:
—In me? Rispondi.
Ella tacque, riabbassando il capo.
—Non rispondi? Ah, tu sai bene che non diresti il vero.
Poi, dopo un intervallo in cui ambedue provarono un'ansietà inesprimibile di leggersi nell'anima, egli seguitò:
—Incomincia così l'agonia. Tu non te ne accorgi ancóra; ma io, da che tu sei tornata, ti guardo continuamente ed ogni giorno sorprendo in te un segno nuovo...
—Che segno?
—Un cattivo segno, Ippolita... Orribile cosa amare ed avere questa lucidità in tutti gli istanti eguale!
La donna scosse il capo, con un atto quasi violento; e si oscurò. Ancóra una volta, come tante altre volte, i due amanti divennero l'uno contro l'altra ostili. Ciascuno dei due si sentiva ferire dall'ingiustizia del sospetto e si ribellava, interiormente, con una collera sorda; ch'erompeva talora in parole crude e irreparabili, in accuse gravi, in recriminazioni enormi. Una invincibile smania li assaliva, di torturarsi a vicenda, di pungersi, di martoriarsi il cuore.
Ippolita si oscurò e si chiuse, corrugando i sopraccigli, serrando la bocca, mentre Giorgio la guardava con un sorriso irritante.
—Incomincia così—egli riprese persistendo in quel sorriso acerbo, in quello sguardo acuto. —Tu provi in fondo all'anima una inquietudine, una specie d'impazienza vaga, che tu non sai soffocare. Standomi vicina, tu senti che qualche cosa in fondo all'anima ti si leva contro di me, quasi una ripugnanza istintiva, che tu non sai soffocare. E divieni taciturna; e devi fare uno sforzo immane per dirmi una parola; e intendi male quel ch'io ti dico; e involontariamente, anche in una risposta insignificante, la tua voce è dura.
Ella non l'interruppe neppur con un gesto. Ferito da quel silenzio egli seguitò; e lo spingeva non soltanto la smania acre di tormentare la sua compagna, ma anche un certo gusto disinteressato delle investigazioni reso più acuto e più letterario dalla cultura. Egli, infatti, cercava di mettere nelle sue parole la sicurezza e l'esattezza dimostrativa apprese nelle pagine degli analisti; ma come nei soliloquii la sua considerazione mentale formulata esagerava ed alterava lo stato interno a cui si riferiva, così nei colloquii spesso la preoccupazione della perspicacia oscurava la sincerità del suo sentimento e lo traeva in errore su i moti intimi altrui ch'egli voleva scoprire. 11 suo cervello, ingombrato da un ammasso di osservazioni psicologiche personali e apprese da altri analisti, spesso confondeva e scomponeva tutto, fuori e dentro. Egli dava al suo spirito attitudini arteficiose e irreparabili.
Seguitò:
—Bada; io non ti rimprovero. Tu non hai colpa. Ciascuna anima umana contiene in sé una data quantità di forza sensitiva da spendere in un amore. Necessariamente quella quantità si consuma nel tempo come ogni altra cosa. Quando è esaurita, nessuno sforzo vale ad impedire che l'amore finisca. E tu mi ami già da molto tempo; da quasi due anni! Il due di aprile cade il secondo anniversario. Ci hai pensato?
Ella scosse la testa. Egli ripetè, come a sé medesimo:
—Due anni!
Camminarono verso un sedile, e sedettero. Nel piegarsi, Ippolita aveva un'aria di grave stanchezza, quasi di abbattimento. Una pesante carrozza nera passò nel viale, facendo stridere la ghiaia; dalla via Flaminia giunse fioco lo squillo d'una cornetta; il silenzio rioccupò i dintorni arborati; gocce di pioggia, rare, cadevano.
—Sarà funebre questo secondo anniversario—riprese a dire Giorgio, implacabile contro la taciturna.—Eppure, bisognerà che noi lo celebriamo. Io ho il gusto delle cose amare.
Ippolita mostrò il suo dolore in un sorriso impreveduto. Poi disse, con impreveduta dolcezza:
—Perché tutte queste cattive parole?
E guardò Giorgio negli occhi, a lungo e a dentro. Ambedue, di nuovo, provarono un'ansietà inesprimibile di leggersi nell'anima. Ella sapeva bene da quale orribile male fosse compreso il suo amante; ella sapeva bene l'oscura causa di quell'acredine. Soggiunse, perché egli parlasse, perché egli esalasse la sua pena:
—Che hai?
Egli era rimasto come confuso da quell'accento di bontà, che non aspettava. Sentendosi da quell'accento indovinare e commiserare, egli sentì in sé crescere la pietà di sé medesimo; e una profonda commozione gli alterò tutto l'essere.
—Che hai?—ripeté Ippolita toccandogli una mano, quasi per aumentare sensualmente il potere della sua dolcezza.
—Che ho?—egli rispose.—Amo.
Le sue parole avevano perduto ogni punta. Mostrando la sua piaga immedicabile, egli s'impietosiva su sé medesimo. I vaghi rancori, che serpeggiavano in fondo al suo spirito contro la donna, parvero dileguarsi. Egli riconosceva ingiusto ogni risentimento contro di lei, riconoscendo un ordine superiore di necessità fatali. La sua miseria non proveniva da alcuna creatura umana, ma dall'essenza stessa della vita. Egli non doveva dolersi dell'amata ma dell'amore. L'amore, a cui per natura tutto il suo essere tendeva con invincibile veemenza, l'amore era la più grande fra le tristezze terrene. Ed egli era legato a quella suprema tristezza, forse fino alla morte.
Come egli taceva sopra pensiero, Ippolita gli domandò:
—Tu credi dunque, Giorgio, che io non ti ami?
—Ebbene, sì, guarda: io credo che tu mi ami—egli rispose.—Ma puoi tu provarmi che domani, che fra un mese, che fra un anno, che sempre sarai egualmente felice d'esser mia? Puoi tu provarmi che ora, in questo attimo, sei tutta mia? Che cosa posseggo io di te?
—Ogni cosa.
—Nulla, o quasi nulla. Io non posseggo quel ch'io vorrei possedere. Tu mi sei ignota. Come qualunque altra creatura umana, tu chiudi dentro di te un mondo per me impenetrabile; e la più ardente passione non mi aiuterà a penetrarlo. Delle tue sensazioni, dei tuoi sentimenti, dei tuoi pensieri io non conosco se non una minima parte. La parola è un segno imperfetto. L'anima è intrasmissibile. Tu non puoi darmi l'anima. Anche nella più alta ebrezza, noi siamo due, sempre due, separati, estranei, interiormente solitarii. Io bacio la tua fronte; e sotto la fronte si muove forse un pensiero che non è mio. Ti parlo; e forse una mia frase ti risveglia nello spirito un ricordo d'altri tempi, non del mio amore. Un uomo passa, un uomo ti guarda; e nel tuo spirito si produce un qualunque moto ch'io non posso sorprendere. E io non so quante volte un riflesso della tua vita anteriore illumini il momento presente... Oh, di quella vita, io ne ho una paura folle!—Sono accanto a te; mi sento tutto invaso dalla delizia che mi viene in certe ore dalla tua sola presenza; ti accarezzo, ti parlo, ti ascolto; mi abbandono. D'un tratto, un pensiero mi agghiaccia. Se io, inconsapevolmente, suscitassi in te una memoria, il fantasma d'una sensazione già provata, una malinconia dei più lontani giorni? Io non ti saprò mai dire la mia sofferenza. Quel calore, che mi dava il sentimento illusorio di non so qual comunione fra me e te, cade d'un tratto. Tu mi sfuggi, ti allontani, diventi inaccessibile. Io rimango solo, in una solitudine spaventevole. Dieci, venti mesi d'intimità non sono più nulla. Tu mi sembri estranea come quando non mi amavi. Ed io non ti accarezzo più, non parlo più; mi chiudo; evito qualunque manifestazione esteriore; ho paura che ogni minimo urto possa sollevare nel fondo del tuo spirito quei sedimenti oscuri che vi ha accumulati la vita irrevocabile. E allora cadono su noi quei lunghi silenzi angosciosi, in cui le forze del cuore si consumano inutilmente, miseramente. Io ti domando: «A che pensi?» Tu mi rispondi: «A che pensi?» Io non so il tuo pensiero; tu non sai il mio. Il distacco si fa sempre più profondo; diventa un abisso. E il guardare in quell'abisso è un'angoscia così forte che, per una specie d'istinto cieco, io mi getto sul tuo corpo, ti stringo, ti soffoco, impaziente di possederti. La voluttà è alta, come non mai. Ma quale voluttà può compensare l'immensa tristezza che sopraggiunge?
Ippolita disse:
—Io non provo questo. Io ho più abbandono. Forse, amo di più.
Di nuovo, questa affermazione di superiorità punse l'infermo.
Ippolita disse:
—Tu pensi troppo. Tu segui troppo il tuo pensiero. Il tuo pensiero ti attrae forse più che io non ti attragga, perché è sempre nuovo e sempre diverso; mentre io ho già perduta ogni novità. Nei primi tempi del tuo amore, tu eri meno pensoso e più spontaneo. Non avevi ancóra preso il gusto delle cose amare, perché eri più largo di baci che di parole. Già che, come tu dici, la parola è un segno imperfetto, non bisogna abusarne. Tu ne abusi, quasi sempre con crudeltà.
Poi, dopo un intervallo di silenzio, allettata ella stessa da una frase, non potendo resistere al desiderio di proferirla, soggiunse:
—L'anatomia presuppone il cadavere.
Come l'ebbe proferita, si pentì. La frase le parve volgarissima, poco feminina, acerba. Ella si rammaricò di non aver conservato quel tono di dolcezza e d'indulgenza, da cui dianzi Giorgio era rimasto confuso. Ancóra una volta ella mancava al proposito d'essere per l'amico una paziente e delicata medicatrice.
—Vedi,—ella disse, mostrando nella voce quel rammarico—tu mi guasti.
Egli appena sorrise. Ambedue sentivano che in quella disputa non avevano ferito se non l'amore.
La carrozza prelatizia ripassò, al piccolo trotto di due cavalli neri dalle code intonse. Gli alberi prendevano un'apparenza spettrale, come più l'aria s'illividiva nel tramonto umidiccio. Plumbee violacee le nuvole fumigavano, sul Palatino, sul Vaticano. Una striscia di luce gialla come solfo, diritta come una spada, rasentava il Monte Mario, dietro i cipressi aguzzi.
Giorgio pensava: «Mi ama ella ancóra? E perché è così irritabile? Sente ella forse che io dico la verità o ciò che sta per essere la verità? L'irritazione è un sintomo. Ma questa irritazione sorda e continua non è anche in fondo a me? Io so in me la causa vera. Sono geloso. Di che? Di tutto:—delle cose che si riflettono ne' suoi occhi...»
Egli la guardò. «È bellissima, oggi. È pallida. Mi piacerebbe sempre afflitta e sempre malata. Quando ella si colorisce, mi pare un'altra. Quando ella ride non posso difendermi da un vago sentimento ostile, quasi d'ira contro il suo riso. Non però sempre.»
Il suo pensiero si perse nel pomeriggio. Notò fuggevolmente una segreta rispondenza tra l'aspetto della sera e l'aspetto dell'amata, godendone. Dal pallore di quel volto bruno traspariva come una leggera soffusione di viola sotto la pelle; ed ella aveva intorno al collo un piccolo nastro giallo, delicatissimo, che lasciava scoperti i due nèi bruni. «È molto bella. Il suo viso ha quasi sempre un'espressione profonda, significativa, appassionata. Qui sta il segreto del suo fascino. La sua bellezza non mi stanca mai; mi suggerisce sempre un sogno. Di che si compone la sua bellezza? Non saprei dire. Materialmente, non è bella. Qualche volta, guardandola, io ho provata la sorpresa penosa di una disillusione. I suoi lineamenti mi sono apparsi nella loro materiale verità, non modificati, non illuminati dalla forza di un'espressione spirituale. Ella ha però tre divini elementi di bellezza: la fronte, gli occhi, la bocca: divini.»
Gli si ripresentò al pensiero il riso. «Che mi raccontava ella, ieri? Mi raccontava non so più che cosa, di sua sorella: un piccolo fatto comico avvenuto in casa di sua sorella, a Milano, quando ella era là... Che ridere!... Ella dunque poteva ridere, lontana da me; poteva essere gaia. Ed ho le sue lettere. Tutte le sue lettere sono piene di tristezza, di pianto, di desiderio disperato.»
Egli provò un'acuta puntura, e poi una inquietudine tumultuosa come se fosse d'innanzi a un fatto grave ed irreparabile ma non bene chiarito. Avveniva in lui il consueto fenomeno della esagerazione sentimentale, per via d'imagini associate. Quell'innocente scoppio di risa si mutava in una ilarità continua, di tutti i giorni, di tutte l'ore, per tutto il periodo dell'assenza. Ippolita aveva vissuto lietamente, d'una vita volgare, tra gente ch'egli non conosceva, tra gli amici del cognato, tra ammiratori, tra gente stupida. Le sue lettere dolorose mentivano. Un brano d'una lettera gli tornò nella memoria, preciso.—Qui la vita è insopportabile. Amici ed amiche ci assediano; non ci lasciano in pace un'ora. Tu sai la cordialità milanese...—Una chiara visione gli sorse nello spirito: Ippolita in mezzo a una folla borghese d'impiegati, d'avvocati, di mercanti. Ella sorrideva a tutti, stendeva a tutti la mano, ascoltava i discorsi melensi, rispondeva una frase sciocca, si mescolava a quella volgarità.
In quel momento gli pesò sul cuore tutta la sofferenza provata in due anni al pensiero della vita che la sua amante conduceva, tra gente sconosciuta, nelle ore in cui ella non poteva restare con lui. «Che fa ella? Chi vede? Con chi parla? Quale atteggiamento ha verso quelle persone che ella conosce, con cui ella convive?» Eterne interrogazioni, senza risposta.
Il tormentato pensò: «Ognuna di quelle persone le toglie qualche cosa; toglie qualche cosa a me. Io non saprò mai quali influenze quelle persone abbiano esercitato su di lei; quali sentimenti, quali pensieri abbiano suscitato in lei. Ella è bella, piena di seduzioni; ha quel genere di bellezza che flagella gli uomini e li fa desiderosi. In mezzo a quella orribile folla, ella è stata desiderata. Il desiderio di un uomo trasparisce da uno sguardo, e lo sguardo è libero; e una donna è in balìa dello sguardo di chi la desidera. Che prova una donna, accorgendosi d'essere desiderata? Non rimane, certo, impassibile. Deve avvenire in lei un turbamento, un qualsiasi moto; e sia pure di ripugnanza, e sia pure di ribrezzo. Ora, ecco che un qualunque uomo può turbare la donna che mi ama. Qual sorta di possesso è dunque il mio?»
Egli soffriva forte, poiché le imagini fisiche illustravano il suo ragionamento interiore.
«Io amo Ippolita; con una passione che io crederei inestinguibile, se non sapessi che ogni amore umano deve avere una fine. Io l'amo e non imagino voluttà più alte di quelle che ho da lei. Pure, più d'una volta, vedendo passare una donna, io sono stato assalito da un desiderio repentino; più d'una volta, due occhi di donna, veduti in qualche luogo, fuggevolmente, mi hanno lasciato nell'anima non so che vago solco di malinconia. Più d'una volta, ho pensato d'una donna che passava, d'una donna incontrata in un salotto, dell'amante d'un mio amico:—Quale sarà la sua maniera di amare? Quale sarà il suo segreto voluttuoso?—E per qualche tempo quella donna ha incitata la mia imaginazione, senza troppa vivezza, ma con una insistenza lenta, a intervalli. Taluna di quelle imagini s'è anche presentata d'improvviso nel mio spirito, mentre io tenevo sotto le mie carezze Ippolita. Or bene, perché ella stessa non potrebbe essere sorpresa da un desiderio vedendo passare un uomo? Se io avessi il dono di guardarla nell'anima e la vedessi attraversata da uno di quei desiderii, sia pure come da un lampo, certo io crederei macchiata la mia amante d'una macchia indelebile e crederei morire di dolore. Io non potrò mai avere questa prova materiale, perché natura vuole che l'anima della mia amante sia invisibile e impalpabile, pur essendo assai più del corpo esposta alle violazioni. Ma le analogie m'illuminano. La possibilità non è dubbia. Forse, in questo istante medesimo, ella guarda dentro di sé una macchia recente e la vede, sotto il suo sguardo, dilatarsi.»
Egli ebbe un gran sussulto, all'urto del dolore. Ippolita gli chiese, con voce dolce:
—Che hai? A che pensavi?
Egli rispose:
—A te.
—Come?
—Male.
Ippolita sospirò. Poi chiese:
—Vuoi che andiamo?
Egli rispose:
—Andiamo.
Si levarono. Si rimisero per la via che avevano dianzi percorsa. Ippolita disse, piano, con le lacrime nella voce:
—Che sera triste, amor mio!
Si soffermò, come per raccogliere e per assaporare la tristezza sparsa nel giorno morente. Il Pincio, intorno, era deserto ormai, silenzioso, pieno d'un'ombra violetta in cui le erme biancheggiavano come sepolcri. La città sottoposta si copriva di ceneri. Gocce di pioggia, rare, cadevano.
—Dove andrai stasera?—chiese ella.—Che farai?
Egli rispose, desolato:
—Io non so che farò.
Mentre soffrivano stando l'uno presso l'altra, pensavano con terrore a una nota e ben più dura sofferenza che li aspettava. Essi sapevano quale orribile strazio le imaginazioni notturne avrebbero fatto delle loro anime senza difesa.
—Se tu vuoi, vengo da te, questa notte—disse Ippolita, timidamente.
L'amante, che si sentiva dentro divorare da un sordo rancore ed incitare come da una smania d'esser cattivo, di vendicarsi, rispose:
—No.
Ma il cuore gli oppose: «Tu non potrai rimaner lontano da lei, questa notte; non potrai, non potrai.» E, in mezzo alle cieche incitazioni ostili, sentendo questa impossibilità, avendo chiara conscienza di questa assoluta impossibilità, egli provò una specie di brivido interno, uno strano brivido come di esaltante fierezza, in conspetto della
grande passione da cui era posseduto. Ripeté a sé medesimo: «Io non potrò rimanere lontano da lei, questa notte; non potrò.» Ebbe il sentimento oscuro d'una forza estranea che lo dominava. Un soffio tragico gli passò su lo spirito.
—Giorgio!—esclamò Ippolita stringendogli il braccio, un poco sbigottita.
Egli trasalì. Riconobbe il luogo dove prima s'erano fermati a guardare nel lastrico sottoposto la macchia di sangue lasciata dal suicida; domandò:
—Hai paura?
Ella rispose tenendogli ancóra il braccio:
—Un poco.
Egli si staccò da lei, si avvicinò al parapetto e si sporse. L'ombra già occupava il fondo della strada; dove egli credette scorgere la macchia nerastra, perché ne aveva ancora fresca l'imagine nella memoria. Le suggestioni della sera crearono vagamente un fantasma del corpo morto: una forma indecisa di giovane, con un capo biondo, sanguinoso. «Chi era colui? Perché si è ucciso?» Vide sé stesso in quella forma, spento. Alcuni pensieri, rapidissimi, senza legame, gli attraversarono il cervello. Rivide come nella luce d'un baleno il suo povero zio Demetrio, il minor fratello di suo padre, il consanguineo suicida:—una faccia nascosta da un velo nero, sul guanciale bianco; una mano lunga, pallida, ma piena d'una espressione virile; su la parete una piccola pila d'argento, per l'acqua santa, sospesa a tre catenelle, che si moveva al vento di tratto in tratto con un tintinno. «Se io mi gettassi? Un semplice salto in avanti; e la caduta, celere. Si smarrisce la conoscenza, a traverso lo spazio?» Egli imaginò fisicamente l'urto del corpo contro la pietra; e rabbrividì. Poi per tutto il corpo provò come una ripulsione forte, angosciosa e mista d'una strana dolcezza. L'imaginazione gli rappresentò la delizia della prossima notte:—l'addormentarsi a poco a poco nel languore; il risvegliarsi con una piena di tenerezza misteriosamente accumulata nel sonno. Imagini e pensieri si succedevano in lui con una straordinaria rapidità.
Come si rivolse, incontrò gli occhi di Ippolita fissi su di lui, grandi, smisurati; e gli parve di leggere quel che esprimevano. Le si avvicinò; mise il suo braccio sotto il braccio di lei, con un gesto affettuoso ch'eragli familiare. Ed ella se lo strinse forte contro il fianco. Ambedue provavano un bisogno improvviso di stringersi, di mescolarsi, perdutamente.
—Si chiude! Si chiude!
Il grido dei guardiani risonò nel silenzio, sotto gli alberi.
—Si chiude!
Dopo il grido, il silenzio pareva più lugubre; e quelle due parole, urlate a squarciagola da uomini invisibili, davano ai due amanti un urto fastidioso. Per mostrare che avevano udito e che si disponevano ad uscire, essi affrettarono il passo. Ma ostinate le voci, di qua, di là, per i viali deserti ripetevano:
—Si chiude!
—Maledizione!—esclamò Ippolita con un gesto d'impazienza, esasperata, affrettando ancóra il passo.
La campana della Trinità de' Monti sonò l'Angelus. Roma apparve come una immensa nuvola grigia, informe, che radesse il suolo. Qualche finestra, nelle case prossime sottostanti, già rosseggiava, dilatata dalla caligine. Gocce di pioggia, rare, cadevano.
—Tu verrai da me, questa notte; è vero?—chiese Giorgio.
—Sì, sì; verrò.
—Verrai presto?
—Verrò alle undici.
—Se tu non venissi, io morirei.
—Verrò.
Si guardarono negli occhi; si scambiarono una promessa inebriante.
Egli chiese, vinto dalla tenerezza:
—Mi perdonerai?
Di nuovo si guardarono, con uno sguardo infinitamente lusinghevole.
Egli disse, piano:
—Adorata!
Ella disse:
—Addio. Fino alle undici, pensami.
—Addio.
Erano in fondo alla via Gregoriana. Si separarono. Ella discese per la via di Capo Le Case. Egli la guardò allontanarsi giù pel marciapiede bagnato che riluceva al riflesso delle vetrine. «Ecco, ella mi lascia. Rientra in una casa a me ignota, rientra nella sua vita volgare, si spoglia dell'idealità di cui la vesto; diventa un'altra donna, una donna comune. Io non so più nulla di lei. Le brutte necessità della vita la prendono, la occupano, la umiliano...» Dalla bottega di un fioraio gli venne sul viso un profumo di violette. Il cuore gli si gonfiò di aspirazioni confuse. «Ah, perché dunque non potremmo noi rendere la nostra esistenza conforme al nostro sogno e vivere per sempre in noi soli?»
II
Giorgio dormiva, verso le dieci della mattina, uno di quei profondi sonni ristoratori che nella giovinezza seguono una notte di voluttà; quando il domestico venne a svegliarlo.
Egli gridò, di pessimo umore, rivoltandosi nel letto:
—Non sono in casa per nessuno. Lasciatemi.
Ma udì la voce dell'importuno, che dalla camera attigua pregava:
—Perdona, Giorgio, se ho insistito. Ho bisogno urgente di parlarti.
Riconobbe la voce di Alfonso Exili, e il suo fastidio crebbe.
Questo Exili era un antico suo compagno di collegio, un giovine di mediocre intelligenza, rovinatosi al giuoco e alla crapula, diventato una specie di avventuriere alla caccia del soldo. Costui poteva sembrare ancóra un bel giovine, sebbene la sua faccia fosse devastata dal vizio; ma aveva nella sua persona e ne' suoi modi quel non so che di furbesco e d'ignobile che acquistano gli uomini costretti a vivere di espedienti e di umiliazioni.
Entrò, aspettò che il domestico fosse uscito, assunse un'aria un po' sconvolta; e disse, mangiandosi a mezzo le parole:
—Scusa, Giorgio, se ricorro a te anche questa volta. Ho da pagare un debito di giuoco. Aiutami. Si tratta d'una piccola somma: trecento lire. Scusa, Giorgio.
—Ah, tu dunque paghi i tuoi debiti di giuoco?—gli chiese Giorgio infliggendogli con perfetta incuranza l'ingiuria; perché, non avendo egli saputo rompere ogni rapporto con quel glutinoso scroccatore, adoperava contro di lui il disprezzo come altri adopera un bastone per preservarsi dal contatto di un animale immondo.—Mi fai stupire.
L'Exili sorrise.
—Via, non essere cattivo!—pregò, con una voce supplichevole, come una femmina.—Me le dai, queste trecento lire? Su la mia parola d'onore, domani te le rendo.
Giorgio scoppiò a ridere. Sonò il campanello, per chiamare il domestico. Venne il domestico.
—Cercate il mazzo delle piccole chiavi, là, in quegli abiti che sono sul divano.
Il domestico trovò le chiavi.
—Aprite, là, il secondo tiretto. Datemi il portafoglio grande.
Il domestico gli diede il portafoglio.
—Andate.
Come il domestico uscì, l'Exili disse, con un sorriso fra timido e convulso:
—Non potresti darmene quattrocento?
—No. Tieni. Sieno le ultime. Vattene.
Giorgio non gli porse il denaro, ma lo posò su la sponda del letto. L'Exili sorrise, prendendolo, mettendoselo in tasca. Poi, con un tono ambiguo tra di adulazione e d'ironia, disse:
—Tu hai un cuore nobile.
Si guardò intorno.
—Tu hai anche una deliziosa camera da letto.
Si sedé sopra un divano; si versò un bicchierino di liquore; si riempì di sigari un astuccio.
—Chi è ora la tua amante? Non è più quella dell'anno scorso; è vero?
—Vattene, Exili. Voglio dormire.
—Che splendida creatura, quella! I più belli occhi di Roma... È ancóra qui? Da qualche tempo non l'incontro. Dev'essere andata fuori. Ha una sorella a Milano, mi pare.
Egli si versò un altro bicchierino e lo bevve d'un fiato. Ciarlava forse appunto per avere il tempo di vuotare la boccia.
—È divisa dal marito; è vero? Credo che si debba trovar male, in finanze. Ma veste sempre bene. L'incontrai, circa due mesi fa, pel Babuino. Sai chi sarà forse il tuo successore? Quel Monti... Tu non lo devi conoscere: un mercante di campagna, un giovine alto, grosso, biondiccio. Quel giorno appunto la seguiva, pel Babuino. Tu sai: si vede sùbito, quando un uomo corre dietro a una donna... Quel Monti ha molti quattrini.
Pronunciò l'ultima parola con un indefinibile accento, misto d'invidia e d'ingordigia, odioso. Poi bevve per la terza volta, senza far rumore.
—Giorgio, dormi?
Giorgio non rispose, fingendo di dormire, sebbene avesse tutto ascoltato. Ma egli temeva che l'Exili udisse i battiti del cuore a traverso la coltre.
—Giorgio!
Egli finse di scuotersi da un dormiveglia.
—Come! Sei ancóra qui? Non te ne vai?
—Me ne vado—fece l'Exili, avvicinandosi al letto.—Guarda qua: una forcina di tartaruga!
Si chinò per raccoglierla, sul tappeto; la esaminò curiosamente; la posò su la coperta.
—Che uomo fortunato!—fece con quel suo tono ambiguo d'ironia e di adulazione.—Dunque a rivederci e grazie.
Tese la mano; ma Giorgio non mosse la sua di sotto la coltre. Il ciarlatore si rivolse alla porta.
—Tu hai un cognac squisito. Ne prendo un altro bicchierino.
Ribevve ed uscì, lasciando Giorgio nel letto ad assaporare il tossico.
III
Il due di aprile cadeva il secondo anniversario.
—Bisogna questa volta celebrarlo fuori di Roma—disse Ippolita.—Bisogna che noi passiamo una gran settimana d'amore, soli, dovunque, ma fuori di qui.
Giorgio disse:
—Ti ricordi, l'anno scorso, il primo anniversario?
—Mi ricordo.
—Era di Pasqua, la Domenica di Pasqua...
—Io venni da te, la mattina, alle dieci...
—Tu avevi la piccola giacca inglese che mi piaceva tanto; avevi teco il libro delle preghiere...
—Non andai alla messa, quella mattina!...
—Avevi però tanta fretta...
—Ero quasi fuggita di casa. Tu sai: di festa, non mi lasciavano mai sola. Eppure, rimasi con te fino a mezzogiorno. E avevamo gente a colazione, quella mattina!...
—Dopo, in tutto il giorno, non ci vedemmo più! Fu un anniversario malinconico...
—È vero.
—E che sole!
—E tutti quei tuoi fiori, nella stanza...
—Ero uscito di casa io stesso, per tempo; avevo comprata l'intera piazza di Spagna...
—Mi gettasti addosso una quantità di rose sfogliate, mi mettesti tante foglie nel collo, dentro le maniche... Ti ricordi?
—Mi ricordo.
—Poi a casa, quando mi spogliai, le ritrovai tutte...
Ella sorrise.
—E mio marito, quando rientrai, scoperse una foglia sul mio cappellino, in una piega del merletto!
—Me lo dicesti.
—Non uscii più di casa, quel giorno; non volli più uscire. Ripensai, ripensai... Sì, fu un anniversario malinconico.
Poi, dopo un intervallo di silenzio pensoso:
—Credevi tu, in cuor tuo, che saremmo giunti al secondo?
—Io, no.
—Io, neppure.
Giorgio pensò: «Ecco l'amore, che ha in sé il presentimento della sua fine!» Pensò anche al ricordato marito, senza odio; anzi con una specie di benevolenza compassionevole. «Ella ora è libera. Ma perché io sono ora più inquieto che allora? Quel marito era per me come un'assicurazione. Mi pareva ch'egli custodisse la mia amante contro ogni pericolo. Forse m'illudo. Io soffrivo molto, anche allora. Ma la sofferenza passata par sempre men dura della presente.» Seguendo il suo pensiero, egli non ascoltava le parole d'Ippolita.
Ella diceva:
—Dunque, dove andremo? Bisogna decidere. Domani è il primo d'aprile. Io ho già detto a mia madre: «Sai, mamma; uno di questi giorni vado via.» La sto preparando. Le inventerò qualche favola credibile. Lascia fare.
Ella parlava lieta; sorrideva. Ed egli credè scoprire in quel sorriso, onde s'illustravano le ultime parole, la spontanea compiacenza che la donna prova nell'ordire un qualunque inganno. Gli spiacque la facilità con cui ella poteva ingannare la madre. Ripensò ancóra, con un senso di rimpianto, la vigilanza del marito. «Perché io soffro tanto, di questa sua libertà che pure è al servigio del mio piacere? Non so che darei per sottrarmi al mio pensiero fisso, al mio timore che la offende. Io l'amo e la offendo; l'amo e la credo capace di un'azione bassa!»
—Bisogna però—ella diceva—bisogna che non andiamo troppo lontano. Non conosci tu un luogo tranquillo, solitario, pieno di alberi, un poco strano? Tivoli, no; Frascati, no.
—Prendi il Baedeker, là sul tavolo; e cerca.
—Cerchiamo insieme.
Ella prese il libro rosso; si mise in ginocchio accanto alla poltrona dov'egli era seduto; e incominciò a sfogliare, con gesti graziati, d'una grazia infantile. Leggeva a quando a quando un brano a voce bassa.
Egli la guardava, attratto dalla finezza della nuca; d'onde si rialzavano verso la sommità della testa i capelli attorti come in una voluta, neri e lucidi. Guardava i due piccoli nei bruni, i gemelli, che stavano l'uno accanto all'altro sul collo pallido, vellutato, a cui davano una attrattiva di più. Notò ch'ella non portava orecchini. Da tre o quattro giorni non portava i soliti orecchini di zaffiro. «Li ha sacrificati forse a un'angustia familiare? Nella sua casa, ella è forse angustiata da dure necessità quotidiane.» Egli guardò in faccia il suo pensiero fisso, con una specie di violenza interiore. Era questo. «Quando sarà stanca di me (e sarà tra breve), ella cadrà nelle mani di qualcuno che le offrirà una esistenza facile, che la toglierà dalle strettezze domestiche, in cambio di piacere. Costui potrà anche essere il mercante di cui parlava l'Exili. Pel disgusto delle piccole miserie, ella vincerà il nuovo disgusto. Si adatterà. Forse anche non dovrà vincere alcuna ripugnanza, perché l'offerente le sarà gradito.»
Gli venne alla memoria l'amante di un amico, la contessa Albertini. Costei, divisa dal marito, rimasta libera in condizioni disgraziate, era discesa a poco a poco negli amori remunerativi salvando con garbo le apparenze. Un altro esempio gli venne alla memoria, avvalorando la possibilità temuta. E, d'innanzi alla chiara possibilità che emergeva dall'avvenire oscuro, egli provò un dolore ineffabile.—I suoi timori non dovevano aver tregua. Egli doveva, o prima o poi, veder cadere la creatura che aveva innalzato. Di simili degradazioni era piena la vita.
Ella diceva, quasi lamentandosi:
—Io qui non trovo nulla. Gubbio, Narni, Viterbo, Orvieto... Ecco qui la pianta di Orvieto: monastero di San Pietro, monastero di San Paolo, monastero del Gesù, monastero di San Bernardino, monastero di San Ludovico; convento di San Domenico, convento di San Francesco, convento dei Servi di Maria...
Ella leggeva con una specie di cantilena, come se recitasse una litania. D'un tratto, si mise a ridere, rovesciando il capo, offrendo la bella fronte alle labbra dell'amante. Era ella in uno di que' suoi momenti di bontà espansiva, che la facevano sembrare una fanciulla.
—Quanti monasteri! Quanti conventi! Deve essere un paese strano. Vuoi che andiamo a Orvieto?
Parve a Giorgio di ricevere sul cuore un'ondata improvvisa di freschezza. Egli si abbandonò, con riconoscenza, a quella consolazione. Come premeva le labbra su la fronte d'Ippolita, ivi colse il ricordo della deserta città guelfa che tace adorando il suo bel Duomo.
—Orvieto! Non ci sei mai stata? Figùrati, in cima a una roccia di tufo, sopra una valle malinconica, una città silenziosa tanto che pare disabitata:—finestre chiuse; vicoli grigi dove cresce l'erba; un cappuccino che attraversa una piazza; un vescovo che scende da una carrozza fermata d'innanzi a un ospedale, tutta nera, con un servo decrepito allo sportello; una torre in un cielo bianco, piovigginoso; un orologio che suona le ore lentamente; d'un tratto, in fondo a una via, un miracolo: il Duomo.
Ippolita disse, un po' sognando, quasi avesse dentro gli occhi la visione della città silenziosa:
—Che pace!
—Io la vidi di febbraio, con un tempo come questo d'oggi, incerto: un po' di pioggia, un po' di sole. Ci rimasi un giorno; partii con tristezza; portai meco la nostalgia di quella pace... Oh che pace! Ero in compagnia di me stesso; pensavo: «Avere un'amante, o più tosto una sorella amante, che fosse piena di divozione; e venire qui, restare qui un lungo mese, il mese di aprile: un aprile un po' piovigginoso, cinerino, ma tiepido, con qualche sprazzo di sole. E passare molte ore dentro la cattedrale, d'innanzi, d'intorno; andare a cogliere le rose negli orti dei conventi; andare a prendere dalle monache le confetture; bere l'Est Est Est in una tazzetta etrusca; amare e dormire molto, in un letto soffice, tutto velato di bianco, verginale...»
Ippolita sorrise a quel sogno, felice. Ella disse, con un'aria di candore:
—Io sono divota. Conducimi a Orvieto!
Ella si raccolse tutta ai piedi dell'amato; gli prese le mani, invasa da una immensa dolcezza, pregustando già quella quiete, quell'ozio, quella malinconia.
—Parlamene ancóra.
Egli la baciò su la fronte, a lungo, con una commozione pura. Poi la guardò, a lungo.
—Hai la fronte tanto bella—disse, con un tremito leggero.
Vedeva ora Ippolita vivente corrispondere all'ideal figura di lei, ch'egli nutriva nel cuore. La vedeva buona, tenera, sommessa, respirante in una nobile e dolce poesia. Come nel motto ch'egli le aveva dato, ella era grave e soave:—gravis dum suavis.
—Parlami!—ella mormorò.
Dal balcone entrava una luce modesta. Di tratto in tratto i vetri mettevano un tintinno debole o le gocce della pioggia facevano un sordo crepitìo.
IV
«Poiché nel sogno abbiamo già assaporata la miglior parte del piacere, provando sensazioni e sentimenti della più rara delicatezza, io penso che noi dobbiamo rinunziare all'esperimento della realtà. Non andremo ad Orvieto.» E Giorgio scelse un altro luogo: Albano Laziale.
Egli non conosceva Albano, non l'Ariccia, non il lago di Nemi. Ippolita era stata ad Albano nella sua infanzia, in casa di una zia che ora non viveva più. Egli dunque avrebbe trovato in quei luoghi il fascino dell'ignoto; Ippolita, un riflesso delle lontane memorie. «Uno spettacolo nuovo di bellezza par quasi rinnovellare e purificare un amore. Le memorie dell'età vergine esalano su lo spirito un profumo sempre fresco e benefico.»
Stabilirono di partire il due di aprile, col treno del tocco. Si trovarono alla stazione, per l'ora stabilita, tra la folla, provando entrambi in fondo al cuore una gioia ansiosa.
—Ci vedranno? Di': ci vedranno?—domandava Ippolita, un po' ridente, un po' trepidante, poiché le pareva di sentire sopra di sé tutti gli sguardi.—Quanto tempo ci vuole ancóra alla partenza? Dio mio, come tremo!
Speravano di occupare nel treno uno scompartimento vuoto; ma con molto dispiacere dovettero rassegnarsi ad aver tre compagni di viaggio. Giorgio salutò un signore e una signora.
—Chi sono?—chiese Ippolita chinandosi all'orecchio dell'amico.
—Poi, ti dirò.
Ella esaminò la coppia curiosamente. Il signore era un vecchio, con una lunga barba venerabile e con un vasto cranio calvo, giallastro, su cui vedevasi una cavità profonda, una specie di ombelico enorme e difforme, simile al segno che può lasciare un grosso dito premuto in una materia molle. La signora, avvolta in uno scialle persiano, mostrava all'ombra d'una specie di tegola un viso emaciato, meditabondo; e nel suo abbigliamento e nella sua espressione ricordava la caricatura inglese d'una blue-stocking. Gli occhi del vecchio, cerulei, avevano però una vivacità singolare; parevano illuminati da una fiamma interiore, come gli occhi di un entusiasta. Inoltre, egli aveva risposto al saluto di Giorgio Aurispa con un sorriso dolcissimo.
Ippolita cercava nella sua memoria. In qual luogo aveva ella incontrata quella coppia? Non riusciva ad afferrare il ricordo; ma sentiva oscuramente che le due strane figure senili entravano in un ricordo del suo amore.
—Dimmi: chi sono?—ripeté all'orecchio dell'amico.
—I Martlet: mister Martlet con la moglie. Ci portano fortuna. Sai dove erano?
—Non so; ma io li devo aver veduti in qualche posto.
—Erano nella cappella di via Belsiana, il due di aprile, quando io ti conobbi...
—Ah, sì, sì; ricordo!
Le raggiarono gli occhi. Il caso le parve mirabile. Ella guardò di nuovo i due vecchi, quasi intenerita.
—Che buon augurio!
Appoggiò il capo e si mise a ripensare, invasa da una malinconia deliziosa. Rivide la piccola chiesa nella via Belsiana, segreta, immersa in una penombra turchiniccia:—un coro di fanciulle coronava la tribuna ch'era simile a un verone ricurvo; sotto, alcuni sonatori di strumenti ad arco stavano in piedi davanti ai leggii d'abete bianco; intorno intorno, su gli stalli di quercia stavano seduti i pochi uditori, quasi tutti canuti o calvi; il maestro batteva il tempo; un pio profumo d'incenso svanito e di violette si mescolava alla musica di Sebastiano Bach.
Ma, vinta dalla soavità del ricordo, ella si piegò di nuovo verso l'amico, mormorando:
—Ripensi anche tu?
Ella avrebbe voluto comunicargli la sua commozione, dimostrargli di non aver dimenticato neppure le più minute particolarità di quell'avvenimento solenne. Egli, con un atto furtivo, le prese una mano tra le pieghe ampie del mantello da viaggio e la tenne stretta. Ambedue provarono dentro di loro un brividìo che somigliava a certe delicate sensazioni dei primissimi tempi. E rimasero così, pensosi, un poco estatici, un poco intorpiditi nel tepore, cullati dal moto eguale e continuo del treno, intravedendo talvolta per i vetri un paesaggio verdastro nella nebbia. Il cielo s'era coperto; pioveva. Mister Martlet sonnecchiava in un angolo; mistress Martlet leggeva una rivista, il Lyceum. L'altro viaggiatore, con un berretto sugli occhi, dormiva profondo.
«Mister Martlet portava la battuta con veemenza, insieme al maestro, se il coro perdeva la misura. Tutti quei vecchi, a un certo punto, portavano la battuta, come invasi dalla follia della musica. C'era nell'aria un profumo d'incenso svanito e di violette.» Giorgio s'abbandonava intieramente al gorgo ritroso delle memorie. «Avrei potuto io imaginare pel mio amore un preludio più strano e più poetico? Pare il ricordo d'una qualche lettura fantastica; ed è invece un ricordo della mia vita reale. Ho d'innanzi agli occhi dell'anima le più minute particolarità. La poesia di quel cominciamento ha poi sparso su tutto il mio amore un'ombra di sogno.» Tenuto dalla lieve torpidezza, egli indugiava su certe imagini vaghe che prendevano nel suo spirito quasi un fascino musicale. «Qualche granello d'incenso... un mazzolino di violette...»
—Guarda come dorme mister Martlet—gli disse piano Ippolita.—Calmo come un bambino.
Poi soggiunse, sorridendo:
—Anche tu hai un po' di sonno; è vero? Piove sempre. Che sarà questo languore? Mi pesano le palpebre.
Ed ella lo guardò con gli occhi socchiusi, di tra i cigli lunghissimi.
«Come sùbito mi piacquero i suoi cigli!» pensava Giorgio. «Ella stava nel mezzo della cappella seduta su una sedia con una spalliera alta. Il suo profilo si disegnava sul chiarore piovente dalla finestra. Quando le nuvole di fuori si diradarono, il chiarore si fece d'improvviso più vivo. Ella si mosse un poco; e m'apparve nella luce tutta la lunghezza dei suoi cigli: una lunghezza portentosa!»
—Di': ci vorrà ancóra molto tempo per arrivare?—chiese Ippolita.
Il fischio del vapore annunziava una stazione prossima.
—Vuoi scommettere—soggiunse ella—che siamo passati oltre?
—Oh, no!
—Bene: infórmati.
—Segni-Paliano,—gridava una voce rauca, lungo gli sportelli.
Giorgio s'affacciò, un po' trasognato.
—Albano?—chiese.
—No, signore: Segni-Paliano,—rispose l'uomo sorridendo.—Va ad Albano? Doveva scendere alla Cecchina, signore.
Ippolita si mise a ridere così forte che mister e mistress Martlet la guardarono stupefatti. L'ilarità di lei si propagò sùbito all'amante.
—Che fare?
—Prima di tutto, bisogna scendere.
Giorgio porse all'uomo le valige; mentre Ippolita rideva ancóra, d'un suo fresco e vivace riso, affrontando gaiamente l'avventura imprevista. Mister Martlet pareva ricevere in mezzo al petto con lieta benignità quell'ondata di giovinezza, come un'ondata di sole. Egli s'inchinò ad Ippolita, che nel discendere provava in fondo al cuore un vago rammarico.
—Povero mister Martlet!—ella disse con un tono tra di gioco e di gravità, guardando il treno allontanarsi per la campagna deserta e squallida.—Mi dispiace di lasciarlo. Chi sa se lo rivedrò!
Poi volgendosi a Giorgio:
—E ora?
Un uomo della stazione avvertì:
—Passa un treno alle quattro e mezzo, per la Cecchina.
—Meno male!—riprese a dire Ippolita.—Sono le due e mezzo. Dichiaro però che da questo momento assumo io l'alta direzione del viaggio. Tu ti lascerai condurre. Tieniti bene stretto a me, Giorgino. Bada di non ti perdere!
Ella gli parlava come a un fanciullo, per gioco. Ambedue si sentivano allegri.
—Dov'è Segni? Dov'è Paliano?
Non si scorgevano intorno paesi. Le colline basse apparivano tutte ignude, dubbiamente verdeggianti, sotto un ciel grigio. Un solo alberello, smilzo e torto, presso al binario, si dondolava nell'umidità.
Come piovigginava, i due smarriti si rifugiarono dentro la stazione, in una piccola stanza dov'èra anche un caminetto, ma spento. Su una parete pendeva a brandelli una vecchia carta geografica solcata di linee nere; su un'altra parete pendeva un cartone quadrato recante l'elogio di un elixir. Di fronte al caminetto, omai immemore de' fuochi, era un canapè ricoperto di tela incerata; il quale versava da molte ferite la sua anima di stoppa.
—Guarda,—esclamò Ippolita, leggendo nel Baedeker—a Segni c'è la Locanda di Gaetanino!
Questa denominazione la fece ridere.
—Perché non fumiamo una sigaretta?—disse Giorgio.—Sono le tre. A quest'ora, due anni fa, io stavo per entrare nella cappella...
Di nuovo, il ricordo della gran giornata li occupò. Fumarono per qualche minuto in silenzio, ascoltando la pioggia che rinforzava. A traverso i vetri appannati, vedevano il meschino alberello torcersi sotto la sferza.
—Il mio amore è più antico del tuo—disse Giorgio.—Era già nato, prima di quel giorno.
Ella protestò.
—Ti vedo ancóra passare, la prima volta—egli soggiunse, con un'aria dolce, attratto dal profondo fascino dei giorni irrevocabilmente lontani.—Che impressione incancellabile! Era verso sera, quando incominciano ad apparire i lumi, quando cade su le vie tutto quell'azzurro... Io stavo, solo, innanzi alle vetrine dell'Alinari; guardavo le figure ma le vedevo appena: in uno stato indefinibile, un po' stanco, molto triste, con non so qual bisogno vago d'idealità fluttuante sul disgusto... Non te l'ho mai detto? Uscivo allora da una casa... È strano questo: come l'anima, dopo le peggiori cadute, tenda all'alto. Quella sera io avevo una gran sete di poesia, di elevazione, di cose delicate e spirituali. Un presentimento?
Egli fece una pausa lunga; ma Ippolita non parlò, aspettando ch'egli seguitasse, provando un piacere squisito ad ascoltarlo, in mezzo al fumo leggero della sigaretta, che quasi pareva mettere un velo di più sul ricordo velato.
—Era di febbraio. Nota: appunto in quei giorni ero stato ad Orvieto. Credo anzi che in quei momento io stessi là, dall'Alinari, con l'intenzione di chiedere una fotografia del reliquiario. E tu passasti! Due o tre altre volte, di poi, due o tre altre volte soltanto ti ho veduta così pallida, di quello speciale pallore. Tu non puoi imaginarti, Ippolita, com'eri pallida. Non mi è mai riuscito di trovare una similitudine. Pensai: «Questa donna, come cammina? Non deve avere nelle vene neppure una goccia di sangue.» Era un pallore soprannaturale, che ti faceva sembrare una creatura incorporea in mezzo a tutto quell'azzurro che cadeva dal cielo sul lastrico. Non guardai l'uomo che ti accompagnava; non ti volli seguire; non ebbi da te neppure l'accenno di uno sguardo. Ricordo anche questa particolarità: a poca distanza, tu ti soffermasti perché un accenditore di fanali ingombrava il marciapiede. Guarda: vedo ancóra luccicare nell'aria la fiammella in cima alla pertica e accendersi d'un tratto il fanale illuminandoti.
Ippolita sorrise, ma con un poco di malinconia; con quella specie di malinconia che assale una donna quando ella guarda un suo ritratto d'altri tempi.
—Già, ero pallida—ella disse.—Mi ero levata dal letto poche settimane innanzi, dopo una malattia di tre mesi. Avevo veduta la morte.
Uno scroscio di pioggia violento si rovesciò su la vetrata. Si vedeva l'alberello agitarsi con un moto quasi circolare, come sotto lo sforzo di una mano che volesse sradicarlo. Ambedue rimasero qualche minuto a guardare quella furiosa agitazione che assumeva una strana apparenza di vita consciente, nello squallore, nella nudità, nella supina inerzia della campagna. Ippolita provò quasi un senso di misericordia. Quella imaginata sofferenza dell'albero li metteva in conspetto della lor propria pena. Essi considerarono mentalmente la gran solitudine che si stendeva di fuori intorno quel misero edifizio, innanzi a cui passava di tanto in tanto un treno pieno di viaggiatori diversi, de' quali ciascuno portava in cuore una diversa ansietà. Le imagini tristi si succedevano nello spirito dei due amanti, rapide, suggerite da quelle cose medesime ch'essi avevano dianzi guardate con lieti occhi. E, quando le imagini si diradarono e la conscienza senza più seguirle si ripiegò su sé stessa, ambedue trovarono in fondo una sola ineffabile angoscia: il rimpianto dei giorni irrimediabilmente perduti.
Il loro amore aveva dietro di sé un lungo passato; trascinava dietro di sé, nel tempo, una immensa rete oscura, tutta piena di cose morte.
—Che hai?—chiese Ippolita, con la voce un poco alterata.
—E tu, che hai?—chiese Giorgio, fissandola.
Nessuno dei due rispose alla domanda. Tacquero, e guardarono di nuovo a traverso i vetri. Parve che il cielo avesse come un sorriso lacrimoso. Un bagliore fievole attinse una collina, la sparse d'una doratura leggerissima, si spense. Altri bagliori si accesero, languirono.
—Ippolita Sanzio—disse Giorgio, pronunziando quel nome con lentezza, come per assaporarlo.—Che palpito ebbi quando seppi finalmente che ti chiamavi così! Quante cose vidi e sentii nel tuo nome! Si chiamava così una mia sorella, morta. Il bel nome mi era familiare. Sùbito pensai, con una commozione profonda: «Se le mie labbra dovessero riprendere la cara consuetudine!» Per tutto quel giorno, le memorie della morta si mescolarono delicatamente al mio sogno segreto. Io non ti cercai, non ti perseguitai, non volli essere mai importuno; ma avevo dentro di me una fede inesplicabile, la sicurezza che tu, o prima o poi, mi avresti conosciuto e mi avresti amato. Che sensazioni deliziose! Vivevo fuori della realtà; nutrivo il mio spirito di musica e di letture esaltanti. Ti vidi, in fatti, un giorno a un concerto di Giovanni Sgambati; ma non ti vidi se non quando tu stavi per uscire dalla sala. Mi guardasti. Un'altra volta anche mi guardasti (forse te ne ricordi): quando c'incontrammo sul principio del Babuino, proprio davanti la libreria Piale.
—Me ne ricordo.
—Avevi teco una bambina.
—Sì: la Cecilia, una mia nipote.
—Io mi fermai sul marciapiede, per lasciarti passare. Notai che avevamo tutt'e due la stessa altezza. Eri meno pallida del solito. Mi balenò un pensiero orgoglioso...
—Indovinavi.
—Ti ricordi? Fu verso gli ultimi di marzo. La mia aspettazione si faceva sempre più sicura. Vivevo di giorno in giorno pensando al grande amore che doveva venire. Come ti avevo veduta due volte con un mazzolino di violette, empivo di violette la mia casa. Ah, io non dimenticherò mai quel principio di primavera! Certi sonni mattutini, nel mio letto, leggerissimi, trasparenti, pieni di sogni quasi volontarii! Certi risvegli lenti, dubbiosi, che mi aprivano gli occhi alla luce, mentre il mio spirito stentava a riacquistare il senso della realtà! Mi ricordo che alcuni artifizi puerili bastavano a darmi una specie di ebrezza illusoria. Mi ricordo che un giorno, in un concerto del Quintetto, ascoltando una musica del Beethoven piena di una frase grandiosa e appassionata che tornava a intervalli, mi esaltai sino alla follia col ripetere dentro di me una frase poetica in cui era il tuo nome.
Ippolita gli sorrise; ma, udendolo parlare di quella primissima apparizione dell'amore con tanta preferenza, ella provava in fondo all'anima un rincrescimento. Pareva forse a lui quello il tempo più dolce? Erano quelle forse per lui le memorie più dilette?
—Tutto il mio disdegno della vita comune—seguitò Giorgio—non mi avrebbe però mai fatto sognare un asilo fantastico e misterioso come l'Oratorio abbandonato nella via Belsiana. Ti ricordi? La porta su la via, in cima ai gradini, era chiusa: chiusa forse da anni. Si passava di lato, per un chiassetto che odorava di vino: c'era l'insegna rossa d'un vinaio, e una gran frasca. S'entrava, di dietro, per una sagrestia, ti ricordi?, che poteva appena contenere un prete e un sagrestano. S'entrava nella sede della Sapienza... Ah, tutti quei vecchi e quelle vecchie intorno intorno, negli stalli tarlati! Dov'era andato a cercare il suo uditorio Alessandro Memmi? Tu forse non sapevi di rappresentare la Bellezza in un concilio di filosofi musicomani, amor mio. Quel Martlet, vedi, mister Martlet, è uno tra i più convinti buddhisti dei nostri giorni; e la moglie ha scritto un libro su la Filosofia della Musica. La signora seduta accanto a te era Margherita Traube Boll, una medichessa celebre, continuatrice degli studi del marito (il defunto Boll) su la funzione della vista. Quel negromante che entrò in punta di piedi, con una gran palandrana verdognola, era il dottor Fleichl, un ebreo, un medico tedesco, pianista eccellente, fanatico del Bach. Il prete seduto sotto la croce era il conte Castracane, un botanico immortale. Un altro botanico, un batteriologo, un microscopista insigne, il Cuboni, gli stava di fronte. E c'era Jacopo Moleschott, il sommo fisiologo, quel vecchio indimenticabile: candido, enorme; c'era il Blaserna, il collaboratore dell'Helmholtz nella teoria dei suoni; c'era mister Davis, un filosofo pittore, un prerafaelita sprofondato nel brahmanesimo... Altri pochi c'erano: tutti intelletti singolari, spiriti rari, dediti alle più alte speculazioni della scienza moderna, freddi esploratori della vita, che hanno il culto appassionato del sogno.
Egli s'interruppe, riproducendo entro di sé lo spettacolo:—I sapienti ascoltavano la musica con un entusiasmo religioso; alcuni prendevano un'attitudine ispirata, altri imitavano inconsciamente col gesto il gesto del maestro, altri univano la loro voce sommessa alla voce del coro. Il coro, maschile e feminile, occupava la tribuna di legno dipinto, ove rimaneva appena qualche resto di doratura. Le fanciulle si aggruppavano sul davanti, tenendo le carte levate all'altezza della faccia. Sotto di loro ardevano le candele sui leggii rozzi dei violinisti, gialle nella mezza ombra azzurrognola. Qualche fiammella si rifletteva nella cassa levigata d'uno strumento, metteva un punto luminoso in cima a un archetto. Alessandro Memmi, un po' rigido, calvo, dalla corta barba nera, dagli occhiali d'oro, diritto innanzi alla sua orchestra, batteva il tempo con un gesto severo e sobrio. Alla fine d'ogni canto, si levava nella cappella un mormorio; dalla tribuna giungeva qualche riso mal represso tra un fruscìo di quaderni sfogliati. Schiarendosi fuori a intervalli il cielo, le candele impallidivano. Una croce smisurata, ch'era comparsa nelle antiche processioni solenni, tutta adorna di ramoscelli e d'olive d'oro, emergeva dalla parete illuminandosi. La canizie e la calvizie dell'uditorio rilucevano su le spalliere di quercia. D'improvviso, per una vicenda del cielo, l'ombra spiegavasi di nuovo su le cose, pari a un vapore tenue. Qualche debole onda d'effluvio (incenso? belzuino?), appena percettibile, vagava nell'aria. Due mazzi di violette, un poco appassiti, in vasi di vetro, su l'unico altare, esalavano il fiato della primavera. E i due profumi morenti parevano essere come la poesia de' sogni che la musica suscitava dalle anime senili; mentre un ben altro sogno, da ben altre anime, aprivasi tra quelli simile a un'aurora tra nevi che si sciolgano.—
Egli così, curiosamente, ricostruiva la scena; la riscaldava con un soffio lirico.
—Non pare inverosimile, incredibile?—esclamò.—A Roma, nella città dell'inerzia intellettuale, un maestro di musica, un buddhista, che ha publicato due volumi di saggi su la filosofia dello Schopenhauer, si dà il lusso di far eseguire una messa di Sebastiano Bach, unicamente pel piacer suo, in una cappella misteriosa, d'innanzi a un uditorio di grandi scienziati musicomani che hanno le loro figliuole nel coro. Non è una pagina dell'Hoffmann? In un pomeriggio di primavera un po' grigio ma tiepido, i vecchi filosofi escono dai loro laboratorii dove hanno lottato a lungo per strappare un segreto alla vita, e si raccolgono in un Oratorio occulto, per inebriarsi d'una passione che accomuna i loro cuori, per sollevarsi fuori della vita, per vivere idealmente in un sogno. E in mezzo alla vecchiezza, un delicato idillio musicale si svolge tra la cugina del buddhista e l'amico del buddhista, idealmente. E alla fine della messa il buddhista inconsapevole presenta alla divina Ippolita Sanzio l'amante futuro!
Egli rise, levandosi.
—Ho fatto, mi pare, una commemorazione in tutte le regole.
Ippolita rimase ancóra un poco assorta. Poi disse:
—Ti ricordi? Era un sabato: la vigilia della Domenica delle Palme.
Anch'ella si levò; e andò a baciare Giorgio su una gota.
—Vuoi che usciamo? Non piove più.
Uscirono e si misero a passeggiare sul selciato umido che riluceva a un sole fioco. L'aria fredda li punse. D'intorno, le collinette digradanti verdeggiavano solcate di strisce chiarissime; qua e là, i larghi pantani riflettevano pallidamente il cielo dove l'azzurro si dilatava tra i nuvoli fioccuti. L'alberello stillante aveva di tratto in tratto un luccichìo.
—L'alberello rimarrà nei nostri ricordi—disse Ippolita, fermandosi a guardarlo.—Solo solo!
Una campanella annunziò alfine l'approssimarsi del treno. Erano le quattro e un quarto. Un uomo del servizio si offrì per andare a prendere i biglietti.
—Verso che ora saremo ad Albano?—domandò Giorgio.
—Verso le sette.
—Sarà già buio,—disse Ippolita, prendendo il braccio di Giorgio, un po' infreddolita. E si compiacque nel pensiero di giungere all'albergo sconosciuto, in una sera fredda, e di pranzare sola con lui davanti a un camino acceso.
Sentendola tremare, Giorgio domandò:
—Vuoi che rientriamo?
—No—ella rispose.—Non vedi che c'è il sole? Camminiamo forte, su e giù. Mi riscalderò.
Ella si strinse al braccio di lui, mossa da un inesprimibile bisogno d'intimità. Divenne d'improvviso carezzevole, lusinghevole, in tutto: nella voce, nello sguardo, nel contatto, in ogni suo moto. Ella voleva espandere il suo più segreto fascino feminino e inebriarne l'amato; voleva far brillare agli occhi di lui una luce di felicità presente che oscurasse il riflesso della felicità lontana; voleva sembrare a lui più amabile, più adorabile, più desiderabile d'una volta. Una paura l'assalse, atroce, ch'egli potesse rimpiangere la donna d'una volta, sospirare le dolcezze trascorse, credere di aver raggiunto il sommo dell'ebrezza soltanto allora. Pensava: «I suoi ricordi mi hanno empita l'anima di malinconia. A stento ho trattenuto le lacrime. Anch'egli, forse, dentro di sé è triste; chi sa com'è triste! Tanto dunque il passato pesa all'amore?» Pensava: «Egli forse è stanco di me. Egli forse non lo sa, non lo confessa neanche a sé medesimo; s'illude. Ma forse non può più prendere da me nessuna gioia, e forse mi tiene cara soltanto perché trova in me i motivi delle sue care afflizioni. Ma anch'io rari momenti ho di vera gioia, accanto a lui; anch'io soffro; eppure l'amo, ed amo la mia sofferenza, e non ho altro desiderio se non di piacergli, e non concepisco la vita senza questo amore. Perché dunque, amandoci, siamo tristi?» Ella si appoggiava forte al braccio dell'amato e lo guardava con occhi in cui l'ombra dei pensieri dava alla tenerezza un'espressione più profonda.
«Due anni fa, su quest'ora, uscivamo insieme dalla cappella; ed egli mi parlava di cose estranee all'amore, con una voce che mi toccava l'anima, che mi posava su l'anima la carezza delle labbra, una carezza tutta ideale e pure assaporata da me come un lento bacio. Io tremavo, d'un tremito incessante, sentendo nascere dentro di me un sentimento ignorato. L'ora fu divina. Oggi cade il secondo anniversario; e noi ci amiamo. Dianzi egli parlava, e la sua voce mi turbava in una maniera diversa ma pur sempre a dentro. Abbiamo d'innanzi a noi una sera deliziosa. Perché rimpiangere il giorno lontano? La nostra libertà, la nostra intimità presente non valgono le incertezze e le esitazioni di quel tempo? Gli stessi ricordi numerosi non aggiungono un fascino di più alla nostra passione? Io l'amo; io mi do a lui tutta quanta, non ho d'innanzi al suo desiderio nessun pudore. Io ho ora il gusto profondo della voluttà; ed egli me l'ha dato, egli solo, ed io l'ho per lui. In due anni egli mi ha trasformata, mi ha fatta un'altra; mi ha dato nuovi sensi, un'anima nuova, un nuovo intelletto. Io sono la sua creatura. Egli può inebriarsi di me, come d'un suo pensiero. Io gli appartengo tutta quanta, ora e sempre.» Ella gli chiese, stringendosi forte a lui, appassionatamente:
—Non sei felice?
Turbato dal suono di quella domanda, investito come da un soffio caldo improvviso, egli ebbe un brivido vero di felicità. Rispose:
—Tanto felice!
E udirono, con un palpito concorde, il fischio del vapore.
Nello scompartimento si trovarono soli; chiusero tutti i vetri; aspettarono che il treno si movesse; si abbracciarono, si baciarono, si ripeterono tutti i nomi carezzevoli che la loro tenerezza in due anni aveva usati. Poi rimasero seduti l'uno accanto all'altra, con un sorriso vago su le labbra e negli occhi, sentendo il moto rapido del loro sangue a poco a poco rallentare. Guardarono a traverso i vetri fuggire un paesaggio monotono in una nebbietta appena appena colorita di viola.
Disse Ippolita:
—Metti la testa qui, su le mie ginocchia, e distenditi.
Giorgio mise la testa su le ginocchia di lei; si distese.
Ella disse:
—Il vento ti ha un po' sciupate le labbra.
E con le dita gli tolse di su la bocca alcuni fili dei baffi leggeri. Egli le baciò le dita. Ella gli solcò i capelli. Disse:
—Anche tu hai le ciglia molto lunghe.
Gli chiuse gli occhi, per ammirarle. Poi gli accarezzò la fronte, le tempie; si fece baciare di nuovo le dita, a una a una, con la testa china verso di lui. Ed egli, dal basso, vedeva la bocca di lei aprirsi con infinita lentezza e dal fondo sorgere il calice niveo dei denti. Ella la richiudeva: e ancóra, lentamente, lentamente, le labbra si schiudevano, come un fiore di due petali; e sorgeva dal fondo il candore perlato.
Ambedue, in quella blandizia, languivano; felici, obliosi. Il romore monotono li cullava. Si scambiarono, piano, parole di adorazione.
Ella disse, sorridendo:
—Questo è il primo viaggio che facciamo insieme; e questa è la prima volta che ci troviamo soli, in treno.
Ella si compiaceva di confermare che facevano una cosa nuova. Un desiderio, che già aveva tentato Giorgio, balenò più forte in lui. Egli si sollevò; la baciò sul collo, proprio su i gemelli; le mormorò nell'orecchio qualche parola. Per gli occhi di lei passò un bagliore indefinibile; ma ella disse vivacemente:
—No, no. Bisogna che noi siamo savi, fino a stasera; bisogna che aspettiamo. Sarà poi tanto dolce...
Di nuovo, ella vide un albergo silenzioso, una stanza con suppellettili antiquate, con un gran letto coperto d'un zanzariere bianco.
—Ad Albano, in questo mese, non ci sarà quasi nessuno—disse, per distrarre l'amante.—Come staremo bene, soli soli, in un albergo deserto! Ci prenderanno per due sposi novelli.
Si raccolse nel suo mantello, rabbrividendo; si piegò contro la spalla di Giorgio.
—Fa freddo, oggi; è vero? Appena giunti, accenderemo un gran fuoco e prenderemo una tazza di tè.
Provarono ambedue un acuto piacere ad imaginare la prossima delizia. Parlavano sottovoce, comunicandosi il calore del sangue e delle promesse. Ma, come parlavano della voluttà futura, il desiderio presente diveniva più forte; diveniva omai insostenibile. Tacquero. Congiunsero le bocche, non udendo più altro romore se non quello delle loro vene agitate, invasi da una brama cieca e violenta.
—Vuoi?—chiese Giorgio, d'improvviso, lasciandosi cadere in ginocchio.
Ella non rispose, ma si abbandonò.
Parve, di poi, ad entrambi, che un velo si dileguasse di su gli occhi loro, che un vapore accolto entro di loro si disperdesse, che un incanto si rompesse. Il fuoco nel camino della stanza imaginata si spense; il letto prese un aspetto gelido; il silenzio dell'albergo deserto divenne grave. Ippolita disse, quasi umiliata di aver ceduto a un impeto selvaggio che nulla forse aveva di comune con l'amore:
—Perché abbiamo fatto questo?
Ella aveva la voce triste ma dolce. Appoggiò il capo alla spalliera e guardò il vasto paesaggio monotono allontanarsi nell'ombra.
Ma Giorgio, accanto a lei, era caduto in balìa de' suoi pensieri perfidi. Una orribile visione lo torturava; a cui egli non poteva sfuggire, perché la vedeva con gli occhi dell'anima, con quegli occhi senza palpebre, che nessuna volontà può serrare.
—A che pensi?—gli chiese Ippolita, con inquietudine.
—A te.
Egli pensava a lei, al viaggio di nozze, all'uso comune dei novelli sposi. «Ella si trovò certo sola con suo marito, una volta, come ora è con me. Ella forse patì nel treno, durante il viaggio, la prima violazione. Ella forse, dianzi, si ricordava del fatto odioso, quando ha risposto così vivamente:—No, no.—Quel ricordo le dà ora, forse, tanta tristezza!» Ed egli pensò anche alle avventure rapide fra una stazione e l'altra, ai turbamenti repentini cagionati da uno sguardo, alle sorprese della sensualità, nei lunghi pomeriggi afosi d'estate, sotto le gallerie favorevoli... «Orrore! Orrore!» Ebbe un sussulto, quel particolare sussulto che Ippolita conosceva pur troppo come un sicuro indizio del male da cui l'amato era afflitto. Ella gli domandò, prendendogli la mano:
—Tu soffri?
Egli accennò di sì col capo; la guardò con un sorriso doloroso. Ma ella non ebbe il coraggio d'interrogarlo più oltre, poiché temeva che egli rispondesse qualche parola amara e straziante. Preferì il silenzio; ma lo baciò su la fronte a lungo, come soleva, sperando sciogliere il duro nodo dei pensieri.
—Ecco la Cecchina!—esclamò, sollevata, udendo il fischio dell'arrivo.—Su, su, amore! Bisogna scendere.
Ella si mostrava allegra, per rallegrarlo. Abbassò un vetro, sporse il capo.
—È una sera fredda ma bella. Su, amore! È l'anniversario. Bisogna che siamo felici.
Egli scosse da sé le cattive cose, al suono di quella voce tenera e forte. Uscendo all'aria viva, si sentì rasserenato.
Una serenità quasi adamantina s'incurvava su la campagna sazia di acque. Ancóra nell'aria diafana erravano atomi di luce crepuscolare. Le stelle si accendevano a una a una, successivamente, come su rami di lampadari pensili invisibili che ondeggiassero.
«Bisogna che siamo felici!» Giorgio riudiva entro di sé le parole dell'amica; e il cuore gli si gonfiava di aspirazioni indefinite. E la stanza tranquilla e il camino acceso e il letto bianco gli parevano troppo umili elementi di felicità in quella notte solenne e pura. «È l'anniversario. Bisogna che siamo felici.» Che pensava, che faceva egli, due anni avanti, su quell'ora?—Vagava per le vie, senza una mèta, spinto da un bisogno istintivo di raggiungere uno spazio più largo e pure attratto dai luoghi popolosi dove il suo orgoglio e la sua gioia gli parevano grandeggiare al contrasto della vita comune. E il romore cittadino, pure avvolgendolo, gli arrivava all'orecchio come di lontano.
V
Il vecchio albergo di Ludovico Togni, con quel suo lungo androne dalle pareti di stucco marmorizzate e con que' suoi pianerottoli dalle porte verdigne tutti illustrati di lapidi commemorative, inspirava sùbito un senso di pace quasi conventuale. Ogni suppellettile aveva un aspetto di familiare vecchiezza. I letti, le sedie, le poltrone, i canapè, i canterani avevano forme d'altri tempi, cadute in disuso; i soffitti, dipinti a colori teneri, gialletti o celestini, portavano nel centro una ghirlanda di rose o un qualche simbolo usuale, come una lira, una face, un turcasso; i fiorami su i parati di carta e su i tappeti di lana erano impalliditi, quasi scomparsi; le tende di velo alle finestre pendevano da bastoni sdorati, candide e modeste; gli specchi rococò, riflettendo le antichette imagini in un'appannatura diffusa, davano ad esse quell'aria di malinconia e quasi d'inesistenza, che talvolta dànno alle rive gli stagni solinghi.
—Come mi piace di star qui!—diceva Ippolita, penetrata dal mite incanto delle cose, raccogliendosi nella gran poltrona soffice, appoggiando il capo alla spalliera, dov'era cucita una mezzaluna bianca, di cotone, umile opera d'uncinetto.—Non mi vorrei più muovere.
Ella ripensò la defunta zia Giovanna, l'infanzia lontana.
—La povera zia, mi ricordo, aveva una casa come questa, una casa dove da un secolo i mobili stavano al medesimo posto. Mi ricordo sempre le sue disperazioni quando le ruppi una di quelle campane di vetro, tu sai, con dentro i fiori artificiali... Mi ricordo che pianse. Povera vecchia! La vedo ancóra, con quelle sue cuffie di merletto nero, con que' suoi buccolotti bianchi giù per le tempie...
Ella parlava piano, interrompendosi, guardando il fuoco ardere su gli alari, sorridendo talvolta a Giorgio con occhi un poco abbattuti, cerchiati d'un'ombra violetta; mentre dalla strada saliva un romore eguale e continuo che facevano certi selciatori battendo le selci.
—Nella casa c'era, mi ricordo, una gran soffitta con due o tre abbaini, abitata dai colombi. Ci si saliva per una piccola scala ripida, dove su le pareti pendevano, chi sa da quanto, certe pelli di lepre con tutto il pelo, secche, tese da due pezzi di canna messi in croce. Io portavo ogni giorno il mangiare ai colombi. Appena mi sentivano salire, si affollavano davanti alla porta. Com'entravo, mi assaltavano. Allora io mi sedevo per terra e spargevo l'orzo intorno intorno. I colombi mi circondavano; erano tutti bianchi; e io li guardavo beccare. Da una casa vicina giungeva il suono d'un flauto: sempre la stessa arietta, alla stessa ora. Quella musica mi pareva deliziosa. Ascoltavo, con la testa levata verso l'abbaino, a bocca aperta, come per bere le note che piovevano. Di tratto in tratto, rientrava un colombo sperso, battendomi le ali sul capo, mettendomi nei capelli qualche piuma. E il flauto invisibile sonava, sonava... Ho ancóra nell'orecchio l'arietta; la potrei cantarellare. La passione della musica mi cominciò in quel tempo, dentro una colombaia...
Ella ripeteva mentalmente la sonata dell'antico flauto albanese, gustandone il sapore dolcigno con una malinconia simile in parte a quella della sposa che dopo molti anni ritrova in fondo al suo cassone di nozze un confetto dimenticato. Successe un intervallo di silenzio. Un campanello sonò in un corridoio dell'albergo pacifico.
—Girava per le stanze, mi ricordo, una tortora zoppa, una delle grandi tenerezze di mia zia. Un giorno venne su a giocare con me una bambina del vicinato, una bella bambina bionda, che si chiamava Clarice. La zia era a letto, con la tosse. Noi giocavamo su una terrazza, devastando i vasi dei garofani. La tortora apparve su la soglia, ci guardò senza sospetto, si fermò in un angolo a godere il sole. Clarice, appena la vide, le corse sopra per afferrarla. La povera bestiola tentava di sfuggire, zoppicando; ma zoppicava in un modo così strano che noi cominciammo a ridere per non finir più. Clarice la raggiunse: era una bambina crudele. Pel troppo ridere, eravamo tutt'e due come ubriache. La tortora, sbigottita, si dibatteva nelle nostre mani. Clarice le strappò una penna; poi (ora che ci ripenso, rabbrividisco) poi la spennò quasi tutta, davanti a me, ridendo, facendomi ridere, come ubriaca. La povera bestiola, spennata, insanguinata, quando fu libera, si salvò dentro la casa. Noi la seguimmo per un tratto. Poco dopo, udimmo scampanellare, e la zia che gridava e tossiva dal suo letto... Clarice infilò sùbito le scale; io mi nascosi dietro a una tenda. La tortora morì, la sera stessa. La zia mi rimandò a Roma, credendomi colpevole dello strazio; e pur troppo non la rividi più. Quanto piansi! Il rimorso mi dura ancóra.
Ella parlava piano, interrompendosi, guardando con occhi fissi e un poco dilatati il fuoco splendido che pareva quasi magnetizzarla, darle come un principio di torpore ipnotico; mentre dalla strada saliva il remore eguale e continuo che facevano i selciatori battendo le selci.
VI
Un giorno gli amanti tornarono dal lago di Nemi, un po' stanchi. Avevano fatto colazione nella Villa Cesarini, sotto le pompose camelie fiorite. Soli, col sentimento di chi solo contempla la più segreta delle segrete cose, avevano contemplato lo Specchio di Diana freddo e impenetrabile alla vista come un ghiaccio azzurro.
Ordinarono il tè consueto. Ippolita, che cercava qualche oggetto in una sua valigia, si volse d'un tratto a Giorgio mostrandogli un plico legato da un nastro.
—Vedi? Le tue lettere... Le porto sempre con me.
Giorgio esclamò con visibile compiacenza:
—Tutte? Le hai conservate tutte?
—Sì, tutte. Ho anche i biglietti, anche i telegrammi. Manca un biglietto solo, quello che gettai nel fuoco perché non cadesse nelle mani di mio marito. Ma conservo i pezzi bruciati: qualche parola è ancóra leggibile.
—Mi lasci vedere?—domandò Giorgio.
Ella celò con un atto geloso il plico. Poi, come Giorgio si avanzava verso di lei sorridendo, ella fuggì nella stanza attigua.
—No, no; tu non vedrai niente. Non voglio.
Si opponeva un po' per gioco e un po' anche perché, avendo sempre custodite gelosamente quelle lettere come un tesoro occulto, con orgoglio e con timore, ella insino le mostrava mal volentieri a colui che le aveva scritte.
—Lasciami vedere, ti prego! Sono tanto curioso di rileggere le mie lettere di due anni fa. Che ti scrivevo?
—Cose di fuoco.
—Ti prego! Lasciami vedere.
Ella alfine consentì, ridendo alle persuadevoli carezze dell'amante.
—Ebbene, aspettiamo che venga il tè; e poi le vedremo insieme. Vuoi che accendiamo il caminetto?
—No; oggi è una giornata quasi calda.
Era una giornata bianca, soffusa come d'un riverbero argentino, in un'aria inerte. Il candore diurno diveniva anche più mite passando a traverso il velo delle tende. Le violette fresche, còlte nella Villa Cesarini, già avevano profumata tutta la stanza.
—Ecco Pancrazio—disse Ippolita, sentendo battere all'uscio.
Il buon servo Pancrazio portava il suo sorriso inestinguibile e il suo tè inesauribile. Posò il vassoio sul tavolo; promise pel pranzo della sera una primizia; ed uscì, con un passo alacre e saltellante. Egli era calvo, ma conservava ancóra un'aria giovanile; era straordinariamente servizievole; ed aveva, come certe divinità giapponesi, gli occhi ridarelli, lunghi, stretti e un poco obliqui.
Giorgio disse:
—Pancrazio è più esilarante del suo tè.
Il tè, infatti, non aveva aroma; assumeva però un sapore strano dagli accessorii. Il vaso e le tazze erano di una capacità e di una forma non mai vedute; il vassoio era illustrato d'una amorosa istorietta pastorale; il piatto contenente le fette sottili di limone recava nel mezzo a caratteri neri un indovinello.
Ippolita versò la bevanda: le tazze fumigarono come turiboli. Quindi ella sciolse il plico: le lettere apparvero tutte ordinate, divise in tanti fasci minori.
—Quante!—esclamò Giorgio.
—Non poi tante! Sono duecento novanta quattro. E due anni, mio caro, si compongono di settecento trenta giorni.
Sorrisero entrambi. Si posero l'uno accanto all'altra, seduti, contro il tavolo; e incominciarono la lettura. Invadeva Giorgio una commozione singolare, dinanzi a quei documenti del suo amore: una commozione delicata e forte. Le prime lettere misero nel suo spirito uno scompiglio. Certi stati dell'animo estremi, che quelle lettere rivelavano, gli parvero da principio incomprensibili. L'elevazione lirica di certe frasi lo empì quasi di stupore. La violenza e il tumulto della passione giovine gli diedero una specie di sbigottimento, in mezzo alla quiete che ora lo circondava, in quell'albergo modesto e silenzioso. Una lettera diceva: «Quante volte il mio cuore ha sospirato verso di te, questa notte! Un'angoscia oscura mi premeva, anche nei brevi intervalli di sonno; ed io aprivo gli occhi per fuggire i fantasmi che si levavano dal profondo dell'anima mia.... Un solo pensiero mi tiene, un solo pensiero mi tortura:—che tu possa andar lontano. Mai mai una tal possibilità mi ha dato un terrore e un dolore più folli. Io ho, in questo momento, la certezza precisa, chiarissima, evidente, che senza di te è impossibile la mia vita. Se penso che tu non ci sei, ecco, il giorno si oscura, la luce mi diventa nemica, la terra mi appare come una tomba senza fondo:—io entro nella morte.» Un'altra lettera, scritta dopo la partenza di Ippolita, diceva: «Faccio uno sforzo immane per reggere la penna. Non ho più vigore alcuno, non ho più volontà. Mi tiene un abbattimento così scorato ch'io non ho altro senso della vita all'infuori d'una insopportabile nausea di vivere. Ed è una giornata grigia, afosa, plumbea, una giornata quasi direi omicida. Le ore passano con una lentezza inesorabile; e la mia miseria si accumula, ad ogni minuto, più squallida e più arida. Mi par d'avere in fondo a me non so quali acque morte e venefiche. Ed è questa una sofferenza morale o fisica? Non so. Io rimango ottuso ed immobile, sotto un peso che mi schiaccia senza farmi morire.» Un'altra diceva: «Ho infine ricevuta la tua lettera, oggi, alle quattro, mentre disperavo. E l'ho letta molte volte, cercando tra le parole l'Indicibile, quel che tu non hai potuto esprimere, il segreto dell'anima tua—qualche cosa che fosse più viva e più dolce delle parole scritte su la carta inanimata... Ho un terribile desiderio di te. Cerco su la carta la traccia della tua mano, del tuo alito, del tuo sguardo—inutilmente. Non so che darei per avere almeno un'illusione della tua presenza. Mandami un fiore lungamente baciato, segnami su la carta un cerchio dove tu abbia premuto lungamente la bocca, fa che io possieda nell'imaginazione una carezza tua inviatami di lontano... Di lontano! Di lontano! Quanto tempo è ch'io non ti bacio, ch'io non ti tengo fra le braccia, ch'io non ti vedo impallidire? È un anno? È un secolo? Dove sei tu andata? Oltre quali terre? Oltre quali mari?... Passo le ore nell'inerzia, pensando. Questa mia stanza è diventata funebre come una cappella sotterranea. Talvolta io mi vedo disteso in una bara; io mi contemplo nella immobilità della morte, con una lucidezza imperturbabile. Esco dalla contemplazione quietato.» Questi gridi e questi gemiti mandavano le lettere, sul tavolo coperto d'un tappeto casalingo; mentre le ampie tazze rustiche, piene di un'infusione innocente, fumigavano in pace.
—Ti ricordi?—disse Ippolita.—Fu quando io partii la prima volta da Roma, per soli quindici giorni.
Giorgio era assorto, appunto nel ricordo di tutte quelle agitazioni insensate; cercava di risuscitarle in sé, di comprenderle. Ma il benessere ambiente non era favorevole a quello sforzo interiore. Un senso di benessere gli avvolgeva lo spirito come in una fascia molle. La luce velata, la bevanda calda, il profumo delle mammole, il contatto d'Ippolita lo intorpidivano. Egli pensò: «Sono io dunque così lontano dall'ardore di quel tempo? No; perché, ultimamente quando ella è partita, io non me ne sono afflitto con minor crudezza.» Ma non gli riusciva di ravvicinare l'io di quel tempo all'io presente. Egli sentiva pur sempre di rimanere estraneo all'uomo che si disperava e si accorava in quelle frasi scritte; sentiva che quelle emanazioni del suo amore non gli appartenevano più e sentiva anche tutta la vacuità delle parole. Quelle lettere erano come epitaffii in un cimitero. Come gli epitaffii dànno un'idea grossolana e falsa delle persone morte, così quelle lettere mal rappresentavano i diversi stati pe' quali l'animo dell'amante era passato. Egli conosceva bene lo straordinario orgasmo che invade l'amante nell'atto di scrivere una lettera d'amore. All'urto di quell'orgasmo, tutte le diverse onde del sentimento si mescolano e s'intorbidano levando un bollore confuso. Non avendo l'amante la conscienza precisa di ciò ch'egli vuole esprimere, constretto nella materiale angustia delle parole, egli rinunzia alla descrizione del suo vero tumulto interno ma cerca di raggiungere una intensità approssimativa esagerando la frase, adoperando i comuni effetti retorici. Per questo appunto tutti gli epistolarii d'amore si somigliano; per questo appunto il linguaggio della più alta passione è poco più vario d'un gergo.
Giorgio pensava: «Qui tutto è violenza, spasimo, eccesso. Ma dove sono le mie delicatezze? Dove sono le mie malinconie squisite e complicate, certe afflizioni profonde e tortuose in cui l'anima si perdeva come in labirinti inestricabili?» Egli vedeva ora con rammarico che nelle sue lettere mancava la parte più rara del suo spirito, quella ch'egli aveva sempre coltivata con maggior cura. A poco a poco, andando innanzi nel leggere, egli trascurava i lunghi brani di pura eloquenza e ricercava le indicazioni dei piccoli fatti, le particolarità degli avvenimenti, gli accenni degli episodii memorabili.
In una lettera trovò: «Verso le dieci, macchinalmente, entrai nel solito luogo, nel giardino Morteo, dove ti avevo veduta per tante sere. Quegli ultimi trentacinque minuti, avanti l'ora precisa della tua partenza, furono atrocissimi. Tu partivi, tu partivi, senza ch'io ti potessi vedere, coprirti di baci la faccia, ripeterti un'ultima volta: Ricòrdati! Ricòrdati! ...—Verso le undici, come per istinto io mi voltai. Entrava tuo marito con la signora solita e con l'amico. Venivano dall'averti accompagnata, senza dubbio. Mi prese una convulsione di dolore così forte che dovetti alzarmi dopo poco ed uscire. La presenza di quelle tre persone che parlavano e ridevano come nelle altre sere, come se nulla di nuovo fosse accaduto, mi esasperava. Esse rappresentavano, d'innanzi a me, la certezza che tu eri partita, partita irremissibilmente.»
Egli ripensò quelle sere di estate, quando vedeva Ippolita seduta a un tavolo, tra il marito e un capitano di fanteria, di fronte a una piccola signora goffa. Egli non conosceva nessuna delle tre persone; e soffriva d'ogni loro gesto, d'ogni loro attitudine, di tutta la loro volgarità esterna; e imaginava la stupidità dei loro discorsi a cui la creatura elegante pareva prestare un'attenzione continua.
In un'altra lettera trovò: «Dubito. Ho contro di te oggi l'animo ostile. Sono pieno d'un'ira compressa. Uscirò fra poco e andrò in mare. Le onde sono allegre e forti. Addio. Non ti scrivo di più, per non dirti cose durissime. Addio. Mi ami tu? O scrivi ancóra parole d'amore per abitudine pietosa? Sei tu leale? Che pensi? Che fai? Io soffro. Ho il diritto d'interrogarti così. Dubito, dubito, dubito. Sono demente.»
—Questa—disse Ippolita—è del tempo ch'io ero a Rimini. Agosto e settembre, che mesi tempestosi! E quando tu finalmente venisti col Don Juan?
—Ecco una lettera di bordo. «Siamo giunti ad Ancona oggi alle due, venendo a vela da Porto San Giorgio. Per le tue preghiere e per i tuoi augurii, abbiamo avuto propizio il vento. Meravigliosa navigazione, che ti racconterò. All'alba, riprenderemo il largo. Il Don Juan è il re dei cutters. La tua bandiera sventola sull'albero. Addio, forse a domani!—2 settembre.—»
—Ci rivedemmo; ma che giorni di supplizio! Ti ricordi? Avevamo sempre testimonii vigilanti. Oh quella mia cognata! Ti ricordi la visita al Tempio malatestiano? E il pellegrinaggio alla chiesa di San Giuliano, la sera prima che tu partissi?
—Ecco una lettera di Venezia...
Lessero ambedue, con un palpito concorde: «Sono a Venezia dal 9, plus triste que jamais. Venezia mi soffoca. Nessun più lucido sogno può uguagliare in magnificenza questo che si leva dal mare e che fiorisce nel cielo chimericamente. Muoio di malinconia e di desiderio. Perché non sei qui? Se tu fossi venuta, seguendo il proponimento d'una volta! Forse avremmo potuto strappare un'ora ad ogni vigilanza; e tra i nostri ricordi innumerevoli sarebbe anche questo, il più divino...» Lessero ancóra, in un'altra pagina: «Ho un pensiero strano che mi balena di tratto in tratto e mi turba nel profondo: un pensiero folle, un sogno. Penso che tu potresti giungere d'improvviso a Venezia, sola, per essere tutta mia!» E più oltre, ancóra: «La bellezza di Venezia è il naturale quadro della tua bellezza. Il tuo colore, quel colore così ricco e possente, tutto materiato d'ambra pallida e d'oro opaco e forse di qualche rosa un po' disfatta, è il colore ideale che più felicemente armonizza con l'aria veneziana. Io non so come fosse Caterina Cornaro regina di Cipro; ma, non so perché, imagino che dovesse rassomigliarti.—Ieri passai appunto sul Canalazzo, d'innanzi al magnifico palagio della regina di Cipro; ed esalai la mia poesia. Non abitasti un tempo tu in quella casa regale e non t'inchinasti fuor del balcone prezioso a guardare nell'acqua i giochi del sole?—Addio, Ippolita. Io non posseggo un palagio di marmo sul Canal Grande, degno della tua sovranità; né tu sei arbitra de' tuoi fati...» E più oltre, ancóra: «Qui c'è tutta la gloria di Paolo Veronese. Un Veronese mi ricordava dianzi il nostro pellegrinaggio in Rimini alla chiesa di San Giuliano.—Eravamo assai tristi quella sera. Uscendo dalla chiesa, ci dilungammo nella campagna, per la riva del fiume, verso quel grande gruppo di alberi lontani. Rammenti? Fu l'ultima volta che ci vedemmo e ci parlammo. L'ultima volta!—E se tu giungessi d'improvviso a Venezia, da Vignola?»
—Vedi: era una seduzione continua, raffinata, irresistibile—disse Ippolita.—Tu non puoi imaginare le mie torture. Non dormivo la notte, per studiare un modo di partir sola, senza mettere in sospetto i miei ospiti. Feci un miracolo d'abilità. Non so più come feci... Quando mi ritrovai sola, con te, nella gondola, sul Canalazzo, in quell'alba di settembre, non credevo alla realtà. Ti ricordi? Mi prese un impeto di pianto e non potei dirti una parola...
—Ma io t'aspettavo. Io ero sicuro che tu saresti venuta, a qualunque costo.
—E fu la prima grande imprudenza!
—È vero.
—Che importa? Non è meglio così? Non è meglio ch'io sia ora tutta tua? Io non mi pento di nessuna cosa.
Giorgio la baciò su la tempia. Parlarono a lungo di quell'episodio ch'era nella loro memoria uno de' più belli e de' più straordinarii. Rivissero di minuto in minuto i due giorni di vita segreta, nell'albergo Danieli, i due giorni d'oblìo, di suprema ebrezza, in cui parevano entrambi avere smarrito ogni nozione del mondo e quasi ogni conscienza del loro essere anteriore.
Quei giorni avevano segnato il principio della disgrazia d'Ippolita. Le lettere seguenti accennavano alle prime sofferenze di lei. «Quando penso che la causa prima dei tuoi dolori e dei fastidii tuoi familiari sono io, mi punge un rammarico indicibile; e vorrei che tu conoscessi tutta, tutta la mia passione, per farmi perdonare il danno.—La conosci tu? Sei tu certa che il mio amore valga il tuo lungo dolore? Ne sei tu certa, sicura, profondamente consapevole?» Di pagina in pagina l'ardore cresceva. Poi succedeva un lungo intervallo oscuro, dall'aprile al luglio, senza documenti. E in quei mesi appunto erasi compiuta la rovina. Il marito debole, non avendo saputo in alcun modo vincere l'aperta e ostinata ribellione d'Ippolita, era quasi fuggito lasciando dietro di sé un gravissimo intrico di affari in cui era rimasta presa la massima parte della sua fortuna. Ippolita s'era rifugiata in casa della madre e quindi a Caronno, dalla sorella, in una villeggiatura. Un terribile male, già da lei sofferto nell'infanzia, un male nervoso che aveva le forme dell'epilessia, era di nuovo apparso. Le lettere, con la data di agosto, ne parlavano. «Tu non imaginerai giammai lo sbigottimento ch'io ho nello spirito. La mia tortura maggiore è questa implacabile lucidezza della visione fantastica. Io ti vedo contorcerti, nell'accesso; io vedo i tuoi lineamenti scomporsi e illividirsi, i tuoi occhi volgersi disperatamente sotto le palpebre rosse di pianto... Io vedo tutta la terribilità del male, come s'io ti fossi vicino; e, per quanti sforzi io faccia, non riesco a scacciare l'orrida visione. E poi, mi sento chiamare. Ho proprio negli orecchi il suono della tua voce, un suono roco e lamentevole, come di chi chiede aiuto e non ha speranza di aiuto.» E tre giorni dopo: «Duro fatica a scriverti queste righe. Vorrei rimanere immobile, in silenzio, là nell'angolo, nell'ombra, a pensare, ad evocare la tua imagine, ad evocare il tuo male, a vederti. Provo non so quale attrazione irresistibile verso questa tortura volontaria...—Oh povero, povero amore mio! Mi sento così triste che vorrei perdere il senso dell'essere, per molto tempo, e poi svegliarmi e non ricordarmi più di nulla e non più soffrire. Vorrei, almeno, avere un acuto spasimo fisico, una ferita, una piaga, una bruciatura profonda, qualche cosa che mi alleviasse l'implacabile tormento dello spirito.—Mio Dio! Vedo le tue mani pallide e convulse; e vedo tra le dita la ciocca dei capelli strappati...»
E più oltre: «Tu mi scrivi:—Se questo male mi prendesse fra le tue braccia? No, no; io non ti vedrò più, non voglio più vederti!—Eri demente quando scrivevi? Hai tu pensato a quello che scrivevi? Mi pare che tu mi abbia presa la vita e ch'io non possa più dare un respiro. Riscrivimi sùbito! Dimmi che guarirai, che non disperi, che vuoi rivedermi. Tu devi guarire. Intendi, Ippolita? Tu devi guarire.» Più oltre, ancóra: «Questa notte la luna era coperta. Andavamo per la marina, io e un amico. Io dissi:—Che notte sconsolata!—L'amico rispose:—Sì, la notte non è bella.—E si fermò. Un cane uggiolava in lontananza. Come potrò ridirti l'impressione lugubre che mi fecero le parole dell'amico?—Non è bella!—Che accadeva lontano? Tu che facevi? Quale sventura si preparava, nella notte? Poi, fino all'alba, gli uccelli notturni hanno cantato. Altre volte non ci badavo. Questa volta ogni grido mi penetrava nel cuore, con uno strazio insopportabile.»... «Tu disperi, senza ragione. Ieri passai gran parte della giornata intorno a un trattato su le malattie nervose, per conoscere il tuo male. Tu guarirai, certamente. Io credo anzi che tu non avrai altri assalti e che la tua convalescenza proseguirà senza interruzioni fino alla guarigione perfetta. Sollevati!—Hai sentito questa notte il mio pensiero continuo? Era una notte malinconica, un po' velata, piena di canti religiosi. Su la strada maestra, fra le siepi e gli alberi, passavano i pellegrini, cantando in coro una cantilena lunga e monotona...»
Le lettere si facevano dolci e delicate verso la convalescente. «Ti mando un fiore, còlto su l'arena. È una specie di giglio selvaggio, bellissimo quando è vivo, e così profumato che spesso nel calice io trovo qualche insetto tramortito di ebrezza. Tutta la spiaggia intorno è piena di questi gigli appassionati che sbocciano in un attimo e durano poche ore, al sole torrido, su la sabbia ardente. Anche morto, guarda com'è spirituale questo fiore! Com'è fino e feminino!» Più oltre: «Stamani, al primo svegliarmi, guardavo il mio corpo arso dal sole. Da tutto il busto mi cadeva l'epidermide, ma specialmente di su la spalla, nel luogo dove tu posavi la testa. Con le dita strappavo piano piano i brani della pelle, e pensavo che forse in quei brani omai morti era ancóra il segno della tua guancia e della tua bocca. Ho perduta la prima spoglia, come un serpente. Quanta voluttà quella spoglia ha contenuto!» Più oltre: «Ti scrivo ancóra dal letto. La febbre m'è passata, lasciandomi una nevralgia su l'occhio sinistro, acutissima. Mi sento anche molto debole perché da tre giorni non prendo cibo. Ripenso tante tante cose, affondato nel letto, con il capo dolente. Qualche volta, d'un tratto, senza ragione, mi sento mordere dal dubbio; e devo far grandi sforzi per cacciare i pensieri cattivi. Anche ieri pensai a te, tutto il giorno. La mia sorella maggiore, Cristina, mi stava accanto e mi asciugava la fronte, con una infinita dolcezza. Io chiudevo gli occhi e m'imaginavo che quella mano fosse la tua; e provavo un sollievo ineffabile; e mormoravo in cuor mio il tuo nome. Poi guardavo mia sorella, con un sorriso di riconoscenza. E quel momentaneo scambio imaginario della sua e della tua carezza mi pareva assai puro e casto e spirituale. Non so esprimerti con le parole la delicatezza, la squisitezza, la estrema idealità di quel sentimento. Ma tu comprendi. Ave.» Più oltre: «Sono triste, ancóra, sempre. Ho i sensi così acuiti che odo cadere a una a una sul tavolo le foglie di alcune rose—ultime—donatemi da mia sorella. Cadono—soavi come pensieri del tuo capo. E per le finestre spalancate giungono le risa delle donne e i gridi dei fanciulli che si bagnano nel mare.»
Le lettere seguitavano, fino ai primi giorni di novembre; ma a poco a poco diventavano amare, torbide, piene di sospetti, di dubbii, di accuse. «Come ti sei allontanata da me! Non è soltanto il sentimento della lontananza materiale, che mi tortura. Mi pare che anche l'anima tua si distacchi da me e mi abbandoni...—Il tuo profumo fa felici gli altri. Chi ti guarda, chi ti ode, gioisce di te...—Scrivimi e dimmi che sei tutta mia in ogni tuo atto e in ogni tuo pensiero, e che mi desideri e che mi rimpiangi, e che non trovi bello nessun momento, lontana da me.» Più oltre: «Io penso, penso, penso, acutamente; e l'acutezza del pensiero mi dà uno spasimo inumano. Provo, talvolta, una smania furibonda di strapparmi dalle tempie dolenti questa cosa impalpabile che pure è più forte e più inflessibile di un aculeo. Il respiro m'è una fatica insopportabile, e il bàttito delle vene m'è fastidioso come il rimbombo d'un martello ch'io sia condannato ad ascoltare...—Questo è l'amore? Oh no. È una sorta di prodigiosa infermità che fiorisce soltanto nel mio essere, facendo la mia gioia e la mia pena. Mi piace di credere che sia questo un sentimento non mai provato da alcun'altra creatura umana.» Più oltre: «Io non avrò mai mai mai la pace intera e l'intera sicurtà. Io non potrei esser pago se non a un sol patto:—assorbendo tutto tutto il tuo essere e divenendo con te un essere unico, vivendo della tua vita, pensando i tuoi pensieri. Vorrei almeno che i tuoi sensi fossero chiusi a qualunque sensazione che non ti venisse da me...—Sono un povero infermo. Tutta la mia giornata è una lunga agonia. Poche volte ho desiderata una fine, come ora la desidero e l'invoco. Ecco, sta per tramontare il sole; e la notte scende nel mio spirito con mille orrori. L'ombra viene dagli angoli della stanza verso di me, quasi con un passo e con un fiato di persona viva, e quasi con un'attitudine ostile...—Ho sul tavolino molte rose. Le ho còlte su gli ultimi rosai. Hanno un colore un poco smorto e anche un odore un poco smorto; ma le amo così. Mi sembrano nate in un cimitero dove sieno sepolti a coppie gli amanti d'un tempo assai remoto.» Più oltre: «Ieri mattina, tra le undici e il tocco, meditai gravemente su la mia fine. Lo spirito familiare del mio povero zio Demetrio da qualche giorno m'inquieta. Ieri il mio stato era così inumano che spontaneamente s'offerse al mio spirito l'imagine della liberazione. Poi la crisi passò. Ora ne sorrido, un poco; ma ebbi un colloquio con la Morte assai fiero.»
Le lettere datate da Roma, dove Giorgio su i primi di novembre era tornato per aspettare il ritorno d'Ippolita, accennavano a un episodio molto doloroso e molto oscuro. «Tu mi scrivi:—Io ti son rimasta fedele a gran pena.—Che intendi di dire? Quali sono le terribili vicende che ti hanno sconvolta? Dio mio, come sei mutata! Ne soffro inesprimibilmente; e il mio orgoglio si adira contro la sofferenza. Ho una ruga tra ciglio e ciglio, profondissima, come una cicatrice. Vi è raccolta un'ira repressa; vi è raccolta tutta l'amarezza de' miei dubbii, de' miei sospetti, de' miei disgusti. Credo che neppure il tuo bacio basterebbe a mandarla via. Le tue lettere piene di desiderio mi turbano. Io non te ne sono grato. Da due o tre giorni ho contro di te qualche cosa, nel cuore. Non so che sia. Forse un presentimento? Forse una divinazione?»
Giorgio soffriva, leggendo, come se dentro gli si fosse riaperta una piaga. Ippolita avrebbe voluto impedirgli d'andare oltre. Ella si ricordava di quella sera in cui il marito era apparso d'improvviso nella casa di Caronno, tranquillo e freddo nei modi ma con lo sguardo d'un folle, dicendole d'essere venuto per ricondurla seco; e si ricordava del momento in cui erano rimasti soli, l'una di fronte all'altro, in una stanza un po' remota, mentre il vento agitava le tende della finestra, e il lume oscillava forte, e giungeva lo stormire degli alberi sottostanti. Si ricordava della lotta selvaggia e silenziosa sostenuta allora contro quell'uomo che l'aveva abbracciata con un movimento repentino, oh ribrezzo! volendola possedere.
—Basta, basta, Giorgio!—ella disse, attirando a sé la testa dell'amato.—Non leggiamo più.
Ma egli volle seguitare. «Ancóra non comprendo. Non comprendo la riapparizione di quell'uomo; e non so difendermi da un sentimento iroso che va, in parte, anche contro di te. Per non tormentarti, non ti scrivo in proposito i miei pensieri. Sono acerbi e oscurissimi. Sento che, per qualche tempo, la mia tenerezza è avvelenata. Credo sia meglio che tu non mi riveda. Non tornare ora, se vuoi evitare a te medesima un dolore inutile. Io non sono buono ora. L'anima mia ti ama e ti si prostra, e il pensiero ti morde e ti macchia. E il contrasto ricomincia sempre, non finirà mai!» Nella lettera del giorno dopo: «Un dolore, un dolore atroce, insostenibile, non mai provato... O Ippolita, ritorna, ritorna! Voglio vederti, parlarti, accarezzarti. Ti amo come non mai... Risparmiami però la vista delle tue lividure. Io non so pensarci senza raccapriccio e senza collera. Mi pare che, se vedessi la tua carne macchiata da quelle mani, mi si spezzerebbe il cuore... Orribile! Orribile!»
—Basta, Giorgio. Non leggiamo più—supplicò di nuovo Ippolita, prendendo fra le sue palme la testa dell'amato, baciandolo su gli occhi.—Giorgio, ti prego!
Ella riuscì ad allontanarlo dal tavolo. Egli sorrideva, lasciandosi trarre; sorrideva di quel sorriso indefinibile che hanno certi malati quando si piegano alla volontà altrui, pur sapendo bene che il rimedio è tardo e vano.
VII
La sera del venerdì santo ripartirono per Roma. Prima di partire, verso le cinque, presero il tè. Erano taciturni. La vita semplice vissuta in quell'albergo apparve loro, nel momento che stava per finire, straordinariamente bella e desiderabile. L'intimità di quelle stanze modeste apparve loro più dolce e più profonda. I luoghi, per ove essi avevano portato le loro malinconie e le loro tenerezze, apparvero in una luce ideale. Ancóra un frammento del loro amore e del loro essere cadeva nell'abisso del tempo, distrutto.
Giorgio disse:
—Anche questo è passato.
Ippolita disse:
—Come farò? Mi pare di non poter più dormire che sul tuo cuore.
Ambedue si guardarono negli occhi, si comunicarono la loro commozione, si sentirono dall'onda cresciuta chiudere la gola. Tacquero; ed ascoltarono il romore eguale e continuo che facevano i selciatori nella strada battendo le selci. Quel romore accorante aumentò la loro pena.
Giorgio disse, levandosi:
—È insopportabile.
Quegli urti cadenzati acuivano in lui il sentimento della fugacità del tempo, ch'egli aveva già così vivo; gli davano quella specie di terrore ansioso ch'egli aveva già altre volte esperimentato ascoltando le vibrazioni del pendolo. Eppure, il romore medesimo, nei giorni scorsi, non lo aveva cullato in un vago senso di benessere? Egli pensò: «Noi ci divideremo, fra due o tre ore. Io ricomincerò la mia vita solita, tutta fatta di piccole miserie. Sarò ripreso dal solito male, inevitabilmente. Io conosco poi le turbolenze che suscita in me la primavera. Soffrirò, senza tregua. E sento già che uno de' miei carnefici più accaniti sarà il pensiero confittomi nel capo da quell'Exili, l'altro dì. Se Ippolita volesse guarirmi, potrebbe? Forse, almeno in parte. Perché non verrebbe ella con me, in un luogo solitario, non per una settimana ma per lungo tempo? Ella è, nell'intimità, adorabile, piena di minute cure e di minute grazie. Più d'una volta ella m'è parsa una sorella, una sorella amante, gravis dum suavis, la creatura del mio sogno. Forse ella potrebbe guarirmi, con la sua presenza assidua; o almeno potrebbe alleggerire la mia vita.»
Egli chiese, fermandosi davanti a Ippolita, prendendole ambo le mani:
—Sei stata molto felice, in questi pochi giorni? Rispondimi.
Aveva la voce commossa e insinuante.
Ippolita rispose:
—Come non mai.
Giorgio le strinse forte le mani, poiché sentiva in quelle parole una sincerità profonda.
Soggiunse:
—Puoi tu seguitare a vivere come vivi?
Ippolita rispose:
—Non so; non vedo nulla innanzi a me. Tu sai che tutto è caduto.
Ella abbassò gli occhi. Giorgio la prese fra le sue braccia, appassionatamente.
—Tu mi ami; è vero? Io sono per te l'unico scopo della tua esistenza; tu non vedi che me nel tuo avvenire...
Ella disse, con un sorriso impreveduto che le sollevò i lunghi cigli:
—Tu sai che è così.
Egli soggiunse, a voce bassa, chinando la faccia sul petto di lei:
—Tu sai il mio male.
Ella pareva avere indovinato il pensiero dell'amante. Domandò, quasi in segreto, quasi restringendo con la voce sommessa il cerchio ove insieme respiravano e palpitavano:
—Come ti potrei guarire?
Tacquero, avvinti. Ma nel silenzio le loro anime consideravano, risolvevano una medesima cosa.
—Vieni con me!—Giorgio interruppe.-Andiamo in un paese sconosciuto; restiamo là tutta la primavera, tutta l'estate, fin che potremo... E tu mi guarirai.
Ella non esitò. Disse:
—Eccomi. Io sono tua.
Si sciolsero, consolati. Prepararono l'ultima valigia, per partire. Ippolita raccolse tutti i suoi fiori, già appassiti nei bicchieri: le violette della Villa Cesarini, i ciclamini, gli anemoni e le pervinche del Parco Chigi, e le rose scempie di Castel Gandolfo, e anche un ramo di mandorlo, còlto in vicinanza dei Bagni di Diana, tornando dall'Emissario. Quei fiori potevano raccontare tutti gli idillii:—Oh la corsa folle giù per un pendìo ripido del parco, su le foglie secche dove i piedi affondavano sino alla caviglia! Ella gridava e rideva, sentendosi pungere le gambe dalle ortiche verdi, che trapassavano la calza sottile; e allora Giorgio, precedendola, abbatteva col bastone le piante pungenti che ella poi calpestava incolume. Verdissime le ortiche, innumerevoli, ornavano i Bagni di Diana, l'antro misterioso ove gli stillicidii erano musicali col favore degli echi. Ed ella dall'ombra umida guardava il campo esterno tutto coperto di mandorli e di peschi, rosei ed argentei, infinitamente delicati sul pallido indaco delle acque lacustri.—Ogni fiore, un'imagine.
—Guarda—ella disse mostrando a Giorgio una tessera—il biglietto di Segni-Paliano! Lo conservo.
Pancrazio batté all'uscio. Portava a Giorgio il conto saldato. Intenerito dalla generosità del signore, egli si profuse in ringraziamenti e in augurii. Giunse perfino a levarsi di tasca due biglietti di visita e ad offrirli «per memoria del suo povero nome», scusandosi dell'ardire. Come uscì, i due falsi sposi novelli si misero a ridere. Sul biglietto era scritto con un carattere pomposo:—Pancrazio Petrella.
Disse Ippolita:
—Conserveremo anche questo!
Pancrazio batté di nuovo all'uscio. Portava in dono quattro o cinque aranci alla signora, magnifici. Gli occhi gli brillavano in un viso rubicondo. Egli anche avvertì:
—È tempo di scendere.
Giù per le scale gli amanti furono ripresi dalla tristezza e quasi da un senso di timore, come se uscendo da quell'asilo di pace andassero incontro ad oscuri pericoli. Il vecchio albergatore li salutò su la porta, dicendo con rammarico:
—Avevo per questa sera certe belle lòdole!
Giorgio assicurò, con labbra convulse:
—Torneremo presto, torneremo presto.
Mentre scendevano alla stazione, il sole tramontava nel mare, all'estremo limite della pianura laziale, rossastro fra le caligini. Alla Cecchina, piovigginava. Roma, nella sera di venerdì santo umidiccia e nebbiosa, parve loro, quando si separarono, una città dove altro non si potesse che morire.