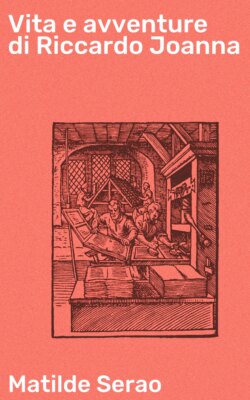Читать книгу Vita e avventure di Riccardo Joanna - Matilde Serao - Страница 4
I.
PICCOLO.
ОглавлениеPaolo Joanna andava e veniva per la stanza, vestendosi, straccamente, ancora tutto pieno di sonno. Sul suo letto disfatto stavano una quantità di giornali aperti e spiegazzati, cascavano dalla sponda, giacevano sul tappetino miserabile; erano quelli della sera innanzi, su cui si era addormentato, su cui si era arrotolato, dormendo: quelli della mattina, ancora chiusi dalle fascette multicolori, erano deposti sul vecchio tavolino da notte, accanto a una tazza da caffè — e attratte dal fondiccio melmoso del caffè, dove lo zucchero si liquefaceva, le mosche vi ronzavano attorno — e un sottile odore d'inchiostro di stamperia restava nell'aria. Paolo Joanna si vestiva pianamente, per non destare il suo figliuolo. In uno stretto lettuccio il piccolo Riccardo dormiva, con una manina sotto la guancia palliduccia, con le palpebre un po' ombrate di livido e socchiuse, con la fresca e rossa bocca schiusa: respirava leggermente, impercettibilmente. Aveva sul volto una espressione di stanchezza, e il corpicciuolo elegante, sottile, di fanciullo a sette anni, si allungava sotto il lenzuolo con una linea di abbattimento profondo: tanto che il padre voltandosi ogni tanto a guardare il suo bimbo, diventava sempre più cauto nei movimenti, per paura di svegliarlo. La notte prima, dopo il teatro, lo aveva condotto a cenare a una trattoria a Vico Rotto San Carlo, che resta aperta sino alla mattina: erano rientrati alle due: il bimbo, eccitato da un bicchierino di Marsala puro, non aveva preso sonno che alle quattro. Ora sembrava troppo felice di dormire, perchè il padre, preso dalla tenerezza, non camminasse in punta di piedi e rinunziasse a cercare, nel vecchio canterano, una cravatta meno vecchia di quella che portava. Ma una mosca si posò sul volto del piccolo Riccardo, e quel visino, dal pallore di perla, si scosse, come se il bimbo fosse lì lì per svegliarsi: il padre tremò. Una seconda mosca venne a ronzare intorno ai riccioli castagni del piccolo Riccardo, poi si posò sulla fronte: e Riccardo fece udire, nel sonno, un piccolo lagno di creaturina che soffre. Allora il padre, delicatamente, senza far rumore, prese da terra un grande giornale e ne coprì il volto del bambino, per difenderlo dalle mosche: e sotto il largo foglio di carta stampata, odorante d'inchiostro di stamperia, il sonno del piccolo Riccardo Joanna continuò tranquillo.
Stava per uscire Paolo Joanna, dopo aver ricercato e trovato un mezzo sigaro spento, quando la serva si presentò sulla soglia. Era una tarchiata, robusta contadina del Cilento, dai capelli ispidi e neri, dagli occhi selvaggi, dalla bocca larghissima:
‟Bon giorno, signorì. Che faccio per pranzo?”
Paolo esitò un momento:
‟Pranziamo fuori, questa sera,” disse poi, presto presto, a bassa voce.
‟E per colazione che gli do, a quest'anima di Dio?” domandò Marianna, accennando a Riccardo che dormiva beatamente, sotto la Perseveranza.
Paolo Joanna mise la mano nel taschino della sottoveste, ne cavò certi soldi e disse a Marianna:
‟Basteranno dieci soldi?” e un piccolo tremito era nella sua voce.
‟Ci bastano e ci soverchiano. E voi, signorì?”
‟.... Io..., non importa. Faccio colazione fuori, sono invitato,” soggiunse.
‟A che ora vi debbo portare il signorino don Riccardo?”
‟Portamelo in ufficio, alle due. Ti raccomando questa creatura, Marià.”
‟Non dubitate, non dubitate,” mormorò lei.
Paolo Joanna se ne andò, contando e ricontando nel taschino i venti centesimi che gli erano rimasti, per comperare due sigari virginia. La serva prese la tazza sporca e se ne andò, richiudendo pianamente la porta. Erano le undici e mezzo quando il piccolo Riccardo si svegliò, il sole meridiano entrava nella camera, si allungava sui mattoni rossastri, illuminava tutta la povera decenza di quella stanza mobiliata: egli si rizzò sul letto, senza meravigliarsi di esser solo, senza chiamar nessuno, balzò in terra, in camicia, scalzo, si dette a cercare le calzette e le scarpette. Una calzettina aveva un buco al tallone, egli la stirò per ficcarla dentro la scarpetta e intanto canticchiava, come un grande:
‟Tu, tu, tu....”
Ogni volta che incontrava un giornale sotto i piedi, lo scartava con un atto di fastidio, o vi passeggiava sopra, come se fosse un tappeto. Solo solo, come un piccolo essere ragionevole e buono, si lavò, si pettinò, si vestì col suo bel vestito nuovo, calzoncini al ginocchio, giacchettina, grande colletto di trina e cravatta di seta rossa: era il vestito nuovo che presto sarebbe diventato vecchio, a furia di portarlo ogni giorno, dalla mattina. E sull'uscio, preso a un tratto da una impazienza nervosa, si mise a gridare:
‟O Marià! O Marià!”
La serva accorse, dal fondo della cucina, dove spremeva il sugo di pomodoro per i maccheroni della padrona di casa: aveva le mani rosse sino all'avambraccio.
‟Voglio la colazione,” disse il bimbo, levando sulla serva i suoi occhioni azzurri e pensosi.
‟Che volete, per colazione?”
‟Una bella cosa: una cosa bella assai,” disse lui, come sognando una ghiottoneria.
‟Ditemela, signorino mio: e Marianna ve la fa. Volete una bella frittatina di due uova?”
‟No, no, voglio una bella cosa.”
‟Volete un'insalatella di patate e tonno?”
‟No, no,” fece il bimbo, con la cera nauseata.
‟Volete dei maccheroni col pomodoro?”
‟No, no, no,” fece Riccardo, irritato, battendo i piedi in terra.
‟Signorino mio, che vi posso fare? ditemelo voi.”
‟Voglio un pollo, tutto un pollo, tutto per me, Marià,” disse il fanciullo.
‟Non può essere, signorino mio.”
‟Io voglio il pollo,” disse il fanciullo freddamente, con l'alterezza del gran signore avvezzo a comandare.
‟O Madonna mia? come vi posso comprare il pollo? Proprio non posso.”
‟O Marià, Marianna mia cara,” disse il piccolo seduttore, con una voce tenerissima, ‟se mi vuoi bene, comprami il pollo.”
‟Creatura di Marianna sua, non mi fate disperare, siate buono, papà mi ha lasciato soltanto dieci soldi per la colazione.”
‟Soltanto dieci soldi?” chiese il bimbo, diventato a un tratto calmo e riflettendo profondamente.
‟Sissignore.”
‟Ebbene, non importa: comprami dieci soldi di pollo.”
E l'ala di pollo a cui era attaccato un pezzetto di petto, Riccardo Joanna andò a mangiarla in cucina, accanto al tegame dove bolliva il sugo di pomodoro: Marianna, la serva, dalle nerborute braccia, aveva fatto in modo da comprargli anche due prugne dolci e mature. Donna Caterina, la padrona di casa, andava e veniva, tutt'affaccendata nei preliminari del pranzo: era una grassona, col viso cosparso di tre o quattro porri rossi e pelosi. Il bimbo, silenzioso e dignitoso, la guardava, ogni tanto, coi suoi occhi fieri, rosicchiando la sua ala, come un piccolo principe.
‟Non ti ha dato nulla don Paolo, per me?” domandò donna Caterina a Marianna, che toglieva le teste e le spine alle alici.
‟Nossignora.”
‟Ma gliel'hai detto?”
‟Nossignora, l'ho dimenticato.”
Donna Caterina fu lì lì per gridare: Marianna le fece un cenno supplichevole, indicandole il piccolo Riccardo, che lavava aristocraticamente le sue prugne in un bicchiere, prima di mangiarle. La padrona di casa fece una spallata, ma tacque. Erano gli otto del mese e Paolo Joanna non ancora aveva pagato l'affitto della sua stanza: ogni mese si faceva pregare sino ai quindici, sino ai venti. In realtà Marianna, presa da pietà, non glielo diceva spesso, vedendolo impallidire e balbettare: non glielo diceva, anche per quella bella creatura di Riccardo, che chinava gli occhi e stringeva le labbra, quando venivano a chieder denaro a suo padre. Il figliuolo, allora, levava gli occhi in faccia al padre, preso da una grande ansietà, muto, angosciato: Marianna voltava la testa in là, per non vedere questa scena silenziosa. E la gentilezza, la intelligenza del piccolo Riccardo erano tali che commovevano anche donna Caterina: era un bimbo senza madre, quello, ed ella era una donna senza figliuoli.
‟Vuoi pranzare con noi, Riccardo?” gli disse, quando le alici cominciarono a saltare nell'olio della padella.
‟Grazie, signora,” rispose il piccolino, ‟ho fatto colazione e pranzo con papà mio, questa sera, alla trattoria.”
E se ne andò in camera sua, dove restò solo solo, di nuovo, a giocare con una scatola di soldatini scompagnati. Ora Marianna aveva piegato i giornali trovati sul letto e in terra e li aveva uniti ad altri sparsi, a fasci, ammonticchiati sul canterano, sul tavolino da notte, sopra un seggiolone di cuoio nero dove nessuno sedeva: ogni tanto, quando eran troppi, Marianna li vendeva al pizzicagnolo, a cinque soldi il chilo, quando non erano tagliati, e con quei soldi pagava la stiratrice che insaldava i grandi colletti di Riccardo, o gli lavorava dei manichini di lana rossa, per l'inverno. Alle due ella entrò in camera, per condurlo all'ufficio del giornale, da suo padre: aveva lasciato il suo piatto di maccheroni a metà, per non mancare.
‟Mettetevi il berretto, e andiamo, signorino don Riccardo.”
‟Posso andare anche solo: so la strada!”
‟Madonna, potete capitare sotto a una carrozza!”
‟Vado sul marciapiedi.”
‟Nossignore, ho promesso a papà di accompagnarvi.”
Egli posò un berretto grazioso sui riccioli castagni e se ne andò per il vicolo dei Pellegrini, raccontando a Marianna le meraviglie di Giroflè-Giroflà, che aveva visto la sera prima, al Circo Nazionale, il nero Mourzouck, i pirati e la vampa del punch, acceso nella zuppiera. La serva lo ascoltava, esclamando ogni tanto:
‟O Gesù, o Gesù!”
Innanzi alla tipografia del Tempo, nella piazzetta dei Bianchi, incontrarono Peppino, un ragazzotto tipografo.
‟Peppì, vai all'ufficio?” domandò il piccolo Riccardo con aria d'importanza.
‟Sissignore, porto le bozze a papà.”
‟Ah! va bene,” fece Riccardo, tutto soddisfatto.
Ora camminavano in tre, la serva col suo passo di anatra grassa, il bimbo sottile e snello e il ragazzo di stamperia. Peppino portava un berretto di carta bianca sui capelli rossi, e il viso bianchissimo era macchiato di lentiggini e d'inchiostro: e sulla blusa turchina parea che ci fosse piovuto l'inchiostro. Egli guardava il figliuolo del redattore, con un rispetto profondo e si teneva un po' indietro.
‟Tu sai leggere, Peppino?”
‟Sissignore: altrimenti non potrei fare il tipografo.”
‟E scrivere?”
‟Un poco.”
‟Io non so nè leggere, nè scrivere,” disse Riccardo. ‟Ma non serve, papà dice sempre che non serve.”
‟Voi non dovete fare il tipografo, signorino.”
‟No, no, io non debbo fare il tipografo,” mormorò macchinalmente il bimbo. ‟Addio, Marianna, addio.”
‟La Madonna vi accompagni,” disse la serva, ferma sulla soglia del portoncino, guardando ancora il bimbo che si arrampicava lestamente per la erta scaletta.
E Marianna Rosanía, la vigorosa contadina di Caposele, se ne andò a casa, col suo passo di bestia grossa, a lavare i piatti, mentre i ferri da stirare si arroventavano sull'altro fornello. Riccardo attraversò l'anticamera senza fermarsi, schiuse una porta, corse a una scrivania e buttò le braccia al collo del padre.
‟O papà, o piccolo papà,” ripeteva il bimbo, strofinando la sua guancia contro quella del padre.
Il padre lo baciava, in silenzio, sui capelli, sugli occhi. Per lavorare in ufficio, Paolo Joanna aveva cambiato il soprabito in una giacchetta di lustrino: la faccia aveva una monotona espressione di stanchezza e quasi di ebetismo: il medio e l'indice della mano dritta erano sporchi d'inchiostro sino alla seconda falange.
‟Hai mangiato, nino mio?”
‟Sì, papà: Marianna mi ha comprato il pollo.”
‟Ti è piaciuto?”
‟Sì, papà: e tu?”
‟Io ho fatto colazione al caffè.”
‟Con gli amici tuoi, papà?”
‟Sì, nino. Ti sei seccato, a casa?”
‟Un poco, papà: ma non importa.”
Peppino, il ragazzo di stamperia, ritto innanzi alla scrivania di Paolo Joanna, teneva sempre le bozze in mano e guardava in aria, seguendo il volo delle mosche. Il giornalista gli prese le bozze e chinò il capo sul tavolino, a lavorare di nuovo. In silenzio Peppino andò via. Riccardo aveva posato il berretto sopra una scansia, sopra un fascio di opuscoli tutti polverosi, e piano piano girava per la stanza, come a cercarvi qualche cosa di nuovo. Ma era sempre la medesima stanza, con due scrivanie che si prospettavano, massicce, profonde di cassetti, due monumenti; con certi scaffali pieni di libri buttati a caso, pieni di opuscoli, di carte vecchie, di fasci di giornali ingialliti; alle mura una carta geografica dell'Italia, un vecchio orario generale delle ferrovie romane, una vecchia réclame dell'esposizione marittima di Napoli, un cartellone rosso con cui il Tempo annunziava ai suoi lettori la pubblicazione del romanzo di Montépin: La Marchesa Castella. Ma su tutto questo una polvere fitta, come se ci fosse piovuta, una polvere che mangiava il colore della carta, che appannava la vernice del legno, che si depositava, a solchi, nella paglia delle sedie, che copriva i libri e gli Atti del Parlamento di uno strato molle, che disegnava delle ombre sugli ondeggiamenti della carta geografica e dei cartelloni.
Insieme al costante odore d'inchiostro di stamperia, questa volta un po' rancido, si univa l'odore secco e aspro della polvere: se ne indovinavano dei monticelli negli angoli dimenticati, dietro gli scaffali, nei cantucci oscuri: Riccardo procedeva con una certa diffidenza, avanzando il nasino, indietreggiando il corpo, per la paura d'insudiciarsi. Sopra un tavolinetto vi era un bicchiere con un po' di limonata in fondo: accanto una vecchia testata del Tempo, tutta nera d'inchiostro, tutta corrosa dalla polvere. Per cavare da uno scaffale un fascio d'Illustrazioni italiane Riccardo sollevò un nugolo di polvere, tossì: Paolo levò il capo, si baloccò con la penna.
‟Che cosa scrivi, papà?”
‟Scrivo che il prefetto è un cattivo, nino mio.”
‟Gliene dispiacerà al prefetto?”
‟Sì, nino.”
‟Imparerà a esser cattivo,” disse imperiosamente il bimbo, con l'intonazione di un piccolo tiranno.
E si mise a sfogliare le Illustrazioni, senza parlare. Aveva subito imparato a non discorrere in ufficio, a non chiedere nulla, a non far rumore, a stare lungo tempo immobile, seduto, curvo sopra un giornale illustrato, sempre i medesimi giornali, senza seccarsi mai, come un bimbo precoce e saggio. Non si accostava neppure al balcone che dava sulla Piazza dello Spirito Santo, quasi alla fine di Via Toledo, donde veniva un grande rumore di carrozze e di persone: ogni tanto, quando una persona attraversava la stanza, Riccardo levava gli occhi, curioso, ma timido. Quella porta, quella stanza di là, dove sedeva e troneggiava il proprietario-amministratore del Tempo, sembrava a Riccardo un tempio: non vi si entrava mai, bisognava chieder permesso, le persone vi restavano lungamente e certo parlavano a voce bassa, di cose importanti, perchè niun rumore ne veniva: il proprietario non riconduceva mai nessuno, era un piccolo uomo panciuto, con una testa di foca e gli occhi grigi e falsi dietro gli occhiali. Ogni tanto, Paolo Joanna scompariva anche lui dietro la porta del tempio: Riccardo restava con gli occhi fissi su quella porta, un po' inquieto. Verso le cinque il proprietario andava via, senza guardarsi intorno, senza salutare, con l'occhio spento dietro gli occhiali, chiuso in sè. Giammai aveva detto una parola a Riccardo, giammai aveva fatto mostra di aver notata la sua presenza: e Riccardo, il piccolo principe, si sentiva pieno di rispetto e pieno di paura per quel breve uomo ventruto, dal mustacchio troppo corto e troppo rado. Quando qualcuno veniva a chiedere del proprietario, domandava sempre se vi era il signor cavaliere, senz'altro: Paolo Joanna, parlando di lui a tavola, a teatro, diceva sempre il signor cavaliere, e questo titolo pareva a Riccardo qualche cosa di misterioso, di grande. Talvolta nella stanza di là le voci si elevavano. Paolo tendeva l'orecchio un minuto, poi diceva a Riccardo di andar a giocare in anticamera. Quest'ordine, per Riccardo, era una liberazione. Quel giorno, precisamente, l'ordine non veniva: e Riccardo si accostò alla scrivania di suo padre, senza dirgli nulla. Costui continuava a scrivere e non si accorse di nulla: ma levando gli occhi, vide la testa ricciuta di suo figlio accanto a lui:
‟Vuoi qualche cosa?”
‟Vorrei andare in anticamera.”
‟Va: non t'insudiciare.”
‟No, papà: mi porti al trattore questa sera?”
‟.... Sì.”
‟A quale?”
‟.... Non so, vedremo, nino mio.”
‟Mi fai mangiare la ragusta, papà?”
‟.... Se ce n'è, nino.”
‟Voglio anche il dolce, papà.”
‟.... Sì, sì,” mormorò il padre chinando il capo.
Il bimbo guardò bene suo padre, con un occhio così indagatore, così acuto, che parea quello di un vecchio.
‟Se non abbiamo quattrini non importa, papà,” disse Riccardo, scotendo il capo.
A Paolo salirono le lagrime agli occhi, ma rispose allegramente:
‟Ne avremo, ne avremo, piccolino, non dubitare.”
Riccardo scappò fuori, tutto felice; l'anticamera, una stanzetta quasi buia, la cucina formavano la sua felicità. Nell'anticamera, innanzi a una scrivania, sedeva don Domenico, un vecchissimo e piccolissimo gobbetto, tutto bianco, tutto grinzoso, con certi occhietti vivi, il gerente responsabile del giornale, che teneva anche il registro degli abbonati e faceva i conti. Don Domenico era grande amico di Riccardo, lo lasciava scherzare col timbro colorato tutto umido d'inchiostro azzurro, gli regalava le ostie colorate, rosse, turchine, gialle: facevano insieme, il gobbetto antico e il bambino, certe conversazioni lente, a voce sommessa, a riprese:
‟Dove sta vostra moglie, don Domenico?”
‟È morta, signorino.”
‟Ah!”
Qui un silenzio: il gobbetto continuava a scrivere in quei suoi libroni.
‟Che avete fatto, don Domenico, quando è morta vostra moglie?”
‟Che dovevo fare? Niente.”
‟Papà ha pianto quando mammà è morta, a Milano,” diceva il bambino, con un accento da trasognato.
‟Mammà vostra doveva essere bella.”
‟Era bella assai, bella assai,” continuava il piccolo, con la sua aria di sonnambulo.
Quando entrava un signore per prendere un abbonamento, Riccardo taceva, mentre il gobbettino scriveva con la sua larga e chiara calligrafia, staccava la ricevuta nettamente e salutava con un sorriso il nuovo abbonato. Quel giorno don Domenico era in collera con una macchia d'inchiostro cascata sulla pagina bianca di un registro, e col capo abbassato, con la gobba quasi fatta più prominente per l'attenzione, strofinava, strofinava con la gomma per cancellare quella macchia. E tutto preso dalla sua smania di pulizia, il gobbetto non gli dava retta, a Riccardo, che gli voleva raccontare come il papà di Giroflè, al Circo Nazionale, rassomigliava a lui, don Domenico.
‟Don Domè?...” disse Riccardo.
‟Ah?” fece quello, senza levare la testa.
‟Don Domè, non vi voglio più bene.”
‟Aspettate, aspettate, signorino mio, ora parleremo.”
Ma Riccardo si era seccato: aveva voltate le spalle e se n'era andato nella stanzetta semibuia, dove stava l'altro suo amico, Francesco. Era un giovanotto alto e forte, che prima aveva fatto il mestiere del fabbro nell'arsenale di Napoli e guadagnava tre franchi al giorno, essendo bravo: ma un giorno, battendo col martello sul ferro incandescente, una scintilla gli era schizzata in un occhio e gli aveva bruciata la cornea: lo avevano tenuto cinque mesi all'ospedale dei Pellegrini, alle mani del primo oculista di Napoli, ma aveva perduto l'occhio: all'arsenale non avevano voluto riprenderlo, egli si era acconciato in quell'ufficio di giornale, lavorando dalle otto della mattina sino alle nove della sera, per cinquanta lire il mese. Chiuso dalla mattina in quella stanzetta oscura, dove si accendeva il gas alle tre, seduto sopra un alto seggiolone, innanzi a una grande tavola, con un forbicione in mano, Francesco tagliava le fasce, lentamente, con un moto uniforme, con uno stridío regolare delle forbici. I larghi fogli di carta dove gli indirizzi erano stampati, sotto le cesoie di Francesco diventavano tante strisce piccoline tagliate precisamente, e gli si ammonticchiavano accanto. Più tardi, quando aveva finito, Francesco disponeva le fasce a scaletta, in tanti mucchi bene ordinati, pronti a essere bagnati di gomma, pronti a stringere il giornale nel loro legame. Riccardo era un grande amico di Francesco, lo andava sempre a trovare nella cameretta buia, dove non entrava mai nessuno, dove il forte fabbro dall'occhio bianco passava le giornate, inchiodato sul seggiolone. Riccardo lo guardava a tagliare, per intieri quarti d'ora, senza dire nulla, e il tagliatore dava prova di maestria, tagliando con una certa grazia, arrotondando il braccio, con un colpo quasi volante delle cesoie.
‟Don Domenico pare un gatto che raspa, oggi,” osservò Riccardo.
‟Certi giorni pare uno scimmiotto,” rispose Francesco, con un accento profondo.
‟Mi fai tagliare un poco, Francesco?”
‟Vi potete far male.”
‟No, no, non mi faccio male.”
‟Mi taglierete storte le fasce e poi mi gridano.”
‟Ti gridano spesso, Francesco?”
‟Non sono molto buono per questo mestiere, signorino,” mormorò l'ex-fabbro.
‟Ti piaceva meglio l'altro, Francesco?”
‟Sicuro.”
‟Raccontami come ti successe la disgrazia,” disse il bimbo, sedendosi sopra uno sgabello e incrociando le mani.
L'aveva intesa raccontare cento volte, quella storia della scintilla ardente che era schizzata nell'occhio di Francesco e glielo aveva bruciato: ma Francesco amava di narrarla la storia della sua disgrazia, il più grande avvenimento della sua vita. Cominciava sottovoce, brandendo le sue cesoie, facendole stridere attraverso i fogli di carta, mentre il bimbo lo fissava coi suoi grandi occhi azzurri, tutti intenti: ma pian piano Francesco si riscaldava, alzava un po' la voce, non tagliava più, gesticolando con le cesoie, la cui lama lucida brillava: una emozione strozzava le parole del fabbro, un pallore si mescolava alla tinta bruna del volto — quando arrivava a dire come dalla barra di ferro arroventato si staccasse la fatale scintilla. Francesco si fermava, tutto commosso, non potendo più parlare. Il piccolo Riccardo ascoltava senza batter palpebra, senza interrompere, preso anche lui da una emozione: e quando taceva il tagliatore, anch'esso taceva, un silenzio regnava nella stanzetta semibuia.
‟Ti fece molto dolore?” disse, dopo una pausa, il bambino.
‟Un dolore immenso.”
‟Bruciava?”
‟Assai, assai bruciava.”
‟Povero Francesco!” disse, sottovoce, il piccolo Riccardo.
‟Volete tagliare, signorino?” esclamò il tagliatore, con un moto di entusiasmo.
E gravemente, stringendo le labbra, Riccardo afferrò le cesoie e si diede a tagliare le fasce.
‟Quante saranno le fasce, Francesco? Un milione?”
‟Sono tremila.”
‟Più di un milione?”
‟Meno.”
‟Tu non sai leggere?”
‟No, signorino.”
‟E non sai a chi vanno queste fasce?”
‟Non lo so.”
‟Non vorresti saperlo?”
‟Che me ne importa?”
‟È vero, che te ne può importare?” soggiunse il bimbo, col suo tono di persona ragionevole.
Ma le cesoie gli stancavano le piccole dita, le depose. Una voce di fuori lo chiamò.
‟Riccardo?”
‟Eccomi.”
Fuori vi era il cronista, un giovinottone lungo e magro magro, con le spalle curve, il collo esile, le guance rossastre del tisico: un Veneziano dalla dolce pronuncia, dai modi dolcissimi, perduto in quel vasto Napoli, tossicchiante appena veniva l'autunno, povero, sempre allegro, che scriveva presto presto un italiano pieno di errori di ortografia che Paolo Joanna doveva correggere e per cui Alessandro Dolfin non si offendeva mai, quando lo riprendevano. Riccardo era il suo prediletto, aveva sempre in tasca per lui un paio di soldi di confetti, un giocarello di pochi centesimi. Entrava in redazione tutto scalmanato, col respiro affannoso, avendo troppo camminato, dalla Questura alla Prefettura, agli ospedali, sempre in giro sino alle tre, e si buttava a scrivere come un disperato, con una calligrafia grande e informe di ingegno mediocre: a un certo punto, domandava:
‟Non ci è il bimbo?”
‟È fuori.”
‟Ora, ora lo vado a prendere.”
E buttava giù in fretta e furia la sua cronaca, facendo uno sforzo sulla sua naturale indolenza, vincendo la debolezza di essere destinato a morire di tisi, scriveva come se avesse il diavolo in corpo, per poter poi andare a cercare il piccolino.
‟Ti ho portato una cosa, indovina?”
‟Che cosa, che cosa?” chiedeva Riccardo, attaccato alla lunghissima gamba di Dolfin.
‟Una pesca, una pesca: ma devi venire a prenderla.”
E Dolfin avanzava il piede e il ginocchio destro, Riccardo vi si arrampicava come uno scoiattolo, gli saliva sul petto, opprimendolo, tendeva le mani, afferrava la pesca, la mordeva.
‟Mangia anche tu, Alessandro.”
‟Non ne voglio, mi fa male.”
‟Tutto ti fa male a te?”
‟Tutto.”
‟A me nulla.”
Questo dialogo avveniva in cucina; una cucina fredda, coi fornelli spenti, senza un utensile: il focolare era coperto di grandi pacchi di Tempo, la resa: sotto l'arco, dove si conservava il carbone, vi erano certe scatole di caratteri tipografici consumati, corrosi, ma sempre un po' umidicci, puzzolenti di antimonio; in un angolo certi strofinacci sudici. Sul muro, dove un tempo erano state le casseruole e vi avevano lasciato la loro orma rotonda, erano attaccate certe caricature rosse e nere del Pasquino, la Francia con la cresta di gallo, Bismarck coi tre capelli ritti sul cranio, Depretis con la barba fluente di un Fiume. Ivi Alessandro Dolfin oziava un pochetto, facendosi arrampicare addosso il bambino, parlandogli affettuosamente in quel molle dialetto veneziano, soddisfacendo quel bisogno di tenerezza che immalinconiva quel giovinottone ammalato, nostalgico e povero. La cucina aveva un finestrino dai vetri sporchi che dava sulla scaletta: un grosso naso, una testa di faina vi comparve e gridò:
‟Cronista, un suicidio!”
Dolfin lasciò Riccardo a malincuore, e andò dietro al reporter che aveva tutti i particolari della notizia. Il reporter era un napoletano, afflitto da uno sciagurato amore pel giornalismo, piccolo, scarno, con un naso che pareva si trascinasse dietro la testa, con la faccia di un vecchietto astuto e un modo di parlare telegrafico, tutto compreso dell'altezza del suo ufficio, quasi che fosse un redattore del New-York Herald. Nell'anticamera, frettolosamente, Angiullo dava la notizia a Dolfin, leggendogli le note del taccuino: Dolfin ascoltava con aria stracca, e Riccardo, che gli aveva tenuto dietro, aveva un contegno di personcina attenta.
‟... Dal Ponte alla Sanità. Si crede che sia morto prima d'arrivare in terra.”
‟L'hai visto, tu?” domandò il bimbo al reporter.
‟Certamente: faceva orrore.”
‟Qual è la causa del triste proponimento?” domandò il cronista, con lo stile della cronaca.
‟Credesi dissesti finanziari,” rispose sullo stesso tono Angiullo. E scappò via.
Dolfin entrò nella redazione per scrivere la notizia, annoiato; Riccardo lo seguiva. Paolo Joanna scriveva sempre, con un movimento della bocca che imitava quasi quello della penna. Non levò neppure il capo. Dolfin scriveva tenendosi il bimbo accanto.
‟Dimmi, che significano dissesti finanziari?” chiese il bambino, dopo aver pensato.
‟Mancanza di quattrini,” disse Dolfin.
‟E uno si ammazza?”
‟Più di uno.”
‟Ah!” disse soltanto il bimbo.
‟Che ora sarà?” domandò Paolo Joanna, levando il capo e mostrando la sua faccia stanca e preoccupata.
‟Mah!...” fece il cronista, con un cenno d'ignoranza.
Ambedue non avevano orologio: e l'orologio grosso e grossolano, da paccotiglia, sospeso al muro, era fermo da sei mesi alle undici e mezzo.
‟Ora domando a don Domenico,” propose il piccolo Riccardo.
Adesso, nella stanza di redazione era cominciato un certo viavai; il deputato ispiratore del Tempo aveva mandato l'articolo di fondo contro il governo, e Paolo Joanna lo arricchiva di punti, di virgole, di esclamazioni, spezzava i periodi, ne rifaceva qualcuno; il corrispondente da Torino aveva mandati due telegrammi, di cui uno si fingeva fosse da Parigi; era venuto il fattorino dell'Agenzia Stefani col solito dispaccio; Peppino era capitato di nuovo, con altre bozze; due o tre signori erano passati, si erano ficcati nella stanza del proprietario. Dolfin con le mani in tasca guardava il soffitto, con quella immobilità sorridente del Veneziano immerso nelle sue contemplazioni.
‟Sono le quattro e un quarto,” tornò a dire Riccardo.
‟Paolo, dammi Riccardo, lo porto a passeggiare.”
‟No, no, lascialo stare,” mormorò Paolo, pensoso.
‟Che ti fa qui? Te lo riconduco all'ora del pranzo.”
‟Lascialo Riccardo: mi serve.”
‟Quello si annoia: fallo venire a passeggiare.”
‟Ti annoi, Riccardo?”
‟No, papà: non mi annoio mai,” rispose il piccolo uomo.
‟Senti una parola, Alessandro,” disse Paolo.
E per parlarsi in segreto, i due redattori se ne andarono fuori il balcone. Ivi Paolo fece la domanda: aveva da prestargli venti lire, Alessandro? E lo aveva detto presto presto, con quella timidità e quella soffocazione di voce che hanno le persone veramente bisognose: e giocherellava col bottone quasi strappato della sua spolverina. Dolfin si fece pallido, una viva espressione di dolore gli si dipinse sulla faccia: non aveva che tre lire per pranzare, potevano dividere, egli si sarebbe contentato.
‟Non importa, non importa,” disse Paolo, vergognandosi.
‟Prendile, Paolo, prendile: almeno per Riccardo.”
‟Troverò altrove: lascia fare,” e abbozzò un pallido sorriso di sicurezza.
Rientrarono. Erano smorti ambedue, e si dolevano, l'uno della domanda fatta inutilmente, l'altro della propria impotenza. Il bambino li guardò, uno dopo l'altro, come se volesse leggere nelle loro facce: egli era serio serio, come se avesse indovinato.
‟O Riccardo, vuoi arrampicarti ancora?” domandò fiaccamente quel bonaccione di Dolfin, tendendo il piede e il ginocchio destro.
‟No,” disse lentamente il bambino, ‟non ho più voglia.”
‟Che hai, piccolino?”
‟Niente.”
‟A rivederci, io vado al Consiglio comunale,” disse Dolfin, che non si reggeva a vedere il padre preoccupato e il bimbo triste.
Uscì. Paolo, dopo aver pensato un poco, aveva preso un foglietto e scriveva una lettera. Poche parole: ma ad ognuna di esse si fermava, come pentito, come esitante, come se non trovasse la forma giusta. Stracciò il foglio: ne prese un altro. Riccardo si era seduto, le mani abbandonate, l'occhio spento, come stanco.
‟Riccardo?”
‟Papà?”
‟Senti una cosa.”
Il figliuolo si appressò al padre, che gli carezzò i capelli leggermente.
‟Mi vuoi bene?”
‟Sì, papà mio.”
‟Allora vuoi farmi un piacere?”
‟Sì, papà.”
‟.... Senti.... senti,” e pareva che inghiottisse difficilmente la saliva, ‟dovresti andare.... dentro.... dal signor cavaliere....”
‟Oh, papà!...”
‟.... A portargli questa lettera,” terminò di dire precipitosamente il padre.
Il bimbo tese la manina, ma aveva chinato la piccola testa sul petto.
‟È proprio necessario, papà, che ci vada io?” chiese poi, con voce fievole.
‟Necessario, Riccardo mio,” rispose il padre.
‟.... Ora vado, papà.”
E si avviò.
‟Senti, Riccardo.”
‟Che cosa?”
‟Digli anche: Papà mio si raccomanda.”
‟Niente altro?”
‟No.”
‟Vado, papà.”
Il bimbo bussò debolmente: una voce secca gli strillò di entrare. Paolo, mentre Riccardo era di là, volle rimettersi a scrivere, ma non potè, le mani gli tremavano. Quando la porta si chiuse, egli arrossì di vergogna sino ai capelli.
‟Ecco, papà,” sussurrò Riccardo.
Gli pose sulla scrivania quattro rotoli bianchi, venti franchi in monete di rame.
‟Bravo, Riccardo.”
Si chinò per baciare il figliuolo sulla guancia, ma il bimbo non potette più rattenersi, le lagrime gli gonfiarono gli occhi, egli si attaccò al collo del padre, dicendo fra i singhiozzi:
‟Oh papà mio.... oh papà mio bello!...”
‟Per carità, non piangere, mi fai disperare,” e cercava di calmarlo, lo carezzava, dava delle occhiate di paura verso la porta.
‟Ti possono, udire, per carità, Riccardo!”
Il fanciullo cercava di trattenersi, ma non poteva, i singulti lo soffocavano. Il padre se lo tolse in collo, e non sapendo dove andare, lo portò in cucina, chiuse la porta.
‟Ma che hai, che hai?” gli andava ripetendo.
‟Oh papà, non mandarmi più.... il signor cavaliere mi fa soggezione.... mi fa paura.... non mandarmi più....”
‟Non ti mando più, non dubitare. Che ti ha detto?”
‟Ha detto, leggendo la lettera: solite fandonie...”
‟Imbecille! E poi?”
‟Poi ha messo la lettera in un librone nero, ha aperto un cassetto: quanti denari, papà! e mi ha dato.... quei quattrini....”
Si diede a piangere di nuovo.
‟Non piangere: perchè piangi?”
‟Mi sono vergognato, papà.”
Tacquero. Un grave silenzio era fra loro: la faccia del padre si era scomposta, quella del bimbo pareva quella di un vecchietto, che avesse tanto vissuto, tanto sofferto.
‟Hai ragione,” mormorò Paolo. ‟Non dovevo mandarti: dovevo andare io, sono un vile....”
‟No, non dir queste cose, non ti arrabbiare, papà mio, un'altra volta non piangerò più, manda sempre me....”
‟Speriamo di non averne più bisogno,” soggiunse solennemente il padre.
‟Speriamo,” aggiunse piamente il figliuolo.
Erano già consolati: uscirono dalla cucina.
‟Ora papà tuo ti manda a comperare qualche cosa che ti piaccia. Vuoi il fernet?”
‟È amaro.”
‟Vuoi il wermouth?”
‟Sì, ma col seltz, papà.”
..........
Nella tipografia il rombo della macchina era finito. Tutta l'edizione di provincia era stata tirata: in un camerotto di legno, sotto la vampetta di un lume a gas, Paolo Joanna e Dolfin scrivevano le ultime informazioni e le ultime notizie di cronaca per l'edizione di Napoli che doveva uscire fra un'ora. I due redattori erano in maniche di camicia: in quel camerotto si affogava — e non parlavano, scrivevano rapidamente, presi dall'ansietà di quella ultima ora. Riccardo gironzava per la tipografia, come una piccola ombra, fra i larghi tavoloni e gli scaffali della composizione: sopra certe casse, dove non si lavorava più, il gas era abbassato: solo tre tipografi componevano gli ultimi pezzi del giornale; Peppino si ergeva sopra uno sgabello, essendo ancora troppo piccolo per arrivare alle cassette dei caratteri; il proto, tutto attento, si curvava sopra un ampio tavolone coperto di marmo macchiato di inchiostro, umidiccio di un'acqua sporca, e con certe sue pinzette cavava certe lettere dalla pagina composta, tutta nera. Riccardo gironzava, ma sapeva che non doveva parlare ai tipografi, massime in quella fervida ora di lavoro: e dopo un poco, se ne andò in un camerotto di legno, simile a quello dove lavoravano suo padre e Dolfin. Attorno a una larga tavola, sedute sopra certi alti seggioloni, stavano le tre piegatrici dei giornali: e innanzi a ognuna di loro, un fascio di giornali aperti si elevava. Rapidamente, senza smettere di parlare, senza guardare, esse piegavano il giornale in due, poi in quattro, poi in otto, poi in sedici: agilissime volavano le dita, l'unghia del pollice passava sulla piega per fissarla meglio, i giornali piegati si elevavano in mucchi.
Maria lavorava lentamente: era la giovane moglie di un cocchiere, bellina, dall'aria signorile, convalescente ancora di un tifo che le aveva minacciato per più giorni la vita, coi capelli corti e ricciuti e la naturale indolenza dei convalescenti: Raffaela chiacchierava, canticchiava, lavorava come se avesse una grande fretta, i suoi quattro figliuoli l'aspettavano a casa per mangiare, era vedova da due anni, suo marito era un fontaniere, era morto in un pozzo improvvisamente inondato: la più silenziosa era Concetta, una sciancata, una povera giovane dal volto lungo e pallido, dal vestito di percalla nero, dal fazzoletto di cotone bianco al collo, una monacella, così la chiamavano le sue due compagne. Riccardo si metteva accanto a lei, a vederla piegare con le lunghe dita scarne, muta, fingente non udire le storielle di amore che le raccontavano le sue compagne, per scandalizzarla un poco. Maria, specialmente, diceva quella sera di un signore che la seguiva sempre, quand'ella usciva dalla tipografia, un signore con orologio e catena, col tubbo e con un brillante grosso grosso al dito mignolo: un brutto signore, del resto, che se Totonno, suo marito, si accorgeva di tale cosa, correvano le coltellate — e ne parlava con un brivido voluttuoso di spavento, con quel desiderio e quella paura mistica del sangue che hanno le Napoletane in fondo all'anima. Raffaela, per scherzare, accusava Concetta di avere un innamorato e quella non rispondeva, piegava più rapidamente i giornali. Sì, sì, aveva un innamorato, la monachina, era don Domenico, il vecchietto gobbo e bianco, un bel matrimonio, il gobbettino e la monacella zoppa. Ella quasi piangeva, col naso che le si faceva rosso e con le labbra che si protendevano per lo scoppio delle lagrime.
‟Non te ne incaricare, Concetta, lasciale dire,” l'ammonì Riccardo, per consolarla.
Il bambino si arrampicò sulla sedia di Maria per toccarle i capelli.
‟Se mo' avessi ancora Pascaluccio mio, sarebbe come voi, signorì,” disse quella, immalinconendosi al pensiero del suo bimbo morto.
‟Ringrazia la Madonna che se l'ha preso,” gridò Raffaela, ‟oh quanto pane mangiano le creature!”
‟A me il pane non mi piace,” osservò Riccardo.
‟Voi siete un signore, è un'altra cosa.”
Le piegatrici avevano finito, si guardavano le mani già tutte nere d'inchiostro, si mettevano gli scialli, Concetta si annodava un fazzoletto sotto il mento.
‟T'aspetta don Domenico?” le disse, per burla, Raffaela.
Le tre piegatrici se ne andarono, attraversando la tipografia, ridendo a qualche motteggio dei tipografi, Maria con la sua fiacchezza di malatina debole, Raffaela dicendo qualche paroletta vivace. E dopo un poco il rombo della macchina ricominciò. Riccardo si era ritirato in un angolo lontano, ma non toglieva gli occhi di dosso alla macchina. Sempre quel grande congegno nero, a ruote che s'ingranavano l'una nell'altra, a rulli neri e lucidi che andavano e venivano, con quel cilindro che si arrotolava sulle pagine, con quei telai semoventi, con quel fischio sottile dei fogli che scivolavano, quasi afferrati e divorati da quell'ingranaggio, quel macchinone rombante sempre lo meravigliava. Quando era al riposo, Riccardo vi si accostava, timidamente, toccava con la punta del ditino una ruota, poi si ritraeva, girava attorno alla macchina con una curiosità ansiosa; ma quando la macchina si metteva in moto, un timore, un rispetto lo faceva rinculare lontano. E nello stesso tempo egli invidiava Peppino, il ragazzo, e Ciccillo un altro ragazzo, che sedevano in cima ai due piani inclinati, sicuri, tranquilli, facendo scivolare i fogli di carta dentro la macchina, con un atto disinvolto, di operai avvezzi. Non tremavano essi, lassù, mentre la macchina si moveva tutta, con un rombo forte, sotto di loro; essi parevano due domatori della macchina, due trionfatori, due piccoli re. Riccardo li invidiava.
A Riccardo la macchina pareva una cosa grande e misteriosa. Quando si trovava innanzi a essa, vedendola inghiottire di mano in mano i fogli bianchi e subito buttarli fuori stampati, con gli articoli, con le notizie, coi telegrammi, gli sembrava che essa sola facesse il giornale: il fanciullo dimenticava il lavorío faticoso di suo padre, di Dolfin, degli altri redattori, a cui assisteva ogni giorno, dimenticava il lavorío quotidiano, paziente dei tipografi che componevano il giornale linea per linea. Per Riccardo la macchina pensava e sapeva, scriveva e correggeva, componeva, faceva tutto, sapeva far tutto: quell'organismo ignoto, ma forte e potente, creava ogni giorno il giornale, lo cacciava dalle sue viscere nere, con un movimento preciso e inflessibile di generazione. Tutto l'agitarsi minuscolo di tante persone, scrittori, fattorini, compositori, stampatori, correttori spariva dinanzi a quel largo movimento di creazione della macchina, stridente, rombante, mugolante. Riccardo, assorbito, contemplava il grande congegno, tenendo la bocca un po' schiusa, le manine inerti lungo le gambe: invidiava Peppino e Ciccillo, i due ragazzi della macchina, ma non avrebbe mai osato di salire lassù. Ogni tanto, quando parlava con suo padre, gli diceva:
‟La macchina, papà....”
E diceva queste tre sole parole lentamente, con un accento profondo, staccando le sillabe, dando alla frase come un senso sacro. Una notte, il padre lo aveva condotto in tipografia, dopo il teatro: Paolo Joanna aveva bisogno di dire qualche cosa al proto: i tipografi della notte lavoravano, ma la macchina stava ferma: sopra certe ruote erano buttati degli strofinacci unti di olio, una gran tela nera quasi quasi la ricopriva.... ed essa s'immergeva nella penombra.
‟Che fa la macchina?” aveva chiesto sottovoce il bambino.
‟Dorme,” aveva risposto distrattamente il padre.
‟La macchina dorme,” ripeteva pian piano Riccardo, come se non volesse svegliarla, ‟la macchina si riposa.”
Gli pareva quasi una gran cosa umana, come un congegno che avesse l'anima. A un tratto il gas intorno alla macchina fu alzato, la tela fu portata via, i cenci unti furono buttati in un cantuccio e con un rombo prima sordo, poi fragoroso la macchina, svegliata, viva, cominciò a buttar fuori le copie del giornale La Patria che usciva al mattino. Riccardo era rimasto compreso di meraviglia; e da quella notte, ogni tanto, pensava fra sè:
— La macchina non riposa mai. —
Sulla porta del suo camerotto, ancora in maniche di camicia, con un mozzicone nero di sigaro spento fra le labbra, Paolo Joanna aspettava. Gli toccava restare in tipografia sino a che la tiratura fosse finita: nel caso che venisse qualche notizia importante da Torino o da Napoli stesso, bisognava inserirla, fare una seconda edizione. Aveva sul volto l'ansietà, l'impazienza di quella ultima ora: era quell'esaltamento finale di un lungo lavoro della mente, quella piccola febbre che soffre il giornalista al termine della sua fatica quotidiana, l'occhio un po' stralunato, le labbra un po' secche, le mani un po' calde, tutti i nervi tesi.
‟Riccardo, levati di là,” disse da lontano Paolo.
‟Perchè, papà?”
‟Perchè ci fa caldo e ti puoi far male.”
‟Non fa caldo, papà, e non mi posso far male.”
‟Riccardo, non discutere, levati di là.”
Il figliuolo guardò bene il padre e gli scorse la brutta faccia nervosa delle ore cattive: non rispose più nulla e lentamente girò intorno alla grande macchina che egli amava, passò attraverso le casse della composizione e si andò a sedere sopra una panchetta di legno, presso la porta a vetri della tipografia: ivi un po' di fresco veniva. Poi, attratto dallo spettacolo di fuori, Riccardo accostò la faccia ai vetri. Fuori la porta, a tre passi di distanza, una trentina di monelli stazionavano, aspettando: vi erano dei bimbi di sei anni e degli adolescenti di quattordici: due o tre vestiti decentemente, tutti gli altri laceri, cenciosi: alcuni scalzi: qualcuno con un cappelletto sfondato, qualcuno con un berretto stracciato, gli altri col capo nudo. Si affollavano innanzi alla tipografia, urtandosi, spingendosi per farsi avanti, buttandosi in terra, dandosi degli scappellotti, piangendo, ridendo, bestemmiando: ma Capozzi, un giovanottone, stava piantato innanzi alla tipografia e non li lasciava entrare. Capozzi era il loro capo, il loro comandante, il loro signore: Capozzi era il loro ingaggiatore, era quello che distribuiva i giornali, era il tiranno temuto e venerato. Stava sulla porta, col cappello abbassato sopra un orecchio, con la mazza d'India del guappo, con un'aria di autorità che pochi ribelli osavano affrontare. E come litigavano fra loro, si acchiappavano pel collo, egli con una parola, con un rovescio di mano li divideva.
‟O moccosiello, sta fermo, se no ti mando via senza giornali!”
‟Bellu guaglione, figlio di buon cristiano, lo vuoi un calcio?”
‟Che credi che non ti vedo, Sciurillo? Adesso ti pigli quattro schiaffi!”
‟Caporaluccio, questa sera ti metto a mezza razione!”
In tutto quel chiasso di monelli impazienti che solo la voce di Capozzi arrivava ogni tanto a sedare, fra gli strilli, le canzoncine e i fischi, solo due di essi stavan quieti, appoggiati al muro. Erano un maschio e una femmina: fra gli otto e i dieci anni, fratello e sorella, si rassomigliavano tanto che parevano gemelli. La femmina, la sorellina, aveva un visetto scarno, dagli occhi vivissimi, con un treccione di capelli castagni mezzo disfatto sul collo: e sul vestitino di percallo scuro un grembiule di merinos, un fazzolettino di cotone al collo. Così il fratelluccio, anch'esso magro e pallidino, con l'aria un po' femminile.
Senza parlare, mangiavano del pane e delle prugne gialline, piccoline, quelle che si vendono a sei un soldo: le prugne stavano nel grembiule della sorellina che le passava al fratello, invitandolo con gli occhi. Quando le prugne furono finite, la sorellina scosse il grembiule: il fratelluccio mangiava ancora il suo pane, guardandolo dopo ogni morso che vi dava. Ma allora i clamori cessarono: la distribuzione cominciava. Capozzi, assistito da un suo aiutante, Salvatore Decrescenzo, detto Totore, dava a chi cento, a chi cinquanta, a chi duecento copie di giornali. Le mani si tendevano, i monelli si urtavano: ma Capozzi era flemmatico, non perdeva la testa, faceva l'appello come pei soldati.
‟Dove sta Gennarino Mennella?”
‟Sto qua.”
‟Sebastiano Loiodice?”
‟Eccomi, don Giovannì.”
‟Margherita Santaniello?”
La ragazzina era lì, con le mani tese.
‟Cento a te, cento a tuo fratello.”
Ora, come la distribuzione finiva, i monelli battevano i piedi per l'impazienza. Tenevano il fascio dei giornali per un capo, spiegati innanzi come un tovagliolo, e stavano già quasi col corpo proteso, per fuggire. Ma Capozzi, quasi scherzando con la loro furia, li tratteneva ancora. Essi aspettavano da lui la parola d'ordine, la frase che dovevano gridare, per vendere meglio i giornali. E solennemente, in napoletano, Capozzi la pronunziò:
‟I' mazzate d'i' Cammere.”
E con un cenno olimpico della sua canna d'India licenziò i monelli. Fu una fuga come la partenza di una freccia: fuga muta, ansiosa. A venti passi una vocina sottile di fanciulla diede il primo grido:
‟I' mazzate d'i' Cammere, vulit'u Temp!”
E il fratellino subito la ripetette, gli altri monelli la ripetettero su tutti i toni, ogni momento, correndo, correndo, gridando, diffondendosi dappertutto, pei vicoli e per le grandi strade, ai cantoni e sulle piazze, dovunque arrivava il galoppo di quei monelli, dovunque si ripercoteva l'eco di quelle vocette stridule o sonore.
..........
Riccardo si era annodato dietro la nuca, con molta disinvoltura, il tovagliolo bianco, per non sporcare il suo bel vestito nuovo. Seduto di fronte a suo padre, a una tavola della elegante trattoria Caffè di Europa, il piccolino non dimostrava nessuna impazienza, aspettava il pranzo con la serietà di un grande che non dà in escandescenze in pubblico.
‟Hai fame?” domandò il padre, offrendogli le sardine di Nantes dell'antipasto.
‟Abbastanza, ma non voglio sardine,” rispose Riccardo, con la cera disillusa del vecchio frequentatore di trattorie.
E aspettava, con un gran contegno indifferente, guardando ora un grasso signore, un agente di cambio che mangiava dei vermicelli al pomodoro, ora una donnina dal vestito di merletto nero, dal largo cappello piumato di nero, dagli orecchini di brillanti simili a rosette, che tutta sola, a un tavolino, sorbiva del brodo, agitando le mani bianche cariche di gemme. Riccardo non parlava, e suo padre era felice di non parlare. Una grande stanchezza si delineava sulla faccia di Paolo Joanna. Paolo in quell'ora, sotto la luce cruda del gas, innanzi al grande candore della tovaglia, al luccichío dei bicchieri, allo scintillío delle posate, pareva molto più vecchio. La tensione dei nervi era calmata, tutti i muscoli della faccia si erano rilasciati in un riposo: egli era pallido, quasi scialbo, con l'occhio spento e il labbro inerte. Era quello il grande accasciamento serotino, l'abbattimento di tutte le forze spirituali che pare il principio quotidiano dell'ebetismo, quello stato di silenzio, di aridità, di nichilismo che fa simile, ogni sera, il giornalista al contadino che si siede alla mensa dopo aver zappato, tutto il giorno, sotto il sole o sotto la pioggia: come il contadino ha in quell'ora il solo, quasi animale desiderio del cibo, il desiderio della sua copiosa minestra di patate o di barbabietola, così il giornalista, così Paolo Joanna, in quell'ora è fatto indifferente ad ogni altro desiderio che non sia quello del pranzo. In quell'ora la fantasia di Paolo Joanna, tolta al continuo rimuginare di nuove e vecchie forme giornalistiche, tolta a quel fittizio esaltamento che fa sembrare fresche e belle idee, immagini da lungo tempo classificate; smontata, come usa dire nel vocabolario giornalistico, questa fantasia secca e inerte come un sughero, non sapeva sognare altro che le voluttà del cibo. Paolo Joanna e suo figlio Riccardo in questo si eran trovati d'accordo nel volere il pranzo a prezzo fisso, a cinque franchi, incluso il vino. Il pranzo da ordinarsi dà minori voluttà agli stomachi corrotti, non vi è la varietà, non vi è il piacere acuto della sorpresa: il pranzo a prezzo fisso, composto di cinque o sei pietanzine, variato, ignoto, soddisfa, solletica, è tutto un lungo piacere dell'immaginazione e dello stomaco.
‟Chissà che ci daranno!” aveva detto Paolo Joanna, divorando, uno ad uno, i ravanelli rossi e bianchi dell'antipasto.
‟Chissà,” aveva risposto Riccardo, posando delicatamente le dita sull'orlo della tavola, per scherzare con la forchetta.
‟Il brodo, di sicuro,” aveva proseguito a dire, macchinalmente, il padre.
‟Il brodo, naturalmente.”
‟Sì: ma che ci sarà dentro?”
E Paolo Joanna levò gli occhi al soffitto in aria di grave interrogazione, come se rivolgesse una domanda al cielo. Un sottile odore di costoletta alla milanese, nuotante nel burro, veniva a tratti dalla cucina: l'agente di cambio spremeva un mezzo limone sopra una triglia fritta, la donnina versava della salsa di maionese sopra un pezzetto di ragusta.
‟Forse ci saranno le costolette alla Villeroy,” mormorò il bambino.
‟Forse,” rispose il padre.
Intanto il cameriere, Peppino, con un'aria di falso signore nella sua marsina, con una disinvoltura di giovanotto che sa vivere, aveva versato nelle scodelle la zuppa per Paolo e per Riccardo. Una glutine bionda si agitava nel brodo: padre e figlio la sorbivano in silenzio, tutti raccolti, con una devozione di gente pia.
‟Sarà tapioca,” disse, dopo un poco, Paolo.
‟No: è sagou,” rispose Riccardo.
‟A me sembra tapioca.”
‟Ti assicuro, papà: è sagou, io lo so, ce l'hanno dato un'altra volta.”
Riccardo, a furia di girare per le trattorie, aveva imparata tutta la convenzionale nomenclatura delle pietanze: egli si rammentava tutti quei nomi benissimo, e quando gli presentavano una pietanza sconosciuta, egli chiamava il cameriere e se ne faceva dire il nome. Per lui non avevano più segreti il bue alla finanziera, le scaloppine al Madera, i vol-au-vents, la zuppa alla Julienne e la Charlotte di frutti. Quelle venti pietanze che si dànno nelle trattorie, che cambiano salsa, cambiano nome, ma sono sempre le medesime; quei venti intrugli fatti di carne pesta, di grosso burro milanese, di mollica di pane, di salse dolci o piccanti, di pesce passato, Riccardo li conosceva bene, e il suo piccolo palato di fanciullo viziato li adorava. Era un buon fanciullo che finiva per rassegnarsi a tutto: e quando dovevano pranzare a casa, per economia, egli fingeva di trovar buono il fitto brodo grasso che faceva Marianna Rosanía, lo stufatino nero per essere stato troppo soffritto, o i maccheroni carichi di un sugo pieno di pepe. Ma quel pranzo casalingo, nella loro stanza, con le forchette appannate e i piatti incrinati, gli sembrava una miseria suprema: gli venivano le lagrime agli occhi e le buttava indietro coi bocconi.
‟Almeno sapete quello che mangiate,” borbottava Marianna, la buona donna che vedeva scontenti il padre e il figliuolo.
‟È vero, è vero,” diceva Paolo, chinando la testa a quella voce saggia e ammonitrice.
Ma erano tristi, Riccardo come Paolo, tristi di non essere in quella stanza della trattoria, dalle pareti stuccate di bianco, dagli specchi incorniciati di oro, dai divani di velluto rosso, dal caminetto di marmo bigio; tristi di non avere quella bella e dura luce del gas, quel mazzo di fiori nel vaso di porcellana, per lo più formato da dalie multicolori; tristi di non esser serviti da Peppino, il cameriere in marsina, dalla camicia sgargiante e dalle guance azzurrognole, rase di fresco; tristi appunto perchè sapevano quello che mangiavano, la carne di vaccina, dura e tigliosa, il formaggio di Cotrone, bianco come la calce e piccantissimo.
‟La carne della trattoria è morbida, perchè è fradicia,” borbottava ancora Marianna, che voleva convertire quel padre e quel figliuolo impenitenti. ‟È tutto un pasticcio.”
Ma giusto quei pasticci piacevano ai due Joanna, quelle falsità, quel baccalà che fingeva di essere storione, quelle uova di tonno che fingevano di essere caviale, quelle creste di gallina che parevano funghi freschi, quelle costolette dall'osso posticcio. Quella incertezza, quel dubbio, quell'inganno li divertiva, li lusingava.
‟Che pesce è questo?” domandò Paolo, tirando la sua parte da un grosso pesce bianchissimo.
‟Non so, papà,” rispose il figliuolo, mettendo sul pesce, invece della salsa, una quantità di olio e di limone.
E quando Peppino venne a portar loro il pezzo grosso, sette od otto ostie sottili di carne rosea arrostita, con un contorno multicolore e artistico di carote, pastinache, cocozzelli, fagioletti freschi e fagiolini ancora verdi, tutti commossi e soddisfatti innanzi a questa tavolozza ingegnosa del cuoco, non chiesero neppure al cameriere che fosse il pesce. Di nuovo, mangiavano in silenzio, Riccardo rosicchiando i suoi grissini, Paolo divorando la carne che doveva rinnovare le sue forze cerebrali e tenerlo pronto al lavoro dell'indomani: sulla sua faccia una novella serenità andava discacciando la stanchezza, l'accasciamento: il viso scialbo si coloriva leggermente sotto l'influenza riparatrice del cibo e del vino. Paolo cominciò a guardare intorno con interesse, con benevolenza, come l'uomo soddisfatto che prende in considerazione il mondo esterno e comincia a non trovarlo molto cattivo. In questo il signor cavaliere, il proprietario del Tempo, entrò e si diresse verso l'agente di cambio che si alzò subito, premurosamente, e con cui intavolò un fitto colloquio, a bassa voce. Il signor cavaliere non aveva più quella sua aria di bonzo, di grasso idolo indifferente dall'occhio bigio e falso: invece pareva un piccoletto grasso e bonario, che ha ben mangiato, che è felice e che farebbe il possibile per la felicità altrui. Era in soprabito chiuso e si asciugava il sudore della fronte con un fazzoletto di battista, tutto profumato di verbena, un profumo dolcissimo: un brillante scintillava alla mano pienotta e bianca, la mano del capitalista contento e quieto. Riccardo quando aveva visto entrare il signor cavaliere, era rimasto interdetto, come confuso, e aveva levato gli occhi in faccia a suo padre, come interrogandolo: ma Paolo aveva conservato la sua serenità e la sua disinvoltura, aveva fatto un cenno con gli occhi al suo bimbo, quasi per rassicurarlo, come per dirgli: continua a pranzare e non curarti d'altro. Il signor cavaliere ascoltava i vivi discorsi dell'agente di cambio, tenendo chini gli occhi, facendo girare e rigirare il suo anello intorno al suo dito mignolo, e sorrideva. Completamente rassicurato sul conto del suo spauracchio, Riccardo gustava lentamente i piselli del piatto di mezzo, mentre Paolo si distendeva un po' sulla sua sedia, stirando la sottoveste bianca, passandosi due dita nel goletto per allargarlo. Il signor cavaliere si divise dall'agente di cambio, si strinsero la mano, guardandosi, come se convenissero di un patto: il piccoletto bonario si fermò amabilmente, ma senza sedersi, presso il tavolino dove la donnina vestita di nero e ingioiellata sbucciava lentamente una pesca.
‟Come va?”
‟Va bene,” rispose quella, con una voce un po' roca, versandosi dell'acqua di Seltz nel vino di Bordeaux.
‟Non si parte?”
‟Presto, per Livorno: venite anche voi?”
‟Oh io!” fece l'altro, crollando le spalle, con un cenno indefinibile.
La lasciò, si accostò al tavolino di Joanna, si sedette, bonario, familiare.
‟Buona sera, Joanna. Ho visto il giornale, il capocronaca mi va, è molto forte, così lo volevo, il prefetto sarà giallo di bile.”
‟Domani lo faremo diventar verde,” rispose Joanna, ringalluzzendosi, sorridendo.
‟Ecco, giusto quello che voleva dirvi. Bisogna che v'informiate precisamente se hanno intenzione di dare quei tali appalti, di cui vi parlai, a trattative private. Sarebbe uno scandalo.”
‟M'informerò, e se è vero....”
‟Anche se non è vero, bisogna fare un articolo sul sospetto, sul caso probabile, m'intendete?”
‟Ho inteso, vedrete domani,” disse Paolo, con una magnifica sicurezza.
‟E questo bel bambino,” soggiunse il signor cavaliere, carezzando i riccioli di Riccardo, ‟diventerà anch'esso un giornalista. Quand'è che farai il tuo primo articolo, piccolino?”
‟Presto, signor cavaliere,” rispose prontamente Riccardo, imitando la sicurezza di suo padre.
‟Ci conto dunque,” disse il proprietario del giornale, ridendo e andandosene.
Il padre e il figliuolo si guardarono con gli occhi lucenti.
‟Non è mica cattivo il signor cavaliere,” osservò Riccardo, sorbendo il suo punch alla romana, un sorbetto biancastro, nel bicchiere, che spezzava in due il pranzo ed era lo chic, l'orgoglio di quel pranzo a prezzo fisso.
‟Ma che! è bonissimo, eppoi è un uomo che sa apprezzare, capisci. Questo vale molto, nel lavoro.”
‟Ha molti quattrini, papà?”
‟Moltissimi: è un riccone,” rispose Paolo Joanna, tutto vanaglorioso, come fosse lui a esser così ricco.
‟Chi glieli ha dati?”
‟Il Tempo, perbacco! Avere un giornale è una gran cosa, figlio mio: ci si arricchisce come nulla.”
E a malgrado la precocità del bambino, a malgrado la quotidiana, dolorosa esperienza del padre, nessuno dei due pensò o disse della propria decente miseria, di quello stento giornaliero a cui non vi era via di scampo. Padre e figlio, verso la fine di quel pranzo, vedevano la vita gradevolmente: era con un contegno di piccolo principe, di fanciulletto ricco e vizioso che Riccardo rifiutava l'insalata russa che accompagnava due quaglie arrosto, le ultime quaglie della stagione: era una smorfia di piccolo principe scontento quella di Riccardo al cospetto della bavarese gialla e tremolante, un dolce che non gli piaceva. Peppino ne era umiliato. Padre e figlio, guardandosi con una vaga espressione di beatitudine negli occhi, con un lento sorriso di soddisfazione sulle labbra, dopo aver ben pranzato, sembravano ed erano due persone soddisfatte dell'esistenza. Un amico entrò, un uomo dalla prolissa barba nera, vestito meschinamente: capitava sempre al Caffè di Europa all'ora del pranzo, ma avendo già pranzato in qualche oscura osteria da studenti, nei vicoli di Toledo, e non prendeva nulla, dava del tu a tutti i camerieri, come un frequentatore assiduo: usciva poi di là, con qualcuno che vi trovava, come se avessero pranzato insieme, ridendo e chiacchierando ad alta voce. Così la gente che lo vedeva, supponeva che egli fosse un gaudente della terra: e lui aveva occasione di poter dire, discorrendo, altrove, con una certa bonomia di signore: iersera, pranzando al Caffè di Europa....
‟Ciao, Joanna.”
‟Ciao, caro: pranzi?”
‟No, ho pranzato, figurati, un invito noioso, una specie di banchetto.”
‟Prendi un caffè, allora?”
‟Preferisco un cognac, mi hanno dato della chartreuse orribile in questo banchetto. Senti, ero venuto per raccomandarti quel libro di mio cognato, mi hai promesso un articolo da tanto tempo.”
‟Lo farò, lo farò.”
‟Sai, mio cognato ci tiene, ci tiene assai. Voi altri giornalisti, quanto vi fate pregare! Debbo diventare giornalista anche io; che vuoi, è una carriera piena di soddisfazione; io t'invidio, Joanna.”
‟Peuh! Peuh! non c'è male, ha i suoi vantaggi....”
‟Altro che vantaggi. Voi potete tutto, voi create tutto: la fama e il disonore, la fortuna politica e la fortuna finanziaria, voi lanciate una prima donna, una commedia, una nuova bibita, una nuova invenzione, voi fate cadere il Ministero,” e si buttò in gola il bicchierino di cognac, dopo avere spifferato la convenzionale tiritera che tutti gli sciocchi ripetono.
‟Come si fa a diventar giornalisti?” soggiunse poi.
‟Bisogna nascerci,” disse, con una certa importanza, Paolo.
‟Io lascerò lo studio del mio avvocato, egli assorbisce tutto, non mi dà un affare: io mi slancerò nella stampa, mi ci sento la vocazione. Intanto fammi l'articolo pel cognato.”
‟Te lo farò.”
‟Te lo dimentichi? Eccolo, lo dirò al bambino, a questo bel bambino. Ricordateglielo voi, caruccio mio, che egli deve fare un articolo al cav. Leutari, sul libro La nave nel diritto internazionale.”
‟Non dubitate, signore, glielo ricorderò.”
L'avvocato senza cause andò via, passando dalla scaletta interna, per farsi vedere agli avventori delle sale terrene. Paolo e Riccardo avevano deciso di andar a prendere il caffè al Gran Caffè, dieci passi più innanzi, dirimpetto al palazzo reale; e Paolo pagò il conto, dieci lire e ottanta centesimi, cinquanta centesimi per Peppino che era un cameriere troppo signore per lasciargli meno, e trenta pel cognac. A quell'ora flutti di gente attraversavano Piazza San Ferdinando, salivano e scendevano per Toledo: Paolo teneva per mano Riccardo. Un giovane bruno, con gli occhiali, dal profilo stranamente somigliante a un gallinaccio, passando, strinse la mano a Joanna e gli disse:
‟Bravo, mi congratulo tanto pel vostro capocronaca.”
Nelle sale interne del Gran Caffè faceva troppo caldo, padre e figlio sedettero fuori, sulla strada, dove si allungava una fila di tavolini, circondati da persone che bevevano il caffè o sorbivano un gelato.
‟Vuoi il gelato, Riccardo?”
‟No, papà, voglio il caffè.”
‟Portami anche dei trabucos,” ordinò Paolo Joanna al cameriere.
Sotto un lampione, l'uno accanto all'altra, i due piccoli venditori di giornali stavano fermi, tenendo il loro fascio di giornali. E la sorellina dava il grido:
‟I' mazzate d'i' Cammere, vulit'u Temp!”
E il fratelluccio, con una voce più flebile, riprendeva:
‟I' mazzate d'i' Cammere, vulit'u Temp!”
‟Papà, dimmi, che è questa cosa che gridano quei due piccolini?”
‟Nulla, Riccardo: è per vendere il giornale.”
‟Ma non ci è, nel giornale?”
‟No, Riccardo.”
‟Allora perchè gridano così?”
‟Te l'ho detto, per vendere il giornale.”
‟E quelli che non ce la trovano, che dicono?”
‟Niente: che vuoi che dicano?”
‟Ah!” fece soltanto il bimbo, come quando gli dicevano qualche cosa che lo sbalordiva.
Ma un signore vecchiotto, dai mustacchi bianchi, dalla carnagione rosea, dagli occhi vivi salutò Joanna e venne a sedersi al suo tavolino.
‟Posso offrirvi qualche cosa, signor commendatore?...” domandò, tutto premuroso, Joanna.
‟Grazie, grazie.”
‟Un buon trabucos?”
‟Questo sì: ma ditemi, che vi ha fatto quel povero prefetto?” e sorrideva argutamente.
‟A me? niente.”
‟E allora? Come è che lo tormentate tanto?”
‟Proprio si tortura assai?”
‟Sicuro: ogni volta che apre il Tempo si fa livido: questa sera avrà la febbre, io credo.”
‟Credete?” e rideva d'orgoglio.
‟Infine smetterete?”
‟No, no, non smetto sino a che il governo non lo traslochi.”
‟Mi pare difficile: il ministro dell'interno non si occupa dei giornali.”
‟E fa male, commendatore. Il prefetto sarà traslocato, vedrete.”
‟Si consolerà facilmente: ha tanti quattrini!” soggiunse filosoficamente il commendatore. ‟Venite al Sannazaro questa sera? È la serata dell'Amalia: ci andiamo tutti, un momento. Ma forse questo bel ragazzo avrà sonno?” e gli carezzava una guancia.
‟Io non ho mai sonno, o signore, domandate a papà,” rispose, tutto baldanzoso, il piccino.
‟Oh, Riccardo è un omino,” soggiunse il padre.
Il commendatore si allontanò, dopo aver presa una gardenia da una fioraia, una bella fioraia, dalla fisonomia corretta e fredda, vestita di broccato nero, con due rose bianche nei capelli rialzati e due stelloni di brillanti alle orecchie. Ella, dopo aver sorriso al commendatore, fece il giro dei tavolini, arrivò a quello di Paolo Joanna:
‟La vuole, una rosa?” chiese ella con la sua voce tranquilla e armoniosa.
‟Dammela pure.”
‟A questo bel bambino gli darò dei gelsomini.”
E diresse al bimbo un affettuoso sorriso che agli uomini non dirigeva mai: il bimbo la contemplava, estatico, per quel volto purissimo, di un biancore delicato, per quella nobiltà dello sguardo. Paolo le dette una lira: ella la gittò graziosamente in fondo al paniere, senza guardarla, e si allontanò col suo passo lieve lieve. Riccardo stringeva il mazzolino dei gelsomini. Paolo Joanna pagava il conto al cameriere, una lira di sigari, settanta centesimi fra caffè e mancia.
‟Questa fioraia mi pare che somigli alla mamma,” mormorò il bambino, riattaccandosi alla mano del padre per andare al teatro Sannazaro.
‟No, no, Riccardo.”
‟Sì, quando ride, papà.”
‟No, la mamma era tutta un'altra cosa.”
‟Sì, è vero, era tutta un'altra cosa: ma quando rideva, papà... non rideva sempre la mamma. Perchè, papà?”
‟Era seria,” disse brevemente il padre.
A un tratto, in mezzo alla folla che ingombrava la Via di Chiaia, fra tante ricche botteghe, fra tanti lumi, fra il chiasso serotino estivo napoletano, il piccolino pareva preso da una grande malinconia. Camminava piano, si faceva trascinare, guardava svogliato, come distratto, le vetrine scintillanti.
‟Vorrei avere la mamma, papà: la mamma mi voleva bene,” diceva, sottovoce, in mezzo a quella folla, il bambino triste.
‟E io non ti voglio bene?”
‟Sì, sì, ma vorrei avere la mamma.”
‟Ma che hai, nino mio?”
‟A casa mi secco, solo: Marianna è noiosa e la padrona di casa è brutta.”
‟Ma ti maltrattano forse?”
‟No, no, ma mi secco, vedi. Se ci fosse la mamma, resterei. La mamma non ci è, non mi lasciare più solo solo, papà.”
‟Ti porterò sempre con me, Riccardo: non dire più queste cose.”
‟Portami sempre con te, papà: non mi lasciare mai.”
Nella folla il padre si chinò per baciare il suo bambino. Erano giunti al Ponte di Chiaia, al fioraio che sta sotto l'arco.
‟Dovremmo portare dei fiori all'Amalia, Riccardo.”
‟Sì, sì, portiamoglieli, ella mi dà sempre i confetti.”
‟Glieli darai tu, Riccardo: un mazzo ci darebbe troppo fastidio, compreremo dei fiori sciolti.”
Ma i fiori sciolti, in quella calda stagione che bruciava tutti i fiori, costavano molto. Per due gardenie, per quattro o cinque rose bianche, per dei bastoncelli carichi di fiammanti gerani, con un po' di cetronella e qualche ramoscello di vainiglia già quasi appassito, il fioraio voleva sei lire. Paolo Joanna discusse lungamente sul prezzo col fioraio: voleva lasciare i fiori e andarsene: ma Riccardo li aveva già presi e li teneva stretti; si dovette venire a patti; il fioraio strillando li lasciò per quattro lire. Riccardo si avviò in trionfo verso il teatro Sannazaro:
‟L'Amalia sarà contenta: i fiori sono molto belli,” disse quasi a sè stesso, a modo di consolazione, Paolo.
Innanzi alla porta del teatro, dei giovanotti stazionavano. Uno di essi si mise a parlare con Joanna, mentre Riccardo aspettava, sulla soglia, impaziente.
‟Vi è molta gente?”
‟Pieno zeppo: l'Amalia fa una bellissima serata. Io non avevo biglietto, sono stato in piedi, ma ora ne ho abbastanza.”
‟Vieni dunque,” diceva Riccardo.
‟Ci avete i biglietti, voi, Joanna?”
‟Noi andiamo in palcoscenico,” disse Paolo, con un gesto di padronanza.
Infatti si avviarono per un piccolo corridoio laterale, sino a una porta pesantemente foderata di panno.
‟Stampa,” disse Paolo, al custode.
Camminavano per un passaggio stretto, fra il muro e le quinte: Riccardo in punta di piedi, temendo di far rumore. Il marito dell'Amalia in parrucca bianca, marsina di broccato e spadino, con un pizzo finto attaccato al mento, appena li aveva visti, aveva sorriso loro, ma posando un dito sulle labbra: l'Amalia era in iscena, vestita da uomo, recitando nelle Prime armi di Richelieu: ella faceva andare in estasi il pubblico, il marito dalle quinte ne sorvegliava il successo, gelosamente. Come un'eco lontana, fioca, giungevano gli applausi. Il marito dell'Amalia, lusingato, crollava il capo e sorrideva: oramai egli non aveva amor proprio che per lei.
‟Milleottocento lire,” diss'egli, senz'altro, a Paolo Joanna.
‟Perbacco!” esclamò l'altro, meravigliato.
‟Dodici mazzi di fiori.”
‟Belli?”
‟Peuh!”
‟Regali?”
‟Un ventaglio e un anello: belli.”
‟Per la stagione, ti devi contentare.”
Parlavano pianissimo, come un soffio: erano risaliti verso il fondo, dietro la scena, in una penombra vasta, piena di cassoni, di tavoloni, dove delle ombre si agitavano vagamente, senza far rumore. Riccardo si teneva stretto a suo padre. Sempre il palcoscenico gli faceva un certo effetto, di sgomento e di curiosità: quel luogo strano, che non rassomigliava nè a una piazza, nè a una trattoria, nè a una chiesa, nè a una casa, che non rassomigliava a nulla, quel parlottío basso e quelle voci lontane che venivano dal palcoscenico, quei comici bizzarramente camuffati, con le guance dipinte, le labbra dipinte, gli occhi dipinti, che si movevano in quella penombra, con la faccia stanca o indifferente, aspettando il loro turno, colpivano la immaginazione del fanciullo.
‟Qui Riccardo ha portato i suoi fiori,” mormorò Paolo.
‟Andiamo ad aspettare l'Amalia in camerino: ora finisce l'atto,” rispose il marito.
Nel camerino il gas fiammeggiava, il caldo era soffocante: le sedie erano coperte di vestiti, di mantelli, di asciugamani: una cagnetta dormiva in un angolo, arrotolata sopra una gonnella di raso rosso: le scarpette erano sbandate, una da una parte, l'altra dall'altra: un paio di calze di seta pendeva dalla spalliera di una sedia: la cameriera, con un paio di occhi imbambolati dal sonno, inginocchiata dinanzi alla tradizionale cesta, cavava il vestito femminile di una commedia in un atto: Lei, voi, tu, di Cagna. Riccardo restava immobile presso la toilette, non osando sedersi, aspirando quell'aria muschiata, guardando i mazzi di fiori sparsi dappertutto, per terra, sopra una mensoletta, alla porta del camerino. Uno stupore teneva il piccolino. Paolo Joanna e il marito dell'Amalia chiacchieravano fra loro. Ma un rumore lontano s'intese: vestita da Richelieu adolescente, con un'aria da birichino, l'Amalia comparve, portando dei fiori, tutta riscaldata in volto, tutta nervosa.
‟Ecco,” disse semplicemente al marito, dandogli i fiori.
‟Quindici,” fece costui.
E subito, con la sveltezza abituale delle attrici, si mise a disfare la sua acconciatura, con le mani un po' tremanti.
‟Ecco dei fiori, signora Amalia,” disse fievolmente il piccino.
‟Oh caro, caruccio, quanto sei gentile, ti voglio dare un bel bacio.”
La bella faccia tutta dipinta di roseo, con gli occhi sottolineati di bistro e le labbra come sanguinanti, si chinò sul bimbo e lo baciò: egli restò tutto interdetto.
‟Se continuate così, signora Amalia, mio figlio prenderà una terribile passione per voi,” e rideva.
‟Lo spero bene: ma Riccardo l'ha digià. Non è vero, piccolo, che mi vuoi tanto bene?”
‟Assai, assai,” disse il piccolino, seriamente.
‟Allora padre e figlio,” disse Paolo. ‟Ti esorto a sorvegliare mio figlio, Giovanni, più di me.”
‟Ci baderò,” rispose il marito, continuando lo scherzo.
E andò a far mettere i fiori avuti in dono dalla moglie, nel salotto moderno che è la scena del Lei, voi, tu. Senza far cerimonie, Amalia era passata dietro un paravento a vestirsi e un po' parlava sottovoce con la cameriera, un po' discorreva, ridendo, ringraziando, salutando le persone che venivano nel camerino. Scostando una mantiglia di merletti, Riccardo si era seduto sull'angolo di una sedia e teneva i piedi tirati indietro per non disturbare la cagnetta che continuava a dormire, in quell'aria calda, odorosa di muschio. L'Amalia uscì di dietro al paravento, già vestita per la commedia, tutta seducente in un vestito scintillante di perline, scollato in quadrato sul petto. Stringeva la mano a questo, a quello, giornalisti, critici, vecchi buontemponi, frequentatori di palcoscenico, che le parlavano all'orecchio, o sottovoce, ed ella si arretrava, ridendo, tutt'amabile, tutta nervosa, esaltata dai complimenti, dai fiori, dagli applausi.
‟Voglio fare una dichiarazione d'amore a Riccardo,” esclamò, a un tratto, l'attrice.
Prese i gerani rossi e se ne acconciò un gruppetto fra i neri capelli.
‟Sto bene così?” domandò al bambino.
Gli astanti ridevano: anche Paolo Joanna. Il bambino crollò il capo, per dire di sì, ma non parlò. Per l'odore, forse, pel caldo di quel camerino, per l'ora avanzata, una crescente stupefazione invadeva il cervello del bambino: il pallore si allargava sul suo visino. Si teneva sul suo angolo di sedia, come stordito, con un piccolo sorriso sulle labbra, un sorriso vago di persona sofferente.
‟Poi verrai a trovarmi, nevvero, Riccardo? Ti darò i confetti!”
Scappò fuori, perchè la musica era finita e l'atto cominciava: gli ammiratori, gli amici si dispersero per quella penombra del palcoscenico: alcuni, più pazienti, si sedettero su certi cassoni, parlando a bassa voce, aspettando l'Amalia, per accompagnarla a casa. Paolo Joanna aveva attaccato una discussione politica con un suo collega della stampa, collega e avversario, un Calabrese barbuto e dottrinario, che parlava con un forte accento di Calabria, e pieno di entusiasmo per la politica si irritava dello scetticismo di Paolo Joanna.
‟Andiamo, Riccardo.”
Tutti e tre si avviarono, Riccardo piccolo piccolo, in mezzo ai due uomini: era quasi mezzanotte. Nella strada la discussione si riscaldò. I due uomini cercavano di convincersi l'un l'altro, si fermavano, gesticolavano, si afferravano il bottone del soprabito, tutti infatuati. Con una sommissione infantile, mentre il sonno gli piombava, pesante, sulle palpebre, Riccardo si fermava anch'esso: e fermandosi, si addormentava leggermente, in piedi, svegliandosi improvvisamente, quando i due uomini si avviavano di nuovo. In quel dormiveglia, egli non capiva nulla di quello che dicevano suo padre e il Calabrese, egli non sentiva che un fastidioso ronzío nella sua piccola testa di creatura stanca: egli non capiva neppure più in che strada si trovassero, ma la via per arrivare a casa gli sembrava lunghissima, eterna. Suo padre, infervorato nella discussione, nottambulo del resto, non si accorgeva del tormento del suo bambino: e il piccolino non si lagnava, oppresso dal sonno, tenendosi lungo il muro per non vacillare. Le sue gambine lo portavano a mala pena, il sonno, prepotente, gli si era diffuso per tutta la persona: gli sembrava di camminare da ore e ore, senza mai arrivare, e nella piccola anima, esaurita di stanchezza, si formulava solo questo desiderio:
— Venisse la casa, venisse! —
A Toledo la discussione, vivace, era passata all'arte: alla Pignasecca, dove Paolo Joanna doveva voltare, si parlava del socialismo. Il Calabrese invitò Joanna ad accompagnarlo un po' più su, sino a Piazza Dante, dove abitava: e il giornalista nottambulo stava per farlo:
‟Oh papà!” disse lamentosamente, nel sonno, la povera creaturina.
E il padre fu tanto commosso da quella voce, che salutò in fretta il collega e si levò in collo il suo bambino — il quale si lasciò prendere e portare, addormentato sulla spalla del padre. Silenzio profondo nella Pignasecca — e l'aria un po' umida della notte. Una carrozzella passò lentamente, ritirandosi alla stalla.
‟Papà?” disse il bimbo, levando il capo.
‟Riccardo?”
‟Non hai più denari, è vero?”
‟Ho... ho ancora una lira, credo.”
‟E domani?”
‟Domani? Qualche santo provvederà.”
‟Va bene, papà.”
E si riaddormentò.