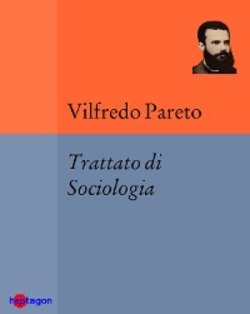Читать книгу Trattato di Sociologia - Парето Вильфредо - Страница 3
ОглавлениеI. PRELIMINARI
A sua moglie JANE RÉGIS PARETOper le cui affetuose curepoté compiere l'opera divisataomaggio diVilfredo Pareto
Dichiarazione delle norme seguite in quest'opera. – Le scienze logico-sperimentali e le scienze non logico-sperimentali. – Le loro differenze. – Il campo sperimentale è assolutamente distinto e disgiunto dal campo non-sperimentale. – In quest'opera intendiamo rimanere esclusivamente nel campo sperimentale. – Il nostro studio è essenzialmente contingente, e tutte le nostre proposizioni debbonsi intendere colla restrizione: nei limiti di tempo, di spazio e dell'esperienza a noi noti. – Esso è in un continuo divenire, procede per approssimazioni successive, e non ha menomamente di mira di raggiungere il certo, il necessario, l'assoluto. – Considerazioni sul linguaggio delle scienze logico-sperimentali, delle scienze non logico-sperimentali, sul linguaggio volgare. – Dichiarazione di vari termini da noi usati in quest'opera. – Le definizioni sono semplici cartellini per indicare le cose. – I nomi così definiti si potrebbero sostituire con semplici lettere dell'alfabeto.
§ 1 – § 40.
§ 1.
La società umana è soggetto di molti studi. Alcuni costituiscono discipline speciali, come, ad esempio, quelli che concernono il diritto, l'economia, la storia politica, la storia delle religioni e simili; altri non esistono ancora con nomi distinti. Alla loro sintesi, che mira a studiare in generale la società umana, si può dare il nome di sociologia.
§ 2.
Tale definizione è imperfettissima; può forse essere migliorata, ma non di molto, poiché infine di nessuna scienza, neppure delle diverse scienze matematiche, si ha una definizione rigorosa; né si può avere, perché l'oggetto della nostra conoscenza solo per comodo nostro si divide in varie parti, e tale divisione è artificiale e varia col tempo. Chi sa dire ove stanno i confini tra la chimica e la fisica, tra la fisica e la meccanica? Della termodinamica, cosa dobbiamo fare? Se la vogliamo mettere nella fisica, non ci starà male; se preferiamo dare ad essa luogo nella meccanica, non vi starà come estranea; e se poi ci piace farne una scienza distinta, nessuno ce ne darà colpa. Ma, invece di perdere tempo per sapere dove essa ha da aver luogo, sarà miglior consiglio studiare i fatti di cui si occupa. Lasciamo stare i nomi e guardiamo alle cose.
Similmente, abbiamo meglio da fare che perdere il tempo per ricercare se la Sociologia è, o non è scienza autonoma, se è altro che la filosofia della storia, con altro nome; o per lungamente ragionare sui metodi da seguire nel suo studio. Occupiamoci di ricercare le relazioni tra i fatti sociali, e poi lasciamo che a tale studio si dia il nome che si vuole, e che con qualsiasi metodo la conoscenza di queste relazioni si ottenga. A noi preme il fine, molto meno e anche niente i mezzi che ad esso adducono.
§ 3.
A proposito della definizione della Sociologia, abbiamo ora dovuto dichiarare certe norme che intendiamo seguire. Potremmo fare lo stesso per altri argomenti, man mano che ne sorgesse l'opportunità; oppure possiamo, una volta tanto, esporre queste norme in un capitolo speciale, che servirà d'introduzione al nostro studio. Ognuno di questi modi di operare ha i suoi pregi ed i suoi difetti. Qui preferiamo usare il secondo di questi modi.
Parecchi argomenti che in questo capitolo accenniamo assai brevemente, saranno poi svolti nel rimanente dell'opera, ove pure si troveranno le prove di alcune proposizioni che sono qui solamente enunciate.
§ 4.
In due modi ben distinti si possono esporre i principii che un autore vuole seguire, e cioè: 1) Si può chiedere che quei principii siano accettati come verità dimostrate; nel qual caso ogni loro logica conseguenza si avrà pure per dimostrata; 2) Si possono, invece, porre quei principii come semplice indicazione di una via tra le tante che si potrebbero seguire; nel qual caso ogni loro conseguenza logica non è per niente dimostrata nel concreto, ed è solo ipotetica quanto e come le premesse da cui è tratta. Perciò spesso si dovrà astenersi dal trarre tali conseguenze, si lascerà da parte questa parte deduttiva dall'argomento, e si concluderanno direttamente le relazioni dai fatti.
Vediamo un esempio. Poniamo che ti si esponga il postulato di Euclide come un teorema. Tu dovrai dare battaglia su questo punto; perché, su tu concedi il teorema, tutta la geometria Euclidea è dimostrata, e non puoi più nulla ad essa opporre. Ma poniamo che al contrario ti si proponga il postulato come un'ipotesi; tu non avrai più da contendere su di esso; lascia pure che il geometra ne tragga le conseguenze logiche; se queste sono d'accordo col concreto, le accetterai, e se non ti paiono d'accordo, le rifiuterai; la tua libertà di scelta non è vincolata da una preventiva concessione. Considerate le cose in questo modo, ci sono altre geometrie non Euclidea, e tu puoi studiarle senza vincolare per nulla la tua libertà di scelta nel concreto.
Notiamo che se i geometri si fossero impuntati a volere, prima di proseguire negli studi, decidere se sì, o no, il postulato di Euclide corrisponde al concreto, la geometria neppure oggi esisterebbe. Quest'osservazione è generale. Le scienze tutte hanno progredito, quando gli uomini, invece di contendere sui principii, hanno discusso i risultamenti. La meccanica celeste si è costituita coll'ipotesi della legge dell'attrazione universale. Oggi si dubita che l'attrazione possa essere altra di quello che si credeva; ma quando anche ciò fosse accertato, mercè nuove e migliori osservazioni, i risultamenti ai quali giunse la meccanica celeste rimarrebbero sempre, e ci sarebbe solo da fare ritocchi ed aggiunte.
§ 5.
Ammaestrati dall'esperienza, vogliamo provare ad usare nello studio della Sociologia i mezzi che furono tanto utili nello studio delle altre scienze. Quindi noi non poniamo come premessa del nostro studio nessun domma, e l'esposizione dei nostri principii sta solo come indicazione della via che, fra le molte che si potrebbero scegliere, vogliamo seguire. Perciò chi con noi per questa si mette, non rinunzia punto a seguirne un'altra.
Sino dalle prime carte di un trattato di geometria è doveroso per l'autore di fare sapere al lettore se egli sta per esporre la geometria Euclidea, oppure, ad esempio, la geometria del Lobacefschi; ma questo è un semplice avviso; e se egli espone la geometria del Lobacefschi non vuol già dire che egli neghi il valore delle altre. In questo senso, e non diversamente, devesi intendere la dichiarazione di principii che qui facciamo.
§ 6.
La Sociologia è stata sinora quasi sempre esposta dommati-camente. Non t'inganni il nome di positiva appioppato dal Comte alla sua filosofia: la sua Sociologia è dommatica quanto il Discours sur l'histoire universelle del Bossuet. Sono religioni diverse, ma pur sempre religioni; e di questo genere ne trovi anche nelle opere dello Spencer, del De Graef, del Letourneau, e di infiniti altri autori.
La fede, per indole propria, è esclusiva. Chi crede di possedere la verità assoluta, non può concedere che altre verità ci siano nel mondo. Perciò sono, e debbono essere, altrettanto intolleranti, il fervido cristiano ed il pugnace «libero pensatore». Quindi, per chi ha la fede, una via sola è buona, tutte le altre sono cattive. Il musulmano non vorrà giurare sul Vangelo, né il cristiano sul Corano; ma chi non ha fede alcuna, giurerà su questo o su quel libro, e anche sul Contratto sociale del Rousseau, se ciò faccia piacere ai credenti umanitari, e neppure rifiuterebbe di giurare sul Decamerone del Boccaccio, non fosse altro che per vedere il muso che farebbero il Bérenger ed i credenti nella religione di questo messere.
Non stimiamo punto inutili Sociologie che prendano le mosse da certi principii dommatici, come non crediamo menomamente inutili le geometrie del Lobacefschi e del Riemann; solo a queste Sociologie chiediamo di usare premesse e ragionamenti chiari e rigorosi quanto è possibile.
Di Sociologie «umanitarie» ne abbiamo a iosa, tali essendo quasi tutte quelle che ora si pubblicano; di Sociologie metafisiche non soffriamo difetto, e tra esse sono da porsi tutte le «positiviste» e tutte le umanitarie; di Sociologie cristiane, cattoliche, e simili, ne abbiamo in piccolo numero; ci sia concesso, senza volere fare torto a tutte queste Sociologie, di esporne qui una esclusivamente sperimentale, come la chimica, la fisica, ed altre simili scienze.