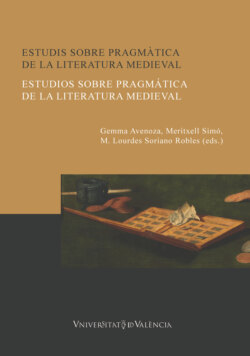Читать книгу Estudis sobre pragmàtica de la literatura medieval / Estudios sobre pragmática de la literatura medieval - AA.VV - Страница 9
ОглавлениеAPPUNTI PER UNA PRAGMATICA INTERSCRITTORIA
MEDIEVALE: CANZONIERI
E LIBRI DEL GOVERNO A CONFRONTO A
MONTPELLIER
GILDA CAITI-RUSSO Università di Montpellier gilda.russo@univ-montp3.fr orcid.org/0000-0002-0388-4388
Riassunto: La nozione di scripta permette di riflettere sulla possibilità di confrontare macro-generi scrittòri studiati finora separatamente, come i canzonieri dei trovatori e i libri governativi dei consolati cittadini. Questi ultimi sono in effetti più affidabili in termini di datazione e di localizzazione poiché sono, per così dire, l’emanazione linguistica della collettività cittadina retta da un consolato. La recente edizione dei Thalami della Montpellier medievale (libri governativi, appunto) porta elementi necessari alla definizione di una scripta cittadina declinata in due modelli cronologici distinti. Il confronto con i canzonieri trobadorici redatti nella regione, in particolare il canzoniere E, sia al livello della grafia che della progressione degli statuti testuali, sarà quindi l’oggetto principale di questo contributo.
Parole chiave: Montpellier, scripta, canzonieri, thalami, prosa occitana.
NOTES FOR A MEDIEVAL INTER-SCRIPTORIAL PRAGMATICS: MONTPELLER’SONGBOOKS AND LEGISLATIVE BOOKS COMPARED
Abstract: The concept of scripta, allows us to reflect on the possibility of comparing scriptorial macro-genres studied so far separately such as the troubadours’ chansonniers or the local customary government books of the town consulate. The latter are more reliable in terms of dating and localization since they are, so to speak, the linguistic expression of the community town ruled by a consulate. The new edition of the medieval Thalami of Montpellier has elements necessary to define a town scripta split in two distinct chronological models. Its comparison with the troubadour chansonniers written in this region, particularly the chansonnier E, as regards the handwriting but also the progression of the textual status is the main object of this paper.
Keywords: Montpellier, scripta, chansonniers, thalami, Occitan prose.
1. COME DEFINIRE IL TESTO MEDIEVALE?
La nozione di «testo» è per la medievistica una nozione problematica, impossibile da definire una volta per tutte, se non per il suo carattere di estrema alterità rispetto ai canoni odierni del lettore colto ma non specialista, al quale il testo arriva ormai sempre più depauperato della sua originaria e intrinseca complessità.
Tale complessità è dovuta, in primo luogo, all’entropia progressiva rappresentata dalla trasmissione manoscritta, con la ricchezza della sua varia lectio. «Il testo è come un viaggiatore che perde un bagaglio a ogni sosta del suo viaggio» (la frase è di A. C. Clark, citato in M. Zaccarello, 2017: 3): per lungo tempo, il mestiere del filologo è stato la restituzione del testo più vicino possibile all’originale, dopo aver passato al setaccio tutte le testimonianze manoscritte (recensio) e aver stabilito la genealogia delle varianti (stemma codicum).
Ogni testimonianza manoscritta contiene però in sé, secondo il ben noto postulato di D’Arco Silvio Avalle, una doppia verità filologica: quella di anello della catena della trasmissione di un testo da restituire nel modo più scientifico possibile, ma anche quella di testimonianza unica di uno stadio storico unico e irripetibile di quello stesso testo: non più ipotesi riconstitutiva, ma accettazione altrettanto scientifica dell’esistenza di una parte di «irrecuperabilità» del testo originario (Avalle, 2002).
Al di là delle posizioni teoriche che hanno visto lo scontro dei sostenitori di una delle due «verità» contro l’altra (neo-lachmaniani contro béderiani; poi filologia tradizionale contro New Philology), quello che a noi importa qui è che la realtà dei testi supera ogni immaginazione e si rivela irriducibile tanto alla reductio ad unum così come agli eccessi dell’ipertestualizzazione (Cerquiglini, 1989).
Il caso della tradizione dei Thalami di Montpellier è in questo senso emblematico dell’irriducibilità della testualità medievale ad un modello unico. I libri del governo di Montpellier, benché dotati di un alto valore simbolico, non rappresentano, come nel caso dell’opera di un autore letterario, diverse copie di un testo scritto in precedenza, ma piuttosto le diverse fasi di una scrittura memoriale collettiva, commissionata dai consoli della città e gestita per quasi due secoli (ininterrottamente dal 1260 al 1426) dai notai del consolato. Si tratta quindi di una testualità, consapevolmente e programmaticamente progressiva, in cui, in modo paradossale, il testimone più importante è proprio l’ultimo anello della catena. Lasceremo da parte la sezione giuridica di tale scrittura memoriale, non ancora sufficientemente studiata, e ci soffermeremo invece sulla parte storiografica. Il percorso delineato dalla collazione dei libri del governo di Montpellier è quello del passaggio dalla forma primitiva di ogni storiografia, quella delle tavole annalistiche, fatte di liste di date e di nomi, per intenderci, ad una vera e propria prosa storiografica cittadina, unica nel suo genere. Intendiamo in questa introduzione indicare che la prospettiva nella quale ci muoviamo è quella di una filologia che prenda in considerazione elementi un tempo trascurati sopratutto dai provenzalisti littéraires, come la variazione grafica tra i testimoni. Tale variazione costituisce un oggetto di studio a sé stante, pronto a fornire ai Thalami di Montpellier l’evoluzione della grafia in lingua volgare in tempi diversi ma ravvicinati. L’edizione della totalità dei testimoni della tradizione manoscritta in TEI1 permette appunto questo studio. Non verrà presa in considerazione la prospettiva paleografica, cosa della quale siamo spiacenti. Tale prospettiva, sicuramente complementare a quella dell’analisi dei modelli grafici, dovrebbe avvenire in un secondo momento e ci auguriamo che un archivista-paleografo possa un giorno dedicarsi con passione a questo studio per il quale non ci riteniamo sufficientemente competenti.
Lo studio della variazione grafica della sezione storiografica dei Thalami di Montpellier costituisce un esempio notevole, facilmente databile e diacronico della scripta della città in anni cruciali per la stesura dei canzonieri trobadorici, redatti nella Linguadoca orientale. Il confronto tra la scripta di Montpellier e la grafia dei canzonieri della regione di Montpellier, o di quello che di essi resta, diventa dunque non solo possibile, ma persino auspicabile.
La prospettiva adottata porterà in un secondo momento sull’analisi degli statuti testuali della pagina manoscritta alla ricerca di elementi che possano indicare le modalità della genesi testuale della prosa. La questione della prosa occitana medievale potrà dunque essere affrontata anche da questo punto di vista e susciterà più ampie analogie.
2. LA SCRIPTA CONSOLARE DI MONTPELLIER
Cominciamo dalla tradizione manoscritta degli annali occitani di Montpellier (parte storiografica dei Thalami)
A. Arch. nat. de France, J 339, n.º 23
B. Arch. mun. de Montpellier, AA 4
C. Paris, NAF 4337
D. Bruxelles, KBR 20807-809
E. Paris, BnF fr. 14507
F. Paris, BnF fr. 11795
G. Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine H119
H. Montpellier, Arch. Mun. AA9
I codici siglati A e B sono riservati ai Thalami in latino, detti «grandi», perché si ispirano maggiormente alle dimensioni del cartulario signorile, mentre i più piccoli, i Thalami parvi, redatti in occitano, si differenziano non solo per le dimensioni, ma anche per una più larga diffusione che giustifica la presenza di copie in gran parte perdute (Chastang, 2014: 124-130). Queste due tipologie di scrittura, i grandi e i piccoli Thalami, sono di per sé la testimonianza di una diversificazione degli usi della scrittura consolare a Montpellier. La ricostruzione della storia istituzionale a partire dalla struttura e dalla cronologia degli archivi «pietrificati» della città è di certo molto suggestiva, ma qui ciò che interessa è la scripta consolare come testimonianza unica nel suo genere di un livello di lingua estremamente elevato, che si prolunga per un lasso di tempo cruciale dal 1220 al 1426, per la parte storiografica dei Thalami. Ci serviremo dunque dello studio di Chastang come punto di partenza per andare verso lo studio della grafia dei codici.
È possibile dividere cronologicamente questi sei manoscritti in 4 fasi diverse.
Ogni coppia è stata datata a un decennio di distanza rispetto alla precedente. La prima coppia,
A. Arch. nat. de France, J 339, n.º 23
B. Arch. mun. de Montpellier, AA 4
unisce le due parti di uno stesso codice poi smembrato e catalogato in due unità diverse. Il codice A contiene solo le liste consolari: è stato redatto nel 1235, in latino. Il codice B contiene invece gli annali storiografici latini cominciati nel 1247. Si passerà in modo spettacolare all’occitano nel momento in cui si cominciano a scrivere in parallelo i nuovi codici, detti piccoli Thalami. Si tratta di:
C. Paris, NAF 4337
D. Bruxelles, KBR 20807-809
Essi rappresentano la fase più antica della scrittura consolare in occitano, il cui inizio è databile negli anni 1258-1260.
La terza coppia è rappresentata dai manoscritti:
E. Paris, BnF fr. 14507
F. Paris, BnF fr. 11795
redatti dopo il 1270; F è stato però continuato fino all’inizio del XIV secolo e presenta caratteristiche più vicine all’ultimo anello della catena, la coppia GH.
L’ultima coppia è stata appunto redatta a partire dall’ultimo decennio del XIII secolo: come per la coppia precedente, c’è un manoscritto che si ferma (G) e un altro che continua a essere oggetto di redazione fino all’inizio del XIV secolo (H).
G. Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Médecine H119
H. Montpellier, Arch. Mun. AA9
Sarà interessante vedere se questa datazione codicologica dello scritto pubblico di Montpellier può essere confermata e precisata dallo studio della variazione grafica dei codici. Rispetto allo stadio attuale delle ricerche, lo studio grafico dei codici può appoggiarsi solo sulla parte storiografica, che chiameremo delle Annales occitanes, la cui edizione è ormai terminata. Più ampi riscontri dovranno essere realizzati in futuro a partire dallo studio dei testi giuridici che sono ancora in fase di edizione.
Vediamo dunque quello che è possibile ricavare da una collazione grafica dei manoscritti al livello delle Annales dei Thalami.
È possibile identificare tratti grafici costanti in tutti i manoscritti, che rivelano una certa stabilità della scripta pre-diglossica, probabilmente confortata da abitudini grafiche già consolidate (cf. infra).
1. La dittongazione condizionata di o breve latina tonica ha curiosamente per esito grafico <ue> con pochissime occorrenze per <uo> che corrisponde invece secondo Mushacke (1884) all’esito attuale nella parlata di Montpellier [ɥɔ]; questo primo rilievo è particolarmente notevole perché sembra invertire la direzione dell’evoluzione del segmento [ɥɛ] > [ɥɔ] così come è stata in genere ricostruita (Ronjat: [ɥɔ] > [ɥɛ] (1930-1941, § 105).
2. L’affricata palatale sorda [ʧ] è rappresentata dalla <g> (ex. Benezeg); di conseguenza il digramma <gu> viene a indicare l’occlusiva velare sonora [g] (ex. paguatz).
3. Il digramma <nh> è largamente maggioritario nella rappresentazione di n palatale [ɲ] fin dai manoscritti latini. Le grafie ibride rappresentano una percentuale trascurabile (Caiti-Russo 2014, 310).
4. La sibilante sorda [s] è rappresentata davanti alle vocali <e>,< i>, indifferentemente da <s> o da <c>. (ex. Marceilla pour Marseilla).
5. La sibilante sonora [z] è rappresentata maggiormente dal grafema <z>.
È possibile rintracciare però anche almeno tre tratti grafici distintivi:
Il digramma <lh> per la palatale laterale [ʎ] appare una sola volta nei Thalami più antichi, mentre si generalizza a partire dal secondo codice della coppia EF che è il codice di transizione verso la coppia successiva (ante 1270) ed è la sola possibilità data negli ultimi codici GH (post 1290).
La palatale laterale [ʎ] è dunque rappresentata nei codici CDE con <(i) l(l)>. Esempi tratti da C: voilla de VOLIA*, conseill de CONSILIU*, fil de FILIU*.
Noteremo, d’altra parte, che la presenza del grafema <y> per /i/ semiconsonantica in iato è costante per FGH mentre questo grafema è utilizzato solo per i nomi propri stranieri e, oltretutto, mai in iato nei manoscritti della serie CDE.
Parliamo infine dell’esito del suffisso latino –ARIU* che dà nella serie CDE <–er> nei nomi propri (Berenger de BERENGARIU*) confondendosi d’altronde con l’esito di –ERIU* (Planter de PLANTERIU*) e <–ier> nei nomi comuni (ex. USURARIU* > usurier); il suffisso femminile – ARIA evolve in <–eira> al femminile (Madeira). I tre manoscritti FGH presentano invece dovunque <–ier> e vanno fino alla trittongazione <–ieira> per il femminile.2
Degli otto tratti grafici registrati, 5 sono comuni e 3 distintivi: se i primi permettono di seguire la continuità della scripta, gli ultimi ne definiscono, per così dire, l’evoluzione. Si definiscono così due modelli grafici con la loro possibile datazione: da un lato quello di CD + E (1258-1270) e dall’altra FGH (post 1290). Sembrerebbe legittimo a questo punto confrontare i modelli grafici ottenuti per la scripta storiografica con quelli dei canzonieri composti in tempi e luoghi non troppo distanti da quelli dove hanno visto la luce i Thalami di Montpellier. Il confronto si giustifica, tanto più che si tratta, nel caso della storiografia consolare come in quello della poesia dei trovatori, di due livelli di lingua estremamente prestigiosi, entrambi carichi di valori simbolici legati a un patrimonio identitario. Bisogna anche ricordare che la scripta dei Thalami non è il riflesso della variante locale del diasistema:
Quel rapport cet occitan écrit entretient-il avec la forme orale telle que la parlent les Montpelliérains au Moyen Âge? Même s’il est difficile d’avoir une idée précise de ce que pouvait être l’occitan vernaculaire à Montpellier à cette époque, tout travail sur la langue ne doit pas se limiter à comparer la langue écrite du Petit Thalamus avec la seule forme dialectale dont nous ayons hérité aujourd’hui. Il ne faut pas tenter non plus de voir dans cet occitan écrit médiéval un simple reflet phonétique, lexical et syntaxique de l’occitan parlé à Montpellier du XIIIe au XVe siècles bien que l’on puisse déceler ça et là quelques évolutions majeures du système linguistique que l’écrit enregistre, sans doute avec un certain retard sur les pratiques orales. La langue du droit et de l’administration n’est pas la langue du peuple et, aujourd’hui comme hier, le registre écrit officiel n’est pas représentatif des usages populaires d’une langue. Même si le travail de codification écrite de l’occitan au sein des Annales occitanes est bien loin d’avoir la rigidité d’une norme graphique comme nous la concevons aujourd’hui, il présente toutefois déjà des choix normatifs embryonnaires qui, comme le montrent certains indices (voir infra), établissent une distance claire avec la forme orale vernaculaire de l’époque. (Lieutard, 2017: 230).
Cominciamo con il Libre di Miquel de la Tor, dichiaratamente scritto «estant en Montpellier». Questo canzoniere, di cui si è perduto l’originale, è tuttavia ricostitutible anche graficamente (Careri, 1991 e 1996). Il suo sistema grafico è appunto per F. Zufferey da ricondurre senz’altro al canzoniere E (Paris, BnF fr. 1749) localizzato nella regione di Béziers-Montpellier «qui offre l’un des systèmes graphiques les plus cohérents qui soient» (Zufferey, 1985: 171).
A differenza degli altri due canzonieri linguadociani, C (Paris, BnF fr. 856) e R, (Paris, BnF fr. 22543), la cui variazione grafica ha sempre costituito un’evidenza, il canzoniere E ha operato una vera e propria normalizzazione grafica, rendendo più ardua la ricerca delle sue fonti risalenti ai rami ypsilon e epsilon. È importante anche notare che l’autore del canzoniere E è un native speaker libero dalle interferenze che potevano prodursi negli scriptoria italiani.
Può essere interessante paragonare il canzoniere E ai due modelli grafici definiti in precedenza a partire dalla tradizione manoscritta dei Thalami di Montpellier, scripta assolutamente legata a una città e databile con una certa precisione.
Nel canzoniere E non solo si ritrovano quelli che abbiamo definito come tratti della scripta storiografica montpellierana del XIII secolo, ma il manoscritto si posiziona chiaramente rispetto a quelli che abbiamo chiamato tratti distintivi (il grafema <yod>, l’evoluzione di –ARUM e la grafia della laterale palatale).
Il grafema <y> è impiegato solo nella trascrizione di nomi stranieri mai in iato per indicare <i> semiconsonantica: Ysac, Ypolite.
L’evoluzione del suffisso latino –ARUM è reso con <er>/ ou <ier> e <–eira> (ex. ribeira); non si registra nessuna occorrenza del suffisso tridittongato <–ieira>.
La grafia etimologica <(i)l(l): es. meillor < MELIORE* e aussi filla < FILIA. Vi si trova persino la forma Orlac de ORLLACO, che figura nel thalamus C. Questi raffronti permettono dunque di confortare l’ipotesi legata alla provenienza della scripta, formulata da Zufferey e recentemente confermata da C. Menichetti, avvicinandola maggiormente agli usi scrittòri di Montpellier.
D’altra parte, la corrispondenza tra il modello grafico del canzoniere E e quello dei Thalami siglati CDE permette anche di ipotizzare per il canzoniere una possibile retrodatazione agli anni 1258-1270 (terzo quarto del 1200). Sono chiaramente necessari altri sondaggi per poter avvalorare con più certezza quest’ipotesi.
3. TRADIZIONE MANOSCRITTA, LANGUAGE-SHIFT
Il paragone tra il canzoniere E e la tradizione manoscritta dei Thalami può essere esteso, se si vuole, anche ad un’altra dimensione: quella dell’evoluzione degli statuti testuali. La tradizione storiografica di Montpellier potrebbe in effetti non essere priva di legami analogici con l’evoluzione delle vidas e razos in alcuni canzonieri tra cui appunto E.
La storica G. M. Spiegel3 ha da tempo messo in evidenza come i language-shift, cioè i cambiamenti che caratterizzano la lingua, (come il passaggio dal latino al volgare) ma anche i procedimenti discorsivi, siano segni palpabili di cambiamenti storici profondi perché i gruppi sociali coinvolti in evoluzioni storiche significative tendono a utilizzare in modo consapevole modelli discorsivi alternativi.
Nella tradizione della parte storiografica dei Thalami di Montpellier, le tavole annalistiche, che elencano laconicamente le liste consolari anno dopo anno, evolvono progressivamente nell’ultimo manoscritto. È noto quanto l’uso della glossa in margine e la sua integrazione nella fase successiva della tradizione manoscritta abbiano permesso ai testi di espandersi per amplificatio (Vid. Wolf-Bonvin, 1999).
Nella tradizione dei Thalami di Montpellier è possibile vedere in un solo codice quello che accade nelle amplissime tradizioni manoscritte dei testi letterari dotati di grande fortuna: il processo di evoluzione dello statuto testuale dal margine al corpo del testo. Tali menzioni narrative in margine prendono nel codice H il sopravvento sulle menzioni nominali annalistiche dando vita a un vero e proprio testo storiografico, che, non a caso, i primi editori critici del testo (Vid. Pegat e Thomas, 1836-1840, vol. 4) avevano staccato dal resto della tradizione chiamandolo chronique romane.
La creazione di una testualità storiografica a partire da forme non-discorsive e arcaiche come gli annali carolingi e monastici non può non sfuggire a chi percorre la tradizione dei Thalami montpellierani (Cai-ti-Russo, 2017).
Il primo language-shift dei Thalami è costituito dal passaggio dal latino all’occitano, a partire dal 1258 per D, per B nel 1260. Questa prima data, il 1258, segna il rinnovato equilibrio tra magistratura consolare e autorità reale dopo una vera e propria ribellione all’autorità reale al suono della campana che chiama i cittadini alle armi.4
Il secondo language-shift, discorsivo è costituito dal cambiamento di statuto testuale cioè dal passaggio dallo stato iniziale di tavole annalistiche storiografiche, elenchi di evenimentz e antiquitatz e liste consolari (è lo stadio dei codici più antichi) all’avvicinamento gerarchizzato delle due tipologie e alla migrazione progressiva delle glosse dal margine verso il corpo del testo, sede di una testualità sempre più complessa. La genesi di questa forma di testualità nuova avviene durante la lunga e incerta fase che segna l’evoluzione del consolato montpellierano. La morte di Giacomo nel 1276 segna il passaggio da Montpellier al regno di Maiorca con Giacomo II.5 Anche qui la tensione tra il potere aragonese e la universitas di Montpellier è palpabile in seguito al giuramento prestato al sovrano che, al di là delle forme, non doveva per la città essere un atto di sottomissione.6 Il 1280 è l’anno del tentato omicidio di Pierre de Clermont luogotenente del re di Maiorca. La città fa parte dello scacchiere continentale del conflitto franco-aragonese cominciato con i vespri siciliani ed è coinvolta nella crociata francese contro gli aragonesi. Nel 1282 Montpellier, dopo l’assedio della città da parte del senescalco di Beaucaire, riconosce la sovranità del re di Francia, al quale il re di Maiorca presenterà l’omaggio l’anno seguente. L’anno 1285 segna lo stabilirsi del dominio francese sul Rossiglione.7
La magistratura consolare rappresentantiva dell’universitas della città, la comunità cittadina, gli «home de Montpellier», che aveva goduto nella prima metà del secolo di una relativa autonomia, diventa qui teatro del dispiegamento del rapporto di forza tra due regni: quello di Francia e quello d’Aragona. Questa storia esterna non può non essere rispecchiata nei libri del governo, memoria vivente della collettività cittadina sotto l’egida dei notai del consolato. Non è dunque un caso che il passaggio ad una vera e propria testualità narrativa avvenga in anni non lontani da questi. Nel manoscritto AA9 lo sviluppo narrativo si manifesta attraverso i parallelismi sintattici all’interno di una stessa unità narrativa e attraverso la variazione su uno stesso tema narrativo in unità successive.
Diamo un esempio dei parallelismi sintattici:
Item, en aquel an meteys a XII setembre que fon divenres, a lums atuzatz, cazet tan gran conglapi de peyras e tant abrivadas, am tant gran aondansa d’aigua, que tota la majer partida dels teules dels ostals de Monpeslier trenqueron las dichas peyras, car segon que comtavon alcus, lo casegron peyras que pezavon una lieura, et avia n’i que pezavon IIII lieuras e X lieuras e de XXV lieuras. E fon tan gran l’auratge que menet que derroquet lo cloquier de Sant Martin de Prunet et de Nostra Dona de Chaulet e derroquet gran multitut d’albres, de grans e de grosses a gran meravilhas e d’ostals. E foron tan gran aondansia d’ayguas que set bestias carguadas de trossels de draps que venian de la fieyra de Pezenas que passavon a la poncha Sant Cristol ne menet l’aygua entro al portalet de Sant Bertolmieu et aqui negueron.8
Per i parallelismi tematici, bisognerà ricordare le innumerevoli processioni raccontate nella cronaca, dove la comunità cittadina (la universitas) è definita dal percorrimento ritualizzato e sacralizzato della stessa città o ancora dalle tappe di un altro viaggio rituale sul quale ha attirato l’attenzione D. Gouiran in un recente convegno: quello di papa Urbano V, enfant du pays, scortato dalle galee genovesi difronte al quale si inginocchia l’ecumene.
L’esempio dei Thalami sembra illustrare in modo evidente il legame tra cambiamenti discorsivi e mutamento storico espresso consapevolmente dalle élites cittadine (notai consolari).
Quale è ora la relazione analogica che, con molta prudenza, possiamo stabilire con il canzoniere E?
F. Zinelli (2002) ha ipotizzato nella tradizione manoscritta trobadorica due modelli di disposizione dei testi in prosa (le vidas e le razos appunto) rispetto ai testi in versi: mentre la maggior parte della tradizione manoscritta alterna il paratesto in prosa ai testi in versi, conseguenza logica di un’integrazione a testo di possibili note aggiunte in margine, RE e P9 (ma anche a loro modo il Libre de Miquel e i canzonieri catalani Sg e V10) tendono invece a autonomizzare i testi in prosa che costituiscono come si sa, sezioni anche codicologicamente separate nei canzonieri citati. Il senso della cronologia di quest’evoluzione vedrebbe il modello di REP come modello posteriore e innovativo rispetto a quello più tradizionale riflettuto dagli altri manoscritti.
Zinelli ipotizza per il canzoniere E, dotato di una sezione autonoma di vidas e razos, una genesi analoga di cui vedremmo soltanto la fine: il compilatore del canzoniere avrebbe liberato il paratesto in prosa del suo ruolo di commento, della sua funzione strumentale e subalterna di accessus ad auctorem. Le vidas sono redatte su due colonne esattamente come i testi in versi e non hanno alcuna relazione apparente con i testi poetici dei trovatori presenti nelle altre sezioni.
Al di là delle ricostruzioni erudite che permettono di separare un E lirico da un E biografico che rivelano le relazioni nascoste tra i canzonieri R et E, è necessario soffermarsi, nel nostro contesto, proprio sulla nascita di un discorso in prosa autonomo e innovante.
L’autonomizzazione di uno statuto testuale dipendente che passa da semplice commento a testo vero e proprio è un cambiamento discorsivo notevole di cui il canzoniere E ci rende partecipi. Al cambiamento dello statuto testuale si aggiunge anche l’amplificazione narrativa e ideologica.
La vida di Perdigon è un unicum dove l’autore introduce un discorso «di parte», una presa di posizione anti-francese, legata certo alla crociata della prima metà del secolo ma i cui riferimenti non potevano non richiamare la situazione in cui il canzoniere veniva assemblato.
Et estan en aquella honor et en aquel pretz, el anet ab lo primse d’Aurengua, en Guilem dels Baus, et ab En Folquet de Marceilla, evesque de Toloza, et ab l’abas de Sistel a Roma, sercan lo mal del comte de Toloza e per azordenar la crozada. Per que fon dezeretatz lo bos coms Raimons de Toloza; e sos neps, lo comps de Bezers, fon mortz, Tolzan e Caersin e Bederes e Albuges fon destruisitz; e mortz lo reis Peire d’Aragon ab mil cavaliers davan Murel e XX milia d’autres homes en foron mortz.
A totz aquestz faitz far e azordenar fon Perdigos, e.n fetz prezicansa en cantan; per que las gens se crozeron; e fes lauzor a Dieu, quar li Frances avion desconfit lo rei d’Aragon e mort, lo cals lo vestia ab se. Per qu’el descasec de pretz, d’onor e d’aver; e l’agr’en enequitat tug li valen home que remazeron viu, que no.l volgron vezer ni auzir.
E tug li baron de la soa amistat foron mort per la guerra: lo coms de Monfort e ‘N Guilem dems Baus e tug l’autre c’avian faita la crozada; e lo coms Raimons ac recobrada la terra.
Perdigons non auzet anar ni venir; el Dalfins d’Alvernhe li ac touta la terra e la renda qu’el l’avia dada. El s’en anet a Lombert de Monteill, qu’era genre d’en Guilem dels Baus, e preguet lo que lo fezes rendre en una maizo de l’ordre de Sistel, qu’a nom Silvabela. Et lo fes recebre en una morguia per morgue; e lai el definet.
Et aqui son escriutas de las soas cansos.11
Il canzoniere E amplifica la vida duecentesca di Perdigon, piuttosto laconica e banale in altre fonti, aggiungendo particolari inediti. Insomma Perdigon, benché inizialmente sostenuto dal re d’Aragona, sarebbe passato dalla parte dei signori occitani che appoggiavano i francesi: della crociata, «e.n fetz prezicansa en cantan».
La figura di Perdigon permette il ritorno su avvenimenti ancora vicini e dolorosi, sopratutto tenendo conto dell’attualità di una Provenza diventata angioina. Il testo più tardo del canzoniere è la pastorella di Paulet de Marseille L’autrier m’anav’ab cor pensiu (BEDT 319,6), segnata da una forte presa di posizione anti-francese che rinvia, come i quattro unica del trovatore catalano Guillem Raimon de Gironela, all’entourage del re d’Aragona. È sul padre del re d’Aragona del 1266, cioè su Pietro II
mortz lo reis Peire d’Aragon ab mil cavaliers davan Murel e XX milia d’autres homes en foron mortz
che si sofferma l’autore della biografia del canzoniere E e sappiamo quanto i trovatori abbiano cercato invano di suscitare la (ri)conquista aragonese dell’Occitania perduta a Muret con la morte di Pietro.
Non si è forse sufficientemente pensato al canzoniere E come a un tentativo programmatico di ricostruire la memoria poetica occitana ricorrendo a tutte le fonti possibili e rifondendole in una grafia unificata, immagine di una cultura che ricostruisce il suo passato per orientare il presente (ogni vera storia è storia contemporanea, secondo l’insegnamento non ancora superato di B. Croce).12
La genesi testuale delle Annales occitanes, benché posteriore e ben più spettacolare, rende più comprensibile l’evoluzione delle vidas del canzoniere E e le mette in rapporto con il duplice language shift dei Thalami: il passaggio della cancelleria di Montpellier dal latino all’occitano in anni vicinissimi a quelli della compilazione del canzoniere (una nuova dignità è conferita allo scritto vernacolare) e l’evoluzione interna della tradizione manoscritta, in cui le élites autoctone tentano nuove modalità discorsive. La pragmatica interscrittoria può probabilmente aiutarci ad individuare la genesi e la direzione nella nascita di una prosa vernacolare nella regione di Montpellier e a datare diversamente la consapevole e orientata patrimonializzazione rivendicativa rappresentata dal canzoniere E nel terzo quarto del Duecento.
BIBLIOGRAFIA
Edizioni
Thalami di Montpellier (2017): Edizione elettronica e critica secondo il protocollo della TEI <http://thalamus.huma-num.fr/> équipe interdisciplinaire ANR s. d. [consultato 09/03/2017].
Canzoniere provenzale E (2017): Edizione meccanica (numerizzata) del canzoniere provenzale E: Paris, BnF fr. 1749. <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000801v.r=.langEN> s.d. [consultato 09/03/2017].
Pégat Ferdinand e Eugène Thomas (1836-1840): Thalamus parvus: le petit thalamus de Montpellier: publié pour la première fois d›après les manuscrits originaux, Montpellier, Jean Martel Aîné, 4 vols.
Studi
AVALLE, D’Arco Silvio (2002): La doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria del medioevo romanzo, Firenze, Edizioni del Galluzzo.
CAITI-RUSSO, Gilda (2014): «Écrire pour la ville. Écrire ‘la ville’: notes pour une nouvelle édition des Petits Thalami de Montpellier», in Patrick Gilli et Enrica Salvatori (dirs.): Les identités urbaines au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, Turnhout, Brepols, pp. 303-312.
— (2017): «L’émergence de la textualité du corps documentaire», in Vincent Challet (ed.) et Gilda Caiti-Russo et Yven Mausen (cols.): Aysso es lo comessamen. Écritures et mémoires du Montpellier médiéval, Montpellier, PULM, pp. 231-240.
CAITI-RUSSO E GRIMALDI, Marco (2015): «La complexité documentaire à l’épreuve de la TEI. Les enjeux d’une édition électronique des Petits Thalami de Montpellier», in Pierre Chastang, Francine Mora-Lebrun e Anne Rochebouet (eds.): L’Ecriture de l’Histoire au Moyen Âge; Contraintes génériques, contraintes documentaires, Paris, Garnier, pp. 293-310.
CARERI, Maria (1991): «Alla ricerca del libro perduto: un doppio e il suo modello ritrovato», in Madeleine Tyssens (éd.): Lyrique romane médiévale: la tradition des chansonniers, Liège, Université de Liège, Faculté de Philosophie et Lettres, pp. 329-378.
— (1996): «Per la ricostruzione del Libre di Miquel de la Tor. Studio e presentazione delle fonti», Cultura Neolatina, 61, pp. 251-209.
CERQUIGLINI, Bernard (1989): Éloge de la variante: histoire critique de la philologie, Paris, Seuil.
CHALLET, Vincent (2015): «Une reconstruction mémorielle. Écritures et ré-écritures du ‘Petit Thalamus’ de Montpellier», in Vincent Challet (ed.) et Gilda Caiti-Russo et Yven Mausen (cols.): Aysso es lo comessamen. Écritures et mémoires du Montpellier médiéval, Montpellier, PULM, pp. 277-291.
CHASTANG, Pierre (2014): La ville, le gouvernement et la ville (XIIe et XIVe siècles). Essai d’histoire sociale, Paris, Seuil.
CRESCINI, Vincenzo (1992): Manuale di avviamento agli studi provenzali, con una post-fazione di Alberto Varvaro, Roma, Gela reprint.
CROCE, Benedetto (1935): La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza.
GERMAIN, Alexandre (1851): Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, J. Martel Aîné, 4 vols.
GRAFSTRÖM Åke (1958): Étude sur la graphie des plus anciennes chartes languedociennes avec un essai d’interprétation phonétique, Uppsala, Almqvist & Wiksells.
LIEUTARD, Hervé (2017): «L’occitan, langue officielle du consulat montpélliérain», in Vincent Challet, Gilda Caiti-Russo et Yven Mausen (cols.): Aysso es lo comessamen. Écritures et mémoires du Montpellier médiéval, Montpellier, PULM, pp. 217-230.
MENICHETTI, Caterina (2015): Il Canzoniere provenzale E, Strasbourg, ELi-PHi Éditions.
MUSHACKE, Wilhelm (1884): Geshichtliche entwicklung der Mundart von Montpellier (Languedoc), Heilbronn, Henninger.
PFISTER, Max (1972): «La localisation d’une scripta littéraire en ancien occitan (Brunel ms 13 British Museum 17920», Travaux de linguistique et de littérature, 10, pp. 253-291.
RONJAT, Jules (1930-1941): Grammaire istorique [sic] des parlers provençaux modernes, Montpelhièr, Société des Langues Romanes, 4 vols.
SPIEGEL, Gabrielle M. (1999): «Theory into practice. Reading medieval chronicle», in Erik Kooper (ed.): The Medieval Chronicle. Proceedings of the 1st Internacional Conference on the Medieval Chronicle (Driebergen / Utrech 13-16 July 1996), Amsterdam, Brill - Rodopi [vol. 2], pp. 1-12.
WOLF-BONVIN, Romaine (1999): De la Tradition latine à l’esthétique du roman médiéval, Paris, Champion.
ZACCARELLO, Michelangelo (2017): L’edizione critica del testo letterario, 4.2 Dinamiche di trasmissione di testi, sessione temporanea aperta su <https://www.academia.edu>, in attesa di pubblicazione a stampa.
ZINELLI, Fabio (2003): «Quelques remarques sur le chansonnier E», in Rossana Castano, Saverio Guida e Fortunata Latella (eds.): Scène, évolution, sort de la langue et de littérature d’oc, Actes du 7e Congrès de l’AIEO, Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002, Rome, Viella, tome 1, pp. 761-790.
ZUFFEREY, François (1985): Recherches linguistiques sur les chansonniers provençaux, Genève, Droz.
1 Text encoding initiative. Per l’applicazione di questo protocollo all’edizione elettronica si veda l’introduzione all’edizione dei Thalami <http://thalamus.huma-num.fr>, opera collettiva sotto il patrocinio dell’ANR (Agence Nationale pour la Recherche).
2 L’evoluzione del suffisso –ARIU* –ARIA* tonico in <–er> <–eira> è registrata da Grafstörm (1958) ad Agen e nel Quercy alla fine dalla metà del XII secolo, nel tolosano alla fine dello stesso secolo; le forme <–ier>, <–ieira> esistono ma sono largamente minoritarie e saranno registrate dagli scribi molto dopo anche in Provenza. Nell’albigese e nel tolosano ci sono altre forme concorrenti come <–eir> al maschile probabilmente rimodellato su <–eira>.
3 Spiegel (1999: 5): «Social groups most affected by changes in status tend to be most conscious of alternative modes of discoursive behaviour».
4 Questa data segna nei Thalami la «composicion» la conciliazione tra le due parti (il re e i consoli) e quindi la fine del conflitto iniziato nel 1252 in merito ai cosiddetti oboli di Lattes. L’episodio è citato in D «En l’an de M et CC LII demande lo rei Jacme rei d’Aragon las mezallas de Latas e lendeman de l’Apareccion apres cobreron lus li home de Monpeslier la cloca dels armatz» [citato in Challet, (2015: 290), dove però la menzione del manoscritto comporta una datazione erronea (si tratta non del 1295 ma del ben più vicino 1258-1260) e dove l’editore francesizza in demanda il demande del manoscritto].
5 L’autonomia del consolato montpellierano è dovuta al vuoto di potere creatosi dopo la morte di Pietro II d’Aragona a Muret, alla giovane età di Giacomo e sopratutto allo spostamento del baricentro espansionistico del regno verso il Mediterraneo.
6 Germain (1851: t. II, 348) ha evidenziato che il giuramento era avvenuto flexis genibus e che la universitas non aveva gradito quest’atto simbolico di omaggio al sovrano.
7 Il conflitto franco-aragonese deve essere letto in relazione ai vespri siciliani, che videro gli aragonesi impadronirsi della Sicilia angioina. Giacomo II, re di Maiorca, si era alleato con Filippo III re di Francia. Pietro III d’Aragona, suo fratello, occupò Perpignano ma i francesi, contrattaccando, arrivarono fino a Girona.
8 Testo citato dall’edizione elettronica e critica in TEI del Petit Thalamus de Montpellier (vid. bibliografia).
9 Si tratta dei codici seguenti: canzoniere provenzale C: Paris, BnF fr. 856 datato al XIV secolo, copiato a Narbona; canzoniere provenzale R: Paris, BnF fr. 22543, datato al XIV secolo e copiato nel Languedoc occidentale; canzoniere provenzale P, Firenze, Biblioteca medicea laurenziana, Pl. XLI. 42 redatto in Italia, datato 1310.
10 Si tratta del Cançoner provençal (Cançoner Gil), Biblioteca de Catalunya, ms. 146 (secolo XIII); Cançoner Vega-Aguiló (Biblioteca de Catalunya mss. 7-8).
11 Canzoniere provenzale E, f. 120.
12 «Il bisogno pratico, che è nel fondo di ogni giudizio storico, conferisce a ogni storia il carattere di “storia contemporanea”, perché, per remoti e remotissimi che sembrino cronologicamente i fatti che vi entrano, essa è, in realtà, storia sempre riferita al bisogno e alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni» (1935: 5).