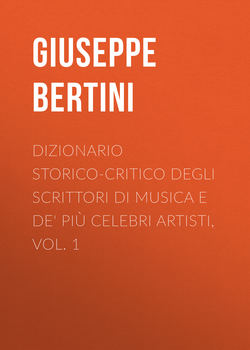Читать книгу Dizionario storico-critico degli scrittori di musica e de' più celebri artisti, vol. 1 - Bertini Giuseppe - Страница 3
DISCORSO PRELIMINARE
ОглавлениеL'Italia “quella celebre nazione, alla quale null'altro rimane della sua antica grandezza, che quella delle idee nelle Bell'Arti”1: l'Italia il bel paese della musica, che per raro caso la fè rinascere nel suo seno in mezzo alla barbarie, che signoreggiava nel resto dell'Europa: l'Italia, a cui, per confession medesima dell'altre culte nazioni debbonsi i progressi, la perfezione e la più nobil cultura di quest'arte: l'Italia, io dico, contenta sol della gloria di aver dati all'Europa intera i più gran genj coltivatori della medesima, le migliori Opere didattiche, la migliore Scuola, e i più perfetti modelli per la pratica, niuna briga si è presa finora di coltivare la Bibliografia Musicale, cioè quella porzione di Storia, che riguarda le notizie degli autori, e delle loro Opere2. Quale storia letteraria o biografica della Musica si è infatti intrapresa giammai nell'Italia? e sebbene da Letterati di estere nazioni siansi date fuori più Opere in questo genere, quale traduzione almanco se ne è fatta dai nostri? Cosicchè un Hawkins, un d.r Burney fra gl'Inglesi3: un d.r Forkel, un Mitzler, un Greber, un Walther, un Gruber fra' Tedeschi, ed altri moltissimi, le di cui Opere riscontrar si possono in più articoli di questo Dizionario, sono tutt'ora nomi ignoti alla più parte degli amatori ed artisti di nostra nazione, non che per difficoltà d'intenderli nelle loro lingue originali, come ancora per lo scarso commercio che de' loro libri si fa nell'Italia. Sì fatta considerazione mi ha mosso ad intraprendere il presente Dizionario, il quale comecchè atto non sia a riempir del tutto il voto della nostra letteratura, contiene non pertanto i materiali tutti della Storia letteraria della musica, e tutte ne addita le fonti, onde più agevolmente tesser la possa, quando il voglia, alcun valente italiano, fornito di lumi e di talenti, che fanno a tal uopo.4
Tra l'ordine cronologico, e quello delle materie, io ho prescelto l'ordine alfabetico, perchè più comodo riesca a' miei Lettori, qualora venga lor pensiero di soddisfare all'occasione la curiosità di sapere in qual tempo e in qual luogo fiorì quel tale Scrittore, quel tal Compositore, quel tal celebre Artista: quali Opere scrisse quegli e intorno a qual ramo della Musica: quali composizioni musicali e con quale successo diè al pubblico quell'altro: quale singolar merito ebbe nell'esecuzione quell'Artista: e quantunque convenga io benissimo dell'utilità del primo metodo, che di mano in mano darebbe una storia progressiva dell'origine e degli avanzamenti di quest'Arte e Scienza: nè men vantaggioso io nieghi esser l'altro nel ripartire gli Autori giusta l'ordine delle materie, e secondo quella porzione, ch'essi han coltivata, della Musica: ho proccurato tuttavia, che non totalmente defraudati vengano i Lettori del doppio vantaggio che trar si può da ambi questi metodi. Per il primo io darò alla fine di tutta l'Opera una Tavola Cronologica, che disporrà tutti i Scrittori e gli Artisti, di cui abbiam ragionato ne' rispettivi loro articoli, secondo l'ordine dei tempi. L'oggetto di questa Tavola si è d'esporre in una maniera pronta e sensibile i progressi successivi delle cognizioni musicali presso tutte le nazioni. In riguardo al secondo, daremo da prima un quadro di tutti gli aspetti, sotto a' quali può riguardarsi la Musica, che servir possa come d'introduzione alla storia di quest'Arte e Scienza, ed alla fine del Dizionario si darà un Catalogo ragionato, ovvero una Biblioteca scelta di tutti gli autori disposti giusta l'ordine delle materie, sulle quali hanno eglino scritto.5
Può dunque considerarsi la Musica o come Arte o come Scienza. Riguardata come arte ella è un linguaggio che ha per elementi quella specie di suoni, che meglio dinotar non si possono che col termine di Suoni musicali6: linguaggio che del pari d'ogn'altro, ha per oggetto di piacere, di dipingere, o di muovere7. All'arte musica in generale si appartiene la disposizione de' suoni in quanto al tuono, in quanto al ritmo ed all'altre modificazioni, di cui son essi suscettibili, come eziandio la scelta de' segni, co' quali vengono rappresentati. A questo ramo dell'Arte musicale si appartengono tutti i Scrittori di Elementi, di Principj, cioè delle prime nozioni grammaticali di questo linguaggio, come ancora gli Autori de' Dizionarj musicali, in quanto spiegano essi i termini tecnici, i segni e i caratteri sì antichi che moderni della Musica.
Quest'Arte si divide in due rami; l'esecuzione, e la composizione. La prima insegna a trovare, mercè l'interpretazione de' caratteri, i suoni con tutte le loro modificazioni, e a riprodurli per mezzo degli organi e degl'istrumenti d'ogni specie: essa ha quindi molte divisioni relative a questi stromenti, e alle modificazioni del suono. L'arte che riguarda l'organo della voce, dicesi Musica vocale, e quella che riguarda i suoni di varj stromenti, dicesi Stromentale. Tutti quegli, che hanno scritto su la maniera di cantare, e sulle regole di formare, di modificare e di riprodurre i suoni con la voce: come ancora quelli che co' loro trattati, insegnano la maniera di sonare i diversi stromenti, o pneumatici, o lirici, appartengono a questo ramo della Storia dell'arte. La Musica Arte è quello che in altra maniera si chiama la Musica Pratica, denominazione, che può ben adottarsi, posto che non ci porti a confondere un sistema fondato sopra osservazioni assai giuste, assai delicate e spesso molto profonde con l'uso e 'l puro abito, che non è se non la cognizione della pratica scevra ed isolata dalle considerazioni di ragione, di gusto e di sentimento, sulle quali essa è stabilita. Ristretta ne' suoi limiti, l'Arte basta a se stessa, e colui che giunge ad essere eccellente anche in una sola delle sue menome parti, ottiene a buon diritto (che che dir ne possano alcuni ignoranti e presuntuosi teorici) il titolo di Musico, e la qualificazione di Artista. Per tal ragione destinati abbiamo varj articoli a più celebri Cantanti, ed a più egregj e valenti Suonatori, che si han fatto un nome al mondo sì negli antichi, che ne' moderni tempi.
Dopo aver considerata la Musica Arte come un linguaggio, che ha per elemento il suono musicale, bisogna successivamente conoscere come il tuono e la durata, che ne sono le prime modificazioni, sottoposte, quello alla modalità, questa al ritmo, producano mercè le loro combinazioni la sillaba, la parola, la frase e 'l discorso musicale; come queste medesime modificazioni, della stessa maniera che le altre, sono la sorgente degli effetti: come quest'effetti caratterizzano i varj stili, rinforzano l'espressione, operano l'azione della Musica, e sono il germe delle idee. Sotto questo rapporto han luogo tutti coloro che hanno scritto sulla Rettorica e poetica musicale: dell'unione della musica con la poesia8, dell'applicazione della medesima musica alle diverse forme del discorso, e de' varj stili di chiesa, di teatro, di camera ec.
La Composizione è l'arte di far della musica. Questa definizione, per quanto ella sembri, e veramente sia triviale e bassa, è non per tanto la migliore che dar si possa di quest'Arte. La parte Didattica, che consiste nelle regole della Composizione, forma piuttosto una scienza di cui si dirà in appresso: quì intendiamo solo la pratica di cotesta scienza, ed essa comprende tutti i Compositori di Musica sì antichi, che moderni. De' primi (per i quali intendo i Greci, i Romani e alquanti Arabi de' tempi culti), assai pochi annoverati verranno in questo Dizionario, stante che niuna produzione e scarse notizie ci sopravvanzan di loro: e de' moderni vi ha forse troppo gran copia, comecchè mi sia pur ristretto a far menzione soltanto de' più rinomati e più celebri, ben sapendo da Orazio che
mediocribus esse poetis
Non homines, non dii, non concessere columnae.
Ma come per i moderni s'intendono tutti i Compositori che han fiorito dopo il risorgimento di quest'Arte nell'Europa, ho dovuto per conseguenza abbracciare la serie de' più secoli, ne' quali gran numero veramente troviamo di bravi scrittori, le di cui composizioni, se non hanno il merito del gusto alla moda, han quello dell'originalità e della scienza9. Mi sono bensì astenuto dal rapportare i nomi di tutti quei gotici Compositori di madrigali, di enimmi musicali e di quelle tante difficili inezie onde in certi tempi era caricata la musica, “da paragonarsi (come riflette un dotto autore) agli anagrammi, logogrifi, acrostici, paranomasie, equivoci, e simili sciocchezze, ch'erano in voga presso a' poeti del seicento10.”
Una ragionevole delicatezza mi avrebbe dovuto far ancora astenere di parlar degli Autori, e de' Compositori tuttora viventi: ho voluto non pertanto contentare anche in questo la più parte de' miei Lettori, e non lasciare una considerevol lacuna nella storia dell'Arte e degli Artisti, a costo di meritar la taccia di avermi voluto erigere in censore o in panegirista di persone, cui la posterità sola ha dritto di giudicare. Mi lusingo tuttavia di poter disporre questi severi Aristarchi a scusare questa mia apparente temerità, qualora vorranno riflettere, che della stessa maniera si sono condotti gli Autori di Biografie musicali di sopra citati: ed allorchè vedranno eglino con quale circospezione ed accortezza mi son io condotto in così delicata e malagevole impresa.
Che se vuolsi ora riguardar la musica come Scienza, essa si divide ancora in due parti, cioè la Teoria e l'Erudizione musicale. La prima è quella scienza, per la quale quest'Arte è ridotta in principj11. Il Fisico disaminando la natura del Suono, e cercando la cagione delle sue modificazioni: ed il geometra rendendosi padrone delle di lui osservazioni, cercano insieme di formar delle ipotesi, per mezzo delle quali possano coll'ajuto de' calcoli, ricondurle alle leggi generali della fisica. Da questi loro travagli e da sì fatte ricerche ne deriva un ramo di mattematiche miste, a cui si è dato il nome di Acustica dalla parola greca αχουω12, che significa udire, o di Teoria fisico-mattematica. Questa scienza esamina il suono in se stesso, ricerca le leggi della sua generazione, della sua propagazione; il principio e le leggi delle sue modificazioni, lo compara con lui medesimo sotto tutti i rapporti, cerca in conseguenza di determinar quei rapporti che conservano tra loro i suoni del Sistema musicale, e riguarda come una delle sue più importanti applicazioni la fattura, la costruzione e soprattutto la divisione degli istromenti di Musica. A questo ramo si appartengono dunque tutti gli Scrittori, che da Pitagora sino a quest'ultimi tempi han ridotta a calcolo la Scienza de' suoni, e che hanno preteso formar della Musica una scienza esatta.
Si è infatti da antichissimo tempo, cioè da Pitagora in poi agitata la questione, se la Musica derivi dalle proporzioni mattematiche, e se ella sia una porzione di questa scienza. Nell'antichità divise essa i Pitagorici e gli Aristossenici, sostenendo i primi le proporzioni numeriche, e rigettando queste i secondi come incerte e fantastiche, standosene soltanto agli sperimenti dell'orecchio, come erasi fatto sempre sin da principio dagli antichissimi Musici13. I moderni non contenti delle ragioni di numero a numero che usarono gli Antichi per trattar della Musica, vi aggiunsero le tre proporzioni armonica, aritmetica e geometrica; e perciò i libri di molti sono pieni zeppi di numeri, e voti di musica: ovvero dopo aver cominciato con un grande apparato di principj mattematici, finiscono, entrando nella pratica, con non far più conto di quegli stessi principj: il che dà a divedere abbastanza che tutte coteste ragioni sono accidentali all'Armonia, e che “la considerazione delle proporzioni geometriche, aritmetiche ed armoniche è illusoria nella Teoria dell'arte musicale14.” Quindi è che molti filosofi musici, come l'Alembert, e il Sacchi, e l'Eximeno e Choron e più altri si sono giustamente impegnati a sottrarre la Musica con ogni sorta di argomenti da' ceppi della mattematica; e a sgombrar dalle menti un sì antico ed invecchiato pregiudizio. “Può veramente il calcolo, dice uno de' più gran Geometri dello scorso secolo (M. d'Alembert), facilitare l'intelligenza di alcuni punti della teoria, come del rapporto fra i tuoni della scala e del temperamento; ma quel che abbisogna di calcolo per trattar di questi due articoli è così semplice, e per dir tutto, è così poca cosa, che non merita di farsene pompa. Non imitiamo que' Musici, che credendosi Geometri, o que' Geometri, che credendosi d'esser Musici, ammassano numeri sopra numeri, immaginandosi forse, che quest'apparato sia necessario all'arte. La brama di dare alle sue produzioni un falso aspetto scientifico, impone solamente agli ignoranti, e non serve che a rendere i loro trattati più oscuri e meno instruttivi15. Come Geometra, io credo aver qualche diritto di protestar quì contro questo ridicolo abuso della Geometria nella Musica: e con tanto più di ragione farlo io posso, quanto in questa materia i fondamenti de' calcoli sono sino ad un certo punto ipotetici, e non sono anche più che ipotetici etc.” (Discours prélimin. aux Elém. de Musiq. p. XXIX.) E più chiaramente nella lettera a M. Rameau così s'esprime questo celebre Mattematico: “Il senso dell'udito non può in veruna maniera darci la nozione, di rapporto, e di proporzione, che noi acquistar non possiamo se non per mezzo della vista e del tatto. Per avere un'idea chiara delle proporzioni e de' rapporti, è necessario comparare i corpi per mezzo di questi due ultimi sensi; la percezione dei suoni non vi contribuisce assolutamente per nulla, nulla vi aggiunge e vi è del tutto straniera. Per dir tutto in brieve, quando gli uomini sarebbero sordi, non vi sarebbero meno per loro de' rapporti, delle proporzioni, una geometria… La considerazione de' rapporti è senza dubbio ad alcuni riguardi necessaria nella Musica per la comparazione de' suoni tra loro: il calcolo, che altro non è se non l'arte di combinare e di trovare i rapporti, è utile per l'intelligenza di certi punti della teoria; ma la considerazione de' rapporti è illusoria per render ragione del piacere che ci cagiona la Musica. In riguardo alle proporzioni, egli è certo, che le proporzioni aritmetiche ed armoniche sono del tutto straniere, e per conseguenza inutili all'arte musicale,” p. 213, 214.
L'Eximeno poi più che ogn'altro, nell'eccellente sua Opera dell'Origine e delle Regole della Musica, impegnossi a provare che la Musica non ha correlazione colla Mattematica: che le corde della Musica possono bensì misurarsi, e con queste misure formarsi molte ragioni: ma che tali ragioni sono accidentali all'armonia, e che per ottenere questa non bisogna regolarsi con quelle. Egli munito di profondi studj sulle mattematiche attacca le formole algebraiche, colle quali l'Eulero fa della Musica un nuovo trattato di Algebra, e con ragioni di geometria e di fisica impugna quanto vi ha di vano e d'ingannevole intorno a queste materie, nel tanto celebre una volta e tanto discreditato oggidì sistema del Sig. Rameau. Ecco come del buon successo di quest'Opera parla l'elegante insieme e sensato Bettinelli: “Un bravo spagnuolo fatto romano di gusto anche in musica con alla mano un principio semplicissimo, che è la sola maniera di scandagliare e di urtar le gran macchine, fece man bassa non sol su la teoria del P. Martini, ma su tutte l'altre, quasi un nuovo Galileo per le qualità aristoteliche, e un nuovo Newton pei vortici Cartesiani di questa scienza, e d'ogni sistema eziandio fondato su le basi mattematiche credute sempre inviolabili e sacre. Io non ho ancor trovato, chi dopo quella lettura non ne sia persuaso.” (Risorgimento d'Italia ec. Part. II, cap. 4. Musica, p. 168.)16
L'applicazione, che si è tentato di fare alla Musica della Fisica, e della Geometria, o di ambedue insieme ha prodotto un'infinità di sistemi misti, e di teorie acustico-musicali, che da noi annoverate verranno in varj articoli del Dizionario. La cognizione e lo studio di tali opere servir può al dilettante e al professor di quest'arte per metterli in istato d'intendere tutte le questioni di tal genere, e di valutare il grado di utilità, che da questa sorta di ricerche può derivar loro ed all'arte medesima17.
Da tutto ciò ben si vede che questa Teoria essenzialmente differisce dalla Didattica, la quale consiste nel dar le regole della pratica, ovvero nello sviluppare i dettagli pratici della Composizione, e che ella medesima, come più avanti si è detto, forma da se una scienza particolare. Egli è ben vero che si è tentato di combinarle insieme, il che si è fatto con più o meno di successo; ma questo tentativo medesimo non autorizza a confonderle, come è sovente avvenuto, e come ve ne ha più esempj nelle teorie miste di moltissimi autori da noi riferiti nel presente Dizionario18, che meno adatti son perciò divenuti a guidar lo studente nei sentieri della pratica.
Di tutte le parti della Musica la più importante è senza dubbio la Composizione. L'Autore del Dizionario di Musica diffinisce la Composizione “l'arte d'inventare e scriver de' canti, e di accompagnarli con conveniente armonia.” Ma siffatta diffinizione è troppo particolare. Essa conviene bensì allo stile libero, in cui canta una sola parte, e tutte le altre sono d'accompagnamento; ma non già conviene allo stile severo o obbligato, nel quale tutte le parti egualmente cantano, e niuna serve d'accompagnamento. Sulzer nel suo Dizionario delle belle arti, per una di quelle omissioni che gli sono ordinarie, trascura di definire la Composizione, e par che voglia confonderla col Contrappunto, che solo ne è un ramo. Bisogna starsene dunque alla diffinizione che di sopra ne abbiam data, come la più semplice e la più generale.
Ma in che consiste quest'arte, e quale è il suo metodo? Secondo gl'insegnamenti di tutti i maestri e di tutti i tempi bisogna sapere che in ogni Composizione si ricerca il soggetto, senza il quale si farebbe nulla, come dice il Zarlino (Istit. armon. 3, part. cap. 26). Ciò posto, la Composizione è l'arte di trattare un soggetto, il che può farsi secondo due modi o sistemi, ossian stili diversi: cioè lo stile severo o ideale. Ma poichè quest'ultimo non è se non una modificazione, ed un caso particolare dell'altro, e che s'egli forma un ramo distinto, ciò è piuttosto a cagione della sua importanza e delle frequenti sue applicazioni, anzichè a motivo della sua natura, ne deriva perciò che qualsivoglia Composizione effettivamente riducesi allo stile severo. Questo stile è quel che si chiama Contrappunto, e la ragione di tal nome è ben nota a tutti coloro, che alcun poco iniziati sono nella storia di quest'arte.
Che che sia di ciò, quest'Arte ha molti gradi: il primo consiste nel determinare quali sono gli altri suoni che debbono essere intesi insieme con ciascuno di quelli, dai quali è formato il soggetto. Cotesta determinazione si fa a norma di certe regole che costituiscono quel che dicesi l'arte dell'accompagnamento. Chiamansi Accordi quelle riunioni di suoni che possono farsi sentire insieme, e si chiama Armonia la scienza che tratta delle proprietà di questi Accordi. Si sono moltiplicati i sistemi intorno a questa materia, secondo i diversi punti di vista sotto i quali si è ravvisata, e secondo i pregiudizj o gli errori che si sono adottati. Che diremo del sistema del Basso-fondamentale e de' rivolti del Sig. Rameau? Il primo a rovesciarlo in Italia fu l'illustre spagnuolo Eximeno: quindi il dotto geometra Conte Giordano Riccati19, e un pò dopo il P. D. Giovenale Sacchi scrittore dottissimo di Musica. “Che giova, dice costui, insegnarmi, e pormi dinanzi agli occhi tanti modi, in cui ciascuno accordo diretto può rivoltarsi, se poi nè il rivolto al diretto, nè l'uno all'altro rivolto generalmente si può sostituire? Per queste ragioni a me sembra, che il novello sistema de' rivolti sia affatto ingannevole. A primo aspetto per l'autorità degli Scrittori20, che lo favoriscono, per l'opinione della novità che lo accompagna, molto più per certa apparenza non so se io dica di filosofia o di misterio, sotto di cui ci si presenta, quasi in un ricco e nobil manto inviluppato, e coperto impone altrui; e dà molto a sperare di se medesimo. Ma considerato che sia da vicino, e tanto quanto ricercato nel suo interno, si scopre non esser solido, e la illusione svanisce.” Rapporta quindi molte ragioni in prova di ciò, e così conchiude. “Queste sono le mie difficoltà contro la celebre opinione del Sig. Rameau, il cui peso io non dubito che gli ammiratori e seguaci suoi sentiranno assai bene21.”
Egli è dunque contro ogni ragione che si è voluto proclamare Rameau qual fondatore della scienza dell'armonia, o come quegli ch'era giunto finalmente a trovar nella natura il principio e 'l centro ove unirsi tutte le regole sparse quà e là come a caso prima di lui. Se questi elogj sono stati ripetuti da intere Accademie e da Scrittori del primo ordine, come un d'Alembert, un Condillac, un Rousseau22 e più altri, ciò non prova assolutamente altra cosa, se non il rischio che vi ha nel parlar di quello che non si conosce. Tutti gli accordi, tutte le regole d'armonia e i principj di composizione esistevano già molti secoli prima di lui: perchè fossero vie meglio intesi non v'era d'altro bisogno che di essere presentati con chiarezza e con ordine. E questo è quello ch'è stato già fatto da mani più maestrevoli e più dotte, e precisamente dal P. Martini, dal Vallotti, dal Paolucci, dal Sabbatini, dall'Eximeno, da' tedeschi Knecht, Marpurg e da molti altri più recenti, che riscontrar si potranno in più articoli di questo Dizionario.
L'erudizione musicale finalmente ch'è l'altra parte della Musica considerata come scienza, ne abbraccia la Storia e la Bibliografia, che non è se non un ramo della medesima. La Storia generale di quest'Arte-Scienza tratta de' successivi progressi della medesima in tutti i luoghi ed in tutti i tempi: la particolare non ne considera che un solo ramo, o allorchè essa si limita a un certo spazio di tempo o di luogo. La Bibliografia contiene la notizia di tutte le Opere che trattan della Musica, che è ancora il soggetto del presente Dizionario. Essa è molto utile servendo di guida a' curiosi ed ai studenti di questa facoltà perchè sappiano di quali Opere provveder si debbano, quali consultar fia loro d'uopo, quali sien le classiche, quali le mediocri, quali le cattive e le inutili, e particolarmente allorquando questa porzione di Storia letteraria vien trattata con iscelta erudizione e sana critica. Un'opera metodica in questo genere è ancora a desiderarsi, e tanto più essa è necessaria, quanto che i libri di Musica, come quei di Pittura, di Scultura ec. siccome non convengono che ad un certo numero di amatori e di artisti, tosto si spargono per le case ove quest'arti coltivansi, ed escono finalmente dal commercio ordinario de' libri che sono in uso presso gli uomini dotti: quindi è che con difficoltà s'incontrano fin anco nelle più ricche Biblioteche, dacchè sono una volta dispersi, e facilmente se ne perde la traccia.
Finalmente han luogo nel nostro Dizionario tutti gli Scrittori di considerazioni filosofiche, di cui è suscettibile questa Bell'Arte; come di tutte le opere che trattano della parte estetica della medesima, cioè de' diversi artifizj che essa adopera per piacere a' nostri sensi; o della patetica, cioè di quei mezzi che essa mette in opera, per muovere gli affetti, ed agire su le nostre passioni: di tutti i prodigiosi effetti in somma, così fisici che morali, che essa produce sull'animo e sul corpo umano.23 E a tal riguardo è d'uopo ancora che annoverati vengono que' celebri professori di Medicina, i quali guidati da filosofico ragionamento e dalla esperienza, non che dall'antica storia hanno date al pubblico le loro ricerche sulla forza e l'energia di quest'arte nelle malattie, e sul vantaggio che trar ne può la medicina24.
Ecco il quadro e l'insieme di tutti i vicendevoli rapporti di tanti oggetti diversi, o per dir meglio dei diversi aspetti sotto a' quali può ravvisarsi questo medesimo oggetto, affinchè il Lettore sia in istato di giudicar meglio delle mie intenzioni e dell'idea che mi sono formato nell'intraprendere questa qualunque siasi opera.
Dovendo dir ora alcuna cosa su la cultura della Musica presso le antiche nazioni e le moderne, ben si sa che di tutti i popoli dell'antichità, che l'han coltivata, non sopravvanzano che pochi Scrittori su la Teoria della medesima, e niuno su la pratica, e questi dei Greci e di alquanti Arabi soltanto25, imperocchè quei de' Latini non sono che de' meschini copisti dei primi. La musica in generale, dice molto sensatamente uno degli autori dell'Enciclopedia metodica, ha una doppia proprietà, che le fa esercitare un doppio potere su i popoli più instruiti, come su quelli men civilizzati. Essa lusinga piacevolmente i sensi, e per gustarla non v'abbisogna che quella sensibilità d'orecchio suscettibile di più o meno di perfezione e di delicatezza, ma che la natura non niega se non ad un picciol numero di esseri disgraziati. Apre essa in oltre un campo libero alle combinazioni dello spirito, ai calcoli ed ai sistemi, e in questo senso non è conosciuta che dalle nazioni dotte, e da coloro che in queste nazioni hanno assuefatto il loro spirito alla riflessione ed allo studio. Cosichè può dirsi che vi sia Musica presso tutti i popoli, perchè l'istinto del genio musicale è comune a tutti i secoli ed a tutte le nazioni: ma che non vi ha sistema di Musica se non presso quei popoli che hanno unito alla coltura di quest'Arte quella delle altre scienze.
E per parlare primieramente degli Ebrei, di quella nazione che primeggia fra tutte per l'antichità e certezza de' suoi storici monumenti, e per l'affinità che ha con noi cristiani, ben sappiamo l'uso grandissimo che sin da' più rimoti tempi fecero essi della Musica, l'immenso numero di persone che fra loro vi s'impiegava, le scuole erette per formar degli allievi in quell'arte, che di esercitar non isdegnavano nè i re, nè i profeti, nè i religiosi ministri della nazione26. Le lodi di un Dio sommo ed onnipotente, e che non ammette compagnia di altri Dei ne furono il soggetto, e ciò la rese invariabile per lo spazio di più di mille anni, in cui conservossi pura ed intatta l'ebrea credenza. Ma i progressi fatti in questa facoltà da un popolo, come fu l'Ebreo per religione e per genio segregato dal commercio di ogn'altra nazione, perirono insieme con questa Repubblica, e nulla contribuirono alla perfezione di quella Musica, che si propagò per tutte le colte nazioni dell'Antichità.
Benchè egli sia certo, che non furono i Greci i primi inventori della Musica, e che dovettero anzi apprenderla in su i principj da nazioni della loro in que' tempi più ripulite e più antiche27: pur nondimeno i Greci, la di cui immaginazione era così bella, di cui l'ingegno era così sublime, e l'anima così sensibile, tanto presi rimasero dagli incanti della Musica che divenne ben presto tra le loro mani la prima delle Arti. I musici de' primi loro tempi furono i Poeti, che erano insieme i legislatori, gli storici e i teologi della nazione. La Musica, dice Mr. de Barthelemy, diede anima successivamente ai versi d'Esiodo, d'Omero, d'Archiloco, di Terpandro, di Simonide, e di Pindaro: essa era inseparabile dalla poesia, e l'una e l'altra tramandavansi a vicenda i proprj vezzi. (Viagg. d'Anac. cap. 27.) La Storia, le massime, le esortazioni, i proverbj, le leggi, gli oracoli degli antichi Greci non si appalesavano che in versi ed in musica. Onde è che la persona del musico-poeta era tenuta come sacra dal popolo ed in somma venerazione e rispetto. Oltr'a ciò tutta l'Enciclopedia de' Greci consisteva nella Musica: essa comprendeva l'oratoria, la morale, la politica, la fisica, la medicina; nè veruno riputavasi in queste uomo di vaglia che non fosse insieme un bravo Musico. Tale era lo stato di quest'arte sino a Pitagora: ell'era perfettissima pria che venisse al mondo quest'ingegnoso filosofo, come cel dimostra la storia di più valenti artisti, che riscontrar si possono nel nostro Dizionario. “Benchè Pitagora, dice un recente Scrittore, non sia stato nè il primo, nè il solo tra' Greci che abbia dinotato il potere della Musica su gl'individui, e la sua influenza su i costumi delle nazioni intere, e che abbia impiegata la Musica, o per guarire delle malattie, o per eccitare o calmare le passioni, fu il primo frattanto, secondo l'opinion generale e riconosciuta per vera, che cercò di soggettare quest'arte a certe regole.” (Meiniers, Histoire des Sciences dans la Grèce, traduite par Laveaux.) Egli stabilì una nuova teoria della musica, con introdurre in essa le ragioni numeriche, e credendo di trovare un legame intimo tra l'astronomia e la musica, formò il fantastico sistema dell'armonia celeste e terrena, il quale altro effetto non produsse che di spargere sull'arte l'incertezza, la confusione, e le tenebre.28
Prova di ciò ne sia l'oscurità che s'incontra nelle opere dei filosofi posteriori a quest'epoca, di quelli eziandio che non furono seguaci di Pitagora. Essi rendonsi inintelligibili, se non si sanno le regole armoniche fondate sopra i numeri de' musici pitagorici. Da ciò derivano ancora tutte le questioni e i dubbj su la greca musica, che han diviso e dividon tuttora i letterati, malgrado i tanti Scrittori della medesima di questa nazione, le cui opere salvate si sono dalle ingiurie de' tempi, come un Aristosseno, un Aristide Quintiliano, un Gaudenzio, un Nicomaco, un Bacchio, un Euclide, un Tolomeo, un Briennio ec. Se non che il più volte da noi lodato Requeno con un zelo degno di sì grand'uomo, e con indefesso studio è venuto a capo d'interpetrarci cogli sperimenti e co' fatti, i principj musicali di siffatti scrittori, e di ordinare in un corpo di Storia le preziose memorie della Greca Musica. Tuttochè egli abbia avuta la modestia di non dare alla sua luminosa opera che il titolo di Saggi, parmi, che dir si possa a ragione, aver egli soddisfatto appieno alle brame d'ogni uomo di lettere, espresse alcun tempo avanti dalla geometrica penna del Signor d'Alembert29.
In Roma, secondo l'espressione di un dotto Inglese30, fu la musica quasi innestata, e trapiantata onde non potè avere quell'influsso su i costumi, sul governo e sull'educazione che ebbe presso i Greci loro maestri. Nulla in fatti hanno aggiunto i Romani alla Musica di costoro, contentandosi solo di copiarli e di tradurli. I Scrittori latini della teoria musicale, come S. Agostino, Cassiodoro, Albino, Marciano Capella, Macrobio e più di tutti Boezio più non dissero di ciò, che avevano imparato da' Greci, cui ciecamente seguivano.
Ma lo stato della musica divenne ancor più deplorabile alcun tempo dopo la rovina dell'impero Romano. Fra tante nazioni barbare che se ne impadronirono, solo trovò un'asilo, il che sembra incredibile, presso i Saraceni o gli Arabi. Costoro dopo di aver distrutto nelle loro prime conquiste tutti i monumenti delle Scienze e delle Arti, e tutti i tesori letterarj che conservavansi nella famosa biblioteca d'Alessandria, appassionatamente si diedero quindi a ristabilirle, e con particolarità nella Spagna. Sopravanzano ancora alcuni loro scritti su la Musica, che essi coltivarono con impegno e come Arte, e come Scienza, recato avendovi l'ajuto delle matematiche cognizioni. L'Ab. Andres, che fè tradurne alcuni dal dotto Casiri autore della Biblioteca Arabo-Ispana, per la sua Storia Letteraria, così ne giudica. “Si vede, egli dice, che gli Arabi, benchè seguaci della dottrina de' Greci, non l'abbracciarono senza esame; ch'ebbero forse più giuste cognizioni della parte meccanica de' suoni, che gli stessi loro maestri, e che in varj punti ne corresser gli errori, ed empirono il vuoto della loro dottrina. Ma degli scritti arabici su la Musica rimasti sepolti nelle biblioteche, poco, o nulla sappiamo per poterne ritrarre qualche lume, e conoscere i progressi, che dovrà forse quella scienza all'erudite loro fatiche, ma che sono a noi poco noti.” (Dell'origine, dei progressi ec. tom. 4.)31.
Nel decorso di questi secoli d'ignoranza dee la Musica alla Religion Cristiana qualche misero avanzo di cultura: non considerossi più allora come un'arte di genio, di cui i progressi interessar dovessero la sensibilità e 'l piacere, ma come una specie di liturgico rito, cui bastava aggiugnerne quello soltanto e non più che richiedevasi per soddisfar al bisogno. “Non per erudizione e cultura, non per compiere il quadrivio delle scuole, non per illustrare le matematiche discipline, ma per cantare degnamente i divini ufficj si coltivava lo studio della musica: e nel lungo catalogo, che si potrebbe formare degli Scrittori di musica di que' tempi, non s'incontrano che monaci ed ecclesiastici.” (Andres ib.)
Dissipatasi finalmente in Europa poco a poco la spessa nebbia, che per lungo tempo oscurato aveva l'intendimento degli uomini, e postosi il genio in attività, rinnovossi l'amor delle scienze e le arti liberali cominciarono a riprendere il loro antico vigore. La Musica, egli è vero è stata fra queste l'ultima a coltivarsi, perchè non trovò essa come le altre, degli antichi esemplari e modelli da imitare, perita essendo quasi del tutto la pratica musicale de' greci e de' latini, e non essendosi scoperte ancora le opere di costoro, che in qualsivoglia maniera ne contenevano i precetti. Per tal ragione si è quest'arte dovuta creare nuovamente del tutto in Europa. Rozzi è vero ne furono i principj, ma questi non debbonsi che all'Italia32: i primi albori di questa scienza non apparvero che in questo clima felice. Guido monaco d'Arezzo sul cominciare dell'undecimo secolo fu l'inventore di un metodo precettivo di Musica, e dettò delle regole certe. A ragione, dice l'Arteaga, “vien egli comunemente considerato come il fondatore ed il padre della moderna musica. In que' tempi tenebrosi egli è ciò, che nel mare agli occhi de' naviganti smarriti è una torre, che veggasi biancheggiar da lontano. I suoi meriti principali sono d'aver migliorata l'arte del cantare, ampliata la stromentale, gittati i fondamenti del contrappunto, e agevolata la via a imparar presto la Musica troppo per l'addietro spinosa e difficile.” (Rivol. tom. 1, pag. 106.) Dopo costui altri valenti Italiani si accinsero a migliorarne il metodo, e a slargarne i confini. Tali furono un Marchetti maestro del re Roberto di Napoli, e Prosdocimo ambi di Padova, e Mascardio e Franchino Gaffurio di Lodi, e Anselmo Parmigiano, e Fisifo da Caserta e più altri. Nel secolo XV e su i principj del seguente cominciossi ancora in Italia a dissotterrare e a tradurre in latino le opere dei Greci Armonici. Niuno di questi Scrittori era stato sino allora pubblicato nè in greco, nè in latino. Giorgio Valla da Piacenza nel 1497, diè il primo una versione latina dell'Introduzione Armonica di Cleonide, o del preteso Euclide, insieme con l'Architettura di Vitruvio, ove questo latino Scrittore tratta ancora di musica. Valgulio da Brescia nel 1507, diè al pubblico una non spregevole traduzione del Dialogo su la Musica di Plutarco con un suo Discorso su l'Antica Musica, e contenente la spiegazione di più termini musicali di questo autore. Troviamo in oltre che nelle opere del prelodato Gaffurio stampate sulla fine del decimoquinto secolo vengono da lui citati i Greci Musici Aristosseno, Tolomeo e Porfirio suo scoliaste, il vecchio Bacchio, Briennio e Plutarco. È prova oltracciò del suo sapere la traduzione di Aristide Quintiliano a sua istanza intrapresa da Francesco Burana Veronese circa 1494, che manoscritta si serba in Verona per testimonio del Maffei (Veron. illustrat.)
A promuovere vie più i progressi dell'Arte stabilironsi allora in Italia molte Accademie. Nel 1543, quella de' Filarmonici in Vicenza, d'onde passò ella poi a Verona. Nel 1662, formossi in Bologna una società dello stesso genere col titolo di Accademia de' Filomusi, e l'anno di appresso quella de' Musici Filachisi, che cedettero quindi il loro luogo al cel. Istituto di quella città. E come è assai naturale il cercar di dare maggior rilievo e annobilire i titoli della prima gloria, si diè allora in Italia il fastoso nome di Virtuosi a coloro che esercitavan l'arte del canto o del suono. Sorsero ancora in que' tempi molti grand'ingegni che co' loro lumi cercarono, per quanto fu loro possibile di fissare le vere regole sì per la teoria, come per la pratica, un Galilei, un Caccini, un Zarlino, un Doni, e altri molti dotti italiani. A riformar poi il cattivo gusto del gotico contrappunto, ch'era in gran voga presso le nazioni tutte d'Europa non vi contribuì che solo l'Italia. “Se la musica italiana, dice Mr. Beattie, ancora nella sua infanzia, non fosse venuta a cadere sotto la direzione d'un gran genio, come Palestrina, non sarebbe così prontamente giunta alla sua virilità. Una lunga serie di Compositori subalterni può menare ad alcune scoperte in un'arte; ma non potrà farla giammai sortire dalla mediocrità, poichè cotali persone non esercitano un'influenza capace d'interessare i dotti ed il volgo ai successi d'un'arte novella. Ma Palestrina ha fatto della sua arte un oggetto d'ammirazione non solo del suo proprio paese, ma d'una gran parte ancora dell'Europa, e tutti gl'intendenti, buoni giudici di questa materia, vedevano con piacere che il suo sistema era fondato sopra ben ragionati principj, e che quantunque potesse esser condotto a maggior perfezione, non poteva frattanto riguardarsi come perfetta se non perchè vi era conforme. Dopo quest'epoca in fatti, la Musica è stata coltivata in Italia con altrettanta attenzione che successo. Bisogna dunque farsi maraviglia dell'eccellenza senza pari della Musica Italiana?” (Essay on poetry, and music, sect. III.)
Un altro efficace mezzo trovato anche in Italia si è l'istituzione de' Conservatorj, nome che si è dato alle scuole pubbliche di musica, senza dubbio perchè son eglino destinati a naturalizzar perpetuamente quest'arte, a perfezionarne il gusto, e a conservarla in tutta la sua purità. Prima di tai stabilimenti eranvi a dir vero in diverse città d'Italia delle scuole assai celebri per il canto ed il suono, per la composizione e per il miglioramento della teoria musicale, ma non eran queste delle fondazioni a perpetuità, e tenevansi solo in case di alcuni particolari. Roma dove la particolar esecuzione della musica sacra avea da lungo tempo introdotta la necessità degli studj, e de' maestri, ebbe la celebre scuola dei Fedi, e degli Amadori. Modena quella di Peli: Milano di Brivio, e Firenze quella di Redi. Bologna ebbe per caposcuola Pistocchi, e quindi il cel. Bernacchi, e per la stromentale il Corelli, ec. Ma l'esperienza ha dato a diveder chiaramente la maggior utilità de' Conservatorj, dove la buona scuola si perpetua, e più agevolmente si propaga. Sono essi in Italia delle pie fondazioni, ove i ragazzi vi sono alloggiati, mantenuti e gratuitamente instruiti. Vi si ammettono inoltre de' pensionarj, di modo che tutte le classi de' cittadini andar possono a cercarvi comodamente un'educazion musicale, che deesi molto preferire alle lezioni particolari. I teatri, e le chiese traggono egualmente da' Conservatorj i soggetti, di cui hanno bisogno.
Venezia si reca il vanto di possederne quattro destinati all'educazione delle giovani orfane donzelle, mantenute ivi a spese de' ricchi amatori di musica, nobili, negozianti e altri. Rigorosamente tenute in riguardo a' costumi, vi sono instruite da' migliori maestri dell'Italia; Jommelli e Sacchini furon di questo numero. Tutti i sabati e le domeniche alla sera vi si fanno de' pubblici concerti, ed egli è curioso pei forastieri, che vi assistono, il sentire non solo tutti i diversi generi di voce, ma ancora tutte le specie di strumenti maneggiati da donne, senza che la durezza delle corde del contrabbasso, o gli aspri suoni della tromba e del corno sbigottissero la debolezza de' loro polmoni, o la delicatezza delle loro dita. Queste ragazze vengono in que' Conservatorj alimentate, finchè vanno a marito.
Napoli sopra tutto è la più famosa in Italia per siffatti stabilimenti, che colà son forse i più antichi. Tre una volta ve n'erano per i figliuoli, poichè il quarto, detto de' Poveri di G. C. che recavasi a gloria di aver formati i Vinci e i Pergolesi, nomi illustri per la musica, era stato soppresso per istabilirvi un Seminario. Quivi era già che presso a seicento allievi occupavansi interamente dello studio della musica33. Ciascuno de' Conservatorj aveva due principali maestri, uno per la composizione, l'altro per il canto, oltre a più maestri per ogni sorta di strumenti. Fra i primi si contano i Scarlatti, i Leo, i Duranti, i Finaroli, ec. e per loro allievi l'Hasse, Traetta, Piccini, Sacchini, Guglielmi, Anfossi, Paesiello, Cimarosa, Zingarelli ec. resi celebri per tutta l'Europa colle immortali loro produzioni. Questa scuola di Napoli da più di un secolo è stata la più feconda in rinomati musici: essa sola ne ha certamente prodotto più che tutto 'l rimanente dell'Italia e fin anche dell'Europa intera34. Se vi sono in Italia alcune città meno principali ove non hanno potuto aver luogo i Conservatorj, vi ha pur nondimeno una scuola, dove un Maestro di cappella assai abile istruisce i giovani principalmente in quel che riguarda il servizio della orchestra della chiesa cattedrale, e che può in certa maniera supplire al difetto de' Conservatorj. Da questi seminarj è quindi straordinario il veder uscire un numero considerevole di gran maestri dell'arte e de' famosi artisti che percorrono le provincie per ispirarne il gusto e moltiplicarne gli amatori? Ed ecco come in Italia tutto il mondo è musico; le orecchie assuefatte alla musica, divengono musicali: ecco perchè si odono su le pubbliche piazze i calzolai, i fabbri, i falegnami, i ciabattini, le donnicciuole ed altre persone di questa specie, cantar delle arie a più parti, con una precisione ed un gusto ammirabile, con ispezialità in Roma e in Venezia, ove si desidererebbe esser tutto orecchio, al dire di Mr. Burney nel suo Giornale de' Viaggi, per sentire e prendere tutto ciò che vi ha di più bello in riguardo alla musica. “Bisogna attribuire questa ricchezza alle numerose istituzioni musicali che la pubblica munificenza e l'amor delle Arti vi hanno da per tutto erette, ed al grand'uso che vi si fa della musica nelle chiese, ne' teatri, negli oratorj.” Così scriveva pochi anni sono un dotto Francese, esortando la sua nazione a seguir l'esempio dell'Italia, se pur voleva una buona scuola di musica (M. Raymond, Lettre à M. Millin, dans le Magaz. Encyclop. 1810.)
Se la Germania è la seconda patria di quest'arte incantatrice, che le deve sì grandi progressi: se la Germania è egualmente celebre per l'immenso numero de' suoi artisti, virtuosi e compositori di prima sfera, ne è in parte debitrice all'Italia. I Conservatorj di Napoli sono stati sempre pieni di Tedeschi; i più gran maestri della Germania Hendel, Bach, Hasse, Gluck, Nauman, Haydn, Mozart, Gretry35 o sono venuti in Italia ad apprender nelle sue scuole la musica, o formarono il loro gusto spezialmente per la vocale su quello de' maestri italiani. “È più d'un secolo, al dire di M. Suard, che il gusto della musica e della buona musica italiana si è generalmente stabilito in Germania, e secondo il giudizio di molti, vi si è conservato più puro e più austero che nella stessa Italia; che quivi più che in Italia si eseguisce musica italiana, che da Leopoldo I, sino a Giuseppe II, gli Imperatori hanno amato e coltivato la musica, hanno chiamato alla loro corte, protetto e ricompensato da gran principi i gran maestri italiani.” Siffatta protezione36 e gara, ed istinto della bella musica italiana ha fatto che i Tedeschi siano naturalmente tutti musici.
Quel che ha contribuito ancora a spargere il gusto della musica in tutta la Germania, egli è un'antichissima usanza, che non si trova in verun altro paese. In tutte quasi le pubbliche scuole de' villaggi come delle città, s'impara la musica ai ragazzi nel tempo stesso che s'insegna loro il leggere e lo scrivere. Niun maestro di scuola vien ammesso ad esercitare la sua professione, che non sappia almeno gli elementi di quest'arte, e sonare qualche instrumento: e quel ch'è più a rimarcarsi, egli è, che da per tutto ove i Gesuiti hanno avuto de' collegj e delle scuole, son essi stati i più attivi in questa parte del pubblico ammaestramento, essi, che da per tutto altrove si sono mostrati poco favorevoli alla coltura delle belle arti37. Ma siccome trovarono in Germania l'insegnamento della musica stabilito nelle scuole, e 'l gusto di quest'arte protetta dal Governo sparso per tutto il paese ebbero la politica di favorirne lo studio e la pratica.
Non v'ha paese al mondo, senza eccettuarne l'Italia, dove il popolo abbia un gusto più generale per la musica come nella Germania; perchè niuno ve n'ha dove le orecchie siano più continuamente inzuppate di musica d'ogni specie. In tutte le città, delle truppe di virtuosi ambulanti vanno per le strade e riempiono le osterie, cantando e sonando molti instrumenti. Da per tutto dove vi sono delle università e de' collegj, gli studenti si radunano per andar per le strade, e sopra tutto la notte, a cantar degl'inni, de' canoni, o de' pezzi da teatro a concerto, accompagnandosi con ogni sorta di stromenti; e prendono senza difficoltà del danaro da quei che se ne sono divertiti38. Fin anco i soldati hanno delle scuole particolari ove apprendano il canto: e poche sono le persone di servizio che non sappiano sonar qualche stromento. Tutti i principi hanno una musica militare; e la maggior parte fanno accompagnare la loro tavola dal suono delle trombe e dei timpani. “Bello è il Prater a Vienna, dice con trasporto il D. Lichtenthal, esso è un pubblico passeggio in un'isola del Danubio. Quà s'ode musica concertata, là sonatori d'arpe, altrove liuti e ghironde, più lontano si volge una folla ebbra di allegrezza dietro il suono di timpani e trombe; non v'è nulla di più magico, di più animato. Le musiche consuete nelle pubbliche piazze, nelle osterie, ne' caffè, divagano la plebe infelice dal sentimento della vita.” (Influenza della musica ec. pag. 26.)
Quel che dà ai Tedeschi un luogo molto distinto nella storia dell'arte, si è il rapido e mirabil progresso ch'eglino han fatto fare alla musica strumentale; quell'immensa copia di concerti, di sinfonie, di sonate di clavicembalo, di cui hanno arricchito tutte le orchestre dell'Europa, dove quasi più non si eseguisce altra musica di questo genere, o che sia composta almeno sul loro gusto. Noi non staremo quì ad annoverare l'infinito numero de' virtuosi del primo merito di questa nazione in tutti i generi: il nostro Dizionario soverchiamente ne abbonda. Ma tra i gran servigj che i Tedeschi han reso alla Musica, obbliar non si devono le preziose e moltiplici invenzioni loro per la perfezione de' diversi strumenti. Noi lor dobbiamo l'uso dei clarinetti, dei tromboni, de' corni nell'orchestre, e di aver portato alla più gran perfezione il cembalo, il piano-forte e l'arpa. Deesi finalmente ai Tedeschi un gran numero di Opere su la teoria e su la pratica della musica. Senza far quì parola dei trattati su l'antica musica, e su quella di chiesa, come su le controversie relative al contrappunto, che hanno diviso ed occupato più dotti uomini per il corso di due secoli, sopra tutto in Italia e nella Germania, citeremo solo l'Opera di Fux, Gradus ad Parnassum, che gl'Italiani tradussero nella loro lingua e per lungo tempo se ne servirono come di un buon libro elementare: e i diversi trattati di Kirnberger, che ha fondato una scuola ed ha sottoposto ad un nuovo sistema tutti i principj dell'armonia. La letteratura musicale della Germania è senza contraddizione e senza alcun paragone la più ricca dell'Europa: essa possiede in riguardo a tutte le parti dell'arte una quantità prodigiosa di eccellenti opere, pubblicate nel corso del secolo 18º, da Mattheson, da Marpurg, da Bach, da Knecht, da Vogler, da Forkel, Nickelman, Gerbert, Koch ed altri moltissimi che potranno quì riscontrarsi.
Se vi fu un tempo in cui i Tedeschi, i Spagnuoli e gl'Inglesi credettero di buona fede di possedere una musica loro propria, persuasi che vi andava della loro gloria ad abolire certe produzioni musicali nelle rispettive loro lingue, che essi vantavano quai capi d'opera dell'arte, benchè insoffribili a tutte le orecchie tranne le loro: alla fine il sentimento e 'l piacere trionfarono della lor vanità, ed essi non dubitarono di sacrificare al gusto ed alla ragione de' pregiudizj, che rendono spesso le nazioni ridicole per quell'onore stesso che esse vi attaccano. Ma i Francesi39, che di tutti i popoli sembrano aver l'orecchio il meno musicale, sono stati gli ultimi nell'Europa ad adottare il buon gusto della musica italiana. Chi non sa l'aspre guerre e le lunghe accanite altercazioni che suscitaronsi nella nazione da' zelanti partigiani della musica francese? “Noi abbiamo veduto a nostri giorni, scriveva un filosofo di que' tempi, delle persone assai folli, e d'un orgoglio abbastanza insoffribile per voler incitare il Magistrato a rigorosamente procedere contro lo scrittore che dando la preferenza alla musica italiana, era d'un sentimento diverso dal loro.” (Helvet. de l'esprit, Disc. II. Chap. III.) Finalmente dopo più di sessant'anni di guerre musicali, il gusto nazionale ha trionfato dell'ostinazione di alcuni individui interessati a sostenere un falso sistema: le penne filosofiche di Rousseau, di d'Alembert, dell'ab. d'Arnaud, di Suard, di Choron han dimostrato appieno la superiorità della musica italiana e della sua scuola. Ad imitazione dell'Italia si ha fin anche eretto in Parigi un Conservatorio di musica nel 1795. Secondo la sua attuale organizazzione, avendo per oggetto la conservazione e la riproduzione della musica in tutte le sue parti, e della declamazione drammatica ed oratoria, comprende due scuole particolari, una di musica, l'altra di declamazione. Un direttore e tre ispettori formano un comitato di direzione, e di soprantendenza all'insegnamento. Trentatrè professori, sei altri sopraggiunti e ventisette allievi ripetitori, danno di due giorni l'uno, lezioni a trecento allievi divisi per classi, tra quali vi ha circa a cento donne. Il cel. Cherubini italiano è uno de' maestri di composizione.
Il Conservatorio è divenuto un punto di riunione per tutti gli amatori di musica. Gli esercizj de' suoi allievi sono i più briosi concerti di Parigi. La musica strumentale sopra tutto vi si eseguisce con rara perfezione, sì per le sinfonie, come per gli a solo degl'istrumenti. Vi si sentono ancora i migliori pezzi di musica classica. L'Instituto nazionale delle Scienze e delle Arti distribuisce ciascun anno de' premj a quegli allievi che più disimpegnati si sono nel concorso musicale, e a spese dal Governo son questi mandati a Roma per compirvi i loro studj. Il Conservatorio ha reso in oltre de' nuovi servizj all'arte, con la pubblicazione di un corpo di opere elementari, compilato in ciascuna parte da' più valenti professori. Quelle, che sinora sono uscite alla luce, hanno avuto tal successo, che si sono sparse per tutta l'Europa e tradotte in più lingue. Si è unito al Conservatorio un teatro destinato a' pubblici esercizj degli allievi e alla distribuzione de' premj, ed una biblioteca pubblica contenente libri e produzioni musicali d'ogni genere.
Sebbene le opere di erudizion musicale sian rare in Francia, e molte ve n'abbia su la teoria, le quali, o hanno per autori degli Artisti, e per non saper eglino ben pensare e ben scrivere, son difettose per la sostanza e per la forma, o de' Letterati che non possedendone la pratica, non insegnano che sistemi ed errori, vi ha tuttavia gran copia di Trattati, i quali contengono delle eccellenti vedute su l'espressione, su l'imitazione, sulla poetica e sulla filosofia della musica. Oltre i Dizionarj di Brossard e di Rousseau, e la parte della grande Enciclopedia che tratta di quest'Arte e Scienza, l'Enciclopedia Metodica, più anni sono, intrapresa da alcuni illustri letterati e molto intendenti di musica di questa nazione, abbracciar doveva con maggior estensione tutti gli oggetti e tutte le parti della medesima; ma per disavventura non si è ancora, e non si sarà forse più oltre al primo volume pubblicato nel 1791. I suoi autori con una libertà e un disinganno, degno veramente della loro filosofia e de' loro lumi, quasi ad ogni articolo combattono gli antichi pregiudizj della lor nazione, e rendon giustizia alla scuola italiana.
Oltracciò un altro non meno insigne letterato della Francia, M. Choron, professore di mattematica, e capo di brigata nella scuola Politecnica, dopo un profondo studio di tutte le diverse scuole di musica, dopo aver letti i migliori didattici sì italiani che tedeschi, de' quali appreso aveva espressamente le lingue, mosso da zelo per gli avanzamenti di quest'Arte tra' suoi nazionali; diè al pubblico nel 1809, i Principj di Composizione delle scuole d'Italia in tre gran volumi in fol., elegantemente incisi in 1456 rami che formano un corpo compito e metodico delle migliori regole che si trovano sparse quà e là in più trattati di autori italiani. Quest'opera d'immense fatiche e d'immense spese, ha meritamente riscossa l'approvazione e gli applausi di tutti i buoni conoscitori non che della Francia ma dell'Europa intera, e può dirsi il trionfo della scuola italiana. Il suo Autore promette in oltre un'immensa collezione di tutti i Classici Italiani. Tale è oggidì lo stato della Musica in Francia, e tra le persone di educazione più non vi ha chi non apprenda la lingua e la musica italiana.
L'Inghilterra è il solo paese, dove la musica è stata considerata a segno di promuovere al dottorato; e ben può dirsi che leggiermente non vi si tratta questa scienza, dappoichè i decreti dell'università d'Oxford obbligano a far prova di sette anni di studio e di pratica, prima che si sia ammesso al grado di Baccelliere, e di altri cinque anni dopo di essere ammesso a questo grado, per aspirare a quello di Dottore. È d'uopo in oltre, per il primo grado, che si facciano eseguire in pubblico de' pezzi di musica a cinque parti, in una sessione intimata tre giorni innanzi; e per il dottorato, de' pezzi a sei e ad otto parti. Reca pur maraviglia che tale usanza, la quale rimonta sino al decimoquinto secolo, non sia stata imitata ancora da veruna delle nazioni d'Europa. Dopo più di un secolo il gusto degl'Inglesi per la musica è diviso a ragione tra quella de' Tedeschi per la strumentale, e quella degl'Italiani per la vocale. A quest'ogetto non vi ha tra le persone colte chi non impari la lingua italiana, per essere più sensibile agl'incanti della sua poesia e della sua musica, e per la stessa ragione vi sono colà più teatri di opere e serie e comiche in questa lingua, rappresentato da attori italiani. “I nostri giovani compositori, dice il dottor Burney parlando de' suoi nazionali, si fanno anche un merito di essere imitatori della musica italiana, senza che siano stati in Italia. Noi abbiamo in Inghilterra l'Opera italiana e seria e buffa in una grande perfezione, e nella lingua italiana, composte l'una e l'altra, ed eseguite dagl'Italiani. Puossi quindi convenire, che questo paese (l'Inghilterra) esser dee una scuola ben adatta a formare un giovane compositore.” (Travels etc.) “Londra sopra tutto è perciò divenuta l'Indie de' maestri, e de' virtuosi italiani: quando uno di questi giunge a contentare gl'Inglesi, comincia allora a stimare se stesso, ed a conoscere di quanta ricompensa sia degna la temerità d'aver affidata la propria sussistenza ad un'arte la di cui sorte dipende puramente dal capriccio.” (Eximeno l. 3, c. 4.) Molti Scrittori in oltre ha prodotti quest'isola su la Musica, che con la profondità delle loro riflessioni e delle loro erudite ricerche, ne hanno illustrato la teoria e la storia.
“La nazione Spagnuola tanto dal carattere, quanto dalla lingua ha dopo l'Italiana le disposizioni più vantaggiose per la Musica, ma queste restano quasi sterili, per mancanza di esercizio. Generalmente la Musica sta nella Spagna confinata nelle chiese, i di cui maestri di cappella sono ecclesiastici, e sono una vera appendice de' contrappuntisti del seicento. Nella Corte e nelle provincie meridionali vi è più passione e più senso per la musica: l'Opera italiana vi è molto ben intesa.” Ecco il saggio che ne dà un disinvolto Spagnuolo (Eximen. loc. cit.). Noi possiamo aggiungervi che molti di questa nazione son riusciti eccellenti compositori dopo di avere studiato in Italia; tali sono stati il Terradeglias, e più recentemente il Martini ed altri. Ma un più importante servigio reso da alcuni dotti Spagnuoli alla Musica sono le opere classiche di un Salinas tra gli antichi, e tra' moderni di un Eximeno, d'un Yriarte, d'un Arteaga, d'un Requeno. Ed ecco abbastanza per dar a divedere, come aveva promesso, il gusto particolare delle principali nazioni d'Europa in riguardo alla musica, e la parte che ha preso ciascuna ai progressi di quest'Arte e Scienza.
Non mi resta che dar conto ai lettori de' materiali, di cui ho fatto uso per la compilazione del presente Dizionario. In riguardo a' Greci e a' Latini Armonici mi sono servito, oltre delle Biblioteche Greca e Latina del Fabricio, della storia delle Scienze presso i Greci di Meiniers, dell'Autore de' Viaggi di Anacarsi, e principalmente de' Saggi del Requeno, sulle di cui tracce ho voluto dare una bastevole idea delle loro Opere. Per gli Scrittori ed Artisti Italiani io ho fatto uso del Tiraboschi, del Bettinelli, dell'Arteaga, del Martini, ec. Per quei delle altre nazioni io ho consultato, per quanto mi è stato possibile, i loro Storici, o le loro opere; e generalmente per tutti ho svolto più giornali, più storie letterarie, gli Atti e le Memorie di più Accademie; ed in questa occasione io devo a molti amici un pubblico attestato della mia riconoscenza per avermi soccorso co' loro lumi, e provveduto ancora di que' libri, che facevano all'uopo. Tutte le volte che io ho potuto aver per le mani le opere stesse de' Scrittori di Musica, io ne ho dato un più lungo Estratto, ed in mancanza di ciò non ho omesso di darne un Saggio d'appresso agli Autori che ne han parlato. Io ho cercato da per tutto delle notizie de' più celebri Compositori ed Autori tuttora viventi: pur nondimeno non ho la presunzione di credere, che molti non ne abbia omessi egualmente pregevoli. Avendone ulteriormente notizie saprò trarne profitto col mezzo di un Supplemento, che si darà alla fine dell'ultimo volume.
Dopo di avere io raccolti e messi in ordine tutti i materiali del mio Dizionario, pervenne a mia notizia che in Francia se ne era pubblicato già uno sullo stesso argomento; per lo che ragionevol cosa mi parve di sospendere allora il mio lavoro, e di ritardarne la pubblicazione. Ebbi l'attenzione di provvedermi di quel Dizionario, ed ecco il giudizio e l'uso che ne ho fatto. Il nome di M. Choron40 che va in fronte del medesimo come uno de' suoi autori, previene in suo favor da prima ogni lettore, che è al fatto de' gran servigj ch'egli ha reso alla Musica; ma, come dicesi espressamente nella prefazione, egli soltanto ne concepì il progetto, e l'esecuzione ne fu ad altre mani affidata41. Tranne alcuni pochissimi articoli e l'Introduzione, che è un eccellente compendio della Storia della moderna Musica, e quel medesimo che M. Choron aveva pubblicato alla fine del terzo volume de' suoi Principj di Composizione, tutto il resto appartiene a dirittura a un certo M. Fayolle, da cui pare che non si possa pretendere tutta l'esattezza e la perfezione, che senza dubbio vi si sarebbe trovata, se fosse stata l'opera di quel valent'uomo, a cui non mancavano i lumi e le cognizioni a ciò necessarie. Nel suo Dizionario vi si trova dell'eccesso e del difetto, e benchè abbracci una più vasta estensione di oggetti, vi ha tuttavia un'infinità di articoli che non contengono se non nomi oscuri e poco benemeriti dell'Arte, mentre moltissimi altri se ne omettono che tornerebbe più conto a far conoscere. Tali sono la più parte de' Greci Armonici e de' loro Scrittori di Storia musicale, de' quali se vi ha degli articoli, nè pur si dà un Saggio delle loro opere. Malgrado però questi difetti, mi è stato d'uopo confessarlo, egli mi è stato utile in riguardo agli Scrittori e Compositori moderni della Francia e della Germania. Io ne ho fatto uso, qualora non mi è riuscito di trovar altronde delle notizie. Ma oltre a quattrocento e più articoli del tutto nuovi nel mio presente Dizionario, che ivi in niun modo s'incontrano, si vedrà che non abbiamo tutti e due attinto agli stessi fonti. Il lettor ne faccia il paragone e ne giudichi.
Non presumo tutta volta di credere che io dato abbia nel segno, e che offra al pubblico un lavoro degno di lui. Sarei pur contento qualora di me venga detto lo stesso, che di certuno disse Longino. Questo Scrittore non è forse tanto da riprendersi a cagione de' suoi errori, quanto da lodarsi pel desiderio ch'egli ha avuto di far bene.
1
Rousseau, Dictionn. de Musique, au mot Opéra.
2
Allorchè nel Prospetto del presente Dizionario mi avanzai ad asserire, che la Storia Letteraria della Musica è stata sinora un ramo trascurato della letteratura; intendendo già dir ciò per l'Italia, certi saccentuzzi di Provincia per prurito di smentirmi, mi opposero la Storia della Musica del P. Martini: senza riflettere o non saper discernere, che dessa non è che una Storia generale e piuttosto didattica, e che per disavventura, sebbene tre ben grossi volumi ne avesse pubblicati l'autore, non sorpassa frattanto l'epoca in cui fiorì la musica presso i Greci. Mi venne opposta ancora l'Opera dello Spagnuolo Eximeno: Dell'origine e delle regole della Musica, e 'l Dizionario di Rousseau, i quali di tutt'altro trattano che di storia letteraria. Conquerar? aut taceam? Ponam sine nomine crimen.
3
In quest'anno medesimo 1814 è uscita in Londra un'Opera, che molto farebbe al nostro proposito se avesse potuto giungerci a tempo: eccone il titolo e l'autore: A. Burgh's Anecdotes historical and biographical of music in letters, 3 vol. in 8vo. V. Giorn. Encicloped. di Sicil. Settembre, n. IX, pag. 95.
4
La Storia degli Artisti in quanto conduce a rischiarar quella dell'Arte, non è stata punto trascurata dagli Antichi, e massimamente da' Greci, presso i quali la Musica era la loro Enciclopedia, come diremo di poi: Aristosseno scritto avea la vita di più Musici, che lo precedettero (Plutarch. lib. quod non suaviter vivi possit sec. Epicur.): Teofrasto la storia di molti cel. suonatori di Tibia e d'altri stromenti (Laert. V. 50). Dionigio d'Alicarnasso il giovane tessuto aveva in 26 libri gli encomj degli Armonici e Poeti d'ogni genere (Suida in Dionys.): e Fillide di Delo citato da Ateneo (L. XIV), e Glauco di Reggio citato da Plutarco (Dial. de Mus.), e Prassidama e Rufo scritto ancora avevano la Storia dei Greci Musici (V. Jonsium Hist. Script. Philos.): ma le loro Opere, come tant'altri monumenti dell'umana industria, sono divenute miserabil preda del vorace tempo e dell'oblío. Non ci restano che scarse notizie degli antichi Artisti presso Ateneo, Giulio Polluce e Plutarco, e da ciò deriva la poca cognizione che noi abbiamo della Greca Musica.
5
A formare un tal quadro della Musica noi ci siamo serviti dell'eccellente Opera di Mr. Choron intitolata: Principes de Composition des Ecoles d'Italie, etc. T. 3 in fol. a Paris 1808.
6
Non consideriamo qui il suono nel suo significato generico, con cui si dinotano tutte le sensazioni che riceviamo per mezzo dell'organo dell'udito, ma il suono soltanto musicale, cioè quello della voce cantante e degli stromenti. Il musico, riguardandolo come l'elemento di un linguaggio, si occupa de' mezzi di riprodurlo e di applicarlo a' piaceri del senso o all'imitazione degli ogetti.
7
“Pochi son quelli, dice un dotto Inglese (M. Usher) che provato non hanno le dolcezze della Musica, e le di lei espressioni intelligibili al cuore. Ella è un linguaggio di così piacevole sentimento, che è assai più eloquente della parola medesima.” V. Elegant Extracts, London 1812, t. 2.
8
Quest'argomento è stato dottissimamente trattato da un valentuomo nostro nazionale in un'Opera da lui pubblicata in Parigi nel corso di quest'anno 1814, con questo titolo: Les vrais principes de la versification développés par un examen comparatif entre la langue italienne et la française: 3 vol. in 8º gr. a Paris ec. L'autore è il Sig. Ab. Scoppa siciliano colà da più tempo stabilito, e che vi si è fatto molto onore con più opere date alla luce. Noi ci faremo un dovere di dar conto al pubblico in un articolo del presente Dizionario, della prima testè citata ove con molta profondità di erudizione e di filosofia si ragiona della Musica. La bontà e la gentilezza, con cui il Dottor Scoppa fratello dell'autore mi fece l'onore di comunicarmela, mi obbliga a qui rendergli un pubblico attestato della mia riconoscenza.
9
“La variazione dei tempi, dice il dotto Arteaga, la diversità de' gusti, che tanto influisce su le cose musicali, e forse ancora l'eccessivo lusso della musica presente farebbero in oggi comparir quella assai povera e rozza. In fatti scarseggia di note, il senso non vi si comprende abbastanza, abbonda poco di varietà… ma in contraccambio regna in quelle composizioni una certa semplicità preferibile a molti riguardi alla sfoggiata pompa della nostra… Maestri e musici del nostro tempo, che col fasto proprio dell'ignoranza vilipendete le gloriose fatiche degli altri secoli, ditemi se alcun si trova fra voi che sappia tanto avanti nei principj filosofici dell'arte propria quanto sapevano quegli uomini, che voi onorate coll'urbano titolo di seguaci del rancidume ec.” Rivoluz. t. 1, p. 257.
10
Per questa ragione ho omesso più articoli di Compositori di musica madrigalesca Siciliani, che riferiti vengono dal Mongitori nella sua Biblioteca Sicola, ove, chi avrebbe tale curiosità, può ben soddisfarsela. Ho creduto dovere avvertirlo, affinchè una tale omissione non mi si attribuisca a freddezza e disinvoltura per le cose patriottiche. Non ho trascurato per altro di far menzione di molti tra' nostri nazionali che han reso un particolar servizio alla Musica o come Scrittori, o come Artisti.
11
“Alla Musica è avvenuto lo stesso che a tutte le altre Arti inventate dagli uomini; il caso da principio ha imparati alcuni fatti; l'osservazione e la riflessione ne ha ben presto scoverti degli altri; e da questi differenti fatti, combinati e messi insieme, non han tardato i Filosofi di formare un corpo di Scienza, che quindi si è per gradi accresciuto.” M. d'Alembert, Elém. de Mus. etc.
12
L'Acustica è la teoria del suono, ed ha per oggetti: 1. i rapporti numerici delle vibrazioni, 2. le vibrazioni proprie de' corpi sonori, 3. le vibrazioni comunicate ossia la propagazione del suono, 4. la sensazione del suono, o l'udito. Il num. 1 forma la parte aritmetica, i num. 2 e 3 la parte meccanica, e il num. 4, la parte fisiologica dell'Acustica. La parte meccanica è molto utile per l'invenzione di nuovi stromenti musicali, e per la perfezione di que' già ritrovati: come ancora per il loro temperamento.
13
L'erudito ab. Andres ha tessuto colla sua solita precisione e chiarezza la Storia dell'Acustica nel 4º tomo, ove tratta di quella delle Mattematiche. Ed ecco qual giudizio egli reca degli antichi coltivatori della medesima. “Ma potremo dir nondimeno (sono le sue parole), che ad alto grido fosse realmente venuto il loro sapere in questa materia? Veramente le loro cognizioni meccaniche nella formazione del suono non possono dirsi molto avanzate. Nicomaco lungamente ci spiega la dottrina de' pitagorici, e lo strepito e suono, che volevano prodursi da tutti i corpi moventisi, e le acustiche proporzioni de' suoni musicali, che credevano poter didurre dal moto circolare de' sette pianeti… ma confesso che non so vedervi che somma scarsezza d'astronomiche cognizioni, ed ignoranza nelle meccaniche ed acustiche. Questa ignoranza ci viene in oltre mostrata in tutti i Greci dagli spacciati e creduti racconti de' martelli, de' bicchieri, de' piatti, quali provano nondimeno, che qualche confusa idea pur v'era de' principj del suono, e degli elementi di lunghezza, grossezza, e tensione, che deono entrare nel suo calcolo. Aristotele, Eliano e Porfirio sono gli unici antichi, ch'abbiano trattato della meccanica del suono; ma que' profondi filosofi altro non seppero discoprire, se non che il moto dell'aria è la cagione del suono che grave producesi col moto tardo, acuto col celere, e che perciò le corde più lunghe e più grosse daranno un suono più grave, grossolanamente sbagliando nel farne l'applicazione agli stromenti da fiato, e generalmente poco sapendo della meccanica del suono.”
14
V. il vol. 7 dell'antica Enciclopedia, p. 62.
15
Il P. Sacchi nella sua dotta lettera al Sig. Pichl sulle Quinte successive nel Contrappunto ec., dopo avere riferite queste medesime parole dell'Alembert p. 73, così soggiunge: “Un recentissimo Scrittore (il Sig. Testori), il quale per altro nella pratica è stato a ragione in questi tempi molto celebre, ha voluto procedere per l'antica via; e di più insulta all'avviso del dottissimo filosofo, e matematico dicendo: scherzi per tanto a suo talento quel bello spirito: se ne faccia pure scudo il pratico Professore: e se ne formi scimitarra quel tal Matematico per tutto distruggere, e far della Musica un Caos; mentre noi seguendo le traccie di Cl. Tolomeo, di Severino Boezio, e d'altri simili Autori, ci adopereremo a stabilire ed a conservar la Musica nel suo diritto di scienza matematica. Io vorrei, che l'illustre Autore avesse preso altro cammino, che ben poteva e sapeva: e che da queste parole, con troppa confidenza dette, si fosse astenuto. Certamente la Musica, cioè la sua prima parte, l'Acustica, appartiene alla Matematica, secondo ch'io penso; ma se noi ci contenteremo di esprimere le vere misure delle corde, e delle voci, e le vere proporzioni delle consonanze, ben pochi numeri ci basteranno.”
16
Terminiamo questa materia con l'autorità di un altro dotto spagnuolo, e filosofo-musico: egli è l'ab. Requeno. “Un altro pregiudizio, egli dice, non solo è stato comune a' grandi ed a' piccioli professori, ma a tutte eziandio le persone di studio e fin anco alla plebe; ed è, che, per parlare a fondo della Musica antica o moderna, fosse di bisogno la Matematica, la scienza del numero pel calcolo delle corde armoniche: contro della quale preoccupazione ardente e coraggioso si dichiarò il primo a ragione lo spregiudicato Eximeno, da cui è dimostrata nella moderna armonia l'insufficienza del calcolo. Noi, per dimostrarla nell'antica, ci rimettiamo a' più rispettabili de' greci armonici, in cui non è bisogno d'altro calcolo oltre quello di saper contare sino a dodici, come faremo palese nel proprio luogo ec.” Saggi sul ristabilim. dell'Arte armonica de' greci, ec. Prefaz. Tom. I. p. XXVIII.
17
“Noi non dubitiamo punto di asserire, dice il dotto Mr. Choron, che questo prurito di applicare la fisica e la geometria alla musica, e di pretendere dedurne le regole d'un'arte unicamente fondata sull'organizazzione e la natura dell'uomo, non sia il più caratteristico contrassegno dell'ignoranza e falsità di spirito. Non già che la cognizion della fisica o della geometria sia del tutto inutile al musico; ma fa d'uopo di molto discernimento per conoscere precisamente l'uso che farne conviene.” (V. art. Rameau) Egli promette ancora di mostrar ciò con più estensione, e con argomenti i più decisivi, in un trattato che è presso a dare al pubblico.
18
Tale è il sistema o la teoria di Rameau, della quale così ragiona Mr. Framery uno degli autori della nuova Enciclopedia metodica. “La più parte delle sue regole, egli dice, in contraddizione con la pratica, producono almanco tante eccezioni quanti sono i casi, ai quali si applicano, e quindi non servono che ad inviluppare lo spirito. Questa difficoltà di accordare la pratica col suo sistema ha trascinato Rameau in molti errori.” (Préf. à l'Encycl. method. de la Musique, a Paris 1791, in 4º.) Tale è il sistema del per altro pregevolissimo Tartini, il quale per testimonianza medesima del suo intimo amico il P. Colombo, ignorando fin anco l'aritmetica semplice, volle ciò non ostante fare gran pompa di calcoli, e darsi così l'aria di un profondo teorico. Gran violinista, eccellente compositore, ma niente geometra; debole fisico e più cattivo logico, ebbe la smania, come Rameau, di fare un sistema così involuto ed oscuro, che nè il lettore, nè potè egli stesso nulla intendervi: non era in fatti possibile, se non a forza di oscurità il dare un'apparenza di realità a siffatte chimere (Veggansi Forkel, Musikalisk Almanac; e Scheibe, Tratt. di Composiz.) Bastino questi due esempi come de' più celebri per giudicare del resto.
19
Il primo di costoro nell'eccellente Opera dell'Origine ec. nel cap. V, del I libro: e l'altro nell'Esame del sistema musico di Mr. Rameau, stampato nel 1779. V. il Gior. de' Letter. d'Italia in Modena, tom. 21.
20
“Rameau, dice Mr. Choron, ebbe in Francia assai comentatori del tutto stranieri per l'arte, ma che ebbero il talento di persuadere il pubblico, ch'egli era il creatore d'una scienza di cui ne rovesciava i principj.” (V. Esquisse historique des progrès de la Composition, pag. 29.) Ben può a lui applicarsi quel che di Ronsard disse Boileau:
… par autre méthode
Réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode. Art. Poet.
21
Nel tempo stesso in cui i Francesi impazzavano per il sistema di Rameau, le scuole più celebri dell'Italia e della Germania non ne fecero verun conto, e conoscendone i difetti e l'inutilità insieme, si accinsero a confutarlo. Venuto meno col progresso del tempo in Francia l'entusiasmo e lo spirito di partito, cadde ancora colà. Ecco come ne ragiona uno Scrittore classico di questa nazione. “Rameau, egli dice, non ostante tutti i suoi sforzi, è a ciascun passo in contraddizione con la pratica della scuola: ed altro risultato non produce che l'avere introdotto nell'atto della composizione la considerazione assai disagiosa e per altro del tutto inutile dei rivolti d'armonia. Quest'è la ragione per cui il suo sistema, che mai è stato ricevuto nè in Italia, nè in Alemagna, è oggidì universalmente rigettato fin anco in Francia.” (Choron, Princip. de Composit., a Paris 1808.) E pure chi il crederebbe? un recente scrittore sedicente filarmonico, che forse non sortì altro dalla natura che uno sterile amore per l'armonia, in una delle sue lettere, o per dir meglio in una delle sue rapsodie misarmoniche vuol darci a credere che fosse il Rameau un altro Prometeo che furò a Giove il fuoco dal cielo, e furando egli medesimo le stessissime parole dell'Alembert e d'altri entusiasti francesi ci ripete la vecchia loro nenia, cioè che “prima del celebre Rameau una cieca esperienza era l'unica bussola degli artisti: e ch'egli il primo ha fatto divenir la Musica una scienza degna di occupare i filosofi, ec.” Ma chi non sa che sommi uomini prima di Rameau fatto avean della Musica una scienza che meritevole la resero dell'attenzion de' filosofi? Tali furono e Galileo, e Doni, e Cavalieri, e Gassendi, e Mersenne, e Cartesio, e Wallis e cento altri. Risum teneatis amici? Dopo così smodati elogj profusi al suo caro Rameau, pretende sin anco inbeccarci il di lui sistema del basso fondamentale e de' rivolti, come esatto e facile e nuovo e 'l migliore che sia possibile. Quel ch'è peggio, si è che al dir di Boileau,
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire
22
Ben vero è però, che sebbene il Rousseau lodi alle volte ed esponga nel suo Dizionario il sistema di Rameau, perchè più generalmente conosciuto e in gran voga allora presso la sua nazione, a pro della quale destinava egli principalmente il suo libro, tuttavia così si protesta in sul principio: Quoique ce systême imparfait et défectueux à tant d'égards, ne soit point, selon moi, celui de la Nature et de la verité (Préf. p. VIII).
23
A chi ha cognizione dell'economia, del commercio dell'anima e del corpo, e singolarmente delle sensazioni che si sveglian in noi per via di tremori, facile in vero è l'immaginare la forza e gli effetti fisici della Musica. Imperciocchè l'armonia stessa non è che tremor potentissimo pria nel corpo sonoro, e quindi nell'aria eccitato, e comunicato finalmente ai nervi dell'udito. Laonde a questa forza è dovuta la sensazion potentissima che si sveglia nell'anima, siccome il mostran le anime ancor irragionevoli delle bestie, or ammansate, or dalla musica ridotte a maggior furore, ma molto più quelle ragionevoli degli uomini, giacchè di questi leggiamo e li vediamo ancor noi alle volte tratti fuor di se non potere agire che a seconda degli affetti dalla Musica inspirati.
24
Questa idea, dice il Dr. Lichtenthal, non fu onorata sinora secondo la sua eccellenza, e raramente ha potuto gloriarsi di alcuni paragrafi presso gli autori. Egli cercando di spargere più di lume su questo punto diè al pubblico nel 1806, primieramente in lingua tedesca e quindi da lui stesso nell'italiana tradotto il suo Trattato dell'influenza della Musica sul corpo umano, e del suo uso in certe malattie, Milano 1811, in 8vo. Anche il Dr. Mojon italiano, professore di medicina in Genova, celebre per più dotte opere in questa facoltà date alla luce, pubblicò quivi una Memoria sull'utilità della Musica sì nello stato di sanità, che in quello di malattia, tradotta poi nel francese dal Dr. Muggetti, e impressa in Parigi nel 1803, in 8vo.
25
Anche i Cinesi vantano qualche Scrittore della loro musica. Nel Giornale Straniero dell'ab. Arnaud nel mese di Luglio 1761 si trova l'estratto di una produzione ms. di un libro intorno all'Antica Musica Cinese composta da Ly-Koang-Ty dottore e membro del primo tribunale di lettere di quell'impero. Su la musica de' Cinesi possono anche consultarsi le Memorie del P. Amiot, e l'articolo ben lungo di M. Ginguené nella nuova Enciclopedia, Musique des Chinois.
26
Veggansi più luoghi della divina Scrittura, come nel Genesi, nell'Esodo, nei libri de' Re, e de' Paralipomeni, ed il cap. 44, dell'Ecclesiastico.
27
Intorno all'origine della musica presso i Greci, puossi leggere con profitto la Storia che con fior di erudizione e di senno ne tesse il dotto ab. Requeno. Egli ne fa derivar loro la cognizione dagli Egizj, ed a questi dai figli di Noemo, che appreso l'avevano dai discendenti de' primi inventori del suono e del canto Jubal ed Enoch. Saggi ec. Tom. 1, cap. 2, e. 4.
28
Leggasi l'esposizione di questo strano sistema nell'opera classica dell'Eximeno, e la dotta confutazione insieme ch'egli ne ha fatta nel cap. 1, del primo libro. “I moderni letterati credono, che Pitagora perfezionasse l'arte armonica, e che la cavasse dall'antica rozzezza; ma basta vedere il piano dell'arte musica anteriore a Pitagora, e l'altro da lui introdotto nella Grecia, per capire quanto danno arrecassero i Pitagorici all'armonia.” Requeno Saggi t. 1, part. 2, cap. 1.
29
Ecco le sue parole: “Ci starebbe molto a cuore che per rischiarare, per quanto sia possibile, questo punto importante della Storia delle Scienze, qualche uomo di lettere, versato del pari nella lingua greca e nella musica, si accingesse a riunire e discutere in una stessa opera le opinioni più verisimili stabilite o proposte dai dotti sopra un argomento sì curioso e difficile. Questa Storia ragionata dell'antica Musica è un'opera che manca alla nostra letteratura.” Disc. prélim. aux Elém. de Mus.
30
Brown, dissert. sull'origine, unione ec. della poesia e della musica, Londra 1763.
31
Nell'Enciclopedia Metodica all'articolo Arabes si dà un Saggio della musica specolativa e pratica di questa nazione.
32
C'est aux Italiens que l'Europe doit la renaissance de la musique comme de tous les arts. Mr. Suard, au mot Académie dans l'Encyclop. method.
33
Sotto il glorioso governo e la protezione de' generosi nostri Sovrani Carlo e Ferdinando, esistevano in florido stato questi Conservatorj di Napoli. La provida cura e 'l zelo per gli avanzamenti di questa bell'arte mossero l'attuale nostro Monarca a formar sin anche per quello detto della Pietà nel 1792; una copiosa Biblioteca di libri teorici, non che di carte d'ogni genere di Musica antica e moderna, di cui ne affidò l'impegno al celebre letterato D. Saverio Mattei. Ma, da che questa città cadde sotto la dominazione francese, si sa che i tre Conservatorj furon ridotti a un solo, la di cui organizazzione, per confession medesima di M. Choron, non ha riuniti i suffragj di tutti.
34
Una pia fondazione di un Conservatorio vi ha anche in Palermo sin dal 1618, detto de' figliuoli dispersi, ai quali facevansi solo da prima apprendere le arti meccaniche. Pensò quindi saggiamente il Governo nel 1747 di aggiungervi la musica ed altri studj per migliorarne l'educazione. Prosperi ne furono i principj, e non pochi allievi ne sortirono virtuosi per la composizione, per il canto e la parte strumentale, che non solo si sparsero in tutto il regno, ma portatisi alcuni di loro in Germania, in Francia, in Spagna, in Inghilterra ed altrove, o vi si stabilirono con onore ed ottimo successo, o ritornarono nella patria dopo di avervi riscossi e meritati degli applausi. Moltissimi potrei annoverarne se non me l'impedisse la brevità d'una nota. Coll'andar però del tempo, per le angustie del paese, più non bastando le rendite a mantenere il necessario numero de' maestri, ed un sufficiente numero di allievi per tutti i rami dell'Arte, questo Conservatorio di Musica è venuto meno a segno che corresi rischio di non esservi di quà a pochi anni più musica in Sicilia. L'anno scorso volendovi provvedere il Governo, diè a me e al Sig. Guerra l'ordine di formare un Piano di Scuola di Musica per una nuova organizazzione del Conservatorio: si ebbe la bontà di approvarlo; ma altre più interessanti cure gli sono state sinora d'ostacolo, perchè non si sia potuto mettere in esecuzione.
Il Conservatorio di Milano è d'una data assai recente: egli non fu stabilito che nel 1808, il cel. maestro Bonifacio Asioli ne ebbe allora la direzione. Egli è formato di 14 professori e di 60 allievi tanto pensionarj che esteri, e ha dati già de' soddisfacenti risultati. Di ciò ne sia un picciol saggio, che dopo men di quattro anni della sua istituzione si fu in istato di farvi eseguire con esattezza la cel. musica della Creazione e delle quattro stagioni di Haydn da' suoi allievi, come glie ne rende pubblica testimonianza il Sig. Carpani nelle sue Haydine, Lett. 11, nella nota p. 186.
35
La scuola italiana, dice quest'ultimo, è la migliore che esiste, tanto per la composizione che per il canto; la melodia degli Italiani è semplice e bella… Con qual piacere io mi trovai in un colpo nelle praterie smaltate di fiori, dove si sarebbe detto che un Genio benefico mi avesse trasportato dalla terra ai cieli! Ma quale fu la mia sorpresa allorchè intesi per la prima volta i canti italiani… questa fu la prima lezione di musica che io ricevetti in un paese ove io correva per instruirmene. Le contrade settentrionali di Europa non han mai prodotto Artisti segnalati, che non abbiano fatto un soggiorno più o meno lungo nell'Italia. Sembra al certo, che questo sia un tributo da pagarsi a quel clima privilegiato, che in ricompensa ne assicura la loro riputazione. Gretry, Essai de Musique, p. 131 seg. edit. de Paris.
36
Non solo gli Imperatori ma la più parte eziandio de' Principi della Germania sono stati in ogni tempo i più zelanti e più generosi Mecenati di un'Arte che essi medesimi per lo più non isdegnavano di coltivare. L'elettor Palatino, la di lui sorella l'elettrice di Sassonia, a cui si fè gloria di dedicar l'Opera sua l'Eximeno, il duca di Wittenberga, senza escluderne il gran Federico re di Prussia sono stati compositori di musica. Si sa che quest'ultimo, il quale regolava da se stesso tutti gli affari di un gran regno, trovava il tempo di sonar di flauto ciascun giorno, per levarsi di noja, con Quantz suo maestro, e che compose un minuetto nella sua tenda dopo aver perduta la battaglia di Collin.
37
Il dotto ab. Lami, che per più anni in un foglio periodico di Firenze proccurò di spargere de' lumi e del buon gusto nell'Italia, mostrava un dì a un forestiero le curiosità di quel paese. Nel vedere il palazzo Pitti, ecco, disse il forestiero, la culla delle arti; ed eccone la sepoltura, gli rispose Lami, nel mostrargli la casa de' Gesuiti che era dirimpetto a quel palazzo.
38
In Berlino vi ha uno stabilimento per mantener 24 figliuoli, che sono instruiti nella musica, vestiti in uniforme, e vanno così a cantar per le strade.
39
Les françois sont celui des peuples qui paroissent avoir l'oreille la moins musicale (M. Suard).
40
Questo è il titolo dell'opera: Dictionnaire Historique des Musiciens Artistes & Amateurs, morts ou vivans, qui se sont illustrés en une partie quelconque de la Musique et des Arts qui y sont relatifs, tels que Compositeurs, Ecrivains didactiques, Théoriciens, Poëtes, Auteurs lyriques, Chanteurs, Instrumentistes, Luthiers, Facteurs, Graveurs, Imprimeurs de musique, etc. Par Al. Choron et F. Fayolle, tom. 2, in 8vo a Paris 1810, e 1711.
41
La santé de M. Choron ayant éprouvé un dérangement assez long et assez violent, M. Fayolle resta seul chargé du travail, et le fit presqu'en entier; en sorte que, si l'on excepte l'introduction et un très-petit nombre d'articles, cet ouvrage est devenu le sien. Avant-Propos p. 1.