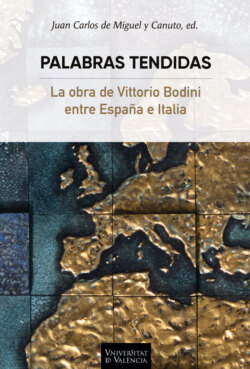Читать книгу Palabras tendidas - AA.VV - Страница 8
ОглавлениеALLE ORIGINI DELLA «VOCAZIONE ISPANOFILA» DI VITTORIO BODINI: IL DIARIO ROMANO E ALTRI SCRITTI (1944-1946)
Carolina Tundo
Università del Salento
Quando Vittorio Bodini approda a Roma nel 1944, all’età di trent’anni, benché molto giovane ha già alle spalle anni di esperienza in campo letterario e di consolidamento della sua formazione. Risale al periodo universitario fiorentino, per esempio, la frequentazione del Caffè delle Giubbe rosse, punto di ritrovo dei principali esponenti del panorama letterario italiano degli anni Quaranta (si parla di Gadda, Luzi, Montale). E proprio grazie a Montale, già quattro anni prima, nel ‘40, alcune sue poesie (Bodini 1940) erano apparse sulla rivista di Bonsanti, Letteratura.1 Inoltre, sulla terza pagina della storica rivista leccese Vedetta mediterranea, a cui collaborava insieme a Oreste Macrì e Leonardo Sinisgalli, aveva già pubblicato anche le sue prime traduzioni, quelle degli spagnoli Jiménez (Bodini 1941a) e Larrea (Bodini 1941b) –il «ventisettano» che Bodini definirà, nell’«Introduzione» all’Antologia dei poeti surrealisti spagnoli, come «il padre misconosciuto del surrealismo in Spagna» (Bodini 1963).
Durante il periodo capitolino, si impegna a livello politico e sindacale, in netta direzione antifascista; la sua produzione letteraria, inoltre, è ricca e diversificata, e spazia dai testi creativi in versi o in prosa, agli articoli di critica letteraria, alle traduzioni. Risale al 1945, la traduzione di una leyenda di Becquer, apparsa sul periodico Domenica con titolo: Il miserere (Bodini 1945b). C’è poi la traduzione di El retablillo de Don Cristòbal, farsa di Federico García Lorca scritta dallo spagnolo nel 1931, e pubblicata in italiano col titolo Teatrino di Don Cristobal farsa guignolesca sulla rivista napoletana Aretusa (Bodini 1945c).
35
Il motivo centrale del divertente dramma di Lorca riguarda le vicissitudini di un vecchio ricco –Don Cristobal, appunto– che sposa una giovanissima fanciulla, secondo un topos ben radicato nel teatro popolare, che trova le sue radici nel genere minore della burla amorosa.
Il folklore popolare andaluso diventa, per Lorca, un serbatoio inesauribile di ispirazioni, e anche le filastrocche per bambini o le canzoncine infantili veicolano un valore antropologico; proprio come sarà per Bodini, che rievocherà situazioni e costumi tipici del suo Sud, il Salento, e, allo stesso tempo, descriverà con sagacia situazioni e tipi umani, scavando nella loro psicologia. Si pensi, ad esempio, al folletto salentino corrispettivo del duende lorchiano che compare anche nel Diario romano di Vittorio Bodini –del quale diremo a breve–: si racconta di una notte trascorsa a rievocare le «gesta acute e terribili» degli spiritelli salentini, qui definiti da Bodini come una «malattia della luna: concrescenze formate dalla corruzione della sua luce».
Ma torniamo alle traduzioni: su Domenica, sempre nel ‘45, esce quella di Las aceitunas del drammaturgo spagnolo Lope de Rueda, col titolo italiano Le olive (Bodini 1945a). In Lope de Rueda Bodini scopre il maestro di Cervantes, e, secondo quanto affermato da Oreste Macrì, aveva in progetto di riunire in un unico volume tutte le sue traduzioni dei pasos dello spagnolo.2 In questi intermezzi recitativi agiscono personaggi stereotipati cari alla tradizione iberica, come il gracioso –il personaggio comico– o il galán –il cavaliere innamorato–, immortalati da altri classici della letteratura spagnola come Caldéron de la Barca o Tirso de Molina, che rincontreremo in seguito.
L’interesse di Bodini per la Spagna si esprime dunque in maniera ‘trasversale’, attraverso le traduzioni, e ‘direttamente’, nella sua scrittura. A testimoniarlo sono anche alcuni testi inediti, trascritti e analizzati in occasione di questo intervento.
Innanzitutto alcune informazioni: il materiale selezionato è conservato nell’Archivio Vittorio Bodini, presso la Biblioteca Interfacoltà dell’Università del Salento. Acquisito dall’Università nel 1987, e successivamente ordinato e inventariato dal personale dell’Archivio centrale dello Stato, il Fondo Bodini comprende un ricco carteggio e un elevato numero di testi poetici e letterari (manoscritti o dattiloscritti), insieme al materiale a stampa. Questa vasta documentazione è testimonianza del lungo e inquieto percorso intellettuale di Bodini, nonché delle sue tante anime di «scrittore, poeta, critico letterario, ispanista» (Serio, Valli 1992: 10), coprendo un arco temporale che va dal 1932 al 1970. Il Fondo è stato inventariato sulla base di uno schema di ordinamento applicato alla documentazione dallo stesso Bodini, con le varie serie già individuate e organizzate.
Foto 1: ms., 107x160x150 mm (misure della copertina). Quaderno con copertina rigida e fogli a quadretti; composto di 124 cc. non numerate, tutte con taglio rosso.
La serie intitolata Prosa Invenzione riunisce tutti gli scritti originali, siano essi racconti, articoli di giornale, soggetti per film o romanzi. Ciascuno di essi risulta legato a un particolare periodo della vita dell’autore, e si rivela portatore di suggestioni e sollecitazioni intellettuali di varia natura, ascrivibili ai diversi ambienti culturali dei luoghi in cui visse. Lo stesso Bodini li aveva raggruppati per tema: «Tema salentino», «Tema fiorentino», «Tema spagnolo» e «Tema vario»: denominazioni che sono state mantenute al momento dell’inventariazione e che identificano attualmente i fascicoli in cui è organizzata la serie.
Il fascicolo «Tema vario», come si intuisce dal titolo assegnatogli, comprende testi in prosa di diverso genere, cronologicamente riconducibili agli anni 1944-1970. Gli scritti qui esaminati appartengono a questo fascicolo; in particolare, ci soffermeremo sugli anni 1944-1946, che coincidono con il periodo di permanenza a Roma di Bodini, immediatamente prima di partire per la Spagna.
Si tratta di: 1) un quadernetto contenente le pagine di un diario (foto 1), tenuto dall’autore negli anni 1944-1951, a cui si è scelto di dare il titolo di Diario romano, trattandosi di un manoscritto anepigrafo. Le ragioni di questa scelta risiedono nel fatto che le annotazioni –di carattere prettamente diaristico– sono relative al periodo 1944-1946; 2) un racconto dattiloscritto con correzioni autografe, dal titolo, già assegnato da Bodini, di Roma 1944 (lo scritto non riporta la data, ma risale probabilmente al 1945, come suggerisce la copertina del sotto-fascicolo) (foto 2); 3) infine, una prosa argomentativa dal titolo Quaderno giallo, assegnato dallo stesso autore, di cui possediamo la copia manoscritta e quella dattiloscritta, entrambe senza data. Per le coordinate cronologiche si è fatto riferimento, ancora una volta, alla data riportata sulla copertina del sotto-fascicolo: «1945-46».
Tenendo conto delle differenze tra i vari documenti, si può sostenere che, in essi, riecheggia quel concetto di «realismo apparente» individuato da Donato Valli (1984) come linea dominante delle prose bodiniane, specie di quelle degli esordi. Anche il Diario romano –che pure rappresenta una forma di scrittura privata, dispensatrice di un autobiografismo che appare sincero– sembra impregnato di un certo realismo ibrido, che talvolta non consente di distinguere la realtà dalla finzione e che costituisce il filo conduttore anche di questi scritti. La realtà, la vita di ogni giorno, offrono lo spunto alla scrittura, e viceversa: esse si alimentano vicendevolmente, si contaminano, si mescolano.
In virtù di queste considerazioni, è bene non indulgere a una lettura in chiave rigorosamente autobiografica dei testi bodiniani. Questi inediti, infatti, comprovano l’ininterrotta dialettica tra due poli, vita e letteratura, che da sempre caratterizza l’iter letterario dello scrittore, e testimoniano l’apparizione –talvolta prepotente– di alcuni motivi che saranno ricorrenti nella sua scrittura: si tratta dei temi del sogno, della natura e del paesaggio, della vocazione ispanofila. Fa capolino la luna, destinata a diventare il mitologema per eccellenza della poetica bodiniana, che nel Diario romano compare sin dalla prima pagina, legata al rosso del sangue uterino di una donna, ed è una luna che «s’infulva», come accade nella poesia Egloga (Bodini 1997), risalente allo stesso periodo; poi, sempre nel diario, la luna è surrealisticamente «molliccia come la scolatura d’una candela. (Si versa nella stanza senza rumore.)», oppure «ha il sapore di una mela tagliata». Compaiono i ricordi della terra-madre, con i suoi colori, i suoi usi e le sue radicate superstizioni, che hanno seguito l’autore nei vari spostamenti, fino all’arrivo a Roma.
Foto 2: ds., 210x310 mm. 5 cc. veline numerate, dattiloscritte sul recto. Ms., 105x150 mm. Fascicoletto di 14 cc. non numerate, ottenuto utilizzando 7 fogli del Modulario L.P.; i fogli del Modulario recano l’indicazione d’origine e il numero romano indica l’anno della dittatura fascista.
Come si diceva, nel Diario romano affiorano i primi riferimenti alla cultura della Spagna: si nomina, ad esempio, la poetessa Fernan Caballero e, alla pagina del 28 dicembre 1944, si legge: «Appunto per Oreste Macrì. Inventare un grande autore spagnolo, possibilmente un poeta, facendone traduzioni e un saggio critico» (foto 3). Ma è nell’incipit del racconto Roma 1944 che Bodini confessa espressamente il suo amore per la lingua spagnola (foto 4). Il racconto autobiografico –del quale ci è giunta la copia dattiloscritta– è stato probabilmente composto nel 1945, come confermano alcuni dati testuali e contestuali. In primis, è il titolo stesso del racconto a fornire un termine a quo: di certo, non è stato composto prima del 1944; ma anche i tempi del discorso narrativo e le locuzioni avverbiali, tutti al passato, sono portatori di informazione in questo senso –in particolare, l’uso del tempo imperfetto restituisce l’immagine di una rievocazione memoriale relativa a esperienze autobiografiche recenti.
Foto 3: pagina del Diario romano datata 28 dicembre [1944].
Si tratta, come dicevamo, di un racconto autobiografico, in cui il narratore è omodiegetico e coincide con l’autore reale. L’intreccio del racconto è di tipo episodico: gli episodi, cioè, sono uniti da legami piuttosto deboli, tanto che ognuno di essi può considerarsi una unità autonoma, un microracconto. Il primo dei tre microracconti di cui si compone questo scritto dà in apparenza l’idea di un soliloquio, che pone subito la scena in medias res. Il narratore-autore-personaggio, parlando in prima persona con discorso diretto libero, introduce sin dall’incipit il tema della Spagna. Nello specifico, si sofferma sul motivo della lingua e delle parole spagnole, che dice di non aver mai dovuto imparare, perché è come se le avesse sempre conosciute; mediante un processo di analessi mista, innesca una serie a catena di recuperi memoriali, i cui effetti perdurano nel presente. Si tratta di tempi passati in cui, dice Bodini, il cuore gli si stringeva nell’ascoltare una canzone popolare spagnola, tempi in cui esisteva in lui la ferma convinzione che l’erba «non potesse chiamarsi altrimenti che yerba, e la stella estrella».
Foto 4: ds., 210x310 mm. 5 cc. veline numerate, dattiloscritte sul recto con correzioni autografe.
Così scrive Bodini:
«Non posso dire quando sia cominciata la cosa con la Spagna. Forse da sempre. La prima volta che avrò sentito una parola spagnola nelle più sopite cavità dell’anima qualcosa si sarà smosso, dei remotissimi echi, e il sangue si sarà messo a correre più svelto, con un senso di freschezza, a quella promessa di confuse e affascinanti vicende che non sapevo bene se m’aspettassero tre secoli più indietro o vent’anni più avanti. Non ho mai dovuto imparare lo spagnolo, l’ho sempre saputo. Non solo le parole più facili come vida, yerba o plaza, ma anche quelle che non somigliano alle italiane, come mesa, cariño, caracola. Ogni parola mi dava al palato una misteriosa dolcezza. Ogni parola, oltre il significato che coincideva più o meno con quello dei dizionari, ne aveva un altro per me solo: un senso segreto, come un ammiccare di nascosto alludendo a fatti, a un destino che m’inviava quelle parole come dei colombi viaggiatori con un messaggio nascosto fra le zampette. (E si cantava a quei tempi una canzone che io non potevo sentire senza che il cuore mi si stringesse. Diceva così:
Mentre la Spagna dorme
nelle sue notti limpide e serene
M’immaginavo questo paese che dormiva, tinto di verde, com’era stampato sugli atlanti, come un’edera addormentata sull’oceano.)
Ma che riconoscessi le parole, che mi volassero sul rinfrescato corso del sangue come colorate farfalle su un fiume, non era niente. Bisognava vedere che convinzione assoluta, che l’erba per me non potesse chiamarsi altrimenti che yerba, e la stella estrella, e la notte noche.»
Foto 5: incipit del racconto Roma 1944.
«La cosa con la Spagna» (cfr. foto 5) non ha un nome perché è una tensione viscerale: ha a che fare col sangue, è nata nelle cavità più inesplorate dell’anima, e ha sollevato degli «echi» remotissimi, o addirittura «ancestrali», come riporta una significativa variante del testo; e, sempre per citare un’altra variante: chiamare l’erba e la stella e la notte con i corrispettivi termini spagnoli non era solo una «convinzione assoluta», ma provocava anche un sensibile «appagamento». Le parole spagnole nascondono un significato segreto, intelligibile solo da Bodini. Questo significato sembra quasi premonire il futuro, alludendo a un «destino» già scritto di innate affinità tra lo scrittore e la Spagna.
E tuttavia, nonostante il suo amore per le parole iberiche, sottolinea come ce ne siano due (gorrión e corazón), che non possono competere con le corrispettive italiane. Quest’ultima osservazione chiude il primo microracconto e funge da introduzione alla seconda unità narrativa. Con un colpo di scena, perché quello che sembrava un soliloquio si rivela in realtà un dialogo.
Confrontare le lingue (italiana e spagnola), rilevarne le differenze e dichiarare una preferenza significa per Bodini avviare una ininterrotta e feconda dialettica tra due poli di un Sud comune, allo stesso tempo complementari e sovrapponibili. Il parallelismo tra il Salento e la Spagna, per esempio, sarà oggetto della prosa Ritratto di Don Giovanni, pubblicata nel 1951 sulla «Gazzetta del Mezzogiorno», nella quale Bodini metterà in risalto le differenze esistenti tra questi due Sud riguardo al culto dei morti. Il 2 novembre, nella sua città, Lecce, «è parato in ogni casa un altare […] coi crisantemi nei vasi»; mentre, in Spagna, i cimiteri sono vuoti, come in un ennesimo, fiero, tentativo di opporsi alla caducità e di «strappare alla morte qualche centimetro» (si veda Bodini 2010).
Un continuo confronto con la Spagna ricompare anche in Quaderno giallo (foto 6 e 7), una prosa argomentativa databile agli anni 1945-46, di cui si possiedono la copia manoscritta e quella dattiloscritta.
In questo brano, Bodini riporta alcune considerazioni generali sul tema della «propagazione della specie», e compare ancora, peraltro, la figura del Don Giovanni. Ma andiamo con ordine.
Il testo si apre con una domanda retorica; si chiede Bodini: «che cosa può volere la natura da noi, di diverso, da ciò che vuole da un insetto o da una pianta?». Niente di diverso: anche l’uomo è naturalmente programmato, come «le rose e il basilico», a obbedire alle leggi della prosecuzione di una specie. Ma la Natura non è solo ‘maligna’: è anche furba, perché ha dotato l’uomo del senso estetico, provocandogli la mera illusione di essere libero.
Ecco perché Bodini include tra i momenti focali della storia dell’umanità, accanto alla scoperta del fuoco e della ruota, la scoperta della sterilità: perché significava che uomo e donna «potevano amarsi senza avere figli». E come dalla scoperta del fuoco era scaturito il mito di Prometeo, così da quello della sterilità, molti secoli dopo e per mano di un monaco –Tirso de Molina («circostanza che non pare casuale», aggiunge Bodini)– era nato il «dongiovannismo». Una scoperta che aveva rappresentato «la Rivolta dell’uomo contro la funzionalità» a cui era stato condannato dalla Natura, e dunque una vittoria del libero arbitrio contro le leggi naturali di conservazione del genere umano.
(Foto 6)
(Foto 7)
Foto 6 e 7: ms. della prosa Quaderno giallo.
Il drammaturgo spagnolo del siglo de oro aveva creato nel suo El burlador de Sevilla l’archetipo del moderno mito del Don Giovanni, destinato a diffondersi a macchia d’olio in tutta Europa. Nato in quest’opera con un preciso debito morale da assolvere –col pentimento o col castigo–, fino a colorarsi di tinte da sacra rappresentazione, ciò che in realtà caratterizza più intimamente il Don Juan di Tirso de Molina è la sua duplice natura di libertino e di cavaliere. Da questa complessità, puntualmente rimarcata da Bodini, emerge un personaggio sfumato e irriducibile a schemi precostituiti, peraltro insolito nel teatro barocco, del quale il dramma conserva comunque la maggior parte dei requisiti esteriori.
La seconda sezione della prosa Quaderno giallo consiste in un excursus sull’evoluzione di questo mito in diacronia e diatopia. Vengono analizzate le sue espressioni nel campo della letteratura, della musica e della psicologia.
Il Don Giovanni seicentesco di Tirso de Molina è una figura carica di dinamismo, di gioia vitale –anche un po’ infantile– oltre che un seduttore impenitente e ingannatore, un burlador disposto a tutto pur di conquistare una donna, financo prometterle di sposarla. Ma questo Don Giovanni è destinato alla dannazione eterna, perché –lussurioso, vizioso, immorale– ha osato sfidare la Provvidenza divina. Per Bodini, quello spagnolo è un Don Giovanni che scala le alcove «bestemmiando», come Capaneo, l’eroe greco troppo superbo che aveva scalato le mura di Tebe, osando sfidare Zeus.
Bodini si concentra poi su un’ulteriore declinazione del mito, quella del Don Giovanni ottocentesco di Mozart-Da Ponte. Diversamente dal suo corrispettivo spagnolo, questo Don Giovanni verrà addirittura celebrato. Innanzitutto, poiché agisce in una società «frivola», non viene punito dalla Provvidenza laddove la società fallisce; di più: è elevato a strumento divino per punire l’infedeltà delle donne, tanto che si assiste a una sorta di celebrazione del libertinismo.
Infine, Bodini passa in rassegna un’ultima tesi, quella novecentesca di Gregorio Marañon, endocrinologo e letterato spagnolo, il quale, innestando le proprie conoscenze mediche su quelle letterarie, individua nel Don Giovanni i caratteri dell’androginismo. Ebbene, in questa singolare interpretazione di Marañon, bisognava riconoscere, secondo Bodini, una verità: anche la compresenza, in un solo individuo, di caratteri maschili e femminili rappresentava una «vittoria sulla distruzione di maschio e di femmina».
Queste le parole Bodini:
«La scoperta della sterilità è il primo segno di rivolta, anzi della Rivolta dell’uomo contro la funzionalità per cui lo aveva concepito la natura. Da questo punto ha inizio la lotta dell’arbitrio contro la necessità.
II furto, l’assassinio, lo stupro, la gravidanza sono fatti naturali. Non lo sono il dongiovannismo e lo stato monacale, il gioco degli scacchi e la poesia.»
È evidente che ci troviamo di fronte a note di lettura, ad appunti frammentari; ma attraverso di essi si può cogliere in presa diretta l’innesto di alcuni capisaldi del futuro paradigma letterario di Bodini. In un’ottica intertestuale, dunque, può essere utile evidenziare i rimandi tra la prosa Quaderno giallo e Ritratto di Don Giovanni, risalente al 1951, prima menzionato. Qui l’autore presenta la sua interpretazione della figura del Don Giovanni. L’eroe della tradizione spagnola, secondo Bodini, si era voluto opporre a un inevitabile destino di transitorietà, a una Natura maligna, affermando il proprio istinto vitale attraverso la seduzione, oltre che per mezzo dei «duelli» e delle «beffe». In Don Giovanni, Bodini rintraccia e segnala una caratteristica, comune a tutto il popolo spagnolo: quella di essere avverso ai compromessi, appassionato del gioco e della sfida, orgoglioso e fiero.
L’esame di queste prose attesta che la vocazione ispanofila di Vittorio Bodini ha origini «ancestrali» e che emerge con vigore già nella metà degli anni Quaranta, prima del fatidico viaggio a Madrid. Il periodo romano registra dunque non solo il distacco dalle esperienze precedenti –dalle incursioni giovanili nel futurismo alle collaborazioni leccesi con Vedetta mediterranea–, ma segna l’imprescindibile punto di partenza per il futuro. Ci si potrebbe addirittura chiedere se, senza il filtro romano, sarebbe stato possibile il parallelismo tra Lecce e la Spagna, dato che le radici della fondamentale esperienza spagnola sembrano affondare proprio nello stesso humus degli inediti scritti durante gli anni romani.
Alla pagina del 28 marzo 1945, per esempio, si legge una vera e propria dichiarazione di poetica.
Foto 8: pagina del Diario romano datata 28 marzo [1945].
Il tema trattato è il Sud. E come sappiamo, per Bodini, non si tratta mai di un Sud geografico, bensì di una condizione esistenziale; è un modo di essere che abbraccia le manifestazioni esteriori e i sentimenti più intimi e radicati, insieme a tutte le loro contraddizioni. Bodini tenterà per tutta la vita di risolvere l’eterno dissidio amore-odio che lo legava alla propria terra. Questa ricerca darà i suoi frutti solo dopo il contatto con lo spirito più vero e misterioso della Spagna, una realtà sconcertante ben rappresentata solo dai maestri dell’arte iberica come Goya (si pensi a quello che Bodini ha scritto nel reportage Capo d’anno a Puerta del Sol, composto nel ‘46);3 e il conflitto sarà davvero appianato dopo la scoperta di un sentire tragico e comune tra il popolo spagnolo e quello salentino.
Il viaggio in Spagna sarà la chiave di volta per decifrare un rapporto complicato con un Sud ambivalente, che, pur cambiando, resta sempre uguale a sé stesso ed è così «sgradito da doversi amare». Ma già da tempo la componente ispanofila di Vittorio Bodini emergeva nella sua scrittura e nella sua coscienza, come confermano le parole del 1945, tratte dal Diario romano (foto 8), che riporto a conclusione di questo contributo:
«Tutto quanto io scrivo ora, tutto quanto scriverò (per quanto ho in mente) sarà una celebrazione del Sud miserabile e sublime, metafisico e primordiale, dove la barbarie si è fatta cristiana direttamente, quando non addirittura cattolica senza passare attraverso il paganesimo. (Il Sud è Goya. Che ne sappiamo noi di Raffaello? […]»
BIBLIOGRAFIA
BODINI, Vittorio (1940): «Proposito; Giardini d’Azeglio; Una foglia; Solitudini a San Miniato; Per una villa presso Settignano; Convergenze», Letteratura, IV, 2, pp. 82-84;
— (1941a): «A una giovane donna», Vedetta mediterranea, I, 1;
— (1941b): «Qualche volta con lacrime», Vedetta mediterranea, I, 12;
— (1945a): «Le Olive», Domenica;
— (1945b): «Il Miserere», Domenica;
— (1945c): «Teatrino di Don Cristobal farsa guignolesca», Aretusa;
— (1951): «Ritratto di Don Giovanni», La Gazzetta del Mezzogiorno, LXIV, 140; ora in BODINI, Vittorio (2010): Corriere spagnolo, a cura di Antonio Lucio GIANNONE, Nardò, Besa, pp. 88-92;
— (1963): I poeti surrealisti spagnoli, Torino, Einaudi;
— (1997): Tutte le poesie, a cura di Oreste MACRÌ, Lecce, Besa, p. 165;
MACRÌ, Oreste (1986): «Lope De Rueda. Sei Pasos», Sudpuglia, 1, pp.79-99;
MACRÌ, Oreste, Donato VALLI e Ennio BONEA (a cura di) (1984): Le terre di Carlo V. Studi su Vittorio Bodini, Galatina, Congedo;
SERIO, Mario, Donato VALLI (1992): «Premessa», in ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO: Archivio Vittorio Bodini, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali –Ufficio centrale per i beni archivistici, p.10.
1 Si tratta delle liriche Proposito, Giardini d’Azeglio, Una foglia, Solitudini a San Miniato, Per una villa presso Settignano, Convergenze.
2 Si veda, a tal proposito, il postumo Macrì (1986). Tutte le traduzioni dei pasos sono di Bodini.
3 Ora in Giannone (2010).