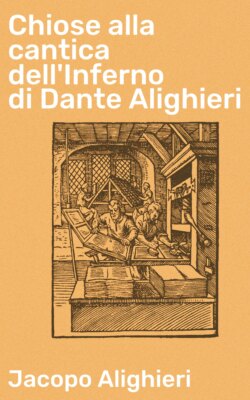Читать книгу Chiose alla cantica dell'Inferno di Dante Alighieri - Alighieri Jacopo - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PREFAZIONE
ОглавлениеIndice
PER la prima volta si pubblicano, corrette nel testo, ridotte alla lor vera lezione, e sottoposte ad indagine critica, rivendicate, con validi argomenti, al suo autore le Chiose alla prima Cantica della Divina Commedia, scritte da Jacopo, figlio di Dante Alighieri.
E c’è da meravigliarsi che fosse lasciato così negletto un testo prezioso per la ermeneutica dantesca: uno fra i più antichi commenti del sublime poema, e che contiene una interpetrazione nuova, con singolarissimo intendimento, per la prima volta or da noi messo in rilievo. E non accade l’insistere su la importanza di tale sottile interpetrazione circa le allegorie della Divina Commedia, se si riflette che Jacopo può averla udita, raccolta dalle stesse labbra del padre.
Ma procediamo per ordine.
Furono, sino ad oggi, raccolte in copia notizie risguardanti i figliuoli di Dante Alighieri, ma non si è ancora appurato, tali notizie essendo sovente incompiute, qual de’ figliuoli fosse il primogenito, o Pietro, o Jacopo. Forse, Pietro è da reputarsi il maggiore, poichè, mentre il padre avea preso stabile dimora in Ravenna, egli era già investito di due benefici ecclesiastici[1]. E ciò si ritrae da una sentenza del Cardinale Bertrando del Poggetto:—sentenza, da cui s’apprende che Pietro si rifiutò di pagare le procuragioni dovute al Cardinale, ed è del 4 gennaio 1321: otto mesi innanzi la morte di Dante. E i benefici doveano essere stati a Jacopo ottenuti dalla moglie di Guido Novello da Polenta.[2] Allorchè il padre ebbe bando da Firenze, nel 1302, i figliuoli rimasero nella città con la madre, stretti d’angustie, ridotta la famiglia a scarso, sottil tenore di vita. Dopo la battaglia di Monteaperti, per l’atto di condanna del novembre 1315, anche i figliuoli son cacciati in bando (Dantem Allagherii et filios): non già perchè avessero compiuto gesta contro la saldezza della Repubblica, ma per effetto della legge spietata che accomunava nella condanna de’ ribelli eziandio i lor figliuoli, che avesser tocco i quindici anni. Sbanditi dalla patria, si rincontravano col padre su la via dell’esilio; ed egli amorevolmente li accolse e li ebbe seco prima a Verona, poi a Ravenna. Nè ci soccorrono documenti a chiarirci del tempo da essi trascorso col padre: ben sappiamo che in Ravenna si trovavano alla morte di lui e, con l’aiuto di Ser Pier Giardini, misero a ordine, devotamente, i manoscritti lasciati dal divino poeta.
Rileviamo dal Boccaccio che gli ultimi tredici Canti del Paradiso andaron smarriti per circa otto mesi e furono, per ventura, dopo assidue, insistenti ricerche, trovati. E già se ne disperava al segno che Jacopo, il più acceso negli studii letterarii, avea formato il disegno di supplire egli alla mancanza. Lieti per la preziosa recuperazione, volsero l’animo a significare la gratitudine degli esuli verso Guido Novello da Polenta, allora podestà per i bolognesi, e ch’era stato agli esuli fiorentini generoso di ospitalità. E fecer disegno, e il posero in atto, di offrire a quel Signore la prima copia integra della Divina Commedia, accompagnata da un Sonetto e da un Capitolo, scritti da Jacopo a dilucidare in quali e quante parti è diviso e suddiviso il grande Poema.
Di lì a breve tratto (nel settembre 1322) i due figli dell’Alighieri, scaduta la signoria de’ Polenta, lasciavan Ravenna. E, nel 1323, nel 1324, Pietro era in Firenze. Come gli desse l’animo di tornare nella città donde era stato sì aspramente cacciato, non sappiamo al certo; ma non ci è conteso il supporre ch’egli facesse questo pensiero: era stato sbandito unicamente come figliuolo dell’Alighieri e, morto il padre, non veniva a mancar la ragione del suo bando? Tanto più che nella sentenza di condanna non era neppure specificato il nome di lui. Questo egli, forse, credeva, ma andava errato. Nel bando era pur segnata la sua condanna di morte: e, sovrappreso da timori, sollecitato da consigli, prima che contro di lui si risollevassero gli odii, si sguinzagliasser le invidie, e il malanimo sì aspro e operoso contro il padre, si dannò da sè a nuovo esilio e si ritrasse in Verona, ove fu giudice del Comune e Vicario del Podestà.
Morì nel 21 aprile 1364 in Treviso ed ivi ebbe sepoltura in Santa Margherita degli Eremitani, oltre il Sile.
Nel 1325 la Signoria di Firenze concedeva perdonanza a’ cittadini mandati in bando e, dava loro balìa, salvo a’ ribelli, di tornar in patria, se assentissero di pagar una certa quota su la ammenda, della quale erano stati colpiti. Jacopo di Dante volle approfittar di quella congiuntura e rifarsi fiorentino. Fu allora ordinata una pratica per appurare se egli dovesse avvantaggiarsi delle larghezze concesse: e fu deciso in suo prò e ciò, verosimilmente, per un garbuglio di legulei, poichè nella sentenza di condanna, secondo abbiamo toccato più sopra, era accennato a’ «figliuoli di Dante» senza specificarne i nomi.
Tuttavia, egli non prese stanza in Firenze, ma riparò a Fiesole ove, nel 1326, ebbe i primi ordini ecclesiastici. Nè si attutivano gli odii contro di esso, aizzati da’ nemici del padre. Acchetate le parti de’ Bianchi e de’ Neri, si era formata un’unica parte, schiettamente guelfa: ma non s’erano acchetati i rancori verso coloro, che avean macchinato contro l’ordine, la ragione dello Stato e fra essi Dante primeggiava: acerbo, implacato riprensore de’ costumi de’ suoi concittadini; disfogatore, senza tener modo, delle sue ire contro personaggi e famiglie, cui non aveva il suo focoso risentimento risparmiato alcun vitupero e che aveva dannato a perpetuo dileggio, ad una infamia insanabile. Donde l’acuta avversione de’ Donati che non sapean perdonare neppure alla sua memoria. I genii sono, generalmente, importuni: prendono troppo posto nel mondo, appaiono invasori, sono dominatori, loro malgrado. Egli era stato, e con spiccatissimi tratti, e quasi a studio, importuno a molti.
E costoro si sfrenavano sempre in calunnie contro il poeta, aveano in dispetto il suo Libro divino, che s’ingegnavano tener nella oscurità (da cui i secoli l’hanno rivendicato) credevano poter spengere quella fiamma, che dovea essere una tra le luci più vive del civile consorzio. Alla divulgazione della Divina Commedia fu contrapposto in Firenze ogni ostacolo, con subdoli espedienti, o recisi pareri: coloro che il poeta aveva percossi, o sfiorati della sua folgore; coloro ch’egli aveva collocati, con scherni sublimi, nelle sue bolgie infernali, urlavano come dannati contro di lui. La morte del poeta non li placava: sentivano che la loro onta dovea essere immortale. Il poema, combattuto a Firenze, era già letto, comentato, diffuso, suscitava ammirazioni in altre città d’Italia, per esempio a Bologna; nella patria del fiero ghibellino rafforzava, perpetuava le inimicizie. Un comentatore, contemporaneo d’Jacopo, esclama: Universus et totus infernus florentinis noscitur esse plenus. E a cotale esclamazione fa seguire i nomi di circa una trentina di ragguardevoli fiorentini, che in varii cerchi infernali son dal poeta allogati.
Se è lecito trar paragoni tra uomini e tempi, tanto diversi, Dante fu tra molti de’ fiorentini suoi contemporanei in disgusto, come furono, nel decorso secolo, fra gl’inglesi Giorgio Byron, e fra i tedeschi Enrico Heine: e ciò per lo stesso motivo, per la sanguinosa satira de’ loro compatriotti, per aver flagellato ove credeano fosse buono e degno l’assestar colpi.
Un’idea dell’accanimento de’ nemici di parte contro il poeta è da rilevarsi dallo stesso opuscolo di un suo contemporaneo, il frate Vernani, da noi ripubblicato e tradotto dal latino, nel quale l’autore del De Monarchia è chiamato «ignorante» e dipinto, scusate se è poco, com’uomo di mal’affare. Già il qualificativo di «barattiere» del quale egli gratificò sì copiosamente altrui era stato, con fermezza, aggiunto al suo nome.
E, scomparso il poeta dalla scena del mondo, il livore non posava, nè stava pago di scatenarsi contro l’opera di lui, anzi inveleniva contro il figliuolo Jacopo. Costui traeva alquanto al vanitoso, era di una sfolgorata ambizione, ma aveva culto, quasi religioso, per l’ingegno del padre: e non si ristava dall’adoperarsi alla divulgazione della Commedia. Infatti, fra il 1330 e il 1340 appaiono scritti un gran numero di Codici danteschi fiorentini, non pochi fregiati con lo stemma degli Alighieri, ed è agevole l’inferirne che a tanta copia di codici, oltre l’attrattiva esercitata dall’opera su le menti degli amici, non dovessero essere estranei il fervore, lo zelo di Jacopo.
Tale amore filiale faceva acuire a’ pertinaci nemici del poeta le lor vendette. E nel 1335 fu riaperta la pratica contro Jacopo e si pose innanzi, di nuovo, il dubbio, se a lui fosse lecito rimanere in Firenze, senza offesa delle leggi.
Ma l’esito di questa seconda pratica non ci è noto: pur abbiam documento che, negli anni 1341-42, egli si trovava un’altra volta lontano dalla sua città natale. E menò vita assai avventurosa. Fu, nel 1342, reintegrato nel possesso de’ beni paterni. E narreremo di lui qualche tratto ben singolare. Da giovane, insieme col fratello, avendo voluto rendersi prete, ricevette gli ordini, e si era pur dato tutto alle cose dell’anima e avea scritto versi su la Morte, che gli accattaron favor popolare per la sincerità della loro ispirazione. E nel 1341 e ’42 godeva la prebenda di un canonicato, in quel di Verona: procacciatagli, è da farsi congettura, dal fratello Pietro. Giunto all’età matura venne in desiderio di tor moglie: e poco stette in tal proposito, chè fu condannato per mancata promessa di matrimonio e per non aver restituito la dote, che aveva, alla chetichella, arraffata.
Si sa che venne a morte prima del 1350; manca ogni data più precisa.
Il Boccaccio chiama i due fratelli Alighieri «dicitori in rima». E già conosciamo di Pietro una Canzone morale contro a’ Pastori: una Canzone per Papa Giovanni XXII e per l’Imperatore Lodovico. Di Jacopo, oltre il sonetto a Guido da Polenta, il Capitolo, in questo volume riprodotto, e che contiene un sì abile, fedel riassunto della Commedia e i versi su la Morte, di cui toccammo più sopra. Di Jacopo si è pur conservato un sonetto, indirizzato a Paolo dell’Abbaco e un poemetto intitolato Dottrinale, in cui egli si atteggiò a dare insegnamenti di Cosmologia.
Ond’io da mia natura,
non per troppa scrittura
ardisco a tale impresa,
però ch’io ho difesa
dalla mia compagnia
d’avere Astrologia,
Acciò che sia palese
per ciaschedun paese
del sito italiano
da presso e da lontano
l’esser dell’universo,
dirò a verso a verso.
Nel nome del Signore
ch’è superno motore
che mi concede gratia
sì ch’io possa far satia
di verità la gente
et futura et presente....
Che piagnendo mi dice
che sua vera radice
quaggiù non è intesa
da que’ che l’han compresa:
anzi le par travolta
e tra bugie ravvolta.
Ond’ella se ne duole,
e riparar si vuole
forse col mio ingegno,
bench’i’ non ne sia degno,
a voler ch’io ripeti
filosofi e poeti....
Ond’io volto a Levante,
Jacopo di Dante,
incomincio mia boce
col segno della croce,
che mi conceda tale,
ch’io faccia un Dottrinale.
Ma i due figliuoli di Dante furono tutt’e due commentatori della Commedia: Pietro di tutto il poema, Jacopo non andò oltre la prima Cantica. A Jacopo, mentre ebbe dimora in Firenze, molti dovean far capo per richiederlo di spiegazioni su i passi più ardui. Ed è curioso che il possessore di un antichissimo codice scrivesse in margine ove non s’intendeva: Jacobe, facias declarationem. In una tra le varie stesure dell’Ottimo è riferita, col nome di Jacopo, una chiosa, mentre altre, numerosissime, di leggeri riconoscibili per la singolarità del dettato, vi si leggono senza che ne sia accennata la provenienza.
Nel codice Palatino 313, che contiene grandissima parte del Comento di questo figlio di Dante, sebbene spesso le sue chiose sien corrotte e alterate, interposte ad altre d’indole e di dettato differenti, quasi ogni chiosa è segnata della sigla Jac (Jacopo). Al Commento, contenuto nel Codice laurenziano XC. Sup. 124 si attribuiva maggior credito, poichè vi si notava il figliuolo di Dante averlo trascritto di sua mano, e fin nel secolo decimosesto la dichiarazione di Jacopo fu con diligenza ricercata.
Siamo nel settecento, al ravvivamento degli studi danteschi. Il Commento di Jacopo fu conosciuto dal Pelli, dal Melius, che non vi assegnarono molta importanza e soltanto nel 1848 un gentiluomo inglese, lord Vernon, insigne per promovimento dato agli studi della classica letteratura italiana, tenero, rispettoso di ogni gloria nostra, più che non fossero in quel tempo molti italiani, lo dava in luce a sue spese.
Ma, contro il divisamento del nobile signore, la pubblicazione riusciva assai imperfetta, quasi inutile per i troppi errori accumulativi, per difetto di critica indagine. L’edizione, di soli cento esemplari, potè esser nota a pochi eruditi: ed ormai è a dirsi introvabile. Però di questa edizione e della nostra discorreremo, con più larghezza, altrove.
I pochi, cui riuscì ad aver contezza di queste Chiose non vi trovaron ciò che, senza fondamento, si ripromettevano di attingervi.
Avevano in animo di ritrarre dalle Chiose di Jacopo ragguagli di fatti storici avvenuti al suo tempo, notizie curiose su i personaggi satireggiati, o lodati, nel poema. Non tenner conto che a Jacopo riusciva ben disagevole l’aver di nuovo ricetto, come sbandito, nella patria e ottenere la restituzione de’ beni paterni. Gli approdava, dunque, il tenersi lontano da ogni causa di dissidii cittadineschi, il dissimulare, anzi, menare il buon per la pace e non andare stuzzicando vespai. Si stava contento alla esposizione delle principali allegorie del poema.
Male erano ispirati coloro che alle Chiose dello scrittore, cui era consigliata tanta prudenza, chiedevano, come oggi si dice, le indiscrezioni di uno stemperato cronista. La forma delle Chiose apparisce un po’ grezza, ispida se vuolsi, con l’arida impronta di altre prose scolastiche in quel tempo: vi ricorron penose circonlocuzioni, i periodi vanno alquanto intralciati, v’è una certa sconnessione e spesso la sintassi è zoppicante. Ciò, specialmente, nella prima versione. E da tali sconci molti furono turbati e sentenziarono che non si trattava di un lavoro originale, ma bensì di una cattiva traduzione dal latino. Altri sollevarono dubbi perfino su la autenticità di tale scrittura.
Ma un uomo di gran sapere, lo Scheffer-Boichorst, fu il primo a dimostrare di quanto rilievo fosse il breve Commento e vi rivolse l’attenzione degli studiosi. Egli pose in chiaro l’analogia che è fra alcuni brani del Commento e il Capitolo di Jacopo, intitolato Divisione: e analogia di sostanza e di dettato. Tale Capitolo si riscontra, o solo, o insieme con l’altro Capitolo di Busone da Gubbio in molti codici della Commedia, e in modo da formar quasi parte integrale del poema. La stessa intima relazione col Commento ha il Dottrinale di Jacopo, come accennò nel 1890 il dottissimo dantista Fr. Roediger, e vi sono pure strette attinenze col Sonetto indirizzato a Guido da Polenta. E se ne può trarre la conclusione che chi aveva scritto quelle rime fosse pur l’autore del Commento.
E, poichè queste somiglianze ricorrono anche in certi vocaboli singolari e costrutti piuttosto ricercati, si corrobora, in favor del volgare, la questione circa la lingua in cui, originariamente, furon scritte le Chiose.
Restava però sempre da dire. E nel 1903 il prof. Luiso tentava mandare a rifascio l’edificio, appena eretto, in onore del nostro autore. Egli brandiva, qual arma formidabile a spulezzar via quanto era stato, con dottrina, accumulato il Codice Laurenziano (XC, Sup. 114) già ben noto, da tempo, ai colti nella ermeneutica dantesca, e che reca la notizia che il figlio di Dante lo fece «co le sue mani»: forse perchè la prima chiosa che vi si legge è traduzione del principio delle Chiose di Jacopo. Per assegnare ad Jacopo il commento latino, contenuto in questo Codice, si credette necessario, anzitutto, di recare al niente le Chiose, andate sin’allora sotto il nome di lui.
Ma peccato che il valentuomo, il quale si avventava ad una sì temeraria risoluzione, non credesse opportuno darsi la briga di mettere a raffronto i due testi. Con questo piccolo avvedimento si sarebbe chiarito che la chiosa italiana è assai più precisa e più nitida della latina e il preteso volgarizzatore non merita di essere tanto svilito.
Ed era pur da procedere, se non erriamo, al raffronto fra altre chiose che offrono, nel codice Laurenziano (XC, Sup. 114) spiccati riscontri con quelle volgari di Jacopo: ad esempio la chiosa su Amfiarao, ove il figlio di Dante cita Stazio «nel suo Thebaidos», mentre il compilatore del Commento contenuto nel codice Laurenziano XC, Sup. 114, dice «Stazius secondo Thebaidos» prendendo forse il suo di Jacopo per una abbreviazione[3].
Ma, senza poterci offrire un testo latino che risponda in tutto alle Chiose volgari, e i due testi son molto dissimili, salvo in qualche chiosa che hanno a comune, il censore si dette a rifrustare nel commento volgare i latinismi e, sin il vocabolo leno gli sa di latino e non gli sovviene che leno significa arrendevole e in questo senso non solo spesso si trova nelle scritture del trecento, ma e’ corre pur oggi, qual moneta di buon conio, nella lingua parlata.
Un altro dotto, Michele Barbi, sventò tali censure e con la virtù della sua dialettica, n’ebbe facil vittoria.
Che, se non bastasse il por mente alle intime affinità tra le Chiose e le altre opere di Jacopo, sarebbero ancor da accennare i brani e vocaboli che son recati nelle Chiose dalla Divina Commedia e dal Convivio. E ciò non avrebbe potuto derivarsi da un testo latino, nè sarebbe occorso ad un volgarizzatore sciatto ed imperito.
Ed al Luiso doveva saltare agli occhi tale difficoltà: egli che, con tanto accorto giudizio, rimette (7º capitolo) nel testo delle Chiose le parole senno umano, invece di sermo umano che offrono i due manoscritti: e la correzione risponde perfettamente alle parole senni umani (nell’Inferno, VII, 81). Ed è, senza dubbio, la genuina lezione, come risulta anche dal codice Ashburnhamiano 833, dove questa chiosa è citata col nome di Jacopo.
Se nel suo Commento è qualche latinismo si spiega con l’aver egli dovuto ricorrere sovente ad interpretazioni latine antecedenti alla sua opera; ma lo stile artificioso, strano è eguale dal principio alla fine: stile tutto proprio d’uno scrittore, e che non può essere stato calcato su un preteso originale latino. Secondo noi, rispetto alla lambiccatura del dettato nel Commento vi è, forse, una spiegazione nel fatto che Jacopo, il quale era vanitoso, e sentiva orgoglio d’esser figlio di Dante, abbia creduto imitare il padre, o inalzarsi, eleggendo uno stile artificioso e usando vocaboli e modi nuovi, giusta l’esempio paterno. Ma di Dante mancavano al figlio il genio poderoso, il gusto e gli studii profondi: studii, in cui si era fatto molto innanzi il figlio Pietro, ma nel quale l’arte del dire non pareggiò la dottrina. Jacopo credè supplire alla coltura con la felice natural disposizione dell’ingegno: ed ebbe studio più di stranezze che di eleganze: e si persuase venir in opinione con ostentati artifici. E non sai s’e’ riesca più bizzarro, o più risibile in quella sua solenne sicumèra con cui si atteggia ad insegnare a tutti i principii della Cosmologia «per sua natura» così e’ dice, non per troppa scrittura. Per natura egli vuol significare ingegno, intellettualità. E di ciò pur si ha riscontro nelle prime terzine del suo Capitolo:
O voi che siete dal verace lume
alquanto illuminati nella mente,
ch’è sommo fructo de l’alto volume,
perchè vostra natura sia possente
più nel veder l’esser dell’universo,
guardate a l’alta Commedìa presente.
E si mettano a riscontro con questi versi il Sonetto a Guido da Polenta e le linee onde muovon le Chiose.
«Acciò che del frutto universale novellamente dato al mondo per lo illustre filosofo Dante Allighieri fiorentino con più agevolezza si possa gustare per coloro in cui il lume naturale alquanto risplende senza scientifica apprensione, io, Jacopo, suo figliuolo ecc.».
Insomma siccome egli è intellettuale, ma senza troppa «scrittura» così scrive anche nel linguaggio nativo (in prosa materiale)[4] per quelli che sono di mente lucida, ma senza «scientifica apprensione». E chi riflette a quanti autori occorrono per illustrare la Divina Commedia sarà preso da meraviglia nell’avvenirsi a vederne citati nelle Chiose pochissimi: Omero, Aristotile, Orazio, Virgilio, Lucano, Ovidio, Tito Livio, Boezio, Terenzio, la Bibbia, tra i quali si debbon escludere Omero e Aristotile, Terenzio e Boezio che, per varie ragioni, egli certamente non ebbe fra mano e forse anche alcuni altri, che soleva citare di rimbalzo.
In generale, non va oltre alla sommaria citazione delle sue fonti; e suol dire «secondo i poeti, secondo le poetiche scritture» le storie di Antenore e d’altri[5].
Vuolsi pur ammettere che Jacopo abbia preso a prestito un certo numero de’ suoi racconti, delle sue esposizioni da altri scrittori sincroni. Così, ad esempio, nel tratto ove parla delle Furie, per il significato delle quali si richiama a’ soliti «poeti»: ed una parte di questa Chiosa proviene da Lattanzio, l’altra da Sant’Isidoro: e il tutto si legge in altro Commento dantesco del tempo, ove non pur son menzionati i detti autori, ma se ne riferiscon quasi testualmente le parole.
Pur tuttavia le Chiose del nostro furon tenute in conto quale opera d’un figliuolo di Dante e fin che non le surrogarono Commenti più ampii e diffusi a tutto il Poema.
A noi delle Chiose pervennero soltanto due copie nel testo integrale e due frammenti.
L’importanza del lavoro di Jacopo non è da ricercarsi nella quantità e qualità del materiale d’erudizione e di raffronto, di cui disponeva, bensì nella esposizione, ch’ei fa con tanta evidenza, della struttura del Poema e nella dimostrazione omogenea e continua delle sue allegorie, ciò che non si riscontra in alcuno degli antichi commentatori. E, se afferma nel Proemio di voler dimostrare parte del profondo ed autentico intendimento della Commedia, ciò si riferisce essenzialmente al contenuto allegorico.
Però lascia in disparte la descrizione dello stato delle anime dopo la morte, con i loro martìri, e le loro gioie, quale resulta dal senso letterale del testo; muove dal concetto che si debba ravvisar nel Poema un Trattato di filosofia morale in cui si dimostrano «le qualitadi della generazione umana»: la prima, quella de’ viziosi mortali, chiamandola Inferno; la seconda quella dei penitenti, il Purgatorio; e la terza quella dei perfetti, il Paradiso «a dimostrare la beatitudine loro e l’altezza dell’animo congiunta con la felicità, senza la quale non si discerne il Sommo Bene.»
Jacopo, dunque, reca tutto alla vita attuale e, astraendo dal magnifico dramma, dalle situazioni, dalle figure che il poeta ha scolpito sì di forza, suggeritegli dalle tradizioni popolari e chiesastiche, e considerandole quali mezzi atti a muovere la immaginazione, ci rivela il loro intimo significato, magistralmente nascosto dal poeta sotto il colore di una visione d’oltre tomba.
Gli orribili, tremendi castighi dell’Inferno si riducono a sofferenze insite nei vizii stessi e derivanti dallo stato morboso in cui si trovano i contravventori alla legge divina: le consolazioni del Purgatorio ad aspirazioni verso la libertà; le beatitudini del Paradiso alle sodisfazioni del vivere in purezza e conforme a’ dettami della celeste Bontà. Alle ardenti fantasie dantesche subentra un arido schema di filosofia morale: alle esaltazioni estetiche, procurateci dalle immortali bellezze del Poema, è sostituito lo scopo pratico di «dare correzione e lode a chi n’è degno.»
Il concetto di Jacopo ci ravviva e ravvalora la dichiarazione del soggetto del Poema, contenuta nella Epistola di Dante a Cangrande: Homo prout, merendo aut demerendo per arbitrii libertatem justitiae praemianti aut punienti obnoxius est e, come causa finale, removere viventes in haec vita de statu miseriae et producere ad statum felicitatis.
Simili concetti sono pur espressi nei Commenti di Pietro Alighieri e di Guido da Pisa: e l’uno e l’altro ne trasser forse l’ispirazione dalla lettera a Cangrande, ma nell’uno e nell’altro non con la continuità, la pertinacia onde Jacopo vi si attenne.
E vediamolo all’opera: scrutiamo nella sostanza del suo nuovo commento.
Dante, nell’età di trentatrè, o trentaquattro anni, si trovava smarrito nella selva oscura, o voglia dirsi smarrito tra le molte genti offuscate dalla ignoranza; già la sua mente era irradiata dal fulgore della intellettuale verità, quando fu affrontato dalle tre fiere: la lonza, il leone, la lupa: simboli de’ tre vizii prevalenti, o fondamentali: lussuria, superbia e avarizia. Allo smarrito si para innanzi Virgilio, cioè l’effetto della umana ragione, che lo campa dalla lupa insaziabile e proferisce il vaticinio della prossima venuta del veltro, cioè d’una costellazione migliore della presente e onde sarà trasfusa la pace negli animi angustiati. Lo invita poi a seguirlo qual messaggero delle tre donne celesti: Beatrice, simbolo della Sacra Scrittura; la gentil donna interpretata la profonda mente della Deità; e Lucia, la grazia di Dio.
Il corto andar alla felicità non è possibile all’uomo, «attratto tanto dalla dolcezza de’ vizii quanto dall’altezza delle virtù». Occorre prima avere una esatta conoscenza delle une e degli altri.... Riconosciuto poi, mercè la Ragione, che le allettative de’ vizii hanno, in fondo, dell’amaro, l’uomo si deciderà a seguire le virtù, che gli assicurano vera felicità.
Così Dante, guidato dalla Ragione, si avvia alla contemplazione de’ viziosi: e prima si abbatte ne’ vili, ma guarda e passa, non si curando di loro che non fanno al suo proposito. Son morsi, punzecchiati da vili insetti, simboleggianti la nullaggine, l’acuta inanità del loro pettegolezzo, della disutile loro ciarla: e corron dietro ad una insegna, senza che ad alcun di loro dia il cuore di sopravanzar gli altri. È la turba de’ meschini, nè buoni, nè rei, senza valore per la contemplazione de’ vizii, cui vuol darsi il poeta.
Discende poi il primo de nove gradi, ond’è composto l’Inferno, dove son allogati coloro, che non ebber battesimo e gli antichi valorosi, che vivono senza speme, in disìo, come dice Jacopo, per il loro non colpevole difetto.
Comincia dal secondo grado dell’Inferno la caterva dei viziosi, che si estende dal secondo al quinto, ove han posto gl’incontinenti. E, mentre nel primo le anime sono imbarcate dal demonio Caron, del secondo troviamo guai motore e giudice il demonio Minos. Il continuo agitarsi dei lussuriosi corrisponde alle inquietudini amorose, perchè come dice Jacopo, l’effetto di ogni peccato è degnamente pena dell’operante.
Terzo grado: i golosi. Motore il demonio Cerbero, le cui tre bocche simboleggiano i tre appetiti. Pena: le infermità, le gotte, le podagre, che si accumulano in siffatti peccatori. E, sia detto qui di volo, nel suo tipo del goloso, in Ciacco, il poeta raffigura uno tra gli uomini cui attribuisce la maggiore intelligenza nel suo tempo, e lo interroga con curiosità, poichè molto si aspetta dal dire di quell’uomo raffinatissimo, in cui riconosce somma autorità e previdenza dell’avvenire.
Quarto grado: Avari e prodighi. Motore, il demonio Pluto (posto qui da Dante probabilmente per la somiglianza tra Pluto e il vocabolo greco Plutos). Pena: infinito affaticare così nel ritenere come nello sparnazzare.
Quinto grado: Iracondia e Accidia. Motore, il demonio Flegias. Pena: la affuocata irruenza degl’iracondi e degli accidiosi, la occulta e finta irata voglia.
Arriva al sesto grado, cioè al peccato della malizia: la eresia, protetta dalle Furie, che raffigurano il «malo pensamento» il dischiesto (sconveniente) parlare, come dice Jacopo e la malvagia e infuriata operazione. La città è chiusa in mura, che sembran di ferro, per la segretezza della eresia. È impossibile avervi adito senza la esperienza della mente che, simboleggiata dal messo del cielo, gli vien in aiuto, aprendogli le porte. Le Furie son cinte di serpenti, a indicar il trascorrere d’un pensiero in altro e per la proprietà di fredda e velenosa malizia degli eretici. Per la gran diversità delle eresie, diverse arche tramischiate di fiamme per dimostrare l’ardente fermezza degli eretici nelle loro credenze.
Col settimo grado i bestiali: motore il Minotauro: o, come si scrive in certe rubriche, Hominotauro: qualità umana unita alla bestiale.
I bestiali sono compartiti in tre classi:
1.ª Quelli che fanno forza, violenza altrui in cosa o in persona. I centauri raffigurano i correnti pensieri bestiali.
2.ª Quelli che se stessi offendono personalmente, o realmente. Personalmente i suicidï, trasformati in sterpi, poichè de’ tre animati: vegetabile, razionale e sensitivo loro è rimasto soltanto il primo. Le Arpie raffigurano le tristi ricordanze. Realmente, gli scialacquatori, sparnazzatori delle loro sostanze. Ignudi, perchè si spogliavano delle loro sostanze: perseguitati da nere e bramose cagne, a indicare la oscurità, i triboli della indigenza.
3.ª Coloro che sforzano la natura, cioè Iddio, e la lor qualità è suddivisa in tre classi: quelli che bestemmiano Iddio; quelli che peccano in lussuria contro la natura; gli usurai.
Ottavo grado: i fraudolenti. Motore, Gerione che accoglie in sè tre qualità: uomo, serpente e scorpione.
Dieci bolgie: i lusinghieri, adulatori, simoniaci, indovini, barattieri, ipocriti, ladri, mali consiglieri, seminatori di scandalo, falsari. I simoniaci han volto le piante de’ piedi in su per lo ritroso loro affetto, sommettendo le spirituali dovizie della misericordia alle terrestri ricchezze.
Commentando il ventesimo Canto della prima canzon dei «sommersi» Jacopo espone che gl’indovini hanno ritroso il viso per la loro ritrosa operazione. Gl’ipocriti della sesta bolgia portan cappe dorate di fuori per una singolare etimologia della parola «ipocrisia»: da ipo (hippo!) quod est supra e kresis (chrepsos): quod est aurum.
Eccoci a’ ladroni della settima bolgia: essi sono spartiti in tre categorie: quelli che non ne hanno l’abito continuo, senza alcun determinamento del sì o del no; subito fanno e si pentono dopo: quelli che di continuo sono adusati ad arraffare: e, infine, quelli che non continuamente rubano, con determinato volere del sì o del no, ma soltanto parandosi la occasione ne prendon diletto.
La nona bolgia è spartita in due: gli scismatici e i seminatori di scandali. I falsatori dell’ultima bolgia son compartiti in tre classi: realmente, personalmente e quelli che falsificano le monete.
Eccoci al nono grado che accoglie i traditori, e vi son posti a guardia i giganti, simboli della «iniqua superbia nella qualità frodolenta». Come la «superbia passa oltre il dovere della natura, così i giganti oltre il dovere di grandezza e di possa.» I traditori son divisi in quattro classi: Caina, quelli che tradiscono i loro carnali e parenti, e sono raffigurati nell’algore di ghiacci, a significare la freddezza dell’animo loro, privo d’ogni naturale calore: Antenora, color che tradiscono lor genti in patria: Tolomea, quelli che servono e tradiscono chi li adopera.
E abbiam negletto, nel nostro riassunto, altre allegorie delle pene assegnate ai peccatori; allegorie tutte aggiustate su la medesima traccia già esposta, poichè vi si riflettono sempre le naturali conseguenze caratteristiche per ogni specie di viziosi.
Non sembra che Jacopo abbia mai esteso ad altra Cantica del Poema il suo Commento, sebbene verso la fine delle Chiose si legga: «Siccome nelle chiose del seguente libro si conta».
E non accadrebbe dire che il Luiso cita un passo, riferentesi al Paradiso, e che dal chiaro erudito è tenuto per un brano del Commento della Seconda Cantica. Ma quel brano non è del figliuolo di Dante: non è altro, se non una delle rubriche, onde son preceduti i singoli Canti delle Tre Parti della Commedia, e si trovano, ora in latino, ora in volgare in numerosissimi manoscritti, che furono eziandio divulgati più volte per la stampa.
Le Chiose di Jacopo non recano alcuna data e, per questo rispetto, non si può, neppure approssimativamente, accertare il tempo in cui furono scritte.
L’unico modo a scuoprir il posto, che loro spetta nella ermeneutica dantesca, è da ottenersi nello scrupoloso esame del loro contenuto, in un paziente raffronto fra esse e altri Commenti sincroni. Tali raffronti lunghi e minuziosi, non entrerebbero però ne’ termini imposti a questa Prefazione.
Ma ci contenteremo di qualche osservazione succinta.
Dal passo sul veltro si ricava che Jacopo confuta l’opinione di altri, che vollero vedere nel veltro, o un personaggio di nazione gentile, o anche di bassa estrazione. Egli l’una e l’altra ipotesi ribatte come non conformi alla intenzione del poeta. E pur sembra che, nel parlar di Alberigo dei Manfredi, si rivolga contro altri, i quali allegarono che l’anima del frate non poteva essere posta nell’inferno, essendo egli ancora vivo.
Abbiamo già accennato agli scarsi studi d’Jacopo e a’ pochi mezzi, ch’egli possedeva per risalir direttamente alle fonti, valersi di materiali utili alla erudita interpetrazione del poema.
Non siamo sicuri che pur dove accenna, in termini generali, alle sue fonti, citando nomi d’autori, egli li abbia veramente consultati. Così non può aver trovato nella Bibbia certi ragguagli, che asserisce; come pure non può aver letto «in Ovidio, o negli altri poeti» che Cerbero era «alcuno così nominato che più in cotal vizio (la golosità) si resse»; nè in Omero che Chirone «fu crudelissimo e bestiale in tutte sue operazioni, ecc.». Abbiam pur menzionato il fatto che per due chiose allegoriche dove Jacopo non cita alcun nome, e che son di Lattanzio e Isidoro, da altro commentatore sincrono, non pur son richiamati i nomi degli autori, ma riprodotte le lor testuali parole.
A ridurla a oro, è evidente che Jacopo si serviva di altre esposizioni del poema ove trovava materiali a lui acconci. Non si può, dunque, consentire col ch. Rocca, che volle metter le Chiose a capo di tutti i commenti, supponendole scritte nel 1325, anteriori, quindi, d’un anno al Commento di Ser Graziolo, cancelliere bolognese, il più antico sin ora conosciuto.
Il Rocca basa la sua ipotesi, specialmente, su le identità della Chiosa allegorica circa le tre bocche di Cerbero.
E noi crediamo pregio dell’opera il riprodurre integralmente la Chiosa di Ser Graziolo e quella di Jacopo.