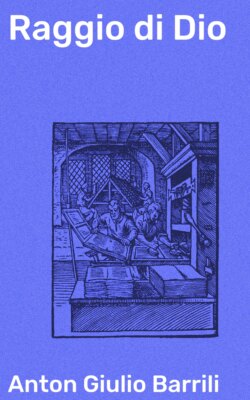Читать книгу Raggio di Dio - Anton Giulio Barrili - Страница 4
Capitolo II.
Ambasciator non porta pena.
ОглавлениеMa ritorniamo una seconda volta, e sia la buona, al nostro don Garcìa, che con tanta attenzione seguiva le vicende di un bellissimo giuoco. Proprio si arriva al punto che la piacevole occupazione gli era interrotta dall’avvicinarsi d’un famiglio, le cui prime parole ebbero virtù di farlo balzar subito in piedi. Molestie dell’ufficio, naturalmente; e la Guardia non poteva esser sempre gioiosa, pel suo degno custode.
—Ci abbandonate?—gli chiese frate Alessandro, che per fortuna di giuoco veniva ad essergli più vicino, e lo vedeva muoversi di scatto dalla panca.
—Per forza;—rispose don Garcìa.—Ed anche, diciamolo pure, con un certo piacere. Arriva il nostro Giovanni Passano.—
La nuova si sparse fra gli altri giuocatori, e la partita fu subito interrotta, come la piacevole occupazione di don Garcìa. Il Passano aveva amici da tutt’e due le parti; e se si contentavano di piantar lì la giuocata quei che avevano il disopra, con “quaranta e la caccia„, era naturale che non si dolessero quelli che s’avviavano a perdere, non avendo che un “quindici„.
Giovanni Passano, al suo smontar da cavallo nel cortile della Gioiosa Guardia, fu accolto a festa dai suoi vecchi compagni d’Haiti e della Giamaica.
—Che buon vento vi porta?—gridavano a gara, stringendogli la mano.—Finalmente! Bisognerà metterci il segno per ricordo, stamparla, toccarsene un occhio. Sapete che ci mancate da un mese?
—Eh, si fa come si può;—rispondeva il Passano, commosso da tutte quelle dimostrazioni d’amicizia.—Appena levati i piedi dagli impicci, eccomi qua. Pietro Gentile! Guglielmo! Battista! frate Alessandro, che per riverenza alla tonaca dovevo metter primo di lista!... Quantunque,—soggiunse ridendo, al vedere tutti quei grembi e sboffi fuor dal cordone di san Francesco,—mi pare che la portiate sempre alla diavola. Giuocate al pallone, vedo. È un bel giuoco; ma non da frati.
—Chi ve l’ha detto, messer Giovanni? Nessun testo lo proibisce; e ce n’è uno che forse li permette tutti. Ma sì. Servite Domino in laetitia; lo raccomanda il Salmista. Volete giuocare anche voi?
—Eh! se non fossero quattr’ore che mangio polvere, e che mi fiacco le reni col cavallo più indiavolato della cristianità.... A proposito, mi fareste un gran piacere ad esorcizzarlo coll’acqua santa.
—O voi col vino di Vernazza, piuttosto.
—Il vino di Vernazza fa bene all’uomo;—conchiuse gravemente il Passano, mentre si avviava colla brigata verso l’ingresso della seconda cinta.—Qui, infatti, ci ho un testo sacro ancor io; vinum bonum laetificat cor hominis. E il signor conte?—ripigliò, con accento mutato, parlando a don Garcìa.—E la signora contessa?
—Benissimo;—rispose lo Spagnuolo.—E vi direi che sono là bene accostati sul medesimo ramo, come due tortore innamorate, se fosse almeno ora di giardino. Saranno invece nella caminata, lei col suo tombolo a far merletti, lui a metter del nero sul bianco.
—Ma anche a far merletti e a scrivere si può star molto vicini, non è vero?
—Oh questo poi sì; alla medesima tavola, per non perdersi d’occhio. Vi faccio annunziare, mentre bevete un bicchiere?
—No, non occorre;—rispose pronto il Passano.—Non dico per il bere, intendiamoci; dico per il farmi annunziare. Non c’è premura; è una visita senza impegno, la mia. A presentarmi, ci sarà sempre tempo per la cena.
—Ah, mi levate una spina dal cuore;—disse quell’altro, mentre lo faceva entrare nel tinello, al pianterreno della rocca.—Avrei giurato a tutta prima che veniste per portarci via il padrone. Che ci volete fare? Presentimenti; e fortuna che qualche volta ingannano! L’altro giorno, passando di qua messer Filippino, che, sia detto con la debita reverenza al casato, ha sempre la lingua un po’ amara, si lasciò sfuggire certe parole! “Che Gioiosa Guardia! diceva; che Gioiosa Guardia! Dormigliosa, dovreste chiamarla. Con Ercole che fila ai piedi di Onfale„. Io, per dirvi la verità, non conoscevo questa signora, ed ho dovuto farmi spiegare l’arcano da frate Alessandro. Ne sapeva poco più di me, quel bravo figliuolo; ma tanto da capire che si trattasse d’una donna, la quale faceva perdere il tempo al dio della forza. Il nostro conte, veramente non fila, e nemmeno la contessa; quantunque, se filasse, vi so dir io che con quelle sue dita darebbe dei punti alle fate. Ma io ho bene inteso, dopo la spiegazione di frate Alessandro, che cosa volesse dire messer Filippino. Il padrone non si occupa se non della padrona, e lascia che gli altri della casata facciano e disfacciano a modo loro le cose della Repubblica. Ma di che si lagnano, se mai? Egli tira le mani e i piedi fuori del giuoco; li lascia dunque padroni; non vi pare?
—Giudicando alla grossa, sì;—rispose il Passano, mentre con diligenza amorosa osservava il liquido topazio delle Cinque Terre attraverso la lucida parete del bicchiere.—Ma possono aver ragione i suoi nobili parenti, a desiderare che un tal uomo non si ritiri dal giuoco. Sapete bene; dove bastano undici, il dodicesimo aiuta.—
Don Garcìa rizzò l’orecchio a quelle parole dell’amico.
—C’è dunque da aiutare a qualche impresa?—diss’egli.
—No, ch’io sappia;—replicò il Passano.—Ma c’è una condizione di cose che parla abbastanza chiaro da sè. Noi del Gatto, o del Basilisco, anzi diciamo pure di tutti e due questi graziosi animali, siamo per Francia; e sta bene, tenuto conto delle buone ragioni che ci abbiamo: ma siccome tutto questo, messo in ispiccioli, significa avere un presidio straniero in città, non si può neanche sostenere alla faccia del popolo che sia la più bella cosa del mondo. D’altra parte, i popolari, cioè a dire i nostri signori d’origine popolana, chiamati altrimenti del portico di San Pietro, vorrebbero aver mani in pasta, allontanando dalla madia quei del portico di San Luca; e questi, capirete, spalleggiati come sono dal gatto e dal basilisco, antiche insegne dei Fieschi, non ci pensano neanche a ceder d’un passo. Si guardano dunque in cagnesco, e come possa andare a finire Dio solo lo sa. Speriamo, nondimeno; Dio misericordioso potrebbe appigliarsi al buon partito di accomodar la testa a tutti. Dei miracoli se ne son visti, in altri tempi: perchè non ne accadrebbe uno nel nostro? Parlo così,—soggiunse il giovanotto,—perchè conosco il padrone, chè non se ne fa nè di qua nè di là. Ma guai a parlar di pace in Violata!
—Gian Aloise è sempre il più forte?—entrò a dire don Garcìa.—E sempre bene coi francesi?
—E come!—rispose il Passano.—Non si muove foglia che Gian Aloise non voglia. Quasi si direbbe che in Genova sia lui il padrone, com’è il capitano generale di tutta la Riviera di Levante. Ci sono i francesi nel Castelletto. Ma quelli si possono magari considerare stipendiati, come se fossero svizzeri, o tedeschi; zuppa o pan molle.
—Sia contento, allora,—disse don Garcìa,—e lasci quieti noi in Gioiosa Guardia, dove si sta così bene.
—Felice mortale! L’avete trovata, la nicchia? E badate, ci verrei tanto volentieri ancor io.
—Con donna Higuamota, non è vero? Ma olà!—ripigliò don Garcìa, come per darsi sulla voce.—Non dimentichiamo che l’ha tenuta a battesimo la madre del padrone, e che bisogna dire donna Bianchina.
—Già,—disse ridendo il Passano,—quantunque sia bruna. Tien più di Caonabo che di Anacoana, la mia dolce metà. Fortuna che amo le brune!
—O perchè non l’avete condotta con voi, amico Passano?
—Che, vi pare? dovendo fare una visita di poche ore....—
Don Garcìa inarcò le ciglia, ma non aggiunse parola.
In quel mentre si faceva udire un gran rumore dalla scala vicina, donde qualcheduno scendeva a precipizio, saltando ad ogni tanto e tonfando, alla guisa dei ragazzi. E subito dopo si vide balzar dentro un adolescente, dai capegli biondi e dalla faccia birichina. Pareva, a vederlo, che il mondo fosse suo, o che lo credesse da vendere, e da poter comprare coi quattro soldi che a lui ballavano in tasca. Polidamante (era questo il suo nome) poteva dirsi l’imagine, il simbolo, il genio della Gioiosa Guardia, ove del resto era nato. Se gli altri ci avevano pochi fastidii, egli non ne aveva nessuno. Tutto di primo impeto, correva sempre, quando c’era da muoversi; quando poi doveva star fermo, si addormentava. Non faceva mai niente con misura; e forse per ciò era molto caro al padrone.
—Che c’è?—chiese don Garcìa.
—Presto, le acque;—gridò quell’altro, senza fermarsi a rispondere in tono.—Dove sono le acque?
—Nei fiumi;—disse il Passano;—e neanche ne han tutti.
—Ah, siete voi, messer Giovanni? Bene arrivato! Dicevo le acque acconce, le acque cedrate, i siroppi per la signora.—
I famigli, che non avevano bisogno di tutte quelle spiegazioni, avevano già levato da una credenza il vassoio con le bocce di cristallo, e si preparavano a seguire con quello il messaggero Polidamante.
—Quando si dice nascer vestiti!—esclamò don Garcìa, volgendosi al Passano.—I padroni hanno anticipata l’ora di uscire in giardino. Potete salire dietro a Polidamante, e presentarvi, e far le vostre ambasciate, senza interrompere i commentarii di Cesare.
—I commentarii.... Che dite voi, don Garcìa?
—Eh, sì, i commentarii di Cesare, come li chiama frate Alessandro.
—Sta bene, avevo inteso;—riprese il Passano.—Domandavo che diavolo è.
—Una storia, amico, una storia di laggiù, mi capite? Il capitano ci ha fatto l’onore di chiamarci nella caminata, per cinque sere alla fila, e ce ne ha letti già cinque capitoli. In quello scritto racconta tutto quello che s’è fatto alle Indie.
—Ah, bene! capisco, ora. Ci avrà molto da raccontare, perchè molto si è fatto. E parla di voi?
—No, non ci siamo ancora, a quel punto;—rispose don Garcìa, rannicchiandosi.—Penso, del resto, che quando saremo a quel punto, egli mi dovrà passare sotto silenzio. Del che non mi lagnerò,—soggiunse egli umilmente;—che anzi, dovrò sapergliene grado. Beati gli uomini di cui non avrà da occuparsi la storia.
—Bravo! siete filosofo?
—Alle mie ore, amico Passano.—
L’amico Passano strinse la destra di quell’altro Seneca; e vuotato il suo calice fino all’ultima goccia, che non era d’aceto, si avviò verso la scala.
—Va, bello mio, va, che non la conti giusta;—borbottò tra i denti il bravo don Garcìa, uscendo alla sua volta di là.—Questa visita di poche ore, a spron battuto, mi sa di chiamata a Genova lontano un miglio. C’è la mano di messer Filippino, qui sotto; scommetterei. Quello là non vuol dare nè lasciar pace a nessuno.—
Il giardino di Gioiosa Guardia, anzi i giardini, perchè erano quattro, bisognava andarli a cercare in alto, come gli orti pensili di Semiramide. Si stendevano essi sui bastioni della rocca, per tutta la lunghezza delle cortine, fiancheggiati e conterminati dalle torri, che, per conseguenza logica quanto architettonica, erano appunto quattro, senza contare il battifredo, gran torre più alta, dalla parte dell’ingresso, colla campana al sommo e con l’orologio nel mezzo. Forte arnese per guerre medievali, la Gioiosa Guardia non poteva più dirsi tale in un tempo che le artiglierie mobili e di grande gittata potevano batterla da parecchie eminenze circostanti. Ma essa non s’aspettava di queste noie, e il suo padrone, amico della pace, ne lasciava il carico ad altri luoghi fortificati della sua parentela, da Montobbio a Pontremoli. In uno di quei casi di necessità, che gli amici della pace come Bartolomeo Fieschi si dovessero ricordare d’essere stati uomini di guerra, la Gioiosa Guardia poteva essere ancora un bell’inciampo a soldatesche raccogliticce, non esperte o impazienti d’assedii; e il suo signore, poi, avrebbe amato sempre meglio far impeto in aperta campagna; che infine non era neanche troppo aperta, e i suoi duecento uomini, ben comandati, potevano valere per mille. Frattanto, sui pensieri di guerra avevano il sopravvento le arti della pace, e prima fra tutte l’arte dei giardini.
Madonna Bianchinetta, la santa madre del capitano Fiesco, ne aveva preso cura da giovane; ma poi, cresciuta negli anni, se n’era via via disamorata, piacendole assai più di passar le sue ore nella cappella del castello, dedicata a san Colombano; un gran santo, quello, e quasi di casa, che era morto non troppo lontano di là, nel monastero di Bobbio, e che dava il nome, del resto, ad una terra vicina. N’era venuto nei giardini del castello un gran guaio per le varie famiglie dei fiori; i quali, si sa, per prosperare domandano amore, intristiscono nell’abbandono, e muoiono anzichè darsene pace. Per contro erano cresciuti gli alberi, gran solitarii, anche quando si ritrovino in molti, che degli uomini non si dànno un pensiero al mondo, e vorrebbero anzi che gli uomini non si dèssero tanto pensiero di loro, per tagliarli, segarli, riquadrarli, piallarli a molti usi volgari, o farne legna da ardere. E insieme con gli alberi erano venute su liberamente le rose, belle salvaticacce che bastano molto a sè stesse. Diradare quegli alberi, sfrondandoli un pochino qua e là, ravviar quelle rose, nettandole d’ogni seccume e potandole, era stata la prima cura dei nuovi arrivati; quanto ai fiori più delicati, poco c’era voluto a trarne da tutti i dintorni, a farne allignare nelle vecchie aiuole risarchiate, e lungo i viali rifatti.
Per quei viali passeggiava la coppia felice; Fior d’oro col braccio sinistro girato intorno alla vita di Damiano; Damiano col braccio destro girato intorno al collo di Fior d’oro. Erano atti, per avventura, di soverchia libertà; ma non veduti per allora se non dagli uccellini saltellanti e chioccolanti sugli alberi. Ed essi, finalmente, come quegli alberi per tanti anni avevano fatto, non si davano pensiero di nessuno. Se n’andavano a passi lenti, così mollemente abbracciati, chiacchierando a mezza voce, bisbigliando quasi, com’è l’uso degli innamorati a buono, che non han nulla da dirsi di serio, nè sopra tutto di nuovo, ma che nelle cose più naturali e più comuni debbono metter sempre un po’ di mistero.
Un rumor di passi sulla ghiaia del viale fece voltar la testa a Damiano. Una sbirciata bastò al felice mortale, perchè egli spiccasse il braccio dalla dolce postura che s’era scelta con tanto buon gusto, e prendendo per mano la contessa Juana muovesse incontro al nuovo venuto.
—Quello, o ch’io sogno, è il vostro genero;—gridò egli con ostentazione di allegrezza, più fatta per consolar l’ospite, che per esprimere il vero sentimento dell’animo.—Capite, Fior d’oro?—incalzò, rivolto alla contessa, mentre stendeva pure la mano al suo antico aiutante.—Vostro genero! vostro genero!
—Già,—disse a sua volta il Passano inchinandosi,—il genero d’una suocera a trent’anni. Si può ben dire l’età d’una donna, in un caso come il mio, non è vero?—
Così dicendo, prendeva la mano che la contessa gli aveva stesa in atto benevolo, e si chinava ancora accennandovi il bacio di cerimonia che la galanteria spagnuola incominciava a far prosperare sulle terre italiane. Mai suocera al mondo meritò tanto un simile omaggio, od altro assai meno cerimonioso di quello.
—Come sta madonna Bianchina?—gli domandava frattanto il Fiesco.
—Bene, benissimo; e saluta, s’intende, e abbraccia la sua bella mamma.
—Perchè non condurla con voi?—
Era la stessa domanda di don Garcìa; ed ebbe l’istessa risposta. Onde da parte del Fiesco l’istesso inarcamento di ciglia, ma con una giunta di parole che non aveva potuta fare quell’altro.
—Visita di poche ore! Mi spaventate, Giovanni mio. Faccende, dunque? e gravi?
—Oh, questo poi no. Son venuto col libro dei conti. Volevo sapere che cosa si dovrà fare della vostra parte di profitti sulla nave Paradiso. Siete il partenevole più grosso, e ci avete un guadagno, quest’anno, di seimila ducati larghi.—
Bartolomeo Fiesco fece una bella riverenza. Seimila ducati larghi erano una bella somma. Il ducato largo, o genovino d’oro come s’era chiamato nei tempi anteriori, con un peso di grammi 3,567, eguale del tutto al suo fino, e con un valore di due lire, due soldi, e due denari, valeva nei primi anni del Cinquecento, in moneta corrente, tre lire e due soldi. La lira genovese ne valeva allora più di tre delle nostre; sicchè, fate il conto, e troverete che il ducato largo ne valeva più di dodici delle odierne italiane. Moltiplicate per seimila, e vedrete che bel guadagno avesse fatto messer Bartolomeo delle Indie col suo Paradiso. Ancora qualche annetto di fortuna, e c’era da farsi foderar d’oro una bella nicchia in purgatorio.
Fece dunque una bella riverenza, come il caso meritava. Ma non gli parve altrimenti che fosse mestieri un viaggio, per sapere dove andasse collocato tant’oro.
—Per questo siete venuto!—diss’egli.—E non la ricordavate, la mia massima? San Giorgio, amico Passano; le “colonne„ di san Giorgio sono le mie colonne d’Ercole. È quello il luogo, il posto, il rifugio sicuro pei ducati larghi. Ma forse avete ancora da dirmi della Santa Giovanna?
—Quella è arrivata a Bari per le lane; non si aspetta prima di giugno. Così almeno mi ha detto ier l’altro il Sauli, che aveva ricevuto lettere. Ho qui invece il fogliazzo delle spese. Se gli date un’occhiata, essendo ancora giorno....
—Volete dire che i numeri si leggono male a lume di lucerna? E sia;—soggiunse messer Bartolomeo,—contentiamo questo terribil Passano. Sedete?—diss’egli, facendo un cenno d’invito a Fior d’oro.
—Fate, fate;—rispose la contessa;—io vi lascio. Quando siete coi numeri, bisogna lasciarvi stare.
—Capirete, Juana, e perdonerete senz’altro. Son genovese; e il genovese, per vostra norma....
—Oh, non dicevo per questo;—interruppe la bella.—Che genovese, del resto? Non vi vantate, amico mio. Volevo dire piuttosto che vi c’imbrogliate parecchio.
—Ah sì, birichina? Ma ciò avviene perchè guardo voi; e allora, povero a me, smarrisco perfino il ricordo della tavola pitagorica.
—Vedete dunque....—diss’ella con aria di trionfo.—Ragione di più per lasciarvi con messer Giovanni mio genero. Farò allestir la cena un po’ prima, perchè egli avrà appetito, m’immagino.
—Abbastanza, madonna;—rispose il Passano.—Ho tanto rinsaccato, su quel maledetto cavallo!—
La contessa si era ritirata; ma dal vano di un uscio, voltandosi, aveva gittato un bacio col sommo delle dita a Damiano. E Damiano, che lo colse al volo, non volle lasciarlo senza ricevuta.
—Povera tavola pitagorica!—gridò egli ridendo.—La vedo brutta.
—Che c’è?—disse il Passano, levando la fronte dai suoi scartafacci.
—Niente, niente; parlavo a mia moglie. Mia moglie!—ripetè il capitano Fiesco.—Ecco due strane parole. Sapete, Giovanni mio, che non so avvezzarmi a questo nome? e che mi par sempre un sogno?
—Restate nel sogno;—rispose quell’altro.
—Certamente, certamente, poichè il sogno è così dolce! Ma ora che siamo soli, ragazzo mio, vuoi tu dirmi che cosa significhi la tua visita? Tu non sei mica venuto per sapere dove andassero collocati i miei ducati larghi.... e neanche per rompermi la testa col fogliazzo. Tu hai una commissione per me, ed una commissione urgente.
—Avete ragione;—rispose il Passano.—Ecco qua, infatti.—
Così dicendo, traeva di sotto al giubboncello una lettera, e la porgeva al capitano Fiesco.
—Ah, volevo ben dire!—esclamò questi.—Gian Aloise?...
—Lui, in persona. Mi aveva mandato a chiamare in gran fretta, ier sera; ed ho risicato, figuratevi, di fiaccarmi tre volte il collo in quei cento scalini di Violata, non avendo altro lume nel buio se non questi due occhi. Giunto alla sua presenza, eccovi il dialogo che corse tra noi: Verrà di questi giorni a Genova il tuo principale?—No, eccelso signore; è più facile che Genova vada a Chiavari, di quello che venga a Genova lui.—Ebbene, andrà Genova a Chiavari, nella persona tua; passerai da me domattina per tempo; ti darò una lettera, che dovrai consegnargli senza fallo in giornata; a lui, mi capisci? e parlandogli a quattrocchi, che nessuno ne abbia fumo. Ritornai da messere Gian Aloise questa mane per tempo; tenevo il cavallo sellato ad aspettarmi fuori della porta di Santo Stefano. Avuta la lettera, son ridisceso dalla Montagnola; ho infilata la via dei Lanieri; son montato in arcione, e via di galoppo, che n’ho ancora le reni fiaccate.
—S’intende che ti sarai ristorato a tutte le frasche.
—Messere!...
—Eh via, non saresti genovese. Hai rinfrescato a San Martino, confessalo; e nota che ti fo grazia di San Fruttuoso. Il secondo bicchiere l’hai bevuto a Nervi; il terzo a Recco, con un rincalzo a Ruta, per ragione della faticosa salita; il quarto a Rapallo, il quinto a Zoagli. Dimmi che non è vero.
—Siete uno stregone, messere;—disse ridendo il Passano.—Per altro, non sono mai sceso d’arcione.
—Te lo credo, questo, perchè al debito non sei venuto mai meno. Quanto a rinfrescar l’ugola, non è mai stato un delitto. E dall’oste della Maddalena, poi? Dicono che ce n’abbia bevuto una mezzina anche Dante.
—Ma sempre stando in arcione;—rispose il Passano.—Furono tutti bicchieri della staffa.
Il capitano Fiesco s’indugiava in queste celie, per non leggere il foglio che gli aveva consegnato il Passano. La lettera donde si aspetta una noia si dissigilla mal volentieri; si spera sempre in un accidente improvviso che possa dispensarcene. Ma l’accidente non ci fu, e messer Bartolomeo dovette rassegnarsi. Aperse il foglio, e lo spiegò; spiegato che lo ebbe, incominciò a leggere, ed anche ad aggrottare le ciglia, a batter le labbra, a sbuffare.
—Oh Dio!—esclamò, quand’ebbe finito.—Ma son pur fastidiosi! Io consigli? E che ci ho da veder io? come ho da darne io, che non ho saputo mai domandarne? Che noia! che noia! E ancora dovrò ringraziarlo, il mio eccelso parente, che ha mandato te per messaggero, e non il suo Filippino.
—Filippino?...—balbettò il Passano, che non vedeva la ragione dell’essere messo in paragone con quel pezzo grosso.
—Già, il nostro buon cuginetto Filippino;—riprese il capitano Fiesco.—Quello là, o con un pretesto o con un altro, è sempre da queste parti; due, tre, quattro volte ogni mese. Il giovanotto non ha mai avuto tanto da fare nel capitanato di Chiavari, come dal giorno che ho preso moglie io.
—Che dite, messere? Io casco dalle nuvole.
—Ed io vorrei risalirci, con Fior d’oro tra le braccia, e non ricomparire mai più alla vista dei seccatori. Vuoi sapere? Filippino s’è messo in mente di toccare il cuore a Fior d’oro. Fa l’occhio pio, lui, ch’è una bellezza a vedere. Sospira, recita i sonetti del Petrarca, e li mette a raffronto colle rime amorose dell’Alighieri. Una sera, che ci fece la stampita più lunga, figúrati che ci sciorinò tutto il canzoniere della Bella Mano. Tu non lo conosci, il canzoniere di Giusto de’ Conti da Valmontone, tutto inteso a celebrare la mano della sua bella? Lo conosco io, pur troppo, e me ne dolgono ancora gli orecchi. Maledetto biondino! Quantunque, a farlo a posta, s’è imbattuto in una che i biondi non li vuol neanche per prossimo.
—O allora, scusate....—si provò a dire il Passano.
—O allora, caro mio, m’annoia egualmente;—rispose il capitano Fiesco.—Qualche volta mi vien voglia di assestargli uno scapaccione.
—La contessa se n’è avveduta?
—E come no? Se ne avvedono gli usci e le imposte, che sono di legno, e gli arazzi e i corami delle pareti; perfino il pappagallo, ultimo avanzo dei dodici portati da San Domingo, che ha imparato a ciangottare: Filippino sciocco! Noto, per amor di giustizia, che vorrebbe dire Filippino Fiesco; ma non gli riesce, e dice sciocco tale e quale. Fior d’oro, dal canto suo, lo chiama Gunora. E potrebbe anche chiamarlo Guatigana. Ma quel poveraccio va rispettato, che almeno ha saputo morire. Quanti pretendenti, mio Dio!—esclamò il capitano Fiesco, sospirando.—Hanno avuto tutti buon gusto, non lo nego; ma ti confesso che m’hanno tutti mortalmente seccato, e mi seccano. Basta, ti ho fatto il mio sfogo, e tu chiudilo in petto, alta mente repostum, come direbbe Virgilio. Il giorno che avrò accoppato messer Filippino, ne capirai il perchè, senza bisogno di venirmelo a chiedere. Ma ora che ci penso.... In questa lettera dell’eccelso Gian Aloise non ci sarebbe la zampa di messer Filippino bello? Mi vogliono levare da Chiavari, è chiaro, come si leva una lepre, o un cinghiale. Vogliono tirarmi sul Bisagno, anzi peggio, sul Rivo Torbido. Una volta là, addio guardia e custodia del fatto mio: feste in Violata, festini a San Lorenzo; dovunque c’è un Fiesco, sarà un invito a ballare. E tu balla, Damiano, o lascia ballar chi ne ha voglia. Così il mio Filippino ha libertà di corteggiare Madonna, di atteggiarsi a suo “intendio„ secondo l’uso della giornata. Ma io me ne intendo più di te, Filippino bello; quando il tuo diavolo nasceva, il mio andava già ritto alla panca. E per la croce di Dio.... Oh, smettiamo; ecco madonna che torna.—
Infatti, sull’uscio dond’era sparita un’ora prima, riappariva Fior d’oro.
—Avete finito di far conti?—diss’ella.
—E da un pezzo;—rispose Giovanni Passano.
—Allora, eccomi qua. Vorrete accettare un rinfresco, per aguzzar l’appetito? Polidamante, i bicchieri e il vin di Cipro.—
Polidamante, che era comparso allora nel vano dell’uscio, corse ad eseguire i comandi. Due minuti dopo, era in giardino col vin di Cipro e il vassoio.
—Dategli da bere, Juana;—disse il conte Fiesco alla moglie.—Ma in verità non lo merita. Sapete che ha vuotate tutte le cantine che ha incontrate in viaggio, da San Martino d’Albaro al ponte della Maddalena? E certo, con lo stomaco scavato da tanto bere, egli ha più fame che sete.
—È anche pronta la cena;—rispose Fior d’oro;—ed egli non avrà da penar molto. Genero,—soggiunse ella, accostando il calice a quello del Passano,—siate il benvenuto coi vostri scartafacci e colle vostre belle notizie. Beviamo ora alla salute della nostra Bianchina.—
Tutto bene, sì; ma le belle notizie il Passano non le poteva mandar giù, dopo averle portate, e conosciute molto noiose.
—Ed ora,—diceva egli tra sè, mentre mandava giù più facilmente il suo vin di Cipro,—come la prenderà Fior d’oro, quando saprà che si vuol Damiano a Genova? Basta, la cosa non mi riguarda; ambasciator non porta pena.—
Indice