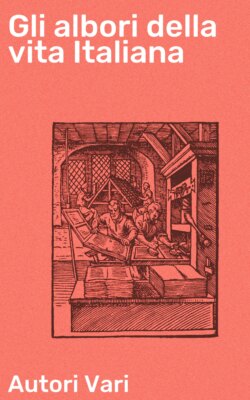Читать книгу Gli albori della vita Italiana - Autori vari - Страница 14
VENEZIA E LE REPUBBLICHE MARINARE
ОглавлениеDI
P. G. MOLMENTI
Signore e Signori,
E dove a chi potrei oggi meglio parlare di Venezia, se non a voi qui in Firenze, in Firenze così legata alla città delle lagune anche da recenti prove d'affetto? Voi la conoscete, ma è sempre curioso il ricordarla la storia di codeste genti veneziane, che non aspettano la loro fortuna, come limosina dal caso, ma la conquistano colla prodezza e l'accorgimento: si fanno innanzi tra la larva d'impero dei Cesari bizantini e i rinnovantisi invasori stranieri, divengono signori di grandi traffichi e conquistatori di vaste provincie, fiaccano l'orgoglio dei maggiorenti e abbassano l'insolenza del popolo, piantano il vessillo repubblicano sulle torri del palazzo imperiale di Bisanzio, divengono i guardiani d'Italia contro gl'infedeli della religione e gli infedeli della libertà; non s'abbassano mai nè anche quando li stringe da presso il nemico: passano, a traverso la storia, eroi talvolta, talvolta uomini pratici, guerrieri e mercanti, statisti e poeti, accorti sempre, sempre ammirabili. Di questa grandezza, paragonabile nell'antichità alla romana, nel tempo presente all'inglese, io vi accennerò, o signori, alle umili origini, non toccando delle altre gloriose repubbliche marinare d'Italia se non per ciò che con Venezia ha rapporto.
Quella regione, da una parte racchiusa dall'Adige e dal Timavo, dall'altra lambita dalla curva settentrionale del golfo Adriatico e difesa dalle Alpi tirolesi e carintie, era conosciuta dai Romani col nome di Veneto. Le origini degli abitanti si collegavano ad Ilio, secondo una tradizione non del tutto creata dalla boria nazionale, ma ravvalorata dai versi dell'Eneide (I, 246). Eneti viene dal greco e vuol dire laudabiles, ma ai veneti cronachisti la nobiltà del cuore non basta e trovano che la voce enetici viene da Enea.
La regione era lieta di città popolose e fiorenti: Padova, Aquilea, Altino, Verona; di paesi ferventi di vita: Ateste, Monselice, Concordia, Treviso, Vicenza, Oderzo, Belluno, Ceneda, Acelo (Asolo). Collocati alle porte orientali d'Italia, caddero primi, nel V secolo, sotto l'impeto delle turbe barbariche, che diruparono dalle Alpi. Gli abitanti, dinanzi a quelle disperate catastrofi, cercarono rifugio là dove le acque dei fiumi dell'Italia superiore, giungendo al mare si fermano, stagnano, si dilatano in lagune. Nulla però in esse d'insalubre. Il Lido, stretta lingua di terra, che separa dal mare la laguna, è rotto in varie aperture, in vari porti, che lasciano libero il corso delle acque. Il flusso marino, che ora copre or lascia a secco quei fondi melmosi, porta via ogni germe mefitico. Nulla di triste. Il cielo, che non splende del troppo vivo fulgore meridionale e non ha la fredda vaporosità del settentrione, si rispecchia nelle acque con quei magici riflessi, con quella smorzatura di toni, con quelle armonie di tinte, che educarono l'occhio dei pittori veneziani. Erano isole, se non deliziose e frequenti, come alcuni sognarono, non abbandonate e squallide, come credettero altri, e abitate e conosciute dai naviganti del tempo romano. Si può arguir ciò da alcuni passi che a quelle isole si riferiscono in Mela, in Tacito, in Plinio, nell'Itinerario di Antonino, in Erodiano. I due limiti estremi della regione insulare, non esposta all'ira degli invasori, cui mancava il navilio, erano, da una parte Grado, dall'altra, Capo d'Argine.
Chi dirigeva quei profughi, chi li guidava? Poetiche leggende ci sono tramandate da una vecchia cronaca, chiamata Altinate, perchè uno degli aneddoti in essa contenuti e scritti anche prima del secolo X, si riferisce ad Altino, città prospera per commercio, magnifica per edifici, fra i quali un palazzo imperiale, e per l'amenità delle ville, degne di rivaleggiare con quelle di Baja, a quanto afferma Marziale:
Æmula Bajanis Altini litora villis.
I primi cronachisti veneti illuminano di luce poetica e religiosa le antiche dimore dei loro padri. Tutti i grandi popoli, dalla Grecia e da Roma a Venezia, hanno carezzata la loro origine leggendaria, e più da essa si sono allontanati, grandeggiando, più si compiacquero non a collegarsi con umili e rozze origini storiche, sinceramente esplorate, ma con quel vago e indefinito della leggenda, che ritrova anche nei primi albori della vita la grandezza. Così le città greche rannodarono le antiche origini con gl'Iddii. Narra la cronaca d'Altino come agli Altinati e agli Aquileiesi Iddio abbia manifestata l'imminente venuta degli Unni. Ciò avveniva nel 452, e si sa come siano intimamente collegate l'origine di Venezia e la leggenda di Attila, intorno alla quale si raccolse ogni ricordanza di distruzione, di sangue, di stragi. Gli uccelli nidificanti nelle mura e sulle torri di Altino fuggirono portando nei becchi i loro nati. Non sapendo una parte di cittadini dove trovare uno scampo, dopo un digiuno di tre giorni pregarono Iddio di manifestar loro se dovessero affidarsi alla terra o alle navi. Si udì una voce: Ascendete sulla torre e guardate verso la parte australe. Molti montarono sulla torre e videro in vicinanza alcune isole, e per tali figure s'intese che doveasi andar là ad abitare. Un terzo circa di cittadini, preceduti dai tribuni e dal clero, si diresse con barche alle lagune e fondò la celebre Torcello. Due sacerdoti, Geminiano e Mauro, incuoravano i fuggitivi e gli spiriti atterriti si commovevano, si sublimavano nelle visioni dell'infinito. Appariva allora a Mauro una bianca nube, dalla quale, insieme con due raggi di sole, scendea la voce di Dio, che imponeva di innalzare in quel luogo una chiesa. Alla voce di Maria, che dava, in altro sito, lo stesso comando, seguiva un prodigioso miraggio: le bianche nubi si squarciarono e lasciarono vedere lidi fiorenti, pieni di popolo e di gregge.
Altri Altinati andarono ad abitare Amoriana o Murano.
Una cronaca, di poco posteriore all'Altinate, quella di Grado, narra che il patriarca Paolo, ritornando coi profughi all'antica patria, Aquileia, ebbe una visione, dalla quale apprese come la sævissima longobardorum rabies avesse distrutto quella città. Egli allora si ritirò a Grado, divenuta poi la più ricca fra le isole veneziane e la sede principale della potestà ecclesiastica.
Eraclea, popolata essa pure da Aquileiesi e dal fiore degli Opitergini, fu sede del governo.
I profughi di Asolo e di Feltre ripararono a Jesolo, più tardi chiamata Equilio, per le razze dei cavalli, che vi si allevavano.
Gli scampati dalla distruzione di Padova si ridussero a Matemauco, l'odierno Malamocco.
Il popolo di Concordia cercò riparo nell'isola, dalle capre che vi condussero i pastori, chiamata Oaprule ed oggi Caorle.
Vissero tutte la fulgida vita della giocondità e della ricchezza. Ora, dove esse sorgevano, si è fatto un triste deserto. Qua e là qualche rudero; eco romita dei vecchi secoli. Vi regnano lo squallore e la malaria.
Esiste ancora in tutta la suprema bellezza dell'arte e delle memorie, Rivoalto, la più modesta di tutte le isole, che a poco a poco unita ad Olivolo, indi a Luprio e finalmente alle Gemine e a Dorsoduro, formò l'odierna Venezia.
L'operosità rinvigorita della sventura e la forza raddoppiata dagli ostacoli animano quella moltitudine di persone, varie di condizioni, di costumi, di sesso, di età, e cento anni circa dopo la distruzione di Attila, i nuovi abitatori delle isole sono descritti con vivi colori da Cassiodoro, in una lettera magniloquente ai tribuni marittimi delle lagune, probabilmente ufficiali inferiori goti, ai quali il ministro, a nome regio, ordina di preparare le navi per trasportare dall'Istria a Ravenna il vino e l'olio.
Provveduti di navilio, arditi sfidano le tempeste del mare e le correnti dei fiumi: erigono case, come nidi d'uccelli marini; collegano la terra con fascine e dighe: ammucchiano sabbia per rompere le onde infuriate: convivono in eguaglianza poveri e ricchi; non invidia, non vizî li macchiano; ogni loro emulazione sta nel lavoro delle saline, da cui nasce il frutto al quale ogni produzione è soggetta e che dell'oro è assai più prezioso.
Nessuna descrizione più attraente, quantunque il ministro di Teodorico fosse disposto ad abbellire il quadro, oltre che dall'indole sua, anche dal bisogno che aveva il suo sovrano di trasportar vettovaglie coi navigli di quei Veneti, i quali del resto riconoscevano nei conquistatori goti l'alto dominio sulle isole.
Tuttavia in questo primo accenno storico, quel popolo risorgente dallo squallore dei bassi tempi alla luce di un'êra novella, si rianima. Noi la vediamo la tranquilla verdura di quelle isolette, specchiantisi nel nitido specchio delle lagune. Oltre alle paludi giuncose, l'occhio si posa sul mare romoreggiante. Qui la pace inconturbata potea destare negli esuli il rimpianto e le memorie delle città disparite, gli splendori distrutti e i tristi albori della nuova patria; là, il furiar delle tempeste e il romoreggiar delle onde rendeano l'imagine dei tumulti della esistenza, di lotte, di pericoli, di gloria. Ma le tranquille melanconie dell'asilo non cullarono quelle anime, da tanti dolori agitate, in una pace mesta. Essi allungarono lo sguardo, oltre le paludi, sul verde Adriatico, e di esso sfidarono le lotte e i pericoli e in esso cercarono la gloria. — Lotta e gloria — ecco il grido anche dei secoli venturi. L'energia di quegli uomini si eleva ad eguale misura delle difficoltà e degli ostacoli naturali: la loro vita tutta si riassume nello scontrar pericoli, domarli, trionfare; una stessa passione li agita, li comanda, li possiede.
Alla vita frugale e laboriosa seguono più prospere condizioni. S'interrano dossi paludosi: ogni prominenza di sabbia, ogni più breve isoletta è abitata; si regolano i canali tortuosi, si preparano approdi e ripari alle barche, si arginano saline, si elevano mulini, si scavano cisterne, si riducono prati, si piantano vigne. Ma anche nel sicuro asilo della laguna giunge l'eco di battaglie e di stragi, di ribellioni e di lotte. Nella Venezia continentale, da prima si agitano guerre fra Ostrogoti e Bizantini, fra Bizantini e Franchi e Longobardi: poi lotte dei patriarchi di Aquileia e Grado e dei vescovi veneti ora coi Longobardi, or coi Bizantini, e controversie fra il papa e i patriarchi e i vescovi. In breve la pace incominciò a turbarsi anche nella Venezia marittima.
La prima costituzione politica, il reggimento dei tribuni marittimi, fu imitato dai Bizantini, sotto la sudditanza dei quali, sciolti ormai dalla gotica, passarono i Veneti. Confermano ciò, tra le fonti più antiche, la Storia gotica di Procopio, le inscrizioni di Grado del secolo VI, edite dal Filiasi e dal Mommsen, la Storia dei Longobardi di Paolo Diacono e gli Annali del franco Eginardo. Allorchè i Bizantini perdettero le città più importanti della Venezia terrestre e ritirarono anche dalle isole i loro eserciti, gli abitanti, non più soggetti a un dominio immediato, elessero un libero reggimento militare di tribuni.
Cessati i pericoli e la pietà e i ricordi delle comuni sventure, incominciarono le rivalità fra le isole, più o meno importanti, fra i tribuni maggiori e minori; poi sorsero contese sui confini o sulla proprietà delle terre coi Longobardi vicini, si sentì necessario creare nelle isole un capo unico, un duce, che il popolo, col suo liquido eloquio, chiamò doxe, titolo ritenuto poi sempre e con lievi mutamenti anche nella lingua e nelle relazioni internazionali. Al nuovo capo, eletto a vita, podestà quasi da sovrano, ricchezza di redditi e di insegne, pari alla dignità, spada, scettro e corona; ei giudice di liti e datore di ecclesiastici benefici: a lui il popolo richiedeva perfino la benedizione nelle adunanze solenni. Tuttavia le cause importanti dovevano essere trattate nell'assemblea generale e non già dal doge come sovrano assoluto.
Il primo Doge, Paoluccio Anafesto, con l'assenso o almeno senza opposizione della Corte greca, fu, nel 697, in un'assemblea del clero, dei tribuni e dei più notabili cittadini, eletto in Eraclea.
Paoluccio strinse coi vicini Longobardi un patto, il primo, di cui si abbia memoria nelle storie veneziane, che determinò i confini dei due Stati e le ragioni scambievoli dei commerci.
In Eraclea, la vita ci si presenta assai diversa da quella descritta con idillica poesia da Cassiodoro. Abbiamo accennato come le varie isole dell'estuario fossero asilo agli abitanti delle desolate città di Altino, di Aquileia, di Padova, di Oderzo, di Concordia, di Vicenza. Ma una buona parte di quei fuggitivi s'erano riparati in luoghi, dipendenti anche prima del loro municipio, come Grado, ad esempio, che aveva fatto parte della dizione aquileiese: altri invece erano venuti ad occupar terre, sulle quali i padri loro non aveano mai avuto alcun diritto. Nei primi tempi, la sventura comune non avea lasciato luogo a discutere i diritti di ciascheduno, e poveri e ricchi, come dice Cassiodoro, conviveano colà in eguaglianza. Ma quando tacque il timore dei barbari, sorsero gelosie e contrasti di elementi diversi, tendenti a soverchiarsi a vicenda. Le ire interne, rinfocolate ora dai Greci, ora dai vicini dominatori della terraferma, diedero origine alle due parti veneto-greca e veneto-italica. Di qui torbidi mutamenti di governo. Non più il doge, ma l'annuo governo dei maestri dei militi. Dopo poco si ritornò ai dogi e per togliere ogni gelosia si trasferì la capitale a Malamocco. Alle rivalità dei maggiorenti, alle gare delle due opposte fazioni, s'aggiungeano le discordie e le vendette del popolo, il quale, specie quando il doge tentava rendere dinastico il potere vitalizio, associandosi quale il figlio, quale il fratello, si ribellava, uccideva, incendiava. È un fiero delirar di battaglie e di stragi. Nel 717, Eraclea è assalita e messa a fuoco dagli abitanti di Equilio, che danno morte al doge Anafesto e a' suoi fidi. Nel 737 il doge Orso è ucciso a furore di popolo; nel 741, il maestro dei militi Giovanni Fabriciaco è deposto e abbacinato; nel 755, Galla si ribella al doge Diodato, lo imprigiona, lo accieca, e usurpa il ducato per poco più d'un anno, trascorso il quale, il popolo insorge contro Galla e gli appresta la stessa sorte, ch'egli avea procurata all'infelice antecessore. Nel 764, i nobili macchinano le fila di una congiura, rompono in furibondo partito, traboccan di seggio il doge Monegario e gli strappano gli occhi. Nel 801, circa, il doge Giovanni Galbaio, fautore dei Bizantini, manda il figlio a Grado, con una divisione della flotta, per assassinarvi quel Patriarca, che inchinava invece ai Franchi. Il figlio di Galbaio prende d'assalto la città, imprigiona il Patriarca e lo fa precipitare dalla torre più alta del Castello. Ma, dopo tre anni, il doge Galbaio e il figlio Maurizio debbono fuggir da Venezia per non cader vittime di una congiura, ordita dal nipote dell'ucciso patriarca di Grado. Il partito franco riacquista allora vigore ed è eletto doge Obelerio. Così che non errava il Machiavelli affermando Venezia, forse più d'ogni altro comune italiano dell'età di mezzo, aver provato il furore delle fazioni.
Codeste terribili agitazioni doveano metter capo all'invasione straniera. Ma Venezia, destinata ad accogliere le fatidiche memorie del popolo italiano, escì salva dalle turbolenze, che ne comprometteano la libertà e l'esistenza.
Obelerio, appena eletto al dogato, era andato, insieme col fratello Beato, a Diedenhofen, dove allora teneva corte l'imperatore Carlo, per rendere omaggio di sudditanza ai principi franchi, che agognavano il dominio anche del veneto litorale. Ma ritornato in patria, quando una flotta greca, sotto il comando di Niceta, approdò alle isole, il doge infido, mutò intendimenti, accostandosi ai Greci. Allora, il figlio di Carlo Magno, Pipino, con forte esercito e numerosa squadra di legni, invase e distrusse gran parte del ducato veneziano, minacciando da presso la capitale Malamocco. Nel supremo pericolo si accetta il consiglio del nuovo doge Agnello Partecipazio, di rifugiarsi nella umile isoletta di Rialto, ove erano le offese più pronte e le difese più sicure. Pipino, dice la tradizione, vuol inseguire i fuggitivi: fa costruire con sassi e fascine un argine, presso Rialto, e ordina ai suoi cavalieri di avanzarsi. Ma i cavalli dei Franchi sulla strada malferma, s'impauriscono, balzano di qua e di là nell'acqua, i Veneti piombano colle loro navi sui nemici sgominati e ne menano tal strage, che a quelle acque rimase il nome di canale orfano per le famiglie franche private de' loro cari. L'orgoglio nazionale ha abbellito coi colori della leggenda la vittoria dei Veneti contro il primo usurpatore, che osasse mettere il piede sul sacro suolo della patria. Le tenebre di questa età tempestosa son come solcate da un bagliore dell'antica gloria. E certo, in mezzo alle lotte fratricide di quei tempi, non ispirate se non all'odio ed alla rapina, questa può anche dirsi la prima vittoria italiana. E il nome sacro d'Italia, offuscato da tante ignominie, era raccolto con tanta pietà sul lembo estremo della penisola, nell'umile isoletta di Rialto. Ed era bene affidato.
Quella stessa incomposta ardenza dovea, per fatalità storica, mettere capo a leggi di moralità e di giustizia; quelle lotte erano pur segnale di molta ed esuberante vita, e per questa via si dovea compire la legge del progresso veneziano. Quando invece sull'alba della vita popolare il dispotismo di un tiranno mette il suo volere in luogo della libertà popolana, la quale deve manifestarsi con tutti i suoi errori e tutti i suoi eccessi, gitta i semi di rivoluzioni, che scoppieranno più tardi e lascieranno turbamenti perenni. Così nella vita dell'uomo: alle giovinezze agitate succede la seria virilità, laddove all'età matura sono riservate le follie, che la gioventù non commise. La vita non soffre violazioni.
A Rialto comincia la città nobile e grande, con lei e per lei stanno la forza e l'avvenire. Rialto, che si denominava così o da un fiumicello Prealto, o dall'importanza del canale o rivo, divenne il centro della nuova potenza. In essa la sede vescovile, il porto e i magistrati, officiales de Rivoalto. Per lungo tempo Rialto significò Venezia, laddove il dogato, l'antico Stato da Grado a Capodargine si chiamò invece Venecia.
Della vittoria su Pipino manca la certezza storica: certo è che il giovane re, disperando di soggiogare i Veneti nel sicuro asilo di Rialto, fu costretto a ritirarsi. Da questo momento cessa nei Franchi ogni idea di conquista su Venezia. Nel definitivo accomodamento fra Carlo e l'imperatore d'Oriente, nei preliminari della pace di Aquisgrana dell'810 e nella pace definitiva dell'812, Carlo rinunzia esplicitamente ad ogni pretensione sulle isole della laguna, riconosciuta come provincia dell'Impero d'Oriente. Col trasferire la sede del governo in Rialto non si era voluto soltanto provvedere alla sicurezza dello Stato, ma s'era anche obbedito all'alto concetto di raccogliere e fondere in luogo senza anteriore importanza, gli elementi migliori di varia origine, dispersi per l'estuario. La prima capitale Eraclea avea rappresentato il predominio greco, poi Malamocco la tendenza verso i Franchi. Rialto significava l'indipendenza, la patria libera da ogni influsso straniero. E si sentì fin dalle prime che la nuova patria era stabile e sicura. Bisanzio, è vero, esercitava ancora una azione su Venezia: i dogi cercavano sempre a quella corte dignità e uffizî, troppe erano ancora le relazioni scambievoli, troppi gl'interessi della vita veneziana, maturata al caldo sole d'Oriente. Ma non era più che un'azione di nome. Che poteva aver di comune, quale autorità esercitare un Impero, nato nella mollezza, fra le ambizioni delle donne e le basse adulazioni dei cortigiani, fra le lusinghe e le menzogne, e volgente alla fine, svigorito dalla decrepitezza, con un popolo fiorente di gioventù, ricco di giovanile baldanza? La vigorìa e la gioventù non furono contaminate dalla vecchiezza e dal vizio.
Venezia passa dall'adolescenza alla giovinezza robusta. Gli stessi scompigli dei primi tempi fanno prova di eccesso di vigoria, della necessità di azione; di quella inquietudine che cerca trar fuori l'ordine dalla confusione delle cose. Agnello Partecipazio (811), primo doge in Rialto, assoda lo Stato, abbellisce la nuova sede, unisce con ponti i sessanta o settanta dossi che formano la nuova città, bonifica i terreni paludosi, crea un magistrato per assicurare i lidi dall'impeto delle acque. Anche qui il primo pensiero è rivolto a Dio, anche qui intorno alle chiese, quasi a cercare la solenne protezione del cielo, si fabbricano le case. E le chiese non sono già, come nei primi tempi di tavola e di canne, fabricæ lignæ, ma si costruiscono di pietra e si abbelliscono di marmi e colonne. Giustiniano, figlio di Agnello Partecipazio e collega nel dogato al padre, fra l'813 e l'820, fondava per incarico dell'imperatore bizantino Leone, un monastero di donne dedicato a san Zaccaria. L'imperatore mandò da Costantinopoli alcuni architetti, perchè l'opera fosse condotta a termine il più presto possibile. E, circa nello stesso tempo, il doge Agnello gettava le fondamenta di quel palazzo, che dovea servir di dimora ai reggitori del più gagliardo Stato d'Europa. Ma per mostrare come legami di sudditanza non esistessero più col decrepito impero di Costantinopoli, la nuova libertà è posta non più sotto il protettorato dell'antico patrono greco Teodoro, ma di un Santo, congiunto ai sentimenti e alle aspirazioni nazionali. Narrava una leggenda che l'evangelista Marco nel suo viaggio da Alessandria ad Aquilea, colto da una bufera, era stato gettato sulle isole realtine, ove un angelo gli era apparso salutandolo: Pax tibi, Marce, Evangelista meus. E in suo fatidico accento, il messo di Dio gli annunziava che là fra quelle isole, chiamate un giorno a meravigliosa prosperità, avrebbero trovato pace le sue ossa.
La leggenda servì mirabilmente a quella specie di misticismo ufficiale, che, come ben fu detto, nessuno Stato ebbe in grado maggiore di Venezia. Tutto ciò che si riferisce all'innalzamento del tempio, dove, secondo l'angelica previsione, dovea trovar riposo il corpo dell'Evangelista, è come avvolto da un'aura di misteriosa poesia. Strano il modo con cui da Alessandria furono trasportati nelle isole realtine i resti di san Marco. Due mercanti, Buono da Malamocco e Rustico da Torcello, nell'828 approdavano ad Alessandria, dove i cristiani erano perseguitati dai musulmani, che spogliavano di quanto contenevano di più prezioso le chiese, per adornarne moschee. Anche il tempio dove era la tomba di san Marco dovea essere distrutto. I due mercanti veneziani poterono ottenere dai sacerdoti greci quelle sacre reliquie, e per sottrarle alle indagini dei gabellieri musulmani, le coprirono di carni porcine, avute in orrore dagli islamiti. Recata quindi la salma sulla nave, spiegarono al vento le vele, approdarono alla patria, fra le festose accoglienze del doge e del popolo. La santa reliquia fu riposta in palazzo ducale fin che si fondasse il tempio, in omaggio del nuovo protettore.
Sotto Giovanni Partecipazio, nella chiesa, ridotta a buon termine e adornata di colonne e marmi finissimi, spoglie di vittorie sui Saraceni, si trasportò il corpo dell'Evangelista, il cui nome fu invocato nelle sventure, nelle gioie, nelle battaglie, nelle vittorie. E Venezia, che diverrà una delle prime potenze denaresche d'Europa, quasi a bene augurare de' suoi commerci, stamperà il busto nimbato di san Marco sulle sue monete; e l'animale simbolico dell'Evangelista diverrà ben presto il segnacolo glorioso della repubblica, e nell'edifizio, sacro e inviolato sepolcro del Santo, si svolgerà una serie di avvenimenti, nei quali si riassume quanto v'ha di più glorioso nella veneta storia.
Se Venezia potea dirsi indipendente dall'Impero bizantino, non avea, d'altra parte, più a temere le forti razze del settentrione. Colla potenza Carolingia, minacciosa un dì per la libertà veneziana, la giovane repubblica potea ora trattare da eguale ad eguale. Lodovico II, nell'855, si reca insieme con l'imperatrice, insino a Brondolo, presso Venezia, per onorar di una visita il doge Pietro Tradonico, del quale tiene al fonte battesimale un nipote.
Ma, fra tanta prosperità, le interne discordie non quetavano, anzi, tratto tratto, prorompevano tremende, specie fra i maggiorenti. Le famiglie più illustri vengono fra loro al sangue: i Giustiniani, i Basegi, i Polani da una parte; gli Istoili, i Barbolani, i Selvo dall'altra. Lo stesso doge Pietro Tradonico è trucidato, non già in tumulto di popolo, ma per mano di congiurati, i cui nomi sono fra i più illustri di Venezia: Gradenigo, Candiano, Calabrisino, Faliero.
Nè men sinistra quella luce di rivolte civili, che circonda la bieca figura di Pietro Candiano IV, prima esigliato per l'indole fiera e turbolenta, poi con voltabile giudizio, richiamato in patria ed eletto al dogato. Ma presto, lasciato veder l'animo suo, prorompente ad ogni maniera di prepotenza, fu fatto nuovamente segno alle ire di congiurati, che lo assalirono nel palazzo dove trovaron fiera resistenza nelle soldatesche straniere, messe a guardia del doge. Allora appiccarono il fuoco alle case vicine. Quando le fiamme minacciavano al palazzo ducale, Candiano fuggì per l'atrio della chiesa di San Marco, insieme col figlioletto ancora lattante. I congiurati lo scoprirono, s'avventarono su lui, implorante la vita, almeno, pel figlio. Risposero col sangue. I corpi degli uccisi, lasciati per ludibrio insepolti, furono raccolti e seppelliti da un Giovanni Gradenigo, uomo pio, aborrente da quei furori.
Altre contese sanguinose sorgono fra le due famiglie dei Morosini e dei Caloprini. Un Morosini, mentre esce di chiesa, è trafitto da un Caloprino. I servi, percossi d'orrore, non pensano a brandire le armi, ma raccolgono il ferito e lo trasportano in un monastero, dove spira fra le lagrime e i propositi di vendetta dei parenti colà riparati. I Caloprini fuggono, chiedono asilo alla corte di Ottone II, che coglie tale pretesto per assediare Venezia da ogni parte, perchè non le giungessero vettovaglie e dovesse arrendersi. Venezia resiste e nel 983 si viene alla pace di Verona.
Più tardi, i Caloprini per intercessione dell'imperatrice Adelaide, ottengono il perdono e il ritorno in patria. Ma gli odî non sono spenti nei Morosini. Una sera, seduti in una barca, tornavano dal palazzo ducale alle loro case, tre giovani Caloprini, allorchè, d'improvviso, assaliti dai Morosini son trucidati con tal furore da farne schizzare il sangue sulle rive vicine. I corpi sanguinosi dei trafitti furono portati da un servitore fedele alla povera madre e alle vedove mogli.
Strano tempo e strane antitesi! L'odio a canto all'amore, la ferocia alla mitezza; e sconsigliati impeti di plebe a canto a sottili e accorti provvedimenti; e qui levarsi su nel limpido azzurro le bianche chiese e là intorbidar l'aria il fumo degli incendi vendicatori; e dotar monasteri dopo esser corsi alla rapina; e appendere a piè degli altari le spoglie dei nemici; e innalzar preci dopo uccisioni e stragi. Ma sol che lo straniero minacciasse ed offendesse la patria, le discordie tacevano e tutti insieme i cittadini correvano alle armi, animati da un volere comune.
È di questo tempo il celebre ratto delle spose veneziane, che ispirò la poesia e le arti. È leggenda, è storia? I più vecchi cronachisti, l'Altinate e il diacono Giovanni, vissuto tra il cadere del secolo X, Martino da Canale, che narrò nel XIII, non ne parlano. Certo, a quell'avvenimento vero e leggendario si dee l'origine d'una delle più pittoresche feste veneziane. Non la storia soltanto, anche la fantasia ha i suoi diritti: e l'indagine fredda non ha potuto cancellare dalle pagine della storia questa tradizione di coraggio e di valore. Era costume veneto, l'adunarsi delle fidanzate nella chiesa di Olivolo, il dì secondo di febbraio, perchè dal vescovo fossero le loro nozze benedette. Biancovestite, coi capelli disciolti, ornate di molti gioielli, tenevano in mano una cassetta (arcella), contenente la dote. I pirati slavi approdarono di soppiatto in Olivolo, irruppero nella cattedrale, rapirono le donne, gli uomini e, secondo alcuni, anche il vescovo e i preti, e si diressero verso Caorle, a un porto, chiamato ancora delle donzelle, per dividersi le fanciulle e la preda. Ma i Veneziani, rimessi dal primo sbigottimento, armarono in fretta alcune barche e guidati dal doge, raggiunsero a Caorle i corsari, li assalirono, li sconfissero e ritolsero loro le spose e il bottino. In memoria di questo avvenimento fu instituita la festa così detta delle Marie. Singolarissima e fastosa. La descrivono, tra altri, un documento del 1142 e la Cronaca di Martino da Canale. Quei documenti parlano di ricche compagnie di damigelle portanti vassoi e fiale d'argento, e precedute da trombettieri, di lunghe file di chierici vestiti di sciamiti d'oro e di damasco. Insieme col doge si recavano tutti al tempio di Santa Maria Formosa. Dodici fra le più belle e le più giovani donzelle, le Marie, acconciate molto riccamente con drappi d'oro e corone di pietre preziose, erano presentate al doge e festeggiate poi lungo il Canal grande. La festa durava dal 25 gennaio al 2 febbraio, fra baldorie, regate e spettacoli d'ogni maniera. Così una delle prime e più solenni feste civili dei Veneziani fu un omaggio alla donna.
Meno gentile, ma non meno singolare sarà la festa commemorante la vittoria sopra Ulrico patriarca d'Aquileia. I Veneziani vittoriosi trassero prigione il patriarca con dodici de' suoi canonici, avendoli, dice Marin Sanudo, il principe dei veneti cronisti, a farli tajar la testa. Ma, ad istanza del papa, furono rimandati, pur che il patriarca dovesse inviare ogni anno, nel giovedì grasso, un toro e dodici maiali — simbolo di scherno del patriarca e de' suoi canonici — per servir di spettacolo alla moltitudine. E la festa del Giovedì grasso, in cui si uccidevano il toro e i maiali, si rinnovò ogni anno con grandi allegrezze e matte baldorie.
Il sommo della veneta potenza, nel periodo delle origini, fu raggiunto sotto il dogato di Pietro Orseolo II. Ei ricondusse la quiete nella fervida città, aggrandì, non impetuosamente, ma per gradi, lo Stato, riescì, col valore, colla sagacia, colla costanza, ad accrescere e consolidare la propria potenza. La mente avea fine ed aguzza nel trovare ingegni a tenersi bene in arcione tra il Cesare bizantino e l'Imperatore tedesco. Trionfò dei pirati narentani, guerreggiò gli Slavi, conquistò la signoria delle città marittime della Dalmazia, tramandando ai successori il titolo di doge della Dalmazia, liberò l'Adriatico dai Saraceni, che l'infestavano. A buon dritto potè il doge, in appresso, commemorando tali conquiste, sposare il mare con la cerimonia più splendida di tutte le feste veneziane. Nè le arti della pace erano trascurate dal gran doge. Compì una parte della basilica di San Marco nel 1006, e quel turrito palazzo ducale, dove ospitò l'imperatore Ottone III, che ammirò, a quel che ne dice il diacono Giovanni, cappellano del doge Pietro, la bella e decorosa fabbrica. Dopo un secolo, sotto Ordelafo Faliero, si gettavano le basi di quell'Arsenale, che fu il più vasto d'Europa, e che ricordano tutti, più ancora che pei suoi fasti, per la stupenda descrizione di Dante — tanta è la potenza dell'arte.
Nel secolo XI, può dirsi veramente fondata la marittima signoria di Venezia, e l'Adriatico incominciò da questo tempo a considerarsi come un lago della repubblica. La libertà e il vero spirito dell'antica Roma qui continuavano in tutto il loro vigore. Questo giudizio non è di qualche storico piaggiatore, ma d'una delle anime più nobilmente fiere, che sieno mai passate pel mondo: Ildebrando. Di tanto fe' degna Venezia ardor di speranze e tenacia d'intendimenti. E il meraviglioso espandersi della possanza guerresca e civile si accompagna all'avanzamento dei commerci. Alle inquietudini interne, alle agitazioni civili succede la forte serenità. Vivissimo il commercio. Nelle vecchie carte si parla sovente di carichi di mercanzie pel valore di 150,000 ducati d'oro, di navi cum raxon de drapi, telle et altre cosse de valor de ducati 200,000. E si noti che erano in gran parte piccoli legni, perchè tutti voleano trafficare, tanto che il governo prescrisse con decreto le proporzioni più piccole di uno scafo per avventurarsi in mare.
Nè men fiorenti le arti e le industrie. — Venezia ha, fin dai secoli più remoti, fonderie di metalli, fabbricatori d'organi, officine di tessitura, di tintoria, di vetreria, fabbriche di sete, lini, velluti, broccati. Le antiche chiese, specie quelle di Grado e di Torcello, scintillavano di mosaici. Negli Annali di Eginardo, si ricorda, all'anno 826, Giorgio, prete veneziano, chiamato in Aquisgrana, per la sua abilità nel costruire organi. Orso I Partecipazio, asceso al trono dogale nell'864, mandò in dono a Costantinopoli dodici campane, e Pietro Orseolo II, fatto doge nel 991, fe' regalo a Ottone III di una tazza di fino lavoro di due troni rivestiti di lamine d'avorio e di una tazza d'argento. Non si può dire che in egual fiore fosse la cultura letteraria, se due documenti sono da due dogi, Pietro Tradonico e Tribuno Memo, firmati così: Signum manus domini excellentissimi Petri ducis e Signum manus Tribuni ducis. Ma fra quel pratico e operoso popolo di navigatori e di trafficanti non potevano aver culto se non le arti, che al dolce unissero l'utile. E tali arti andarono a mano a mano meravigliosamente avanzando.
Martino da Canale, narrando l'incoronazione di Lorenzo Tiepolo, nel 1256, descrive con pittoresca efficacia la sontuosa processione delle Arti veneziane: primi venivano i fabbri col loro gonfalone e con ghirlande in capo: poi i pellicciai riccamente addobbati di armellino e vaio, di sciamito e zendado. Seguivano, cantando, accompagnati da trombe, portando coppe d'argento, i tessitori; i sarti in veste bianca a stelle vermiglie: i fabbricanti di drappi d'oro e di porpora, con cappucci dorati in testa e belle ghirlande di perle; e via via i lanaiuoli, i barbieri, i vetrai, gli orefici. Gli orafi specialmente raggiungeano la dignità d'arte più squisita in quei piccoli capilavori di imagini, imitate dai bizantini, in quegli ornamenti d'oro e perle, di cui è perfino menzione nel testamento del doge Giustiniano Partecipazio dell'829, e in quelle catenelle d'oro, preferito ornamento sì delle gentildonne come delle popolane venete. Cito questo lieve, ma non insignificante particolare. Nel 1225, Federico II, il grande sovrano e il grande artista, ordina a un orafo di Venezia una zoia, un gioiello.
In questo periodo delle origini, la città ha un aspetto singolarissimo. Questa maravigliosa zattera di sabbia e di fango è indefinibilmente strana per forma e non rassomiglia ad alcun altro paese. Il Sannazaro, nel tempo in cui Venezia, un po' invecchiata, incominciava a porgere ascolto benigno alle bugie dei poeti, scrisse un epigramma, che gli fruttò cento scudi per ciascun verso (i versi erano però sei soltanto) e nel quale, comparando Roma a Venezia, conchiude col dire che quella fu fabbricata dagli uomini, questa dagli dei.
Illam homines dices, hanc posuisse deos.
Nulla di più poeticamente menzognero. Venezia fu fatta dai Veneziani. Il nume indigete erano la forza, l'operosità, il vigore, il coraggio, l'ardore di quei profughi intrepidi. Per voi, ad esempio, o signori, la patria è un dono, uno splendido dono di Dio — pei Veneziani è l'opera dell'industria umana. Entro questo vostro divino anfiteatro di colline, rigate dai canali freddi e molli, fra la magnifica pompa della verzura e dei fiori, palpita una dolce vita, dove hanno sorrisi tutte le cose, viventi nella felicità di un'armonia serena, armonia dei colori e della luce, del suolo e dello spazio. Qui l'opera dell'uomo è un sublime commento all'opera della natura, e l'arte temperata al sentimento dell'aere circostante, assume una elegante semplicità e compostezza di linee, una nobiltà morale di forme che riposa l'animo e contenta l'occhio. La cupola del Brunelleschi, il campanile, la loggia dei Lanzi, Orsanmichele sono come il compimento di Bellosguardo, di Fiesole, di Monte Oliveto, di San Miniato, e le linee del paesaggio con quelle degli edifizî si fondono nel comune accordo. Venezia invece, eretta sur un labirinto di secche e di paludi, sovra un piano di acque e di alghe, dovea rispecchiar nell'aspetto, fin dall'origine sua, i capricci imaginosi dell'uomo, non già l'impero della natura esteriore. Guardate San Marco, il prodigio dell'architettura veneziana! È una sublime bizzarria. I rosoni, i rabeschi, gli intrecci, i pinacoli slanciantisi al cielo, presentano l'aspetto di una lussureggiante vegetazione di pietra. Le arcate a trifoglio, le aguglie traforate, l'innesto dell'arco acuto sul bizantino, tutta l'opera fine, con la sua ricca veste di sculture e di cesellature, colle sue armonie e co' suoi disaccordi, sembra una vasta sinfonia nel marmo. Nessuna licenza è vietata; simboli di tristezza macilente e di florida giovinezza, figure misticamente rigide e mondanamente voluttuose, vergini e martiri assorti in visioni serafiche, e angeli e beati, vivificati da idee terrene, mostri e chimere del paganesimo a canto ai santi del cattolicesimo. — Tale Venezia. — Percorrendo il Canal grande, ci passano dinanzi fantastiche architetture bizantine, palazzi di stile arabo-archiacuto simili a trine di marmo, edifici del Rinascimento corretti e severi, moli maestose della decadenza dalle bugne massicce, dalle cornici ponderose. Qui l'architettura non ha tradizioni e, tra gli splendori del cielo e le iridescenze delle acque, cresce mobile, varia, fantastica, come le tinte dei tramonti, come i riflessi delle lagune. Nessuna città è passata per più diverse forme.
L'imaginazione può compiacersi senza allontanarsi dal vero, a raffigurarsi così l'aspetto di Venezia adolescente. Quelle sporgenze dal fondo lagunare, su cui era sorta la città, si chiamavano con varî nomi: dossi, scanni, barene, tombe, velme. Eretta una casa sopra una palude, si chiedeva al governo di estendervisi con interrimenti. E il tributo per la concessione, era alcune volte un bel paio di guanti di camoscio pel doge. I canali (rivuli), che s'incrociavano in ogni parte e si chiudevano per sicurezza con catene, erano fiancheggiati da alberi. Si attraversavano i ponti di legno di brevissimo arco, senza gradini, si seguivano strade lungo i canali, chiamate fondamenta o junctoria, si entrava in certe piazzette anguste (campielli), per certi chiassuoli stretti (calli) e si riesciva all'aperto dinanzi a qualche largo specchio d'acqua (piscina), a seni, a sbocchi, oppure fra verdi prati (herbidi piani), dove pascevano armenti, o in mezzo a folti boschetti. La piazza di San Marco si chiamava brolio, ossia orto, perchè ricoperta d'erba e piantata d'alberi. Apparivano qua e là saline in muratura, e incassati tra argini e canali stendevano i raggi delle loro ruote i molini, chiamati acquimoli. Si camminava sul nudo terreno: i cavalli correvano per la città, e i porci dei monaci di sant'Antonio grufolavano continuamente per le vie — sub specie et reverentia Sancti Antonii vadunt per civitatem — diceva un decreto del Maggior Consiglio. Le case erano, nei primi tempi, coperte di tavolette di legno o di paglia e alcune non aveano altra via che d'acqua. Ogni magnificenza era riservata ai pii edifici e alla dimora del capo dello Stato. E fra le case e sopra i tetti, nettamente intagliate nel pieno azzurro, vele, antenne, cordami. Poi prospetti lontani di altre case e di altre vele, e sullo specchio tranquillo della laguna le svelte navi — le zalandrie, i dromoni, le galee — il cui solo nome, il solo ricordo, ci svegliano nella mente la visione della gloriosa epopea marinaresca delle città italiane. Squadre intere di navigli, che toccavano i porti dell'Asia e dell'Africa e scorrevano i mari del Nord; naviganti che, con la sicurezza della forza e il presentimento della gloria, spingeano la prora così fra le acque su cui si riflette il sole d'oriente, come fra le sconfinate solitudini brumose del settentrione; marinai che passavano a traverso mari inesplorati e toccavano terre ignote, fra gli ostacoli della natura e i più perversi ostacoli degli uomini, fra grida alzantisi nello spazio a osannare al trionfo e urla imprecanti inutilmente alla morte — intrepide avanguardie del progresso umano, della civiltà moderna, della gloria italiana.
Una sola città avrebbe potuto rivaleggiar con Venezia e metterne in dubbio il primato: Amalfi. Alla città surta là dove il monte cala, lieto di verzura e fiorente di messi, al mare, accorrevano d'ogni fatta stranieri. La descrizione di Amalfi fatta da uno scrittore, a cui la poesia non fa velo alla verità del giudizio, Guglielmo Apulo, non ha nulla da invidiare alle condizioni di Venezia nei tempi più prosperi. Straricca di tesori e frequente di popolo: le case piene d'argento, di stoffe d'oro, di tessuti di seta. I suoi marinai, noti in tutto il mondo, san farsi strada sulle onde, in mezzo ai venti e alle tempeste. Le merci che escono da Alessandria d'Egitto e dalla città d'Antioco sull'Oronte, affluiscono tutte alla spiaggia d'Amalfi. Non v'ha porto in Arabia, nella Libia, in Africa, o nei paesi della Sicilia, che non sia stato visitato dall'Amalfitano. Ma fu luce rapidissima, come fu passeggero lo splendore di Napoli, Gaeta, Sorrento, signore dei mari, ben prima che dalle ruine dell'antica grandezza greco-romana risorgessero le repubbliche di Pisa, di Genova e di Venezia. In sui primordi del secolo XII, la libertà e la prosperità amalfitana furono spente dalla violenza di quegli eroici avventurieri normanni, a cui nulla omai più resisteva in Italia, nulla, tranne Venezia, la quale con la giovanile energia delle sue forze, dopo una fierissima guerra, durata tre anni con varia fortuna e finita nell'agosto del 1085 colla presa di Durazzo, salvò dai Normanni il decrepito Impero bizantino, ottenendone in compenso privilegi importantissimi, nuovi possedimenti, libertà assoluta di traffico e perfino un quartiere distinto in Costantinopoli stessa.
Qui Venezia si trova di fronte ad altre due città marittime, che andavano anch'esse crescendo in potenza, e alle quali la fortuna della rivale non poteva non destare sospetti e antagonismi, scoppiati poi in sanguinose discordie.
Pisa non era una nuova venuta. I documenti della sua nobiltà risalivano all'antica civiltà etrusca, alla grandezza romana. Risorta dopo l'invasione barbarica, ebbe a combattere i Saraceni. Ma il valore delle armi non si scompagna agli accorti maneggi del commercio e ai provvidi ordinamenti civili. Il dominio della contessa Matilde fu più di nome che di fatto e non impedì il libero svolgimento della libertà, fecondatrice di ricchezza e benessere materiale. E quanta fosse la sua floridezza commerciale, provano le parole del monaco Donizone, il quale, nel suo ascetico fanatismo, vede i navigatori pisani trasformati in mostri marini e la città insozzata da male generazioni di Pagani, Turchi, Libici, Parti, e le sue spiaggie corse dai Caldei.
Dopo aver combattuto contro la vicina Lucca, Pisa combattè pel possesso della Sardegna contro Genova.
Difficili i primi passi di Genova, umili le origini: trafficare coi porti vicini, combattere i predatori saraceni e normanni. A poco a poco, a nuovi commerci nuovi lidi. Fin dal 958, essa gode della sua libertà, non funestata mai da capricci superbi di conti, di marchesi, di duchi, ai quali tutti il trattato di Berengario II e di Adalberto vietano di porre piede nella città. Prosperano le compagnie cittadine belligere e trafficanti. Da prima, insieme coi Pisani, Genova strappa ai Mori la Sardegna, ma ben presto le armi consociate diventano fratricide, e la guerra fra le due città dura sessant'anni.
Ad accrescere la ricchezza e le rivalità delle città marinare d'Italia giungono le crociate.
È opinione comune che tra le prodezze irreflessive, ma generose delle crociate, Pisa, Genova e, in ispecie, Venezia, non abbiano cercato che l'interesse ed abbiano fatto servire una grande idealità religiosa ad ottener dovizie materiali, ad aprir nuovi scali al commercio. Certo, fra quei tre popoli non apparve l'ascetismo feroce, nè il principio di autorità dogmatica, soccorritore del feudale e del dinastico, ma la religione fu sentita e intesa fra quelle genti, nè fu ipocrito pretesto di mercantili speculazioni. Vi sono popoli credenti e pratici a un tempo, come l'inglese e il veneziano. Sono sinceri in tutti e due gli atteggiamenti della loro esistenza, e perchè sinceri colgono i frutti di ambedue queste attitudini dello spirito. Il missionario inglese, quando con la Bibbia, tradotta in tutti gli idiomi asiani e africani, s'avanza in regioni ignote a spargere la santa semente del verbo di Dio, è profondamente sincero e devoto al suo ideale fino a rifiutare per esso la vita. Ma, superate le difficoltà, egli è egualmente convinto di servire alla sua patria mutando l'evangelista in negoziante, segnando la via ai cotonieri del Lancashire e qualche volta, e Dio gli perdonerà, ai fabbricatori di brandy del suo paese. Così Venezia: devota a Cristo, si sentiva bensì accesa di zelo religioso per la liberazione del Santo Sepolcro, e, all'infuori di ogni pensiero mondano, palpitava nella isoletta di Rialto, come il grande signore di Francia e di Lamagna nel suo maniero. Ma a canto all'imagine di Gesù crocifisso, i signori dei mari intuivano tutti i nuovi orizzonti di traffichi e di colonie e vi si fisavano con amoroso zelo. E in quel connubio di palpiti cristiani e di mercantili disegni, si accordavano la religione con l'industria, l'ascetico col mercadante, e l'imagine di Gesù liberato si adornava di tutte le opulenze della nuova vita economica. Così erano, o signori, anche i vostri antenati. Credenti, mercadanti e diplomatici a un tempo, mistici e positivisti, i lucri guadagnati negli arditi commerci consegnavano alla divinità e dai banchi uscivano gli artefici, che erigevano i vostri insigni monumenti. Così la nostra storia prova come sia vano, sterile e oseri dire irreligioso, un ascetismo monastico orientale, che si consuma ne' suoi malaticci idealismi, e come, alla sua volta, conduca a ruina una sete di lucro, che non si temperi, non si legittimi e direi quasi non si purifichi in queste aure salubri della idealità. Quanto diversi, o signori, dai coloni italiani del nostro tempo, i quali, senza ideali religiosi e senza disegni di utili operosità, si avventurano in luoghi, che nè i nostri antichi apostoli, nè i concittadini di Marco Polo e di Colombo avrebbero eletto a sede di colonie. Il che dimostra appunto, perchè ci fa difetto il modo di scegliere con infallibile rettitudine di giudizî, quanto ci manchi e quanto siamo lontani dalla sana idealità e dall'avveduta operosità dei nostri maggiori. Oh! non disputavano a Venezia sulla fecondità e sull'avvenire delle grandi colonie che occupavano, come non disputavano a Genova su quelle del mar di Marmara e del mar Nero. Le opime spoglie che ne traevano non consentivano i dubbi dolorosi, che s'odono nei nostri parlamenti.
Ma, siamo giusti, ciò che ai nostri maggiori mancava era il senso della concordia. I vicini interessi e le comuni imprese fecero scoppiare più fieri i dissidî fra Pisa, Genova e Venezia.
Intanto da una straordinaria impresa era agitata quest'ultima città. Quando Innocenzo III tentò ravvivare la santa guerra, i crociati francesi si rivolsero, per ottenere il navilio, a Venezia. Era allora doge Enrico Dandolo, vecchio ottuagenario, a cui gli anni e la debole vista accresceano l'ardimento e l'energia; indole tenace e impetuosa e nello stesso tempo astuta e dissimulatrice. Egli accettò le proposte, ma prima di accingersi all'impresa, volle avere l'approvazione del popolo, ch'ei fe' radunare nella chiesa di San Marco, la plus belle que soit, come la chiama Goffredo di Villehardouin, uno di quei crociati. I cavalieri di Francia dalle armi corrusche, i veneti patrizî dalle vesti gravi e maestose dell'Oriente, il popolo dalle fogge variopinte, si adunarono sotto le cupole dorate dai scintillanti mosaici, fra quella strana architettura di colonne superbe sovrapposte a colonne, tra le effigie mirabili e i marmi preziosi.
Il vecchio doge, in luogo eminente, indossava una tunica purpurea, un manto affibbiato con borchia d'oro e un corto bavero d'ermellino. Parlò Goffredo di Villeardouin pregando Venezia ad accompagnare i baroni francesi a vendicare l'onta di Gesù. La voce di quel guerriero entusiasta si alzava trionfante come un inno, ricercava le fibre più intime di quei cuori, finiva addolcendosi in una prece, nella quale passava il puro alito della fede. Allora da più di diecimila petti un grido s'alzò sotto le vôlte dorate della chiesa e il doge e i legati francesi giurarono sulle loro spade. Ma quando furono pronte le navi, non trovando i baroni di Francia, tutta la somma stabilita pel passaggio, Enrico Dandolo propose loro, in luogo di soddisfare intero il debito, di riconquistare insieme coi Veneziani la città di Zara ribellata. La proposta fu accettata, e, dopo poco tempo, Zara cadeva. Durante l'assedio si presentava ai crociati Isacco, imperatore di Costantinopoli, spodestato da un usurpatore, chiedendo aiuto per ricuperare il trono. Papa Innocenzo, che avea con ogni possa cercato d'impedire l'impresa di Zara, scagliando perfino i fulmini apostolici, ora secretamente favoriva la spedizione di Costantinopoli, vagheggiando l'unione della Chiesa anche in Grecia. Avea finito col trovare gli opportuni ripieghi sacerdotali, concludendo con un pensiero degno della politica odierna: necessitas, maxime cum insistitur opere necessario, multum et in multis excusat. E poi troppo recenti erano le greche perfidie contro la repubblica di San Marco, perchè ogni veneziano non sentisse in cuore il desiderio della vendetta. Non erano ancor vive le generazioni che aveano veduto il fedifrago imperatore gettar un giorno in carcere tutti i Veneziani, che avea potuto prendere ne' suoi stati? E il valore dei Veneti, condotti da Vitale Michiel non era stato reso impotente dalle inique arti dei Greci? E non si era tentato di perdere coll'inganno più infame lo stesso Enrico Dandolo, che in Costantinopoli avea tentato di salvare l'onore della patria? Non erano le leggi e i trattati arbitrariamente violati dalla corte bizantina? D'altra parte, e i documenti attestano ciò, il Pontefice e il Doge si accordavano nel pensiero che la sommessione di Costantinopoli potesse agevolare il conquisto di Terrasanta. Fu stabilita l'impresa e compiuta; ma poco stante, in seguito a nuove rivoluzioni e intrighi di palazzo, i crociati vennero a rottura coi Greci, e Costantinopoli fu presa per la seconda volta. Quando il gonfalone di San Marco sventolò sulle mura di Costantinopoli, i Greci fuggirono spaventati, fra il confuso rumor d'armi e di grida, unito al frastuono orrendo di urla, di gemiti, di pianti. E il Papa, plaudendo agli eventi fortunati, scriveva ai vescovi, abati e duchi dell'esercito: sane a domino factum est istud et est mirabile in oculis nostris. E dimenticò Terrasanta.
«Dalla creazione in poi non v'ebbe più larga preda» scrisse il Villehardouin. Immense ricchezze e preziosi oggetti d'arte furono salvati nella generale rapina, e trasportati in patria dai Veneziani: quadri, statue, gemme con cui arricchirono la pala d'oro e il tesoro di San Marco, e i quattro celebri cavalli di rame dorato che, trasportati da Chio, dall'imperatore Teodosio II, a ornare l'ippodromo di Bisanzio furono posti sul pronao della basilica veneziana.
La forza di Venezia imperava ormai sull'Oriente. All'interno potea dirsi secura, coi nuovi ordinamenti politici, per mezzo dei quali si svolgeva la sua attività, colla legge che impera e custodisce, colla concordia che fortifica e rafferma. Sottratta già da lungo tempo al popolo la dogale elezione, chiuso a chi non fosse nobile, il governo, s'era consolidato quel reggimento di ottimati, grande anomalìa fra due cose normali, il governo cioè di tutti e quello di un solo che tutto eguaglia in una comune tirannide, quel reggimento di ottimati che salvò l'indipendenza veneziana. Costituzione non certo desiderabile oggi, ma per quei tempi ammirabile, e che illuminò del suo raggio uno dei periodi più gloriosi della libertà fiorentina, quando, tenendo gli occhi fissi a Venezia, fra Girolamo Savonarola, Paolo Antonio Soderini, Francesco Valori e altri magnanimi volevano garantire la nuova indipendenza, affidando la somma delle cose ai migliori dei cittadini, ai benefiziati, e instituendo il Consiglio grande. Il tentativo fallì, poichè la tenacia del volere non fu pari all'altezza degli intendimenti.
Delle due forti rivali di Venezia, Pisa in breve non fu più da temersi. La sua potenza s'infranse allo scoglio della Meloria e sulla bella e sventurata città aleggiò l'arte, supremo conforto. Quando l'età delle forti imprese si oscura, s'inalba luminosa quella delle arti.
Restava Genova, nè il vessillo di San Giorgio volle per lungo tempo e a niun patto piegare dinanzi a quello di San Marco. Lunghe e accanite le guerre, brevi le tregue, per ripigliar lena a nuove battaglie, combattute con varia fortuna.
Nel 1256, i Liguri spogliano le navi veneziane nel porto d'Acri e saccheggiano il quartier veneziano. Lorenzo Tiepolo corre alla vendetta, con gran numero di navi e coll'aiuto dei Pisani, spezza la catena del porto, preda e arde le navi nemiche, penetra nella città, incendia il quartiere dei Genovesi ed espugna il castello di Mongioia. Invano i Genovesi tentano riannodare le forze: il Tiepolo, presso a Tiro, li sbaraglia una seconda volta; poi non lungi da Acri stessa, li sconfigge nuovamente con più sanguinosa battaglia.
Nel 1261, la gelosia ligure rialza il trono greco a Costantinopoli. Vi si oppone Venezia e ne vien nuova guerra, finita colla rotta dei Genovesi nelle acque di Trapani.
Una fiera rivincita prese Genova a Curzola, quando, sotto il comando di Lamba Doria, un minor numero di galee vinse i Veneti condotti da Andrea Dandolo. Il Doria trasse seco a Genova 5000 prigioni. Marco Polo fra questi. Lo sfortunato ammiraglio di Venezia die' di cozzo nell'albero della sua nave e morì....
Ma a che oggi riandare la serie di questi gloriosi delitti? Nel camposanto di Pisa, in quella dimora di morti, dove palpita tanta parte di storia italiana, stanno appese, non già trofeo di ire fraterne, ma segno perenne di fraterno affetto le catene del porto di Pisa, dai Genovesi prese e donate ai Fiorentini. Nell'affetto sereno della patria unificata, Firenze e Genova vollero restituite a Pisa quelle catene, come augurio d'invitta concordia fra le città italiane, pegno e segnacolo di un'êra novella.
Ora una luce irradiano quei torbidi ricordi di storia italiana, luce di fraternità e di pace.