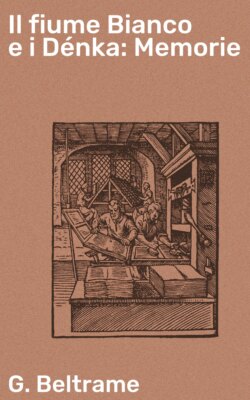Читать книгу Il fiume Bianco e i Dénka: Memorie - G. Beltrame - Страница 6
III.
ОглавлениеCaratteristiche della razza negra — Il paese dei Scìluk — I cani — Odio contro i Turchi — Raffronti della lingua dei Dénka con quella dei Scìluk.
Il viaggiatore che parte dal Cairo e si dirige, rimontando il Nilo, verso il sud, traversa successivamente l'Egitto, la Nubia, il Sènnaar; e a misura ch'egli s'avvicina all'equatore vede cangiarsi intorno a sè il teatro delle creazioni di natura.
Arrivato però a Chartùm (15°, 37′), s'egli continua il suo cammino lunghesso il fiume Azzurro sino a Fazòql, e quindi segue il Tómat fin quasi alle sue sorgenti, si troverà finalmente in mezzo alle tribù nere dei Bèrta, e crederà così d'aver veduto concatenarsi l'Egiziano aborigene col crespo Etiope per una gradazione insensibile di colore, che non gli permetterà di segnare il punto ove finisce l'uomo bianco ed ove incomincia il nero.
Che se dalla città di Chartùm veleggia pel fiume Bianco verso il mezzodì, egli distinguerà facilmente dall'Arabo giallognolo o bruno i negri Dénka della penisola del Sènnaar, che dal 12º grado si estendono fino al 9º di lat., e i negri Scìluk, posti agli stessi paralleli, a sinistra del fiume.
Ma i Bèrta, i Dénka, i Scìluk, i quali tutti hanno la pelle nera, ci presentano forse tutti il tipo del vero Negro, del crespo Etiope?
Il color della pelle, che cade subito sott'occhio, non può essere trascurato da un osservatore superficiale. Le differenze di forme potranno sfuggirgli, ma non quelle di colore, le quali saranno per lui base d'una classificazione grossolana.
Il naturalista al contrario poco o niun caso fa del colore, il quale talora non serve nè manco a distinguere le varietà d'una medesima specie; e altrettanto dicasi delle tinte dei fiori e delle foglie nelle piante, dei peli e dei capelli negli uomini. La materia colorante, la sostanza, (il pigmentum), che sta nelle cellule dello strato mucoso dell'epidermide, si sviluppa e si condensa sotto l'influenza di alcune circostanze, fuori delle quali sparisce o vi si mostra appena. Quindi è che l'Arabo giallognolo dell' Heggiàs si fa bianco in Algeri e in Aleppo, e bruno nel Sènnaar e sulle rive del Senegàl. Il corpo umano trasportato da una in un'altra latitudine, vi perderebbe la vita se non si producessero in lui delle modificazioni. Sotto una temperatura elevata, un'aria secca, un vento rapido, la traspirazione sarebbe eccessiva se la pelle non fosse resa assai meno porosa e quasi impermeabile a certi fluidi, che sono i veicoli stessi della vita. Una pelle densa e rugosa sottrae il corpo dall'azione troppo brusca delle variazioni atmosferiche; lo preserva da congestioni cerebrali e da colpi di sole; lo ripara dal freddo, imperciocchè arresta l'irradiazione e la dispersione del calore del sangue: sicchè la pelle dei Negri è al tatto meno calda della nostra, e li protegge come protegge noi il vestito.
Questa pelle densa però non presenta presso tutti gli Africani le medesime tinte di colore. Ma egli è certo che fra i popoli più barbari del centro dell'Africa la pelle offre una tinta assai nera, o s'avvicina a quella della fuliggine, pelle dura, rugosa, la quale facilmente si screpola. Presso i Negri del Sudàn le unghie sono bianche o, dirò meglio, sembrano tali, e talvolta sono leggermente colorite, e tal'altra hanno un color rosa.
Non si creda però che la pelle abbia lo stesso colore in tutte le parti del corpo. Ov'essa è più densa ha un colore più oscuro, come sui ginocchi, sul gomito, sulle tempie ecc.
La pianta del piede però, la palma della mano, la pelle posteriore al ginocchio sono le parti meno oscure.
Il sudore dei Negri, che in generale è poco abbondante, manda un odore acuto, acre, spiacevolissimo. Quindi non deve far meraviglia se le bestie feroci attaccano i Negri a preferenza dei Bianchi. Il loro fiuto annunzia assai più facilmente l'avvicinarsi dei primi che non quello dei secondi.
Se non che non è la pelle, come già dissi, che noi dobbiamo interrogare per conoscere le differenze reali che passano tra l'una e l'altra razza.
La fisonomia del Negro puro è talmente caratteristica, che è impossibile, anche a chi non sia molto addentro in questi studi, non riconoscerla a prima vista, quando pure l'individuo avesse la pelle bianca. Le sue labbra sporgenti, la fronte bassa, i denti in fuori, i capelli corti, lanosi, semiricciuti, la barba rada, il cranio depresso, il naso largo e schiacciato, il mento fuggente, le mascelle salienti, gli occhi rotondi, le orecchie grandi, le braccia lunghe e gracili, le gambe arcuate con polpaccio piccolo, i ginocchi semipiegati, i piedi lunghi e piatti col tallone sporgente all'indietro, lo sterno tondeggiante, il corpo un po' curvo all'innanzi e il portamento stanco, gli danno un aspetto speciale fra tutte le altre razze umane.
La Negra sovente raccoglie da terra degli oggetti, senza punto piegare le gambe; chinando il corpo tutto d'un pezzo, a partir dal bacino, ella prende colla mano ciò ch'ella desidera. Una donna bianca a grande stento potrebbe imitare tale movimento.
Ciò premesso, i Bèrta, quantunque la loro pelle sia nerissima, non ci presentano il tipo del vero Negro[5], mentre invece sono veri Negri i Dénka e i Scìluk. Dei Bèrta ho già parlato in un altro mio lavoro, ove scrissi pur qualche cosa dei Dénka, dei quali però molto ancora mi resta a dire, che dirò più tardi quando mi toccherà di parlare delle tribù Dénka del Nilo superiore. Or qui non farò che trascrivere alcune note, le quali trovo sparse qua e là ne' miei vecchi giornali di viaggio risguardanti i Negri scìluk e il loro paese.
Il paese dei Scìluk, che conta dai 15 ai 20 mila, abitanti, dal 12º grado si estende lungo la riva sinistra del fiume fin quasi al 9º di lat. settentrionale, mentre non oltrepassa un quarto di grado in longitudine, partendo dalla riva verso occidente. Esso in generale è fertilissimo; l'estremità sud-ovest però è assai paludosa, e sabbiosa è quella a nord.
Nelle vicine boscaglie più che altrove crescono i tamarindi, e moltissime piante, che gli Arabi chiamano Àmbag[6] (Aedemone mirabilis), e verdeggianti nàbak (Rhàmnus Nabèca, secondo Forskal,) adornano ambedue le rive.
Nei luoghi paludosi cresce naturalmente il riso rosso selvatico, e dopo il 10º grado, rimontando il fiume, s'incontrano boscaglie di palme delèb (Borassus Aethiopum) e di palme dóm.
I Scìluk coltivano con amore il sesàme, il mais bianco (dùrah), piccoli fagiuoli e tabacco. Non parlo degli animali selvaggi, dell'ippopotamo, del coccodrillo, degli animali domestici, poichè son quegli stessi che si trovano nella valle del fiume Azzurro, e dei quali già dissi qualche cosa nel mio lavoro «Il Sènnaar e lo Sciangàllah.» Non voglio tacere però che fra gli uccelli si mostrano qui più frequenti le anitre, i pellicani, le folaghe (anas aegiptiaca, anas gambensis, anas melanotos, anas plotus vaillantii, pelecanus rufescens, sterna leucoptera, fulica atra ecc.); quindi le gru (grus pavoninus, anatamus camelligerus); le ibi, tra le quali la religiosa; le ardee (ardea atricollis, ardea minuta, ardea purpurea).
Vidi fra i Scìluk una bellissima razza di cani. Il fondo della loro pelle è grigiastro e screziato qua e là di macchie oscure. Essi hanno forme eleganti; somigliano a' nostri levrieri, ma sono più piccoli. Non saprei per qual sentimento, i Scìluk gli amano e li proteggono.... sarà forse per solo interesse, poichè i cani guardano nella notte i loro bestiami. Avvicinandosi qualche fiera alle zerìbeh (ricinti), ove trovasi raccolto il bestiame, essi mettono urli, latrati e guaiti da lacerare le orecchie ad un sordo; i Negri gridano l'allarme, aizzano i cani; questi uniti in frotta s'avventano contro le fiere, e se non possono raggiungerle le inseguono rabbiosamente fino a una certa distanza; qualche volta però piombano loro addosso, e allora ne segue una battaglia feroce, un sottosopra da non poter farsene idea. Le fiere possono rimaner vinte; ma più spesso ci perdono i cani. Qualcheduno nel mattino non si vede più a comparire; qualche altro è là sul terreno disteso vittima della mischia; questi grondano sangue, quelli han rotte le gambe o lacerate le orecchie. Poveri cani!.... e non meriterebbero d'aver dei padroni che gli amassero e li proteggessero un po' meglio di quel che non facciano i Scìluk? Ma essi invece sono abbandonati, vagabondi, senza nome, senza una capanna che li ricoveri, senza leggi. Sono tutti nel deserto, vi si scavano delle piccole tane, vi dormono, vi mangiano, vi nascono, vi allattano i piccini e vi muoiono. Tutto l'amore che i Scìluk hanno per loro si riduce a non maltrattarli, a non permettere che sieno maltrattati e a non lasciar loro mancare il cibo. Non ho udito mai che un cane sia divenuto rabbioso; e sì che da quelle parti i cani patiscono seti ardentissime a lungo tempo sostenute. Bisogna dire adunque che la sete ardente non sia il motivo o, dirò meglio, l'unico motivo della rabbia dei cani. Certo è ch'essa nasce spontanea nel cane, nel lupo, nella volpe, nel gatto, e che questi animali la trasmettono agl'individui della loro specie, ai quadrupedi di specie diversa, ed all'uomo; ma non s'è potuto fin qui dimostrare in che consista la disposizione di detti animali, e specialmente del cane, la quale da origine alla rabbia spontanea, nè quali sieno le circostanze o le condizioni a ciò necessarie. E supponendo pure colali condizioni, si ignorano le cause, onde sono poste in atto. Molte, a dir vero, se ne sono divisate, ma non àvvene alcuna la quale regga ad un esame profondo.
I primi viaggiatori e mercanti europei che visitarono i Negri scìluk, li trovarono sospettosi, diffidenti, e per conseguenza pericolosi e crudeli. E tali divennero specialmente dopo la spedizione egiziana in Nubia (1821), del cui passaggio si risentirono tanto, mentre essa era diretta verso il fiume Sóbat, e nel suo ritorno a Scèndi. Ma il loro odio contro i Bianchi, ch'essi credevano tutti Turchi, crebbe assai più allorquando, un anno dopo, intesero la disumana strage di Scèndi, per la quale si volle in qualche modo vendicata la morte d'Ismail-Pascià[7]; odio che il monarca e i vecchi del paese non tralasciarono mai d'istillare nel cuore dei giovani, allo scopo di renderli avversi ad ogni relazione coi Bianchi. Fin d'allora i Scìluk ebbero in fondo all'anima il vago sentimento d'una forza aggressiva, crescente, minacciosa de' popoli bianchi, dalla quale temevano o presto o tardi d'essere schiacciati. E quando gli Europei dopo alcuni anni tentarono di metter piede fra loro per recar doni al Capo supremo, in apparenza, ma in realtà, pensavan essi, per vedere, scrutare, fiutare, corrompere e spiare così il terreno per farne una conquista; quando furono veduti con taccuini in mano, con cannocchiali, con istrumenti misteriosi ficcarsi da per tutto, notar tutto, misurar tutto, voler saper tutto.... tanto più crebbero i sospetti ed i timori d'un'invasione, e immaginavano questa invasione accompagnata da tutti gli orrori dell'odio e della vendetta, persuasi com'erano che i Bianchi nutrissero contro di loro gli stessi sentimenti, ch'essi nutrivano contro i Bianchi. Ma a poco a poco i Scìluk cominciarono a distinguere i Turchi dagli altri Bianchi europei ed a comprendere che questi non avevano mire ostili, e che tutt'al più attendevano al solo commercio.
La prima volta ch'io vidi i Scìluk fu nel 1858, allo spuntar dell'alba del 28 gennaio. Ero coi miei compagni e col missionario Matteo Kirchner, che fu poi degno successore del defunto Provicario Ignazio Knoblecher, quando la dahabìah (gran barca) della Missione, carica delle provvisioni di un anno per le due stazioni di Santa Croce, nella tribù dei Kic fra il 6º e il 7º lat. N., e di Kondókoro, nella tribù dei Bàri tra il 4º e il 5º grado, arrenò in un banco di sabbia presso la sponda sinistra, ov'erano attendati provvisoriamente alcuni Negri scìluk pescatori colle loro famiglie. I nostri barcaiuoli fecero tutti gli sforzi per disimpacciarla, ma inutilmente. Dovemmo aspettare il chiaro giorno, ed invitare que' Negri che venissero in nostro soccorso, promettendo loro un bel regalo in perline di vetro che essi amano tanto. Ma non ci fu verso di persuaderli a venire fin quasi al mezzodì; essi non si fidavano della nostra lealtà; ci credevano Turchi. Allora uno dei nostri barcaiuoli, di nome Mahàmmed-Chèr, saltò in acqua e s'avvicinò alla sponda mostrando loro alcune file di perline di vetro delle più belle che avevamo per adescarli, assicurandoli nello stesso tempo che i Bianchi che si trovavano nella gran barca non eran Turchi, e che perciò non temessero di nulla. Capitarono quindi sopra una mal connessa barchetta circa dodici Scìluk, e giunti alla distanza d'una decina di passi da noi, s'arrestarono, ci squadrarono ben bene, si scambiarono a bassa voce alcune parole, vollero vedere la quantità de' regali che noi avremmo data; fecero poi sforzi incredibili, insieme coi nostri barcaiuoli, per cavare la barca dall'arena, ma non riuscirono nè manco a smoverla. Noi demmo loro il regalo convenuto e li pregammo d'indurre anche i loro compagni, che ci stavano osservando dalla riva, perchè venissero a prestarci assistenza, facendo loro nuove promesse. Accorsero allora su quattro o cinque barchette tutti i Scìluk pescatori che colà si trovavano e che saranno stati intorno a trenta, muniti di lancia, lasciando sole le donne con i bambini. A dir vero noi temevamo questi liberatori, che alzando la voce pretendevano vedere quali e quante perline avremmo loro date; e vedutele ce le presero fuor di mano quasi colla forza; lanciando poi grida selvagge cominciarono a spingere la dahabìah verso il corso d'acqua navigabile; ma non appena essa fu smossa, le donne dalla riva, agitando le braccia e mettendo acutissimi strilli, incitavano i loro mariti a fuggire. Questi saltarono tosto nelle loro piroghe e in pochi istanti guadagnarono la sponda, negandoci ogni ulteriore soccorso e dicendo che noi eravamo Turchi. Stemmo lì fermi fino al giorno seguente; i Negri durante la notte erano già scomparsi; che cosa fare?... Noi credemmo miglior partito di alleggerire la dahabìah delle casse più pesanti, improvvisando alla meglio una zattera coi remi e con altro per adagiarvele; quindi tentammo a tutto fiato di smuoverla, ma indarno; calammo allora altra roba sulla zattera; e finalmente alle due pomeridiane, la Dio mercè, siamo usciti dal difficile passo e ci rimettemmo sul buon canale. I barcaiuoli ricaricarono con gran fatica ogni cosa, e alle ore cinque e mezza partimmo col vento in poppa.
Nell'anno 1860 io tornai a visitare i Scìluk e li trovai trattabili e pieni di fiducia specialmente verso gli Europei non Turchi, ch'essi sapevano distinguere assai bene.
In questa occasione io ebbi la fortuna di parlare più volte con un Capo di questi Negri, il quale oltre la propria lingua e quella dei Dénka parlava speditamente anche l'araba, essendo egli stato schiavo per alcuni anni nella casa di un Turco, alla morte del quale potè ricuperare la libertà che aveva perduta fin da tenero giovinetto.
Da questo Capo io raccolsi principalmente quanto sto scrivendo sui Negri scìluk, ed ho ragione di credere che tutto ciò che mi disse sia vero, perchè è conforme a quello che udii ripetere da qualche Arabo, il quale da lungo tempo trattava con questi Negri, ed a ciò ch'io stesso ho potuto osservare.
Ho detto altrove che i Scìluk, come i Nuèr, non sono compresi nel novero dei veri Dénka (Gièn), dai quali vengono considerati come antichi invasori delle loro terre; e di fatto essi fanno uso di un'altra lingua, sebbene intendano e parlino pure quella dei Dénka[8].
Io volli notare alcune parole della lingua propria dei Scìluk, per indagare a quale altra razza potessero appartenere, e dedurne così la provenienza.
Ecco le poche parole ch'io trascrivo quali trovo segnate sul mio giornale di viaggio, a fronte delle quali porrò quelle della lingua dénka, per conoscerne e valutarne il divario.
| Nomi scìluk | Nomi dénka |
| Dio — Kuàe | Dio — Dèn-did (pioggia grande) |
| Uomo — Giâló, Dâno | Uomo — Ran, Móg |
| Donna — Dakóu | Donna — Tík |
| Fanciullo — Dèn | Fanciullo — Mèvt, Uén |
| Fanciulla — Gñàn | Fanciulla — Gñà |
| Cielo — Màl | Cielo — Vniàl |
| Terra — Figñ | Terra — Pigñ |
| Acqua — Fíu | Acqua — Píu |
| Fuoco — Màg | Fuoco — Màg |
| Vento — Rùde | Vento — Ióm |
| Pane — Bièl | Pane — Kuín |
| Albero — Tàu | Albero — Tim |
| Frutto — Gñuèl | Frutto — Tàu (l'a quasi o) |
| Casa — Uàt (l'a quasi o) | Casa — G¨ùt |
| Barca — Jái | Barca — Rièi |
| Stella — Kièlo | Stella — Kuél |
| Tabacco — Tàbo | Tabacco — Tàb |
| Pipa — Dak | Pipa — Tógñ-e-tàb (vaso del tabacco) |
| Bestia — Diàn | Bestia — Lái |
| Lancia — Ton | Lancia — Tòn |
| Pronomi personali | |
| Scìluk | Dénka |
| Io — janèn | Io — g¨èn |
| Tu — jin | Tu — jín |
| Egli, Ella — ñġatì | Egli, Ella — jèn |
| Noi — Uèn (l'e quasi o) | Noi — òg¨ |
| Voi — Un | Voi — uék |
| Eglino, Elleno — Ġi (ġ dura) | Eglino, Elleno — kék |
| Tutti — Ġebène (ġ dura) | Tutti — ké-vdia, rór-e-bèn (Tutti gli uomini) |
| Addiettivi indicativi numerali cardinali | |
| Scìluk | Dénka |
| 1 — dièl | 1 — tók |
| 2 — ariòu | 2 — ròu |
| 3 — adèk | 3 — diàk |
| 4 — añġuèn | 4 — ñġuàn |
| 5 — abìġ | 5 — vdiéc |
| 6 — abik-ièl | 6 — vde-tèm |
| 7 — abi-riòu | 7 — vde-ròu |
| 8 — abi-dèk | 8 — bêd |
| 9 — abi-ñġuèn | 9 — vde-ñġuàn |
| 10 — fiàr | 10 — vtiár |
| 11 — fiàr ógiàk-ièl | 11 — vtiár-ko-tók |
| 12 — fiàr ógià-riòu | 12 — vtiár-ko-ròu |
| 13 — fiàr ógià-dèk | 13 — vtiár-ko-diàk |
| 14 — fiàr ógià-ñġuèn | 14 — vtiár-ko-ñġuàn |
| 15 — fiàr ógià-biġ | 15 — vtiár-ko-vdiéc |
| 16 — fiàr ógià abik-ièl | 16 — vtiár ko-vde-tèm |
| 17 — fiàr ógià abi-riòu | 17 — vtiár-ko-vde-ròu |
| 18 — fiàr ógià abi-dèk | 18 — vtiár ko-bèd |
| 19 — fiàr ógià abi-ñġuèn | 19 — vtiár ko-vde-ñġuàn |
| 20 — fiàr-riòu | 20 — vtiár ròu |
| 21 — fiàr-riòu ógiàk-ièl | 21 — vtiár ròu ko-tók |
| 22 — fiàr-riòu ógià-riòu | 22 — vtiár ròu ko-ròu |
| 30 — fiàr-dèk | 30 — vtiár diàk |
| 40 — fiàr-ñġuèn | 40 — vtiár ñġuàn |
| 50 — fiàr-abìġ | 50 — vtiár vdiéc |
| 60 — fiàr-abìk-ièl | 60 — vtiár vde-tèm |
| 70 — fiàr-abì-riòu | 70 — vtiár vde-ròu |
| 80 — fiàr-abì-dèk | 80 — vtiár bèd |
| 90 — fiàr-abì-ñġuèn | 90 — vtiár vde-ñġuàn |
| 100 — fiàr fiàr | 100 — buòt |
| Addiettivi indicativi possessivi | |||
| Scìluk | Dénka | ||
| mio | ġià (ġ dura) | mio | kedià |
| mia | mia | ||
| tuo | ġiìn (ġ dura) | tuo | kedù |
| tua | tua | ||
| suo | ġiì (ġ dura) | suo | kedè |
| sua | sua | ||
| nostro | miuón | nostro | kedà |
| nostra | nostra | ||
| vostro | miubèn | vostro | kedún |
| vostra | vostra | ||
| loro | ġitinaciá | loro | kedèn |
Basta, io credo, questo brevissimo saggio per iscorgere chiaramente che la lingua propria dei Scìluk è bensì diversa da quella dei Dénka, ma presenta press'a poco la stessa fisonomia, e che quindi i Negri che parlano questa lingua debbono appartenere alla medesima razza. Si vuole che i Scìluk sieno provenienti dal sud-ovest.