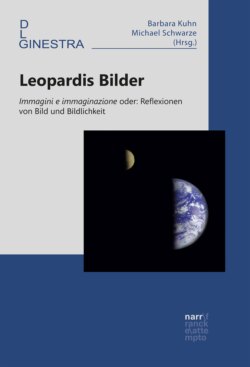Читать книгу Leopardis Bilder - Группа авторов - Страница 7
L’infinito
Оглавлениеe la poetica dell’immaginazione dopo Burke
Silvia Contarini
È possibile tentare una genealogia de L’infinito sullo sfondo delle teorie dell’immaginazione nel cosiddetto Tournant des Lumières, ossia quando le concezioni della fantasia di derivazione cartesiana e lockiana hanno oramai lasciato il posto a un’estetica e a una poetica dell’immagine di matrice antropologica? La questione non è di poco conto, se è vero che ancora di recente, dopo la significativa stagione di studi che fa capo a Jean Erhard, Robert Mauzi, Roland Mortier, Jean Deprun, Jean Starobinski e Michel Delon (per citare solo i nomi più noti), si è sentito il bisogno di tornare a interrogarsi sul rapporto fra l’immaginario letterario del primo Ottocento e la tradizione medica e filosofica del vitalismo ma l’esplorazione di tutte le filiere di indagine sembra lungi dall’essere completa.1 Muovendo da un punto di partenza provvisorio, si può tuttavia concordare sul fatto che se nel corso del Settecento l’affermazione crescente del vitalismo non riesce a incrinare l’orizzonte meccanicistico dei Lumi – l’esempio emblematico sono i Pleasures of Imagination di Addison -, viceversa all’inizio del nuovo secolo il dibattito filosofico sull’immaginazione, la memoria e il sogno, avviato da Cabanis, Destutt De Tracy e Bonstetten, giunge ad attribuire uno statuto autonomo a facoltà che non vengono più intese come un’eco più o meno precisa delle sensazioni, ma come il prodotto creativo di un dinamismo interno indipendente, espressione di una sensibilità soggettiva in grado di istituire nuove relazioni fra l’io e il mondo.2
Bisogna subito chiarire che non si tratta tanto, nel caso di Leopardi, di verificare improbabili rapporti di filiazione fra il poeta de L’infinito e il pensiero degli Idéologues (che lascia invece probabilmente tracce significative, ancora suscettibili di approfondimenti, nell’itinerario psicologico del romanzo manzoniano, avviato quasi negli stessi anni degli Idilli), quanto di interrogarsi sull’esistenza di una poetica autonoma dell’immaginazione in questa fase del pensiero critico leopardiano, già debitore della «contextation vitaliste»3 di Helvétius e di Rousseau. E di verificare, in seconda battuta, se e in che misura tale poetica possa essere messa in rapporto con l’estetica di Burke, che uno studioso del sublime come Lyotard ha definito proprio in termini di «réalisme vitaliste»4.
Non c’è dubbio che sia le riflessioni dello Zibaldone, che gli esperimenti lirici del periodo documentino in parallelo la ricerca di una diversa espressività nella forma insieme antica e nuova dell’idillio, la quale si può leggere anche come il tentativo da parte della letteratura di cogliere il dinamismo del vivente, la sua parvenza effimera, attraverso una modalità che fa appello non solo al presente confuso della sensazione, ma al suo recupero memoriale nella scrittura. Torneremo più avanti su questo punto decisivo, per ora importa soprattutto ribadire la frequenza con cui, negli anni che ci interessano, le pagine dello Zibaldone ritornano sul problema dell’immaginazione, in rapporto al ruolo determinante della poesia nell’epoca della modernità e della ragione sterile. Il dialogo a distanza che Leopardi intrattiene con uno degli interlocutori più raffinati dell’avverso schieramento romantico, Ludovico Di Breme, si interroga più volte sulle idee di patetico e di sentimentale nei termini derivati dal vitalismo («quello che i francesi chiamano sensibilité e noi potremmo chiamare sensitività», Zib. 155), ovvero, come ha insegnato Jean Starobinski, di azione e reazione.6 Constatando l’allontanamento degli scrittori moderni dalla «nuda natura», ovvero da «quei semplici, innocenti oggetti, che per loro propria forza inconsapevoli» agiscono sull’animo umano producendone effetti sublimi («quell’albero, quell’uccello, quel canto, quell’edifizio, quella selva, quel monte», Zib. 15), alla quale hanno sostituito un’analisi minuziosa dell’interiorità che spegne ogni slancio poetico, Leopardi così commenta:
non si avvedono che appunto questo grand’ideale dei tempi nostri, questo conoscere così intimamente il cuor nostro, questo analizzarne, prevederne, distinguerne ad uno ad uno tutti i più minuti affetti, quest’arte insomma psicologica, distrugge l’illusione senza cui non ci sarà poesia in sempiterno, distrugge la grandezza d’animo e delle azioni. (Zib. 16sq.)
Dal punto di vista di Leopardi, l’«eccitamento del patetico» nel quale consiste «la somma arte del poeta» non può derivare né dall’osservazione minuta della realtà né dalla pratica artificiale dell’analyse interiore, praticata da «tutti quanti i romantici e i Chateaubriandisti», bensì, al contrario, dalla restituzione autonoma, attraverso le operazioni di una scrittura sublime, di quell’epifania sentimentale presa in considerazione anche dal Breme nel testo dello «Spettatore» da cui muove l’appunto dello Zibaldone: «la campana del luogo natio», «la vista d’una campagna», o «d’una torre diroccata» (Zib. 15). Allo scandaglio dell’anima, che produce gli eccessi artificiosi di Byron (autore, come osserva Leopardi in un altro luogo del suo giornale critico, di una poesia «caldissima» ma viziata da un eccessivo intellettualismo che la trasforma in «un trattato oscurissimo di psicologia» (Zib. 204), Leopardi oppone insomma la «profondità» indistinta e potente del sentimento, suscitato nei «cuori sensitivi» per mezzo «dell’impressione che fa sui sensi qualche cosa della natura» (Zib. 15). Non so fino a che punto l’argomentazione filosofica dello Zibaldone, che a ben vedere si serve della grammatica medica del vitalismo, possa essere messa in rapporto, dal punto di vista stilistico, con il rifiuto della figuralità metaforica cara ai Romantici di cui ha parlato Mengaldo per l’esperimento poetico dei Canti;7 certo è che qualche pagina dopo, ritornando sull’argomento, Leopardi aggiunge una postilla significativa al discorso, sempre in direzione di un effetto sublime per così dire naturale, che non può più essere, per definizione, quello degli antichi:
Spesso ho notato negli scritti de’ moderni psicologi che in molti effetti e fenomeni del cuore ec. umano, nell’analizzarli che fanno e mostrarne le cagioni, si fermano molto più presto del fine a cui potrebbero arrivare, assegnandone certe ragioni particolari solamente, e questo perché vogliono farli parere maravigliosi, come il Saint-Pierre negli studi della natura lo Chateaubriand ec. E non vanno alla prima o quasi prima cagione che troverebbero semplice e in piena corrispondenza col resto del sistema di nostra natura. (Zib. 53)
A questo stadio della riflessione leopardiana, l’immaginazione è ancora «il primo fonte della felicità umana» (Zib. 168). Sebbene indebolita rispetto all’afflato potente degli antichi e dei fanciulli, che conservano vichianamente la spontaneità delle origini, essa è in grado di manifestarsi nel lievito di una poesia che recupera il rapporto immediato benché transitorio con la natura, in modi forse più vicini alla descrizione rousseauiana del sentiment de l’existence8 che ai piaceri dell’immaginazione di tradizione inglese. Del resto già Beccaria aveva mostrato a metà degli anni Sessanta come la formula vulgata di Addison potesse agevolmente convertirsi nell’operazione intensa della rêverie disincantata, sulla scorta dell’articolo Délicieux dell’Encyclopédie a firma di Diderot. Così I Piaceri dell’immaginazione, pubblicati nel 1765 nel foglio VII de Il Caffè, avevano delineato la figura epicurea del «beato contemplativo», lontano dagli artifici rituali del mondo e dal tumulto degli affetti.
Gli uomini corrono ansanti, si urtano, si sterminano tra di loro per rubbarsi scambievolmente i pochi fisici piaceri sparsi qua e là nel deserto dell’umana vita, ma i piaceri d’immaginazione si acquistano senza pericolo […]. Volgi gli occhi agli innumerabili ed immensi globi gettati dal Grand’Essere nell’immensità dello spazio, a quei torrenti di luce, a quello spirito di vita che circola nell’universo, e trovandoti or colosso, or atomo, ti riderai egualmente di chi sopra tutto e di chi nulla s’aprezza. Lascia gli uomini combattere, sperare e morire; […] riposa mollemente in quella illuminata indifferenza delle umane cose, che non ti tolga il piacere vivissimo di essere giusto e benefico, ma ti risparmia gl’inutili affanni e le tormentose vicende di bene e di male che sbalzano continuamente gli uomini inaveduti, cioè la maggior parte.9
Ascoltiamo allora, per antitesi, la riflessione di Leopardi datata 23 agosto 1821, dove risuona una consapevolezza storica e temporale del tutto diversa, che già prelude alla metafora notissima del mondo come «jardin des souffrances»:
Ma la natura, e le cose inanimate sono sempre le stesse. Non parlano all’uomo come prima; la scienza e l’esperienza coprono la loro voce: ma pur nella solitudine, in mezzo alle delizie della campagna, l’uomo stanco del mondo, dopo un certo tempo, può tornare in relazione con loro benché assai meno stretta e costante e sicura […]. Ecco un certo risorgimento dell’immaginazione, che nasce dal dimenticare che l’uomo fa le piccolezze della natura, conosciute da lui colla scienza; laddove le piccolezze e le malvagità degli uomini, cioè de’ suoi simili, non è quasi possibile che le dimentichi. Egli stesso assai mutato da quel di prima, e conosciuto da lui assai più intimamente di prima, egli stesso da cui non si può allontanare né separare, servirebbe a richiamargli l’idea della miseria, della vanità, della tristizia umana. (Zib. 1550sq.)
Dentro questa tonalità esistenziale, che ha preso le distanze anche storicamente dall’ottimismo dei Lumi, la considerazione dei rapporti fra il particolare e il generale, il determinato e l’indeterminato, dà origine nello Zibaldone a tutta una serie di osservazioni che introducono già la sintassi de L’infinito, tanto che questi appunti sparsi si presentano a tutti gli effetti come un autocommento al testo poetico, fino al pensiero riassuntivo del principio di agosto del ’21, che tuttavia non sembra tanto una conclusione del discorso, quanto un suo continuo rilancio entro la tematica più vasta del sublime, ripresa e approfondita nelle pagine che seguono in termini su cui dovremo tornare, per le analogie profonde con le estetiche psicofisiologiche del Tournant des Lumières, in primo luogo l’Enquiry in to the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful di Burke:
Circa le sensazioni che piacciono pel solo indefinito puoi vedere il mio idillio sull’infinito, e richiamar l’idea di una campagna arditamente declive in guisa che la vista in certa lontananza non arrivi alla valle; e quella di un filare d’alberi, la cui fine si perda di vista, o per la lunghezza del filare, o perch’esso pure sia posto in declivio ec. ec. Una fabbrica o una torre ec. Veduta in modo che ella paia innalzarsi sola sopra l’orizzonte, e questo non si veda, produce un contrasto efficacissimo e sublimissimo tra il finito e l’indefinito […]. (Zib. 1430sq.)
In queste rapide annotazioni, l’epifania della natura, frutto delle operazioni dell’immaginazione e della memoria («gran parte delle immagini e delle sensazioni indefinite che noi proviamo pure dopo la fanciullezza e nel resto della vita, non sono altro che una rimembranza della fanciullezza, si riferiscono a lei, dipendono e derivano da lei, sono come un influsso e una conseguenza di lei», Zib. 515) muove dall’idea di una privazione rispetto alla realtà dei sensi e in particolare della vista («il non veder tutto, e il poter perciò spaziare coll’immaginazione», Zib. 1745):
Alle volte l’anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell’infinito, perchè allora in luogo della vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse da per tutto, perchè il reale escluderebbe l’immaginario. Quindi il piacere ch’io provava sempre da fanciullo, e anche ora nel vedere il cielo ec. Attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come la chiamano. Al contrario la vastità e la molteplicità delle sensazioni diletta moltissimo l’anima. Ne deducono ch’ella è nata per il grande ec. Non è questa la ragione. Ma proviene da ciò, che la molteplicità delle sensazioni, confonde l’anima, gl’impedisce di vedere i confini di ciascheduna, toglie l’esaurimento subitaneo del piacere, la fa errare d’un piacere in un altro senza poterne approfondare nessuno, e quindi si rassomiglia in certo modo a un piacere infinito. (Zib. 171sq.)
Gilberto Lonardi ha colto in tale manifestarsi della poesia «per lampi o per barlumi e frammenti»10, più volte oggetto dell’attenzione di Leopardi, un riflesso della poetica longiniana del sublime. Tuttavia si potrebbe osservare, da un altro punto di vista, che l’idea di una immaginazione dominante, frutto di associazioni rapsodiche, interiori e soggettive, appartiene di diritto anche alla tradizione più vitale del sensismo tardosettecentesco. In Rousseau, per esempio, le dinamiche interne della «rêverie solitaire», che prende forma grazie all’«asile caché» dell’Île de Saint-Pierre, raccontano l’immersione in una realtà interiore, in uno stato di effimera quanto perfetta plenitudine, estranea all’attività razionale della mente («sans prendre la peine de penser»11). Ciò che importa qui rilevare è che, come avverrà ne L’infinito, ma diversamente da quanto accade ne I piaceri de l’immaginazione di Beccaria, che pure presentano evidenti somiglianze con il passo di Rousseau per quanto riguarda la celebrazione di un «sentiment précieux de contentement et de paix»12, il momento del godimento sensoriale non esclude ma contempla quello successivo di una meditazione sulla temporalità che procede per via analogica. Il «flux et reflux des eaux» che immerge l’animo «dans une rêverie délicieuse» richiama il moto perenne dell’esistenza, soggetta alle leggi incessanti della materia. Un'impressione che si amplia fino a lambire la sfera psicologica:
Tout est un flux et reflux continuel sur la terre. Rien n’y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s’attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme elles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n’est plus ou préviennent l’avenir qui souvent ne doit pas être […] et comment peut-on appeler bonheur un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant, ou désirer encore quelque chose après?13
Il paragone con la meditazione di Rousseau serve a mettere in evidenza come la cornice filosofico-sensistica de L’infinito sia ancora per larga parte quella di matrice lockiana che permea la Cinquième promenade, nell’assunzione pervasiva della dinamica di repos e mouvement propria di ogni forza vitale. In Rousseau, come poi in Leopardi, l’attività dell’immaginazione rappresenta una sorta di forza intermedia fra la stasi del movimento, che prefigura la morte, e l’eccesso delle passioni, su cui si infrange la rêverie:
Sans mouvement la vie n’est que léthargie. Si le mouvement est inégal ou trop fort, il réveille; en nous rappelant aux objets environnants, il détruit le charme de la rêverie et nous arrache d’au dedans de nous pour nous remettre à l’instant sous le joug de la fortune et des hommes et nous rendre au sentiment de nos malheurs. Un silence absolu porte à la tristesse. Il offre une image de mort. Alors le secours d’une imagination riante est nécessaire et se présente assez naturellement à ceux que le ciel en a gratifié. Le mouvement qui ne vient pas du dehors se fait alors au dedans de nous.14
Nella costellazione dei testi settecenteschi dedicati al meccanismo sensibile della rêverie che opera per sottrazione o cancellazione della realtà esteriore si può ricordare forse a questo punto un altro precedente degno di figurare nella genealogia de L’infinito, anche in considerazione della sua natura intrinseca, legata alla ripresa della tematica gessneriana dell’idillio che interesserà poi, da un altro punto di vista, lo stesso Leopardi.15 Mi riferisco alle Lettere campestri di Aurelio De’ Giorgi Bertola, contemporanee alle Nuove poesie campestri e marittime presenti nella biblioteca leopardiana16 e grosso modo alla stesura delle Rêveries rousseauiane, che senz’altro contribuiscono a definire la natura tutta interiore dei piaceri dell’immaginazione nel Tournant des Lumières italiano. Nella lettera fittizia datata 23 settembre 1779, per esempio, Bertola offre la sua personale rivisitazione dei pleasures of imagination, risultato di un uso particolare dei due sensi primari, l’udito e la vista, che cooperano alla costruzione di una realtà alternativa a quella della «chiusa campagna» da cui muove la contemplazione:
Seduto su questa pietra ho ancora de’ piaceri d’immaginazione novi in una chiusa campagna. Se freme gagliardamente il mare che bagna la costiera d’Amalfi, qui se ne sente lo strepito: pensando che se mi piacesse di far il cammino della montagna, che pure fan molti, singolarmente in cerca di erbe utili e rare, o a cacciagione (e dell’une e dell’altra la montagna è ricchissima) avrei d’improvviso l’aspetto del mare, e un altro tutto peregrino orizzonte, così pensando, io m’inebbrio di un piacer vivissimo, e lascio il freno alla mia fantasia; e di mezzo a’ boschetti di cedri, ond’è lieta la costa, parmi guardar la tempesta.17
Quasi due anni dopo, nella lettera datata 20 febbraio 1781, troviamo un altro passo significativo, nel quale l’occhio, che questa volta si apre all’orizzonte «senza alcun ostacolo», introduce la figura dell’antitesi. Riletto insieme al precedente, il brano sembra quasi una sorta di anticipazione in prosa de L’infinito leopardiano: gli elementi ci sono tutti, manca solamente un respiro poetico più ampio, in grado di animare la forma ‹sentimentale› dell’idillio attraverso soluzioni retoriche e linguistiche sconosciute al Bertola, per il quale il contrasto fra il «gaio» e l’«orrido» non esce dalle sfumature del pittoresco:
L’occhio misura di là la vicina altezza del Vesuvio, indi va tutto senza alcun ostacolo signoreggiando e Napoli e i colli e i monti, e il mare e le isole. Il tratto di verdura che dal poggetto frapponesi al mare, rende il color di questo anche più risentito; e il contrasto di un luogo gradatamente si vago e ridente coll’orrido della valle sottoposta è vivissimo. [… T]alvolta ancora il mover del vento piegando il fogliame ne va tratto tratto ampliando il quadro; e talvolta osa pure interromperlo piacevolmente.18
Rispetto agli esempi fin qui ricordati, che pure testimoniano a modo loro la progressiva autonomia dell’immaginazione rispetto alla realtà esterna, grazie a una sorta di analisi della dinamica interna della sensibilità, è evidente come L’infinito muova proprio dal momento iniziale della privazione, che diviene anzi la condizione stessa della poesia. E nell’ambito frastagliato retorico delle estetiche tardosettecentesche, dove l’allusività e la reticenza vengono intese sempre più come necessarie allo sviluppo dell’immaginazione,19 l’idea di privazione non può non richiamare alla mente del lettore la prospettiva rivoluzionaria di Burke, ovvero un’idea psicofisiologica del sublime, alternativa alla tradizione classicistica divulgata da Boileau che nel corso del Settecento non cessa di esercitare la sua influenza, talora anche attraverso l’unione con le categorie di Addison. Per quanto riguarda in particolare l’Italia, il riferimento a Burke diviene poi quasi d’obbligo dopo la data canonica del 1804, quando le due traduzioni dell’Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, apparse rispettivamente a Milano e a Macerata, impongono all’attenzione dei contemporanei su un testo che fino a quel momento aveva conosciuto una diffusione assai più limitata e meno riconoscibile, per lo più attraverso la mediazione francese.20 Non è dunque un caso se Giorgio Panizza, tornando sulla filigrana tematica de L’infinito, ha richiamato l’attenzione su di un passo della recensione al trattato di Ignazio Martignoni sopra il Bello e il Sublime (uno dei primi a confrontarsi in maniera diretta con l’Enquiry), pubblicata negli «Annali di scienze e lettere» nel 1810, dove l’autore, Pietro Borsieri, aveva commentato in piena sintonia con Martignoni:
Non è perciò da negarsi al ricordato Burke che tutte le privazioni generali siano grandi: il silenzio, il vuoto, la solitudine, le tenebre, le idee di morte e di annientamento. Siffatte privazioni generali invadono l’anima di un solenne terrore, e col richiamarci dagli oggetti esterni ne dispongono a concepire i più sublimi pensieri ed affetti.21
Prima di tornare con maggiore attenzione sulle conseguenze, nell’impianto teorico dello Zibaldone e di riflesso nel tessuto della lirica leopardiana, non solo del libro di Martignoni, ma di una possibile lettura di prima mano di Burke da parte di Leopardi, vale però la pena di ricordare che sull’idea di privazione si era soffermato a lungo, da una prospettiva retorica e stilistica, anche colui che è forse uno dei primi attenti lettori dell’Enquiry in Italia, vale a dire il Beccaria delle Ricerche intorno alla natura dello stile22. Rilevando l’influenza profonda delle idee che non vengono espresse ma «semplicemente suggerite o destate nell’animo di chi legge o di chi ascolta»23, Beccaria si era appellato, sulla scorta di Burke, ai principî stessi del vitalismo: «è legge della nostra sensibilità che tutt’altra forza abbiano le idee espresse e le tacciute»24. Probabilmente sulla scorta dell’Enquiry, da cui mutuava il concetto cardine di privazione (privation nella traduzione francese che restituisce letteralmente l’originale privation) Beccaria giungeva così a teorizzare l’energia invisibile di uno stile allusivo che opera per sottrazione, attraverso la catena delle idee accessorie, le quali destano a loro volta sempre nuove associazioni attraverso il movimento interiore, soggettivo e potenzialmente infinito dell’immaginazione, sotto l’effetto del sublime e delle passioni da lui risvegliate. Da questo punto di vista, la conclusione delle Ricerche intorno alla natura dello stile si può intendere come una sorta di riscrittura delle pagine più note di Burke per ricavarne i lineamenti di una poetica moderna, in parte riconoscibile anche nella stratigrafia de L’infinito leopardiano:
Quanto più grandi e più forti saranno le idee accessorie espresse, tanto più numerose possono essere le idee tacciute, ma necessariamente destate da quelle, perchè l’efficacia delle prime tende e rinforza l’attenzione, che con più rapidi voli slanciasi ad abbracciare le idee non espresse senza pregiudicare l’interesse del tutto, e perchè espressioni più grandi e più forti fermano l’immaginazione di chi legge od ascolta […]. Chi ben considera, e ritorna sull’esperienza dell’animo suo, potrà facilmente scorgere che, sempre che un grande ed interessante oggetto fermi il pensiero e percuota l’immaginazione; questa, dopo considerato quell’oggetto, nell’atto che si riscuote e si risveglia dell’intensione nella quale trovavasi, per così dire, attuata e raccolta, non si abbandona subito all’ordinaria impressione delle cose che le stanno d’attorno, ma sebbene destasi in lei una moltitudine d’idee tutte relative non solo a quella straordinaria impressione che l’ha percossa, ma ancora alle passioni dalle quali è dominata.25
Che la riflessione di Beccaria fosse destinata a lasciare un segno, lo conferma del resto lo Zibaldone, dove Leopardi mostra di aver compreso l’importanza di un libro difficile e spesso frainteso dai contemporanei come le Ricerche intorno alla natura dello stile. All’interno di una serie di pensieri dedicati alla lingua e allo stile, troviamo un appunto rivelatore sulle risorse dell’analogia per mezzo delle idee accessorie: «Le parole, osserva il Beccaria (tratt. dello stile) non presentano la sola idea dell’oggetto significato, ma quando più quando meno immagini accessorie» (Zib. 109sq.). Qualche pagina prima, quasi sul modello esemplificativo del libro di Beccaria, affiora un’altra citazione complementare, che porta questa volta sul valore della reticenza. Leopardi trascrive il passo di un romanzo che per tanti versi rientra anch’esso nell’orbita del sublime moderno, tra Piranesi e Burke, ossia Le notti romane di Alessandro Verri: si tratta del brano «dove la Vestale dice che diede disperatamente del capo in una parete, e giacque» (Zib. 82), e l’autore dello Zibaldone, quasi sperimentando su se stesso l’effetto potente di quel vuoto grammaticale che agisce profondamente sull’immaginazione in termini fisiologici, chiosa:
la soppressione del verbo intermedio tra il battere il capo e il giacere, che è il cadere, produce un effetto sensibilissimo, facendo sentire al lettore tutta la violenza e come la scossa di quella caduta, per la mancanza di quel verbo, che par ti manchi sotto ai piedi, e che tu cada di piombo dalla prima idea nella seconda che non può esser collegata colla prima se non per quella di mezzo che ti manca. E queste sono le vere arti di dar virtù ed efficacia allo stile, e di far quasi provare quello che tu racconti. (Zib. 82, corsivo mio)
L’insistenza sull’effetto sensibile del sublime effetto di una mancanza ci riconduce dunque all’origine di questa fitta costellazione intertestuale, vale a dire al trattato di Burke, che come suggerisce il catalogo della biblioteca di Recanati Leopardi poteva aver conosciuto di prima mano, ovvero non solo attraverso la pur possibile mediazione della cultura italiana e francese, grazie alla traduzione di Carlo Ercolani pubblicata a Macerata nel 1804 dalla stamperia di Bartolomeo Capitani. Prima di quella data, che vede anche l’uscita in parallelo, a Milano, di una traduzione anonima dell’Enquiry dovuta al conte veronese Gian Giuseppe Marogna, sodale di Leopoldo Cicognara,26 per individuare la prima citazione esplicita (cursoria) dell’opera di Burke in ambito italiano si deve risalire alla Dissertazione intorno al sublime di Girolamo Prandi (1793), anche se richiami impliciti di qualche rilievo affiorano nel Discorso sull’indole del piacere e del dolore di Pietro Verri (ben noto a Leopardi che lo utilizza nel Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez), e più decisamente nelle già ricordate Riflessioni intorno alla natura dello stile di Beccaria, per tacere della probabile influenza del trattato di Burke, forse attraverso Helvétius, sull’immaginario tragico alfieriano.27 All’inizio dell’Ottocento, viceversa, l’oramai ampia ricezione dell’Enquiry, con cui si misurerà anche la critica romantica attraverso i Saggi sul Bello di Ermes Visconti (la cui prima versione inedita risulta contemporanea a L’infinito), è comprovata anche dalla nuova edizione francese del 1803 presente nella biblioteca di Alessandro Manzoni, che reca postille autografe dello scrittore,28 a segno di una lettura che nel suo caso avviene ancora attraverso il filtro d’oltralpe, sulla quale potranno ritornare con qualche utilità i commenti ai Promessi sposi.29
Per provare a definire meglio la presenza di Burke in Leopardi bisogna dunque ripartire dal testo più vicino, vale a dire dalla traduzione dell’Ercolani, quest’ultimo autore anche autore di una versione delle Lectures on Rhetoric and Belles Lettres di Blair rimasta inedita perché completata a poca distanza dalla fortunatissima traduzione del Soave uscita nel 1803 e più volte ristampata. Rispetto alla versione di Burke messa a punto dal Marogna, il lavoro traduttorio dell’Ercolani appare piuttosto preciso e tutt’altro che superficiale, grazie soprattutto alle competenze linguistiche dell’autore, interprete fedele e acuto dell’originale.30 La prima osservazione interessante, dalla nostra prospettiva, si trova proprio nelle pagine iniziali e riguarda la ridefinizione del concetto di gusto. Svincolato sia dalle posizioni normative del classicismo che dal relativismo illuministico, il Gusto viene subito messo in relazione con l’effetto del sublime, in termini non molto diversi da quelli che abbiamo visto nel brano dello Zibaldone dove Leopardi dialogava con Di Breme. Per Burke, infatti, il gusto non è altro che «quella facoltà, o quelle facoltà dell’anima» per le quali «sono tocche e commosse dall’opere dell’immaginazione o delle belle arti»31, e qualche pagina dopo troviamo un corollario sul rapporto fra l’immaginazione e la sensibilità che potrebbe figurare a buon diritto nello Zibaldone fra commenti d’autore a L’infinito: «l’immaginazione è la provincia più estesa del piacere e del dolore, siccome essa è la regione de’ nostri timori e delle nostre speranze, e di tutte le nostre passioni»32.
Di là da questa generale tonalità di fondo, immediatamente riconoscibile, sono molti i riscontri fra la versione italiana dell’Enquiry e le pagine dello Zibaldone su cui si potrebbe discutere, a cominciare dalle «idee dell’eternità e dell’infinito», secondo Burke «le più commoventi idee che noi abbiamo»33, dall'insistenza sull’indeterminato proprio della poesia, risultato di «grandi e confuse immagini», che induce il richiamo inevitabile – sopratutto per un lettore del Settecento abituato a confrontarsi con Shakespeare e con Milton, esempi per eccellenza di un sublime letterario anticlassicistico – del primo canto del Paradise Lost:
Qui si vede una pittura nobilissima; e in che consiste questa poetica pittura? Nell’immagini d’una torre, di un arcangelo, del sole nascente in mezzo alla nebbia, in un’eclisse, nella rovina de’ monarchi, e nelle rivoluzioni de’ regni. L’animo è trasportato fuori di se da una folla di grandi e confuse immagini, che lo sorprendono appunto perché sono affollate e confuse. Poiché separatele, e perderete molto della grandezza; riunitele, e perderete la chiarezza. Le immagini risvegliate dalla poesia sono sempre di questo genere oscuro […] difficilmente alcuna cosa può far colpo sul nostro spirito con la sua grandezza, se non si approssima in qualche modo all’infinito.34
Un altro luogo degno di essere preso in considerazione per i suoi sviluppi in un’ottica leopardiana è poi quello sopra le cosiddette Privazioni che aveva già attratto l’interesse di Beccaria, di Martignoni e di Borsieri,35 e che prevedibilmente lascia più di un segno negli appunti sparsi del 1821, insieme alla riflessione complementare sul potere dei suoni.36 Nel capitolo XIX del libro, intitolato al Repentino, Burke si sofferma a lungo sulle risonanze interiori di ciò che definisce «un subitaneo principio, o un’improvvisa cessazione di suono», come «i rintocchi di una gran campana, quando il silenzio della notte impedisce l’attenzione dall’esser troppo dissipata»37. All’esempio, di per sé abbastanza significativo per la sua immediata traducibilità poetica, sembra di poter collegare un commento dello Zibaldone in data 16 ottobre 1821, dove Leopardi si sofferma sugli effetti dello «stormire del vento» quando «freme confusamente in una foresta, o tra i vari oggetti di una campagna», o quando «è udito da lungi», e dunque «non si vede l’oggetto che lo produce, giacché il tuono e il vento non si vedono» (Zib. 1929).
Rispetto a quella che a prima vista si presenta come una sostanziale adesione, se non proprio come una rilettura critica dell’estetica di Burke nello Zibaldone, anche in vista di un suo riuso in poesia, l’aspetto più controverso rimane tuttavia quello che riguarda il giudizio di Leopardi sulla definizione di sublime divulgata dall’Enquiry, ovvero il rapporto con la sfera psicologica del terrore, nella quale è implicita una totale soggezione, o annientamento delle facoltà dell’anima. Ricordo qui brevemente i due passi maggiormente commentati dai censori sette-ottocenteschi di Burke:
Qualunque cosa è atta in un certo modo ad esercitare idee di dolore e di pericolo, vale a dire ciò che è in qualche modo terribile, e riguarda oggetti terribili, o opera in maniera analoga al terrore, è la sorgente del Sublime; cioè è atta a produrre la più grande commozione, perchè sono persuaso che le idee del dolore siano più potenti di quelle che vengono dalla parte del piacere.38
La passione cagionata dal grande e dal sublime della natura, quando queste cagioni operano più potentemente, è lo stupore; che è quello stato dell’anima, in cui tutti i suoi movimenti sono sospesi, con qualche grado di orrore. In questo caso lo spirito è sì pienamente occupato del suo oggetto che non può ammetterne verun altro, né per conseguenza ragionare sopra quell’oggetto che tutto l’impiega. Quindi nasce il gran potere del sublime, che lungi dall’esser prodotto dai nostri raziocinj, gli anticipa, e ci trasporta con forza invincibile.39
Si tratta, come è noto, di affermazioni spesso contestate fin dal primo apparire dell’Enquiry e lungo tutto il Tournant des Lumières, per ragioni che riguardano in primo luogo l'orizzonte fisiologico dell’estetica di Burke:40 dopo il Kant della Kritik der Urteilskraft, anche in Italia teorici e critici meno noti e tuttavia influenti del primo Ottocento, come il Visconti dei Saggi sul Bello41, rifiutano le premesse materialistiche implicite nell’idea di delight, sulla scorta delle proposte meno radicali di Blair. Lo stesso Martignoni, su cui è giunto il momento di soffermarsi, non fa eccezione, e nella parte del suo trattato dedicato al Sublime annota al riguardo:
Non saprei tuttavia circonscrivere con Burke al solo terrore gli effetti di questo eccelso sentimento, comeché non di rado esso entri nelle impressioni, che di lui vengono risvegliate. Al che per avventura egli si indusse per avere osservato, che anche la meraviglia serba un cotal carattere grave ed austero, e con un non so qual turbamento ricerca l’anima nell’atto di sollevarla sopra se stessa, e ne abbia quindi per analogia confusi gli effetti con quelli del terrore.42
Significativamente, Martignoni si preoccupa di distinguere fra l’impressione del sublime, esercitata sui sensi, e la sua rielaborazione artistica attraverso l’immaginazione creativa, che opera attraverso il sentimento della meraviglia, la cui azione ha (cartesianamente) l’effetto di «elevar l’anima e di rinvigorirla contro l’impression del terrore»43. Il risultato è una sorta di rivisitazione moderna del topos lucreziano del Suave mari magnum, ovvero del sublime come prodotto di una distanza. L’esempio chiarificatore è quello pittorico di Vernet, già oggetto dell’attenzione profonda di un altro esegeta acuto di Burke, ma assai più attrezzato, il Diderot dei Salons. Contrapponendo il terrore reale dei marinai preda della burrasca al sublime convertito in arte del pittore di marine, Martignoni osserva, in maniera quasi perentoria:
Una burrasca, la qual non è, che un oggetto di spavento e di orrore pe’ naviganti, che agghiacciano all’aspetto dell’imminente loro naufragio, era un sublime spettacolo per Vernetto, che il terrore non ne apprendeva, o il pericolo, ma l’imponenza soltanto ne scorgeva, o la maestà di così eccelsa scena.44
Viceversa, in un altro luogo del testo, e precisamente nel passo sulle Privazioni che era piaciuto al Borsieri, Martignoni sembra per un attimo contemplare una forma di immaginazione senza limiti, frutto dell’esperienza radicale del sublime inteso come «solenne e sacro terrore»:
Convengo perciò volentieri col ricordato Burke nel ritenere che tutte le privazioni generali sieno grandi, come lo sono infatti il silenzio, il vuoto, la solitudine, le tenebre, ed anche più le idee di morte e di annientamento, siccome quelle, dalle quali l’anima rifugge sbigottita. E a dir vero cotali idee invadono gli animi di un solenne e sacro terrore, il qual tanto più diviene energico, quanto che da nessun limite è frenato l’entusiasmo della commossa fantasia, e lo spirito ripiegato in se stesso tutta dispiega la sua forza creatrice.45
Se dunque perfino la sintesi conciliante proposta dal Martignoni nel suo trattato, vera e propria summa dell’estetica settecentesca nella quale Burke occupa una posizione significativa ma non assoluta, finisce quasi per confermare suo malgrado l’influenza delle posizioni più radicali dell’Enquiry attraverso l’ossimoro dello «spirito ripiegato in se stesso» che «tutta dispiega la sua forza creatrice», tanto più viene da chiedersi quale sia al riguardo la posizione di Leopardi. In altre parole, il verso finale de L’infinito («E il naufragar m’è dolce in questo mare») si deve intendere come una traduzione poetica del delight nel senso psicofisiologico di Burke, o invece si può pensare che proprio la memoria, evocata fin dall’inizio attraverso la forte cesura del primo verso («Sempre caro mi fu quest’ermo colle») sia funzionale a introdurre nel testo una dimensione temporale successiva, nella quale l’attività libera dell’immaginazione ritorna sulle idee di morte limitando alla finzione della scrittura quello che Giuseppe Sertoli, attribuendo al sublime di Burke una moderna sfumatura freudiana, ha definito il brivido dell’annientamento46? Un appunto senza data dello Zibaldone, nel quale Leopardi commenta un brano della Corinne di Mme De Staël relativo alla mancata visita dei due protagonisti alle catacombe romane, sembra autorizzare questa seconda interpretazione:
L’ame est si mal à l’aise dans ce lieu (dice la Staël delle catacombe, liv. 5 ch. 2 de la Corinne), qu’il n’en peut résulter aucun bien pour elle. L’homme est une partie de la création, il faut qu’il trouve son harmonie morale dans l’ensemble de l’univers, dans l’ordre habituel de la destinée; et de certaines exceptions violentes et rédoutables peuvent étonner de la pensée, mais effraient tellement l’imagination, que la disposition habituelle de l’ame ne saurait y gagner. Queste parole sono una solenniss. condanna degli orrori e dell’eccesso terribile tanto caro ai romantici, dal quale l’immaginazione e il sentimento in vece d’essere scosso è oppresso e schiacciato, e non trova altro partito a prendere che la fuga, cioè chiuder gli occhi della fantasia e schivar quell’immagine che tu gli presenti. (Zib. 73sq.)
Alcune pagine dopo, nel pensiero datato 4 marzo 1821, Leopardi aggiunge una lunga chiosa sull’«eccesso di sensazione» che assume quasi il valore emblematico di una risposta implicita al sistema estetico dell’Enquiry, fondato come si è visto su di una sorta di rovesciamento dei principî del vitalismo:
L’eccesso delle sensazioni o la soprabbondanza loro, si converte in insensibilità. Ella produce l’indolenza e l’inazione, anzi l’abito ancora dell’inattività negl’individui e ne’ popoli […]. Il poeta al colmo dell’entusiasmo della passione ec. non è poeta, cioè non è in grado di poetare. All’aspetto dell’infinito, mentre le idee segli affollano al pensiero, egli non è capace di distinguere, di scegliere, di afferrarne veruna; in somma non è capace di nulla, né di cavare nessun frutto dalle sue sensazioni: dico nessun frutto o di considerazione e di massima, ovvero di uso e di scrittura; di teoria né di pratica. L’infinito si può esprimere solo quando non si sente: bensì dopo sentito. […] Il sommo dolore non si sente, cioè finattanto ch’egli è sommo; ma la sua proprietà è di render l’uomo attonito, confondergli, sommergergli, oscurargli l’animo in guisa, ch’egli non conosce se stesso, né la passione che prova, né l’oggetto di essa; rimane immobile, e senza azione esteriore, né si può dire interiore. E perciò i sommi dolori non si sentono nei primi momenti, né tutti interi, ma nel successo dello spazio e de’ momenti […]. Anzi non solo il sommo dolore, ma ogni somma passione, ed anche ogni sensazione, ancorché non somma, tuttavia tanto straordinaria, e, per qualunque verso, grande, che l’animo nostro non sia capace di contenerla tutta intera simultaneamente. (Zib. 714-716)
A naturale complemento di queste riflessioni, che implicano quasi sempre delle conseguenze sul piano poetico, si può infine citare, tratto sempre dallo Zibaldone, una sorta di avantesto in prosa de L’infinito e de La sera del dì di festa (due idilli legati da una rivisitazione personalissima del topos dell’ubi sunt in chiave autobiografica) il quale documenta per così dire una prima fase della scrittura, rispetto al tempo dell’esperienza e alla sua rielaborazione poetica:
Dolor mio nel sentire a tarda notte al giorno di qualche festa il canto notturno de’ villani passeggeri. Infinità del passato che mi veniva in mente, ripensando ai Romani così caduti dopo tanto romore e ai tanti avvenimenti ora passati io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco. (Zib. 50sq.)
Mentre nello Zibaldone si percepisce ancora l’effetto pervasivo del sentimento doloroso, nel testo lirico di arrivo – L’infinito – l’attenzione si concentra tutta sull’attività dell’immaginazione che rielabora il dettaglio quotidiano, come mostra la trasformazione del «canto notturno» «de’ villani passeggeri» nel rumore indistinto della stagione «presente e viva», evocata per contrasto attraverso il paragone con il silenzio dell’eternità («le morte stagioni») interrotto dal rumore improvviso del vento tra le piante. Ma se tutto questo è vero, allora proprio l’autonomia creativa del momento poetico successivo all’esperienza dominante della passione, che Leopardi rivendica più volte nel suo giornale letterario, induce a credere che riguardo all’Enquiry Leopardi potesse implicitamente condividere, anche senza conoscerla, l’opinione di Ermes Visconti, quando nei Saggi sul Bello afferma recisamente, con un giudizio che assomiglia a un elogio funebre, che la dottrina di Burke aveva segnato un’epoca, «come la segnano per l’ordinario tutti i sistemi inventati dai grandi valentuomini, all’ingegno de’ quali è dato di compensare con molti dettagli pregevoli l’erroneità dell’insieme»47.
Di là da ogni confronto con le teorie estetiche del Tournant des Lumières, L’infinito possiede senza dubbio una coerenza testuale in sé conclusa, che le riflessioni dello Zibaldone contribuiscono a illuminare dall’interno. Tuttavia dopo quanto si è detto non sembra inutile riaprire quella sintesi della cultura estetica del Tournant des Lumières che è il trattato di Martignoni, e precisamente la sezione dedicata al Sublime artificiale, ovvero al sublime in poesia, che come provano anche i commenti dello Zibaldone alle Riflessioni intorno alla natura dello stile di Beccaria è il vero oggetto della riflessione leopardiana. Dopo aver affermato, in maniera piuttosto tradizionale, che un oggetto di per sé non sublime «può elevarvisi, qualora a renderlo illustre, e ad ingrandirlo pongansi in uso vocaboli splendidi, gravi ed armoniosi», Martignoni cerca va di chiarire le caratteristiche di un sublime di «composizione» che potremmo definire retorico, nel senso ancora di Beccaria, perchè opera secondo un processo analogico non razionale:
A ben comprendere […] come si generi una tal sorta di Sublime detto artificiale, giova il riflettere, che alle volte un oggetto per se non sublime può divenirlo col mezzo dell’associazione: conciosiaché per di lei effetto gli obbietti in guisa si agglomerino, che quasi un solo se ne formi. Lo splendore infatti d’un oggetto sublime su quello, che gli è associato, riverbera, e di sua luce lo irradia. Divien perciò sublime un obbietto, che in noi l’idea risveglj di un altro, il qual lo è realmente.48
A ben guardare il passo lascia intravedere un’idea di comparazione non riconducibile alle operazioni razionali della mente descritte da Condillac, spesso richiamate nei commenti a L’infinito in maniera forse un po’ troppo meccanica rispetto a quelle che sono le indicazioni stesse dello Zibaldone. Se infatti si può dire in linea di massima che comparare sia un «verbo tecnico della filosofia sensistica»49, bisognerebbe poi aggiungere, sulla scorta di Leopardi stesso, che lo scopo dichiarato della poesia non è il démêler, ovvero il seperare dei diversi momenti della percezione per giungere a un’idea chiara e distinta dell’insieme, quanto piuttosto l’unire di ciò che è distante attraverso il ricorso all’analogia. E da questo punto di vista, quale che sia il peso da attribuire a Martignoni nella preistoria de L’infinito, non si può negare che l’associazione del sublime descritta nelle sue pagine, fondata sulle risorse evocative dell’immaginazione, si presta a illuminare non solo quello che avviene nel sistema poetico dell’idillio, ma anche, più in generale, i modi nei quali poteva essere declinato il rapporto fra la realtà finita del quotidiano e le risorse potenzialmente infinite della natura, al fine di sottrarre la poesia al giogo di quel realismo «triviale» che secondo Leopardi costituiva il limite stesso della visione romantica della letteratura.