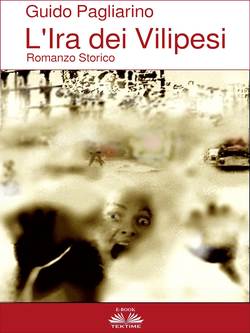Читать книгу L’ira Dei Vilipesi - Guido Pagliarino - Страница 11
ОглавлениеCapitolo 6
L'autoblindo era sbucata a passo dâuomo da via Cesare Battisti in piazza Carità .
Il drago tedesco sâera stagliato attraverso la feritoia a prua, piantato immobile a una quarantina di metri a 45 gradi alla destra del mezzo italiano: era un carro Panther dalla formidabile corazzatura di 110 millimetri, armato con un cannone da 75 e due mitragliatrici MG, una in torretta e una nel corpo dello scafo a prua, le quali fino a poco prima avevano vomitato fuoco. Sembrava quasi che il bestione stesse riposando dopo un gigantesco sforzo. Era evidente a cosa fosse stata indirizzata la sua fatica, ché a terra giacevano corpi e corpi insanguinati di civili dei due sessi e le finestre dei palazzi tuttâattorno alla piazza erano in frantumi, mentre i muri mostravano profonde sbrecciature. Si poteva capire, dalla vista d'un fuori strada Kübelwagen semidistrutto ancor fumante e di quattro cadaveri carbonizzati, uno dentro e tre a terra, che indossavano gli elmetti della Wehrmacht, divenuti neri, che la ritorsione del carro tedesco era seguita a un attacco con molotov contro la camionetta:
Al momento dell'assalto al Kübelwagen, il Panther stava perlustrando la vicina strada del Formale. Il suo equipaggio aveva udito due esplosioni, a distanza dâun paio di secondi lâuna dallâaltra, e il capo carro, un maresciallo di carriera di nome Konrad Müller, aveva capito da quale direzione fossero giunte. Su suo ordine, il mezzo sâera diretto verso piazza Carità . Quandâerano giunti, i carristi avevano trovato i resti dei loro quattro camerati e della camionetta e nessuna persona sulla piazza, ché dopo aver lanciato due bottiglie incendiarie, di cui una giunta a segno, gli attentatori erano fuggiti mentre i residenti sâerano riparati nelle case e nei negozi, serrandone i portoni e le saracinesche. Il sottufficiale aveva ordinato senza remore di mitragliare le facciate degli edifici tuttâattorno ad altezza dâuomo e, mentre le sue MG crepitavano, aveva chiesto via radio disposizioni al Comando. Gli era stato ordinato di far vendetta rastrellando civili, dieci per ogni tedesco ucciso, e fucilarli sul posto. Il caporale vice comandante del Panther e due carristi erano scesi armati di mitra MP80 e bombe a mano modello 24 e avevano lanciato queste granate contro serrande e portoni, uccidendo o ferendo chi sâera riparato dentro. Il maresciallo Müller, in uno stentato italiano, aveva ordinato per altoparlante d'uscire dalle case, ché se no tutte sarebbero state colpite coi loro residenti a colpi di cannone; aveva promesso che se gli stessi si fossero presentati ordinatamente alla sotto squadra tedesca, sarebbero stati solo interrogati e poi lasciati liberi. Erano state così adunate quarantadue persone, due in più del decuplo dei morti tedeschi. Tuttavia, nonostante il caporale avesse comunicato al capo carro, che intanto s'era affacciato dalla torretta, lâesubero di rastrellati, la misura era stata valutata consona dal superiore, nazista convinto anche se non SS, il quale aveva ordinato di âgiustiziarliâ tutti. Quei civili inermi erano stati abbattuti a raffiche di mitra. Risaliti i carnefici sul loro panzer, il maresciallo aveva comandato ai mitraglieri di riprendere a sparare tuttâattorno, stavolta mirando ai piani alti. Le raffiche terroristiche erano andate avanti per molti minuti mentre quel razzista di Konrad Müller pronunciava con odio, esprimendosi nel suo dialetto bavarese, espressioni che in italiano sarebbero suonate così: âItaliani di merda! Bastardi traditori! Razza di porci!â
Il drago d'acciaio stava per riprendere il suo pattugliamento per le vie quandâera sopraggiunto il mezzo blindato di altri italiani di merda. Questo era di molto inferiore al Panther tanto per corazzatura che per potenza di fuoco. Il maresciallo Bennato poteva solo tentare una rapida marcia indietro, nella debolissima speranza che il nemico avesse altri ordini da eseguire subito e non si buttasse allâinseguimento: aveva frenato di botto, senza bisogno di riceverne il comando, innestato la retromarcia e dato gas, mentre i sei patrioti appiedati, vedendo lâautoblindo iniziare a retrocedere, sâerano ritirati precedendola nell'arretramento. Il mezzo era però riuscito a infilarsi in via Battisti solo per una parte della lunghezza, perché il motore sâera ingolfato e spento per la manovra convulsa, e il blindato sâera fermata col muso ancor esposto al nemico.
Contrariamente alla fievole speranza italiana, invece di riprendere il pattugliamento per Napoli il comandante del Panther aveva deciso di distruggere il mezzo ribelle e aveva ordinato al cannoniere di puntare ad alzo zero contro la prua nemica.
Vittorio, intravista dalla feritoia la torretta del carro prendere a ruotare indirizzando la bocca da fuoco all'autoblindo, aveva urlato ai suoi dâabbandonare il mezzo e imboscarsi negli anditi di via Battisti e, nel dare lâordine, egli stesso sâera diretto al portello, toccando terra per primo: avrebbe poi ragionato che, dopotutto, indugiare non sarebbe servito a far uscire più in fretta gli altri; in realtà era prevalso semplicemente in lui lâistinto di conservazione.
Il colpo di cannone era rimbombato un istante dopo che il maresciallo Bennato, per ultimo, era balzato fuori. Il proietto era esploso preciso sulla parte esposta del mezzo cui il cannoniere aveva puntato. Per simpatia esplosiva era brillata anche la bomba anticarro Panzerwurfmine entro il Panzerfaust del granatiere, arma che fin a un momento prima era stata sulla sua spalla ma ch'egli aveva gettato per meglio fuggire. Il blindato italiano era stato scagliato indietro e incendiato, investendo e schiacciando i quattro patrioti più vicini, mentre fitte e grosse schegge si spandevano a raggiera devastando. Ne era rimasto ucciso il maresciallo Bennato che, colpito al collo da un rovente spezzone di lamiera, era morto sul colpo con la testa tranciata. Il granatiere era stato dilaniato dalla bomba Panzerwurfmine e dalle schegge del Panzerfaust, cui era stato ancor troppo vicino. Gli agenti Tertini e Pontiani, colpiti alla schiena da una gragnola di frammenti, erano morti minuti dopo, bocconi sul selciato. Se lâerano cavata solo il vice commissario, il brigadiere e la giovane donna, châerano riusciti a imbucarsi, appena un attimo prima dello scoppio, nel più vicino androne. Al contempo, a causa del violentissimo spostamento dâaria, i fatiscenti muri esterni di due vecchie palazzine, che sâergevano ai lati dellâautoblindo, erano crollati trascinando con sé i residenti e seppellendoli a morte. Vittorio e i suoi due compagni avevano attraversato di corsa il cortiletto dove sâerano rifugiati e, di séguito, passando sotto un arco trasversale a un muro, erano entrati nella corte dâun altro caseggiato. Qui la giovane, che già aveva buttato il mitragliatore MG allâinizio della precipitosa ritirata, sâera disfatta dei nastri di munizioni portati a bandoliera e stava per gettare pure la borsa con la radio, ma Vittorio glielâaveva presa e, senza parole, lâaveva messa ad armacollo al brigadiere: âCi potrebbe servireâ, aveva detto. Il trio era riuscito, passando circospetto da corte a cortile, da cortile a cavedio, da cavedio a corte, a sboccare in via del Chiostro, sgombra di tedeschi, che terminava e termina ancor oggi nella via Monteoliveto, dove abitava la ragazza. Appunto a casa propria ella intendeva rifugiarsi. I due poliziotti contavano invece di raggiungere via Medina, consecutiva a via Monteoliveto, oltre lâincrocio col corso Umberto I, e di tornare in Questura.
Vittorio aveva fatto capolino su via Monteoliveto e aveva lanciato unâocchiata a sinistra e una a destra. Aveva scorto con disappunto, non lontano alla sua destra alla confluenza della via nel corso Umberto I, un posto di blocco dâun plotone di Waffen25 SS dotato di camionette, di motocarrozzette e dâun cannone caccia-carri semovente da 47 millimetri Panzerjäger, antiquato modello frutto dellâadattamento dâun ancor più antico panzer e arma poco efficace verso carri armati moderni, ma micidiale contro mezzi non corazzati ed edifici. I veicoli erano stati posti dai tedeschi lâun dietro lâaltro lungo il corso Umberto I, frapposti allâintersezione dello stesso con via Medina e via Monteoliveto. Evidente era lo scopo dâimpedire ad automezzi lâingresso nel corso o il suo attraversamento. Poiché il cannone caccia-carri era rivolto verso via Medina, Vittorio aveva supposto, correttamente, che scopo del blocco fosse ostacolare mezzi e uomini in uscita dalla Questura. Aveva anche immaginato che, per impedire il passaggio dâautomezzi in entrambe le direzioni, dovesse esserci un altro posto più in là oltre la stessa Questura, allâincirca nel punto dove sâera svolto il combattimento dei patrioti coi granatieri tedeschi.
Dunque, dâattraversare corso Umberto I e raggiungere i colleghi rimasti in sede neppure a parlare. Si trattava adesso di ripararsi tutti in casa della ragazza. Poiché il brigadiere era in uniforme, il DâAiazzo aveva pensato bene, prima che il terzetto si ponesse in vista su via Monteoliveto col rischio dâesser notato dai tedeschi, di dare al dipendente la giacca del proprio completo grigio in lanital26 , perché lâinfilasse sopra la giubba, nascondendola alla meno peggio e coprendo la borsa della radio che, appesa al collo, pendeva davanti allâaddome del sottufficiale. Così sâera fatto. Marino aveva pure celato sul petto, sopra la giubba e sotto la giacca prima di chiuderne i bottoni, il copricapo militare.
Lâabitazione della ragazza sorgeva a sinistra di via del Chiostro sullo stesso lato della via Monteoliveto in cui l'altra sfociava. I tre sâerano mossi uno alla volta a una trentina di metri lâuno dallâaltro, davanti la giovane, dietro il brigadiere e, ultimo, il vice commissario. Come questi aveva raccomandato, avevano camminato lentamente e, se pur erano stati notati dai nazisti del posto di blocco, il che non era sicuro, di certo non erano nati sospetti, visto che nessun tedesco aveva lasciato lâincrocio per raggiungerli e verificarne i documenti.
Lâedificio era una palazzina con due soli appartamenti sovrastanti, di cui il più arioso era al primo piano, con soffitti a tre metri dal pavimento, mentre lâaltro, dove viveva la giovane coi propri genitori, era un ammezzato alto due metri e cinquanta; esso sovrastava un magazzino a piano terra che sâapriva su via Monteoliveto sia con una porticina, alla sinistra del portoncino del palazzotto entrando, sia, ancor più a manca, con unâapertura carraia, in quel momento chiusa da una saracinesca. La casetta era di proprietà dâun venditore ambulante di frutta e verdura che abitava al primo piano e si serviva del magazzino per la sua attività , mentre affittava il mezzanino alla famiglia della giovane.
La ragazza aveva aperto il portoncino ed era entrata nel piccolo atrio del palazzotto, che odorava di chiuso, lasciando la porta accostata e attendendo i compagni. Un poâ dâaria fresca era entrata per la fessura. Uno alla volta i due uomini sâerano riparati. Vittorio sâera tirato dietro lâuscio e subito dopo, con la giovane in testa, il gruppetto aveva montato la mezza rampa di scale che conduceva allâammezzato.
Come risultava dalla targhetta a lato della porta dellâappartamento, la famiglia si chiamava Scognamiglio.
âTu sei Scognamiglio e poiâ¦?â aveva chiesto Vittorio alla giovane.
âMariapia.â
âPiacere, Mariapiaâ, aveva sorriso lui, smessa lâespressione preoccupata che aveva avuto in faccia da quand'era uscito di Questura: âIo sono il vice commissario Vittorio DâAiazzo.â
ââ¦e io il brigadiere Bordin Marinoâ, aveva fatto eco il suo aiutante, al contrario del superiore rimanendo serissimo, quasi sussiegoso, evidentemente fiero del proprio grado.
Sebbene i lineamenti di Mariapia non fossero più corrucciati, il viso non le si era rasserenato: la sua espressione da tenebrosa sâera mutata in mesta.
Aveva aperto la porta di casa con la propria chiave, che teneva in un portamonete in tessuto di canapa entro lâunica, fonda tasca della gonna grigio topo tessuta in filato cafioc27 , sorretta da una cinghia opaca nera di cuoital28 , nella quale era infilata una camicetta color azzurrite anchâessa in cafioc; la giovane indossava ai piedi calzerotti grigi in lanital entro due scarponcelli neri di coriacel29 con le suole in gomma parimenti nere ricavate, direttamente dallâartigiano fabbricante, da vecchi copertoni di auto.
Come i due poliziotti avevano osservato, lâappartamento era composto di tre vani e un corridoio; questo, largo un paio di metri, attraversava lâalloggio per tutta la sua lunghezza terminando su di una finestrella senza imposte; le tre stanze erano tutte alla sinistra di chi entrava, in quel momento avevano le porte chiuse ma, come sâintuiva dalla posizione, sâaffacciavano su via Monteoliveto. A destra accedendo, câera una balconata che fiancheggiava il corridoio e sovrastava una piana di orti larga come la palazzina e profonda il triplo, con sparsi meli e susini, fitte piantine di ortaggi e tre brevi filari paralleli di viti: anche quella pezza di terra apparteneva allâambulante. A un estremo della balconata, a sinistra di chi fosse uscito all'aperto per lâunica porta-finestra, centrale al corridoio, câera un gabbiotto in legno che, come gli ospiti avevano intuito, ospitava il wc domestico.
Sâera udito qualcuno muovere nella stanza prossima allâingresso, che si sarebbe rivelata una cucina tinello.
âChi câè?â aveva chiesto Vittorio alla giovane.
Senza rispondergli, Mariapia ne aveva schiuso per appena un terzo la porta e sâera infilata nel vano, richiudendosela dietro. Sâera udito un parlottare incomprensibile, poi la porta sâera riaperta, questa volta interamente, e la ragazza era uscita seguita dai genitori.
Il papà , Antonio Scognamiglio, sâera fatto incontro agli ospiti con la fronte increspata d'inquietudine, gli occhi rivolti agli stivali e ai calzoni del Bordin dall'evidente banda laterale fucsia. Il manifesto disagio del padron di casa sâera accentuato quando, un momento dopo, il brigadiere sâera tolta la giacca del DâAiazzo per restituirla al proprietario, mettendo così in bella mostra i gradi cuciti sulle maniche della propria giubba. Nondimeno il padre di Mariapia era in sostanza uomo probo. La sua diffidenza non era stata causata dallâaver avuto qualcosa da nascondere alla giustizia, ma dal fatto châera radicato in lui fin da bambino, come di norma nella plebe napoletana, un senso di grande prudenza, per non dire di sfiducia, verso le autorità grandi e piccole, trasmesso da generazione a generazione nel ricordo atavico delle prepotenze dei birri e degli altri pubblici funzionari dei re Borboni. Lâuomo era assai piccolo, un cinque centimetri meno del non alto Vittorio, aveva mani callose, era magro come Mariapia e aveva come lei una folta capigliatura, un tempo corvina come quella della figlia ma ormai candida, nonostante non avesse che quarantotto anni; a invecchiargli lâaspetto concorreva il volto rugoso come, dopo anni di mare, diviene quello dei naviganti e dei pescatori per la continua esposizione al sole e alla salsedine; e infatti egli aveva esercitato, su natanti dâaltura, lâapprezzata professione di capo pesca, com'era ancora scritto sulla sua carta dâidentità . Quattordici mesi prima però, come aveva confidato quasi sùbito agli ospiti per giustificare il suo essere in casa, aveva perso il lavoro, dopo più di tre decenni sullo stesso peschereccio prima quale apprendista, poi come pescatore rifinito e, infine, quale capo pesca. Aveva rivelato dâaverlo perduto drammaticamente, nel luglio del 1942, per lâaffondamento dellâimbarcazione, colpita a morte da una bomba dâun cacciabombardiere marino inglese De Havilland Sea Mosquito il cui profilo stilizzato, visto dal basso, era notissimo ai naviganti italiani perché affisso nei porti: Antonio era stato lâunico sopravvissuto alla mattanza perché, bravo nuotatore, sâera buttato in acqua non appena aveva avvistato la sagoma nemica abbassarsi sul peschereccio. Era stato recuperato da un cacciatorpediniere della Regia Marina italiana, in rotta verso il porto di Napoli, châera passato per buona ventura nellâarea nautica dellâaffondamento appena una decina dâore dopo, essendo ancora giorno, e altra fortuna, essendo di vedetta sul caccia un occhiuto comune di prima classe30 , che aveva scorto il pescatore aggrappato a una tavola del fasciame del peschereccio mandato all'aria dalla bomba. Pure bene, nel male, era stato che la stagione fosse stata lâestiva, con lâacqua marina a temperature sopportabili, e che lâaffondamento fosse avvenuto allâalba, per cui le dieci ore in acqua erano state tutte di sole. Dopo d'allora, Antonio sâera arrangiato, come tanti suoi conterranei, con lavori raccattati dì per dì, solitamente nel porto come scaricatore, ma solo finché le strutture portuali, già danneggiate dai bombardamenti angloamericani, non erano state distrutte dai tedeschi occupanti e non era stato emesso il divieto ai civili dâavvicinarsi al mare a distanze inferiori ai 300 metri.
Diversamente dal proprio immusonito marito, la madre di Mariapia, Concetta, aveva accolto i due ospiti sorridente, abituata comâera a trattare col pubblico da trentâanni, quale impiegata dâun botteghino del gioco del Lotto. Quel lunedì mattina peraltro, presentandosi al lavoro, aveva trovato il locale serrato e sulla porta un cartello con la scritta Chiusi per lutto; dunque, che si fosse trattato di vero cordoglio o di prudenza in previsione di scompigli nelle vie, che s'attendevano ormai da qualche giorno, Concetta se n'era tornata a casa, da cui il banco del Lotto non era distante essendo affacciato sul corso Umberto I a cinquanta metri a destra di via Monteoliveto. Non aveva avuto noie né andando né tornando in quanto, per sua fortuna, le Waffen SS erano sopraggiunte a sistemare il posto di blocco una decina di minuti dopo il suo rientro. A differenza dei brevilinei marito e figlia, la donna era alta un metro e settantadue, statura notevole in quei tempi rispetto alla norma della popolazione campana dâentrambi i sessi i cui antenati avevano sofferto la fame, come dâaltro canto lâavevano patita non pochi dei loro pronipoti prima del conflitto e quasi tutti dopo il suo scoppio. Concetta tuttavia, nonostante la guerra affamatrice, era una donna obesa. Stando ai lineamenti fini e agli occhi grandi che spiccavano belli sul suo volto sformato dal grasso, doveva essere stata unâavvenente giovane, ma ora dimostrava più dei suoi quarantaquattro anni e non solo per la ciccia, traballante sotto il mento al solo muoversi, ma perché era priva di tutti gli incisivi e dei due canini inferiori, oltre che di quattro non visibili molari, denti che aveva perso prima di giungere alla quarantina a forza di rimpinzarsi di caramelle e cioccolatini, quando lo zucchero e i dolci non erano pressoché introvabili come dopo lâinizio del conflitto; poiché però la tessera annonaria riguardava soltanto â non che fosse piccola privazione â zucchero, pasta, pane, farina, latte, burro, strutto, lardo, olio e carni, generi alimentari venduti per legge in quantità limitatissime a prezzi politici, lei si rifaceva della mancanza di caramelle mangiando frutta, soprattutto uva e fichi quandâera la loro stagione, comprata dal fruttivendolo suo padrone di casa, e bevendo generosamente vin dolce grazie allâabbondante produzione viticola, e quindi enologica, non solo nella zona ma in molte altre dellâItalia, nazione mediterranea che, in quel tempo, era prevalentemente agricola, tanto che la vendita di frutta e vino non era stata sottomessa a tesseramento. Concetta Scognamiglio era nata, sotto il diffusissimo cognome Esposito, nella famiglia relativamente benestante dâun pizzaiolo proprietario dâun locale dâangiporto, frequentato da marinai e pescatori, che dopo qualche anno camorristi avevano devastato e incendiato, non essendo state esaudite le loro pretese di compenso per la cosiddetta protezione. Dunque il padre era stato ridotto a pizzaiolo in casa altrui, la madre a cucire e stirare per conto terzi e a pulire pavimenti di altri, il dodicenne figlio maschio a fare lo sguattero in trattorie; invece la figlia maggiore, Concetta, che aveva allora quattordici anni, aveva avuto la buona fortuna di trovar posto nel banco del Lotto, grazie a un parente del titolare amico del suo papà : tal genere dâimpiego era considerato elevato nellâambiente popolano, sistematico giocatore ai 90 numeri, perché la persona che stava dietro alla cassa non solo prendeva i soldi, ma doveva conoscere a menadito la scienza della Smorfia per dar consigli sopra sogni e numeri. Lâimportanza del suo lavoro aveva provocato, nei riguardi della ragazzina, la feroce diffamazione di due sgraziate sorelle zitellone, inutilmente bramose del maschio in pancia e anche altrove; esse sâerano dette fra loro, e avevano immediatamente diffuso ad altri orecchi, che chilla pezzènte senza santi ân Ciélo era stata assunta soltanto perché sicuramente! aveva accettato di fare âe schifezze câo prencepà le, un anziano vedovo effettivamente in fama di satiro: quelle arpie ne erano sicurissime, nemmeno che avessero visto personalmente copule e lascivie varie tra il vecchio e la giovinetta. Era decisamente una calunnia: essendo morto lâanziano titolare, appena tre mesi dopo lâassunzione di Concetta, ed essendo passata la ricevitoria in gestione a una donna, la ragazzina aveva continuato a lavorarvi stimata dalla nuova conduttrice per la propria opera; e però la voce non sâera spenta, anzi sâera accresciuta dellâappendice che oâ vecchio puórco era crepato per la troppa foga di chilla purcellazza. Per buona sorte la voce calunniosa non era mai giunta né allâinteressata né al suo vendicativo padre né, in seguito, al sanguigno marito; e dire che le pinzochere in calore, se non fossero state scimunite, avrebbero dovuto capire da sole, finalmente, dopo il matrimonio di Antonio e Concetta, che essendo in quel tempo ancor apprezzatissima da tutti la verginità prematrimoniale della sposa e non avendo affatto il novello sposo commesso sfracelli la prima notte di nozze, egli doveva aver trovato la sposina come la mamma lâaveva messa al mondo.