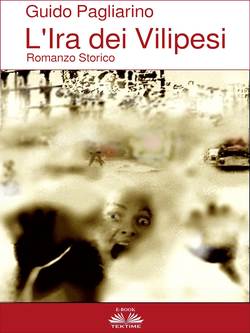Читать книгу L’ira Dei Vilipesi - Guido Pagliarino - Страница 8
ОглавлениеCapitolo 3
Il giovane vice commissario giustiziere di tedeschi e incaricato dâinquisire lâuomo in salopette era un ventiquattrenne, napoletano di nascita e per discendenza materna. Portava fitti capelli neri naturalmente ricci, tenuti corti alla militare secondo il regolamento di quegli anni. Era di non di alta statura, un metro e sessantacinque, ma ben proporzionato e robusto. Sâera laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli con lode e dignità di stampa e, se di mente era brillante, dâanimo era pulito, formato in famiglia e in collegio secondo classici principi etici, in sostanza i precetti dei 10 comandamenti giudeocristiani. A causa però della verde età , che poche disillusioni gli aveva fatto soffrire per il momento, Vittorio DâAiazzo era un poco immodesto. Abitava col papà , Amilcare DâAiazzo tenente colonnello dei Regi Carabinieri, e con la mamma, signora Luigia-Antonia diplomata maestra elementare ma casalinga, nel loro appartamento di proprietà , non situato in zona prestigiosa come sarebbe piaciuto alla famiglia, per esempio non in via Caracciolo o sulla Riviera di Chiaia, ma nel popolare rione Sanità , in via San Gregorio Armeno su cui sâaffacciavano abitazioni alla portata dei non pingui stipendi, in quell'epoca, e dei non eccelsi risparmi dâun ufficiale superiore dellâArma Benemerita. Al momento Vittorio viveva da solo nellâalloggio, a parte una donna a mezzo servizio, ché la mamma era sfollata in campagna allâinizio della guerra e il padre, da un paio di settimane, aveva passato le linee nottetempo, benché sessantunenne, quindici anni più della consorte, per non restare, di fatto, agli ordini dei tedeschi occupanti e per raggiungere il proprio sovrano. Aveva fin a quel momento prestato servizio nel 7° Gruppo Provinciale Carabinieri di Napoli, quale capo della Sezione Coordinamento Investigativo Provinciale. I coniugi DâAiazzo avevano due figli maschi. Mentre erano orgogliosi di Vittorio, non potevano stimare lâaltro, Emanuele, che fin da bambino era stato un indolente: dopo bocciature diverse, preso il diplomino delle elementari soltanto a quattordici anni e col minimo dei voti, aveva abbandonato i non sudati studi allâinizio del primo anno della scuola complementare per l'avviamento al lavoro, cui il padre sâera rassegnato a iscriverlo perché, a differenza del ginnasio10 , non prevedeva un esame dâammissione. Sedicenne, era scappato da casa, senza poter essere rintracciato dalla forza pubblica, dando notizie di sé solo dopo anni, una volta maggiorenne11 , con unâunica cartolina illustrata, indirizzata alla mamma, spedita dalla Svizzera nel maggio 1940, con poche parole di saluto. Non essendosi Emanuele presentato alla visita di leva, era stato considerato renitente e condannato in contumacia alla prigione dal Tribunale Militare di Napoli; e scoppiata la guerra, era stato considerato disertore. Il tenente colonnello DâAiazzo aveva avuto un danno dâimmagine da quel figlio e temeva che, a causa sua, non sarebbe più salito di grado, nonostante gli ampi meriti personali. Di più Vittorio, per le colpe del fratello, non aveva potuto seguire le orme paterne ed entrare nellâArma, come avrebbero voluto tanto lui che i genitori; a quei tempi infatti, non solo i personalmente disonesti, ma anche coloro che avevano ascendenti o parenti non assolutamente specchiati non potevano presentare domanda per la Benemerita. Amareggiato ma non rassegnato del tutto, Vittorio sâera laureato e aveva partecipato al concorso per vice commissario nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, ente che richiedeva solo lâintegrità personale dellâaspirante e non pure dei dei suoi congiunti. Aveva superato brillantemente la prova e, al termine della successiva scuola di specializzazione professionale, era risultato il primo in classifica, con buone speranze, dunque, dâessere esaudito nella scelta della destinazione, la sua Napoli; e proprio nella domestica città era stato assegnato.
Dopo aver letto il breve rapporto del maresciallo Branduardi, il vice commissario DâAiazzo s'era diretto alle camere di sicurezza, al piano terra, e vi aveva osservato la figura del sedicente Gennaro Esposito. Era sceso quindi nellâumido archivio sotterraneo e vi aveva controllato se qualcuno con quei dati anagrafici risultasse schedato e se le sue foto, di fronte e di profilo, corrispondessero alla fisionomia del prigioniero. Aveva trovato diverse cartelle segnaletiche con gli stessi nome e cognome, ma tutte riguardanti persone di lineamenti differenti da quelli del presunto assassino. Tornato nel proprio ufficio, sâera fatto condurre il fermato.
Lâaveva inquisito con lâaiuto del proprio assistente brigadiere Marino Bordin che, seduto al proprio tavolino, aveva battuto le domande del superiore e le risposte dellâinterrogato sulla macchina per scrivere dellâufficio, unâobsoleta Olivetti M1 nera modello 1911.
Il Bordin era un veneziano biondo robusto, alto un metro e ottanta. Quarantacinquenne, serviva in Pubblica Sicurezza da un quarto di secolo e aveva moglie e due bambini, che aveva sfollati in una casa colonica nella campagna napoletana, sacrificando allâagricoltore ospitante i due terzi del proprio stipendio e rassegnandosi, col rimanente, a mangiare e dormire in caserma.
Per ore lâindagato, senza demordere, aveva detto e ripetuto, in un corretto idioma che faceva pensare avesse frequentato almeno le classi elementari, assai severe a quel tempo, dâessere un cuoco disoccupato, dâabitare, così comâera scritto sulla sua patente, in vicolo Santa Luciella e che stava rientrando a casa quando aveva visto la porta di casa della morta accostata e aveva udito gemiti provenire dallâinterno: per mero altruismo era entrato, chiedendo permesso, aveva visto nellâatrio la donna a terra che continuava a gemere e, avendo adocchiato un apparecchio telefonico su di una parete, aveva deciso di chiamare unâautolettiga; ma proprio in quellâattimo era entrata la ronda di Pubblica Sicurezza che lâaveva ammanettato.
Dà i e ridà i, poco dopo le 7 del mattino il vice commissario aveva finalmente ottenuto un dato nuovo, che lâuomo era un frequentatore abituale della prostituta e ch'era entrato da lei, essendo atteso, per avere uno svelto rapporto sessuale, così da andarsene presto e raggiungere casa propria prima del coprifuoco. A domanda, aveva precisato che aveva fissato telefonicamente lâappuntamento da un bar, come tante altre volte. Richiesto di recitare il numero telefonico della Demaggi, aveva detto che non se lo ricordava più e, allo scetticismo manifestato dal DâAiazzo, aveva giustificato lâamnesia con lo stato di subbuglio mentale dovuto alla situazione. Per il resto non aveva cambiato versione ribadendo che, una volta entrato attraverso lâuscio lasciato socchiuso apposta per lui in seguito alla telefonata, aveva visto la donna a terra e sâera sùbito risolto a chiamare soccorso con lâapparecchio telefonico dellâappartamento, quandâecco che la pattuglia era sopraggiunta e lâaveva fermato.
Come già gli agenti della ronda, nemmeno il vice commissario aveva potuto credere che lâuomo fosse un cliente dellâesosa mondana, avendo valutato il suo abbigliamento modesto e mal ridotto e lâassenza di denaro nelle sue tasche. Considerando che lâuscio era stato lasciato aperto verosimilmente proprio per lui, lâaveva supposto un complice nel mercato nero. Lâaveva dunque accusato dâaverla ammazzata per sopraggiunti contrasti: âConfessalo e ti mando a dormire!â
âNon è vero niente, sâè trattato sicuramente dâun incidente avvenuto prima châio entrassiâ, aveva negato lâaltro.
âSe non eri un complice in disaccordo, allora eri stato mandato a ucciderla da un concorrenteâ, aveva premuto il funzionario.
âSignor dottore, vi12 dico ancora che non è vero!â sâera acceso lâuomo abbandonando lâatteggiamento docile che aveva tenuto fin a quel momento.
Non richiesto, il brigadiere Bordin era scattato: âBusòn!13 Porta rispetto al dottore o ti riempio di calci dove te lo fai ficcare!â
Il vice commissario non ammetteva villanie e lâaveva redarguito: âMarino, i calci e lâinsulto te li tieni per te.â Aveva ripreso: âGennaro, sempre che tu ti chiami davvero Gennaro Esposito, e staâ sicuro che controlleremo allâAnagrafe domani⦠no, stamattina, vista lâora, sentimi bene: anchâio, come te, avrei voglia di concludere, dunque ti faccio una propostaâ â lâuomo aveva alzato la soglia dâattenzione visibilmente, semi schiudendo la bocca mentre le pupille gli si dilatavano un poco â: âSe ti confessi colpevole di omicidio preterintenzionale, il che significa che hai ucciso andando oltre lâintenzione che aveviâ¦â
ââ¦lo so.â
âAllora senti: potresti ad esempio dirmi che non avevi soldi e che la vittima non voleva concedersi a credito, per cui in un irrefrenabile impulso dâira le avevi dato una spinta, senza volerla ammazzare ma, disgraziatamente, lei cadendo era rimasta lesa a morte; insomma, mi hai capito: in questo modo davanti al plotone dâesecuzione, non ci finisci14 , ti fai solo un poâ di galera. Se invece io scrivo nel mio rapporto per il giudice istruttore che sospetto tu sia il sicario dâun qualche borsanerista della camorra che ha voluto eliminarla, oppure un diretto concorrente della donna al mercato nero che ha voluto farla fuori per sempre, tu sei già bellâe fucilato.â
Lâuomo, pur se più stanco del vice commissario, non aveva confessato: âNon solo vi ripeto unâaltra volta che non sono un assassino e, a quanto ne so io, che la donna è morta per un incidente avvenuto prima châio entrassi da lei, ma adesso vi dico pure che sono un sergente maggiore artigliere e che ho passato le linee raggiungendo Napoli ieri sera.â
âHm⦠dimmi di più.â
âSono anche cuoco, ero in servizio come direttore di cucina nel circolo ufficiali del 3° battaglione, 1° reggimento Artiglieria Costiera, di stanza a un cinque chilometri a nord di Paestum, in provincia di Salerno.â
âLo so dovâè Paestum⦠va beh, supponendo che tu mâabbia detto adesso la verità , è nel tuo stesso interesse che noi si controlli la tua identità militare e perciò dimmi della scuola allievi sottufficiali da cui vieni e da quale corsoâ: in realtà , nel caos seguito allâarmistizio quella verifica sarebbe stata probabilmente impossibile e il DâAiazzo lo sapeva, ma aveva contato sul fatto che lâaltro, qualora gli avesse mentito, si sarebbe scoperto.
Lâuomo non sâera scomposto: âLa mia carriera è partita dalla gavetta: a ventotto anni, dopo aver perso il posto di aiuto cuoco in una trattoriaâ¦â
ââ¦cosâavevi combinato?â
â...ma niente di male! Il locale aveva chiuso perché, come dicevano i padroni, erano arrivate le ultime conseguenze della crisi del â29.â
âVa beh, vaâ avanti.â
âAvevo cercato lavoro altrove ma trovato niente: nessuno assumeva, semmai licenziavano. Allora, per non pesare su mia madre châera rimasta vedova e faticava facendo le pulizie in negozi e cucendo e ricamando in casa per estranei, alla fine mâero arruolato volontario, sperando di fare carriera e diventare sottufficiale: sei anni prima ero stato congedato dal servizio, con onore, col grado di caporale, che mi era stato riconosciuto alla riafferma; e siccome ero stato già nelle cucine durante la leva, dopo il corso dâaggiornamento su certi cannoni mâavevano di nuovo spedito davanti alle pignatte, a parte le periodiche esercitazioni di tiro con lâartiglieria, il fucile e la pistola; e così è stato per tutta la mia carriera militare, prima da caporalmaggiore, quindi da sergente e, finalmente, da sottufficiale15 : sergente maggiore direttore della cucina del circolo ufficiali. Dopo lâarmistizio e lo sbarco degli ex nemici16 sulle nostre coste, mi sono trovato allo sbando coi commilitoni, preoccupato di non incontrare né angloamericani né tedeschi. Mi sono imboscato, mangiando frutta e verdura portate via agli orti e, le poche volte che mi ospitavano in cascine, anche pane, latte e uova; ma i contadini, o almeno quelli che ho incontrato io, son gente interessata, mi hanno chiesto senza eccezioni un compenso, prima in soldi, e ho dato loro, a mano a mano, quanto mi restava dellâultimo stipendio, poi, finito il denaro, ho dovuto lasciare il mio orologio: era dâacciaio, ma di marca; e allâultimo purucchio17 ho mollato la mia medaglietta di san Gennaâ con catenella, tuttâe due in oro 18 carati, dono dei miei per la Prima Comunione, in cambio del camisaccio e della tuta da lavoro che ancora indosso. Mi sono messo in borghese e ho gettato la piastrina militare di riconoscimento e anche i documenti militari, perché noi di carriera lâabbiamo non solo dâaltro colore ma con scritto sopra che siamo appunto militari e anche il nostro gradoâ¦â
ââ¦lo soâ
âGià , pure per voi è così. Ho buttato la carta dâidentità e la patente militari tenendo solo la patente civile e, non più in divisa, mi sono diretto alla mia Napoli, sono riuscito a passare la linea del fronte e, ieri sera, sono entrato in città . Muovendomi prudentemente anche se ero in borghese e avevo con me un documento, sono giunto in piazzetta del Nilo, che non è lontana dallâalloggetto di mammà e mio nel vicolo Santa Luciella; e, per colpa del mio buon cuore, dopo quantâavevo già passato, ho ancora avuto lâimpulso dâaiutare quella donna che gemeva e⦠eccomi qui, proprio quandâero ormai vicinissimo a casa.â
âCome mai sul tuo permesso di guida non è segnato il tuo domicilio nella zona di Paestum?â
âOccupavo una stanza in caserma, assieme a un altro sergente maggiore anchâegli scapolo, non avevo unâabitazione esterna: mai ho considerato le caserme come casa mia e mai mâè venuto di far togliere lâindirizzo di Napoli: solo sulla carta dâidentità e sul permesso di guida militari facevo variare, perché era obbligatorio, a parte il fatto che sulla patente civile avrei dovuto far cambiare sovente lâindirizzo dalla Motorizzazione18 , dato che mi trasferivano ogni pochi anni; e invece la carta e la patente militari, me le rifacevano direttamente nel nuovo reparto; e poi, dopotutto, a Napoli da mammà tornavo ogni volta che andavo in licenza.â
âSappi che andremo in vicolo Santa Maria a controllare se ci abita davvero tua madre e se altre persone ti conoscono.â
ââ¦e io vi ringrazio, signor commissario, perché è proprio là che sta mammà e potrete avere conferma di me da lei e pure dai vicini; mi raccomando, però, di tutto cuore: non spaventatemi mammà , ditele, per piacere, che vi ho incaricato io di salutarmela dato che non ho potuto venire di persona per ragioni di servizio.â
âSe troviamo tua madre, non te la spaventiamo e le parliamo come tu desideri.â A questo punto, però, il vice commissario gli era stato di nuovo addosso: âPrima avevi tentato di farmi credere dâaver avuto con la Demaggi un appuntamento galante prezzolato e poi hai ammesso che non era vero; allora dimmi: se la vedevi per la prima volta, come facevi a sapere che quella donna era un prostituta?â
Non sâera scomposto: âLâavevo sentito dal vostro capo ronda che ne aveva parlato coi suoi davanti alla morta.â
âControllerò. Adesso dimmi ancora una cosaâ â il DâAiazzo aveva lasciato la domanda per ultima, per scoccarla quando lâinquisito fosse stato stanchissimo â: âPerché mai portavi guanti di lana in questa stagione? Per non lasciare impronte, non è vero?â
ââ¦ma no, signor commissarioâ, non sâera preoccupato lâaltro, âil motivo è semplice, li indosso ormai da tempo, li avevo anche in servizio, su permesso del capitano: soffro di dolori alle dita delle mani e anche al palmo sinistro.â
âHmâ¦â
ââ¦ma sì, per lâumidità delle cucine nel corso di tanti anni, tra vapori di pentole e acqua dei lavaggi delle marmitte, come mi aveva spiegato il tenente medico, ed era stato lui a dirmi di portare i guanti.â
Stremato lâuomo e stracchi i due poliziotti, a un ordine del vice commissario il presunto sergente maggiore Gennaro Esposito era stato scortato in camera di sicurezza dal brigadiere Bordin.
Coi soli dati raccolti Vittorio DâAiazzo non aveva potuto formarsi unâidea certa: restavano per lui contemplabili tanto lâipotesi dâun incidente quanto quella dâun omicidio e questo non necessariamente perpetrato dal fermato; nel caso però di sua colpevolezza, il movente poteva trovarsi nella concorrenza fra borsaneristi, se lâidentità e in particolare la posizione nellâEsercito del sedicente Esposito non fossero state confermate, mentre in caso contrario sarebbe stato verosimile un diverso motivo. Peraltro, se lâanatomopatologo avesse stabilito essersi trattato dâassassinio, lâinquisito, sebbene non avesse confessato, sarebbe stato trasferito alla Casa Circondariale di Poggioreale quale sospetto, mentre parallelamente il vice commissario avrebbe dovuto stilare e trasmettere alla Procura del Regno una relazione contenente sia le conclusioni del medico legale, sia le notizie raccolte dallo stesso DâAiazzo durante lâinterrogatorio. Sul suo rapporto il giudice istruttore avrebbe deciso se aprire un procedimento contro il sospettato oppure farlo scarcerare per insufficienza di prove.
Non mancava più molto alle 8 del mattino e il giovane funzionario stava per terminare il suo turno; tuttavia, prima di tornarsene a casa intendeva ancor ordinare al brigadiere dâandare in vicolo Santa Luciella a controllare se ci vivesse davvero la madre dellâindagato e, in questo caso, se ella riconoscesse il figlio nella foto della patente e se confermasse châegli era davvero un sergente maggiore dâartiglieria. Il vice commissario non aveva però in programma dâaspettare il ritorno del sottoposto, ne avrebbe ascoltato la relazione il giorno seguente; tanto, prima che giungesse al suo ufficio il verbale dellâanatomopatologo sarebbero passati almeno due o tre giorni, duranti i quali il fermato se ne sarebbe rimasto chiuso in guardina.
Il Bordin, dopo aver fatto ridurre lâinquisito in cella, era tornato dal DâAiazzo. Entrato in ufficio gli aveva detto: âSignor commissario, secondo me quellâEsposito o presunto tale è stato mandato dalla camorra ad ammazzare la Demaggi per due possibili motivi: o per ragioni di concorrenza a borsa nera, o perché quella lurida puttana non voleva più pagare la tangenteâ¦â
ââ¦Marino, quella donna è morta e i defunti non sâinsultanoâ, lâaveva ammonito il giovane superiore, âe comunque non sono convinto che lâindiziato sia un assassino.â
âScusatemi se mi permetto, ma penso⦠beh, che voi siete sempre troppo buono: se noi gli menavamo qualche colpo allo stomaco coi sacchetti di sabbiaâ¦â
ââ¦che non lasciano il segno?â
âPrudenza lo vuole; e state sicuro che quel delinquente si sarebbe dichiarato colpevole e pure camorrista e chi sa cosâaltro. Invece cosìâ¦â
ââ¦invece così non ho rischiato di far confessare un innocente, a parte che se ti vedessi mollare sacchettate a qualcuno⦠mi hai capito, Marino?â
âEehâ¦.â
âCi penserà il giudice istruttore, semmai, a fargli ammettere la colpevolezza, sempre che il medico non ci dica che sâè trattato dâun incidente così châio archivi la pratica e liberi quellâuomo.â
âGià , può darsi; però, parlando in generale, voi, signor commissario, siete forse lâunico qui a non mollare almeno qualche ceffone aglâinterrogati. Il fu dottor Perati che servivo prima di voi faceva confessare tutti.â
Nellâardore dellâetà , non disgiunto da quel pizzico di presunzione che permaneva in lui, era sfuggito al vice commissario, istintivamente nella lingua partenopea che usava in famiglia: âTu siâ ânu fésso.â
âCosa?!â era divenuto paonazzo il sottufficiale.
Il superiore sâera parzialmente emendato: âVa bene, Marino, ritiro il fesso, però sbagli a parlarmi senza riguardo solo perché ho la metà dei tuoi anni. Staâ accorto, perché se ricapita, ti punisco.â
Il Bordin aveva ritenuto saggio scusarsi, sia pur a denti stretti: âPerdonate, signor commissario, è stato tanto per dire, non volevo criticarvi.â
Se Vittorio DâAiazzo, col tempo, avrebbe acquisito appieno lâumiltà grazie alle metaforiche sberle della vita, al momento voleva ancor essere lui a pronunciare lâultima parola: âVa bene, ma dâora in poi pensa a quello che dici, prima di dire quello che pensi.â
Lâuomo aveva ritenuto saggio irrigidirsi sullâattenti: âSignorsì.â
âStaâ pure sul riposo e non restare mortificatoâ, aveva addolcito il tono il superiore, nel quale aveva avuto la meglio, finalmente, la compassione. Aveva proseguito: âHai detto che il Perati faceva confessare tutti: certo, lo so bene, me lâavevano raccontato quandâero arrivato qui; ma tu te lo ricordi chi lâaveva ammazzato?â
âSissignore, la madre dâun ladro abitualeâ¦â
ââ¦ladro cui il Perati aveva lanciato lâaccusa dâaver accoltellato a una mano un panettiere, per derubarlo, e che aveva fatto confessare sì, ma come? Legandolo a pancia in su sopra un tavolo e frustandolo con la cinghia; e due giorni dopo, te lo ricordi? lâindagato era morto per unâemorragia interna.â
âScusatemi, posso parlarvi liberamente ma con tutto il rispetto?â
âPuoi.â
âIo credevo che il dottor Perati fosse stato nel giusto perché non ne aveva avuto rimproveri da superiori.â
âAllora non sai che la faccenda era stata sepolta per ordine del federale di Napoli19 , perché il Perati era fascistissimo e leccapiedi; e però, nella mente della madre del morto la cosa non era stata affatto seppellita, e oltretutto ella aveva appreso, un paio di settimane dopo la morte del figlio, châegli era innocente tanto del ferimento che del furto, e questo tu lo sapevi, no?â
âSapevo che il vero colpevole era stato riconosciuto per strada dal panettiere e denunciato a una nostra pattuglia, dalla quale era stato fermato e portato qui.â
âGià , e la mamma del morto ne era stata messa al corrente da un amico del figlio, che aveva raccolto la verità in giro; e la sai una cosa? Non era stato troppo iniquo, in fin dei conti, che quella donna fosse venuta da noi chiedendo di parlare al Perati, con la scusa dâavere rivelazioni da fargli, e una volta davanti a lui avesse estratto un piccolo coltello per la spellatura della carne dal proprio seno e gli avesse mollato un fendente che gli era giunto al cuore; e quasi mi dispiace châella fosse stata bloccata subito dopo e che adesso sia in attesa di giudizio, perché temo che sarà condannata a morte per omicidio premeditato.â
âSperiamo le concedano la seminfermità mentaleâ, gli era stato solidale il Bordin.
âSperiamolo; ma a parte questo, tu adesso mi vai al deposito automezzi con questo foglio di servizio⦠tieni: è la mia autorizzazione a prelevare una macchina con conducente; poi vai a controllare in vicolo Santa Lucia se lâEsposito è persona conosciuta.â Gli aveva sporto anche la patente dellâinquisito: âFai vedere la foto alla madre, sempre se ella esiste, e pure ai vicini, e raccogli quanto puoi su di lui.â
âAgli ordini; al ritorno però, signor commissario, magari io me andrei in camera a dormire ché, per oggi, le mie ore di servizio sarebbero già scadute.â
âDovere e sacrificio è il nostro mottoâ, gli aveva restituito sorridente, in uno spontaneo endecasillabo, il superiore, gran lettore di poeti classici.
Essendo noto in Questura che la temperatura sociale in città stava salendo e non era affatto improbabile una sollevazione, prima di recarsi allâautorimessa il brigadiere aveva voluto passare dalla sala radio per raccogliere notizie sulla situazione esterna. Non appena reso edotto, era tornato dal diretto superiore e lâaveva informato che camionette di ronda avevano comunicato châerano iniziati isolati scontri a fuoco. Aveva concluso chiedendo: âSignor dottore, devo proprio andarci oggi, o posso aspettare domani, ché forse il clima si sarà calmato?â
Prima che il D'Aiazzo avesse deciso, avevano preso a salire dalla via Medina, su cui sâaffacciava e ancor sâaffaccia la Questura di Napoli, i rombi dei motori diesel di automezzi che stavano passando in colonna davanti allâingresso principale del palazzo, come tutti i giorni da due settimane: si trattava dâun plotone motorizzato di granatieri germanici che andava a dare il cambio a un altro, dello stesso battaglione, comandato a guardia dâun corridoio allâultimo piano di Castel SantâElmo, possente baluardo che sâeleva sulla collina del Vomero a 250 metri sul livello del mare e da cui sâosservano il Golfo e la città : su quel corridoio s'affacciano due locali non comunicanti fra loro adibiti in quel tempo ad armeria del fortilizio, di cui uno è uno stanzone che conteneva armi e munizioni convenzionali e l'altro un ambiente non molto grande che custodiva armamenti segreti di progettazione e produzione italiane. La sorveglianza delle armi si svolgeva ventiquattrâore su ventiquattro in due turni, dalle 8 e mezza alle 20 e 30 e dalle 20 e 30 alle 8 e mezza. Fin dal 9 settembre i tedeschi avevano occupato Castel SantâElmo impadronendosi degli armamenti, con particolare interesse per quelli speciali. Proprio a causa di tali armi non convenzionali, lo stesso castello era in quei giorni un obiettivo primario per gli Alleati che, da tempo, se ne stavano occupando coi propri servizi segreti.
Vittorio DâAiazzo stava per rispondere al sottoposto di tralasciare il suo precedente ordine e d'andarsi a riposare, quando sâerano levati spari dalla via Medina, dapprima di fucili e dâun mitragliatore leggero, poi, in rapida successione, di mitra e dâuna mitragliatrice.
Vice commissario e aiutante sâerano abbassati istintivamente e, avanzando a gambe semi piegate, sâerano portati alla finestra e avevano fatto capolino guardando di sotto, esponendosi il meno possibile.
Contemporaneamente, diversi altri poliziotti avevano sbirciato giù dai rispettivi uffici, tanto personale del turno smontante che di quello montante essendo l'ora del cambio, le 8 in punto; arrivato da poco, aveva spiato dalla propria finestra anche il caposezione vice questore Remigio Bollati; il suo ufficio dava sullo stesso corridoio su cui sâaffacciava quello di Vittorio e i due locali erano contigui.
Occhieggiando di sotto s'era visto o intravisto, a seconda della posizione della propria finestra, a una cinquantina di metri oltre il portone e il limitrofo passo carraio, il plotone teutonico fermo in mezzo alla strada, al riparo dei propri automezzi allineati di traverso, impegnato in uno scontro a fuoco con persone che dovevano essere più in là sulla via e che non si potevano scorgere dal palazzo della Questura, ma di cui ben sâudivano gli spari: si poteva supporre che fossero riparate dietro i muri diroccati e i cumuli di macerie di due vicini palazzi, fra loro prospicienti, bombardati pochi giorni prima dellâ8 settembre da fortezze volanti americane.