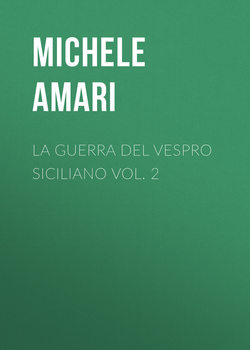Читать книгу La guerra del Vespro Siciliano vol. 2 - Amari Michele - Страница 4
CAPITOLO XVI
ОглавлениеRibellione de’ feudi dell’ammiraglio in Sicilia. È spenta, ed egli sconfitto da’ nostri sotto Catanzaro. Preparamenti di Giacomo e di Federigo. Il primo sbarca sulla costiera settentrionale dell’isola; passa ad assediar Siracusa. Fatti della guerra guerriata che s’accende in Sicilia. Giovan Loria vinto e preso nello stretto di Messina; sciolto l’assedio di Siracusa; e Giacomo torna in Napoli e in Catalogna. Nuovo passaggio di lui in Sicilia. Parlamento di Messina. L’armata siciliana debellata dalla catalana a capo d’Orlando. Estate del 1297–4 luglio 1299.
Incominciò Loria il servigio del novello signore, con ritentar tradimento all’antico; arrischiatosi a venire in Sicilia con un sol velocissimo naviglio; non però tramando sì cauto, che Federigo non n’avesse spia: il quale, come era ardente di vendetta contro l’ammiraglio, fe’ armar navi che l’appostassero alle isole Eolie. Scampò Ruggiero per navigar guardingo, e darsi a una rapida fuga come scoprì i nostri, che non seppero o non vollero raggiugner l’antico lor capitano; ma tal contrattempo pur bastò a rompere tutti i disegni. Perchè risaputosi, Giovanni Loria nipote dell’ammiraglio e cresciuto da lui come figliuolo, ancorchè carissimo a Federigo, lasciava improvviso la corte, per levar l’insegna della guerra in Castiglione; tentava Randazzo indarno, armandosi il popolo contro i suoi partigiani206; poneva a sacco ed a guasto il vicin villaggio di Mascali; ma non potè altrimenti offendere il re e il paese senza la persona di Ruggiero. Federigo senza dimora il bandisce nimico pubblico; strigne d’assedio le fortezze feudali dell’ammiraglio; ponendosi ei medesimo a campo a Castiglione, importantissima tra tutte per esservisi chiusi con Giovanni Loria, Guglielmo Paletta quel valoroso del ponte di Brindisi, Tommaso di Lentini207, e molti altri guerrieri di nome, congiunti o clienti dell’ammiraglio. Indi con assai sangue, ma non lungamente, si travagliò quest’assedio nella state dei novantasette; finchè oppugnato da tre bande il castello, crollato da’ tiri delle macchine, fuor di speranza d’aiuto di là da’ mari, Giovanni s’arrendè, salve persone ed averi, e passò in Calabria con Ilaria moglie sua, figliuola del conte Manfredi Muletta, Ruggier Loria figliuol dell’ammiraglio, e tutta lor amistà. Francavilla s’era già data a’ Messinesi, venuti a osteggiarla. Il castel d’Aci, foltissimo sur una roccia che bagnasi in mare, tenne contro gli assalti de’ Catanesi. Ma venutovi Federigo dopo la resa di Castiglione, fece costruir una torre di legname, alta a pareggio delle mura, mobile su ruote interne, congegnata con un sottil ponte che s’addimandava cicogna, la quale approcciata a una picciola gittata di mano, fe’ tosto calare il presidio ad arrendersi. E così fu spenta in Sicilia la ribellione dell’ammiraglio208.
Nello stesso tempo la fortuna peggio l’umiliava in Calabria. Con un grosso di cavalli di re Carlo209 si pose egli a sfogare il fresco dispetto, sugli acquisti nostri di quelle province, mescolando pratiche e forza210; che fin tirò Blasco Alagona a un abboccamento, per tentarlo, o metterlo in sospetto di Federigo; ma riuscì solo a questo intento. Il dubbioso principe chiamava Blasco in Sicilia: e Loria colsene il tempo a ribellar la città di Catanzaro, e patteggiar col castello che si desse a capo a trenta dì, se non fosse soccorso. Nè a ciò Federigo, impacciato in quegli assedi in Sicilia, ben potè riparare. Rimandò in fretta in Calabria il generoso Blasco e con esso Calcerando e Montecateno; ma la più parte dei feudatari non fu pronta a partirsi dalla Sicilia, per anco non queta; talchè il termine strignea, nè v’avea de’ nostri meglio che dugento cavalli, raccolti a Squillaci, mentre Loria con quattrocento minaccioso aspettavali. Era la notte anzi il trentesimo dì, e Blasco, fitto in questi pensieri, sforzavasi indarno a rifocillarsi con un po’ di sonno, quando un de’ suoi scorridori affannoso viene a dirgli, esser testè giunto al campo nimico Goffredo di Mili con trecento cavalli. Saltò Blasco dal letto; l’afferrò pel braccio, e «Taci, gli disse, o morrai; niuno de’ nostri nol sappia:» e il cresciuto pericolo dileguò nel suo grand’animo ogni dubbio al combattere. Innanzi dì, consultatone con gli altri due capitani, fa cibar le genti; muove da Squillaci su Catanzaro. Giunsero a vespro, in un vicin rispianato tra letti di torrenti, che s’addomandava Sicopotamo, e trovaron Loria uscente a battaglia.
Settecento cavalli avea, con ventiquattro bandiere di signori, ordinati in tre linee: e comandava egli il primo squadrone, l’altro Reforziato cavalier provenzale, l’ultimo Goffredo di Mili. De’ siciliani uomini d’arme, partitisi ventiquattro anzi il combattimento, restaron centosettantasei, che Blasco, per la pochezza del numero, strinse in una sola schiera, toltone un drappelletto che pose all’antiguardo con Martino Oletta: e della battaglia ei comandò il centro, la destra Calcerando, Montecateno la manca; i lati assicurò con almugaveri e gente dell’armata, sparsi sulle ripe di due torrenti. In tal postura aspettavan lo scontro.
Dall’alto al basso caricò l’ammiraglio con la prima banda; nè pur fe’ tanto, che rompesse il nostro antiguardo: onde, perduta la foga, da paro a paro cominciò a combattere, e impedì Reforziato, che seguiva a corsa con l’altra schiera credendo compier la vittoria. Si distende Reforziato dunque su i fianchi dell’oste siciliana; donde i fanti a furia di dardi e sassi il ributtavano con molta strage. Ma Goffredo di Mili, movendo con la terza schiera, perplesso per l’inaspettata resistenza, postosi a canto a Ruggiero, per la strettezza del luogo, o non l’aiutò, o l’impacciò, mentr’ei si travagliava duramente con Blasco: ambo ostinati, l’uno, dice Speciale, per uso alla vittoria e fidanza nel numero; l’altro per vedere i suoi sì feroci e serrati, e non aver giammai voltato faccia in battaglia. Ruggiero, ferito al braccio, mortogli sotto il cavallo, sparve un istante in mezzo la mischia; la sua bandiera, assalita da un nodo di uomini fortissimi, balenò; l’alfier che la reggea, ferito in volto, non vedendo più il signor suo, die’ le spalle alla zuffa. Allor Blasco con terribil voce incalza, gridando: «Avanti, cavalieri, or che cede il mico:» e i Siciliani, nel decisivo momento fatti maggiori che uomini, aprono gli squadroni nimici, li squarciano e sparpagliano. Di qui «Alagona» gridan essi, di lì «Aragona» le genti dell’ammiraglio, sperando invano l’usata vittoria in quel grido; e or nocque, perchè Goffredo Mili, nell’agitazione e rovinio del conflitto, credendo sentirsi gridar Alagona a’ fianchi, come circondato e perduto, fuggì, traendo con sè le altre schiere; e fece compiuta la disfatta. Caddervi i figliuoli di Reforziato e di Virgilio Scordia, Giordan d’Amantea e nobili molti. Reforziato stesso fu preso, ma fuggì, corrotte le guardie; assai più camparono per la notte sorvenuta. Il gran Ruggiero, ferito, a piede, obbliato da tutti i suoi nella rotta fuga, s’ascondea sotto una siepe, aspettando da un momento all’altro i nostri guerrieri e la morte; quando a caso il vide un suo famigliare che fuggiva, e smontato in un attimo, gli die’ il proprio cavallo. Piangendo di rabbia, risaliva in arcioni l’ammiraglio; anch’egli, a spron battuto dileguandosi innanzi i nostri, si rifuggiva a Badolato; e dava poi grande avere nel reame di Valenza a questo fedele, che con tanto pericol suo il tolse a indubitabil morte. Ma se il capo di Ruggiero non fu tra i premi di questa giornata, bastò ai nostri avergli dato la prima rotta ch’ei toccasse in sua vita: un pugno d’uomini, in mezzo al paese nimico, incontro a tal capitano, vinse tre tanti e più del suo numero. Si tornarono la dimane a Squillaci; e non che mantenere il castello, Calcerando ripigliò la terra di Catanzaro, ove gli avanzi della gente nimica non osaron far testa211.
Non guari dopo Bernardo Sarriano, audace capitan di navilio finchè ebbe Siciliani, volto a parte nimica, assaltava Malta con un armatetta, tentava Marsala; e, deluso nell’una e nell’altra impresa, tornavasi a’ porti di Napoli; non aspettato Federigo, che a’ primi avvisi armò in fretta in Palermo ed altrove una trentina di galee, con le quali pensava andar egli stesso. Senz’altra fazione d’importanza finì poi l’anno novantasette, e tutto il verno. Federigo, con Manfredi Chiaramonte e Vinciguerra Palizzi, macchinava contro lo ammiraglio, or di spegnerlo per una mano di uomini risoluti, allettati da gran premio; or di sfidarlo a duello per un campione, che fu il famoso difenditor di Girona, Ramondo Folch, visconte di Cardona; e dovealo appellar di tradigione secondo gli usi di Barcellona o il foro aragonese, e in duello ammazzarlo, o almeno, tirandolo in Ispagna, toglier tal mastino dal collo a Federigo212. Ma nulla approdaron queste pratiche contro Ruggiero. Un Montaner Perez de Sosa, mandato alsì da Federigo in Catalogna ad attraversare i preparamenti della guerra, non trovò riscontro ne’ popoli; e per poco scampò dalle mani di re Giacomo213, infiammato nella causa, come diceanla, della santa Chiesa, dal danaro che il papa e Carlo gli porgeano214. Perchè Loria, trafitto dall’onta di Catanzaro, ma feroce in volto e superbo come per vittoria, era andato a re Carlo, a far grande scalpore della vergognosa fuga dei suoi, e che nulla s’otterrebbe senza il re d’Aragona: onde Bonifazio, visto che qui n’andava tutta la fortuna della guerra, die’ a Giacomo quanto ei volle; tollerò ch’ei tardasse la restituzione degli stati di Giacomo re di Maiorca, sollecitata efficacemente dal re di Francia; snocciolò dalla camera apostolica i danari raccolti da quelle province, che il pio Costantino, scrive Niccolò Speciale col fiero piglio del Dante, il pio Costatino ad altro uso largiva a Silvestro poverello. Questa moneta armò contro la Sicilia Aragonesi, Catalani, Francesi, Provenzali, Guasconi, Italiani e altre genti; di che fornite a un di presso ottanta galee, fatta tregua col re di Castiglia, navigava re Giacomo a Ostia215, entrando la state del novantotto.
E Federigo, fatto ammiraglio Corrado Doria, che avea nome di valente in mare, armava sessantaquattro galee; forse con grande aiuto dei Messinesi, ai quali in questo tempo raffermò la franchigia delle dogane di mare e di terra, e diede immunità dalle collette, imprestiti e tutte altre esazioni, per premiarli del passato, e ingaggiarli a nuovi sforzi di fede e valore216. Gravate queste galee, oltre i soldati d’armata, di settecento cavalli, impedimento in mare, in terra pochi, salpò di Sicilia, proponendosi antivenire l’arrivo della armata d’Aragona a Napoli. Federigo sulla capitana, spiegando lo stendardo reale di Sicilia, seguito da lunga fila di galee, solcava il golfo di Napoli, a suon di trombe, in atto baldanzoso e minaccevole, senza ch’alcuno uscissegli contro; gittava l’ancora ad Ischia, che teneasi per lui; ove soprastato un bel tratto, fe’ inaspettato ritorno in Sicilia. Speciale il dà ad ammonimento del fratello, che volendo fare romore e non danno, mandava da Roma ad avvertirlo, non arrischiasse tutte le sue sorti lungi dalla Sicilia. Ma ne’ fatti dell’uno e dell’altro in questo tempo, si scorge tutto il contrario che moderazione e pietà di fratelli; onde più probabil sembra che per la flotta sua non provveduta, per avvisi della nimica sì forte, e sopra ogni altra, per non saper che si fare nè egli nè il Doria, buoni soldati ma infelici capitani d’armata, abbandonavano un disegno maggiore assai di loro, mal copiato da que’ maestri assalti di Loria dell’ottantaquattro e dell’ottantasette. Tornò dunque Federigo in Sicilia a munir castella e ordinar forze terrestri. Giacomo, di Roma andò in Napoli con la flotta; e dopo lunghi consigli, affrettandosi tanto che non aspettò stagione, fe’ vela sopra Sicilia a ventiquattro agosto del novantotto217, con gran podere di navi e di genti218; seguendolo non guari dopo, Roberto duca di Calabria, erede della corona di Napoli; e portando con loro, come usato stromento di guerra, un legato della corte di Roma, che fu il cardinale Landolfo Volta219.
Messe in terra le genti vicino Patti, drizzata quivi la flotta, occupava Giacomo l’indifesa città il dì primo settembre: e principiò da questa banda l’impresa di Sicilia, per consiglio di Ruggiero, ch’ebbevi già molte castella, ed or, agognandone il racquisto, il procacciava con dir più agevole in quelle regioni per le sue molte clientele lo effetto delle armi. E in vero i collegati fondarono assai su le pratiche, aiutandole con la scena, niente spiacevole a Bonifazio, del rendersi la Sicilia non a casa d’Angiò, ma alla romana corte, di cui Giacomo si nominava capitan generale, ed esercitò con tal sembianza atti d’autorità, che avrebbero dovuto svegliare a gelosia la corte di Napoli, s’ella fosse stata in tali condizioni da potersi risentir delle usurpazioni de’ suoi alleati, dalle quali tornavate immediato comodo220, S’aggiunse a questo la riputazione de capitani; quando insieme col nome di Loria, suonava quel di Giacomo, principe non caro all’universale in Sicilia, ma intimo con parecchi baroni, riverito da molti per consuetudine a obbedirlo, e ridottato da’ più per arti di regno e valore in guerra. Indi lo sbarco si divulgò per tutta l’isola con terrore; e, sedotte da Ruggiero, s’arreser le castella di Milazzo, Novara, Monforte; San Piero sopra Patti e poche altre. Ma la più parte delle terre d’intorno, non curando lusinghe nè spaventi, tenne per la siciliana causa221. Il re d’Aragona, consumati poco men che due mesi senza maggiore acquisto, cercando alla flotta sua un porto vernereccio più capace, pensò impadronirsi di Siracusa. Andovvi allo scorcio d’ottobre, rinforzate prima le occupate castella; e trovò Siracusa sì gagliarda, da non mancare allo antico suo nome.
Attendatasi la formidabil oste di Giacomo sulla costiera ond’esce in penisola la moderna Siracusa, ch’era di già misero frammento dell’antica, si sparse depredando per la campagna; drizzò le macchine contro il castello dell’istmo; poi die’ furiosi assalti di terra e di mare; e sempre fu niente alla città, forte e fedele, comandata dal pro Giovanni Chiaramonte. Sdegnò costui fin d’ascoltare i messaggi dello insidioso re d’Aragona. Penetrò una congiura, macchinata da chierici, che per promessa di dignità ecclesiastiche, accoppiando simonia a tradigione, profferiano a’ nemici la torre della porta Saccara; i quali furon puniti nel capo. Con estrema costanza i Siracusani patiron la fame: per quattro mesi e mezzo il re d’Aragona indarno li strinse con ogni argomento d’assedio. In questo tratto, di ferro e di morbi scemavasi l’oste; nè più s’allargava in questa orientale, che nella settentrional regione. Buscemi, Palazzolo, Sortino, Feria, Buccheri, gli s’arresero; e Buccheri pochi dì appresso tornò in fede. Mandatovi da re Giacomo il conte d’Urgel a ripigliarla, con un forte di cavalli e di fanti, i terrazzani, rustici e fieri, al dir di Speciale, diersi a combatterlo dall’alta lor postura, con una tempesta di selci, talchè mal concio si ritirò. Ma que’ ch’a furia di popolo avean vinto, la notte fur presi d’un vano timore che non tornassero i nimici con maggior forza; onde la terra sì egregiamente difesa contro gli armati, senz’alcuno assalto abbandonarono. Tal è senza capi la moltitudine. Tali passioni in quel tempo infiammavano i Siciliani, fin delle terra più rozze, ove non son ordini da rendere util valore una natura animosa e pugnace222!
Ondechè Federigo, consigliandosi di far guerra guerriata al nemico che non potea fronteggiare con giusto esercito, ragunò il più che potea genti a Catania, nè troppo discosto, nè troppo vicino al nimico, per vietargli, senza battaglia, di spargersi per l’isola, Nè perchè la città di Patti, tornata al suo nome, l’invitasse all’assedio della rocca, ov’eransi chiuse le soldatesche nimiche, lasciò Federigo l’importante sua postura. Manda a Patti uno stuol di Catalani sotto Ugone degli Empuri, di Messinesi sotto Benincasa d’Eustazio, di Catenesi sotto Napoleone Caputo e altri Siciliani. Ei da Catania confortava i Siracusani a tener fermo, forse con aiuti, certo con larghe concessioni di franchigia nelle dogane, e abilità a legnare nei boschi regi: e redintegrò i confini antichi del territorio; die’ loro la proprietà d’alcuni poderi223. Non lungi dal re, Blasco Alagona stava con un pugno d’audacissimi, a volteggiar, dice lo Speciale, intorno i nimici alloggiamenti, come lupo che non osa assalire i mastini, ma rabida fame lo stiga al ratto. In questo tempo Giovanni Barresi, barone siciliano d’illustre prosapia, ribellatosi da Federigo, per animo non curante del pubblico, ed error di troppa scaltrezza a speculare il privato suo bene224, die’ agli stranieri le castella di Naso e Capo d’Orlando nel settentrione, la forte Pietraperzia nel cuore dell’isola. Sperando quivi sicuro asilo, i mercenari di Giacomo si avventurarono allora a cavalcar il paese più addentro che non soleano. Seppelo Blasco dai suoi rapportatori, e li appostò in Giarratana al ritorno di Pietraperzia. Una notte dunque di folgori e tempesta, mentr’essi, carichi di bottino, venian sicuri al campo, si trovano avviluppati nell’agguato di Blasco, tra sentieri mal noti; nè seppersi difendere, nè trovar via alla fuga. Berengario e Ramondo Cabrera, Alvaro, fratello del conte d’Urgel, con più altri andaron prigioni; pochi scamparono. E Blasco, tutto lieto della prima vittoria contro i Catalani, recò a Federigo in Catania le funate de’ gregari, legati a dieci a dieci, e sciolti, sotto buona scorta, gli uomini di paraggio225.
Più segnalato avvantaggio s’ebbe per mare. Saputo l’assedio del castel di Patti, spiccavansi al soccorso dal campo sotto Siracusa trecento cavalli capitanati dall’ammiraglio, e venti galee cariche di vivanda con Giovanni Loria. Dei quali l’ammiraglio, con ardire e fortuna, cavalcando per lo mezzo della Sicilia nemica, giunse a Patti, e dileguò l’assedio; perchè i nostri, com’era intendimento di quella guerra, scansaron venire a giornata: e dato lo scambio al presidio del castello, stracco o dubbioso nella fede, velocissimo al campo tornò Ruggiero. Dopo lui giunse a Patti l’armatetta di Giovanni, e vittovagliò anco il castello, ma non fu felice al ritorno, Perchè Federigo vedendo qual destro gli offriva la fortuna, di combattere contro una punta sola delle navi nemiche, sopraccorre di Catania a Messina; gittasi nelle braccia dei cittadini, scongiurandoli a montar sull’armata; nè molto penò a infiammarli, sì che avean allestito sedici galee, quando si seppe da’ riconoscitori l’armatetta catalana navigar ne’ mari di Mirto, e poi fur viste le prime galee, che abbandonate da’ venti si sforzavan remigando a valicare lo stretto. S’odono in Messina squillare le trombe per ogni contrada; corrono armati al mare giovani e vecchi; il fratello, scrive Speciale, chiama all’armi il fratello, il padre non respinge i figli che il seguono al rischio; in tutti è una brama, di perire o pigliar vendetta di cotesti Catalani, predon venderecci, venuti a portar guerra ingiusta a’ lor liberatori della vittoria di Roses. Disordinatamente vogan dunque i Messinesi all’affronto, con tal furore che il disordine stesso non nocque. Per breve zuffa, senza molto lor sangue, trionfarono de’ nemici, contrariati dal vento; ogni galea messinese ne cattivò una Catalana; le altro quattro si salvaron fuggendo; ma Giovanni Loria restò tra i prigioni. Al ritorno de’ vincitori, non furono spettacol nuovo a Messina, un re piangente di gratitudine che mescolavasi tra il popolo e combattenti; le donne che traeano agli altari, recando la offerte votate nell’ansietà del rimirar la battaglia. I prigioni più notabili furono chiusi in castello; i minori in altre carceri di Messina e di Palermo, ch’eran Catalani la più parte, e i nostri, com’è aspro il risentimento dopo dimestichezza e vicendevoli obblighi, non contenendosi che non aggravassero la prigionia col dileggio e chiamaronli garfagnini226. Dopo questo disastro poco giovò ai nimici la ribellione di Gangi; ove se vennero il traditor Barresi, Tommaso Procida, e Bertrando de’ Cannelli, catalano, a confortare la terra a difesa, non tardavano a presentarsi ostilmente con armi siciliane Matteo di Termini, maestro giustiziere, uom nuovo, ascendente a possanza nella corte di Federigo, e Arrigo Ventimiglia conte di Geraci s d’Ischia, d’antica nobiltà e nimistà a parte angioina227; i quali trovando ostinati i terrazzani e fortissimo il luogo, davano il guasto al contado228. Ma un altro più grave effetto ebbe il combattimento del Faro. Perchè arrivate al campo di Siracusa le navi fuggenti, ristretti a consiglio Giacomo, Roberto e il legato, co’ principali capitani, consideravano la resistenza durissima di Siracusa, da non vincersi di leggieri: le molte migliaia mancate all’oste229; la flotta menomata, ch’essi in paese nemico non potrebbero ristorare, ma ben i Siciliani la loro, incoraggiati dall’ultima vittoria: e certo fu tra le principali ragioni, che la guerra andava in lungo, e gli stipendi della gente catalana correano scarsamente230. Perciò, messo il partito da un Pietro Cornel, assai riputato tra i condottieri di Giacomo231, si deliberò la ritirata. Raccolsero sulle navi gli arnesi e le tende di maggior prezzo; poser fuoco agli alloggiamenti; e l’armata fe’ prora a settentrione. Lasciati da cinquecento cavalli e duemila fanti nelle occupate fortezze, il re d’Aragona, pria di partirsi di Sicilia, sostava a Milazzo, ridomandando a Federigo le sedici galee co’ prigioni; e promettea che mai più non tornerebbe a’ suoi danni. E forse, quant’era stato bene una volta non ascoltar Giacomo, tant’era in questo incontro assentirgli; e Vinciguerra Palizzi sostenealo caldamente nel consiglio del re, mostrando che a sì grande utilità potea ben sagrificarsi un po’ di vendetta. Corrado Lancia, per lo contrario, stigava Federigo ch’usasse la fortuna; che rispinto ogni accordo, di presente uscisse con l’armata a combattere i Catalani fuggenti: e il re, che non sapea reggersi fuorchè ad altrui consiglio, seguì per abitudine quel di Corrado. Data dunque tal risposta ai legati d’Aragona, Federigo, per novella ira di qualche parola di Ruggier Loria riportatagli in mal punto, affretta il supplizio di Giovan Loria e di Giacomo Rocca, condannati nel capo dalla gran corte, a ragione, per ch’eran rei di tradimento; ma costò poi molte lagrime alla Sicilia. Intanto infellonito contro il fratello, messa in punto tutta la flotta in pochi dì, montovvi Federigo, cercando battaglia. Gliela tolsero un vento fortunale che si levò, e la prudenza di re Giacomo, il quale amò meglio affrontar la tempesta, che il fratello in quell’ira; non sappiam se mosso da carità del sangue, o da coscienza delle proprie sue forze. Perdute due navi tra le isole Eolie, tornossi di marzo del novantanove a Napoli; ove Bianca gli partorì un figliuolo, ei fortuneggiò tra vita e morte in breve malattia, e appena sorto dal letto, sopraccorse in Ispagna ad assicurar le sue frontiere minacciate. Federigo, battuto e mal concio dalla tempesta, si ricolse nel porto di Messina. Nè andò guari che Manfredi Chiaramonte ridusse Pietraperzia; il re stesso, con maggior oste e più duro assedio, Gangi, uscitini a patti i tre baroni nominati dianzi; ed ebbe alsì le castella occupate dai nimici presso Siracusa. Quelle della costiera di tramontana, già vicine ad arrendersi non ostanti i soccorsi di Napoli, instando all’assedio Federigo, furon liberate dal nuovo passaggio de’ Catalani232.
Così allenando in primavera del novantanove, ambo le parti ripigliavan forze al nuovo conflitto. Papa Bonifazio, superbo di questo gran colpo di scatenare il fratello contro il fratello, sì che scrivealo fra le principali sue geste in accrescimento del nome cristiano, e vantavasi delle notti vegliate a macchinarlo, e della moneta gittatavi233, raccolse allora sotto il patrocinio della Chiesa il reame di Aragona, che, assente il re, i vicini nol turbassero; die’ a Giacomo per la guerra siciliana le decime ecclesiastiche de’ suoi reami, e il vescovo eletto di Salerno, legato apostolico da maneggiar censure e perdoni234; ma questa fiata men prodigo fu di danari. Smorzava ciò lo zelo di Giacomo, ch’era cominciato a pentirsi, e tornò ciò non ostante a Napoli in fin di maggio235, perchè l’anno innanzi, fidandosi ne’ sussidi di Bonifazio e di Cario, s’era vincolato a pagar egli i soldati, e indi i debiti stessi lo strinsero a continuar nel servigio de’ due potentati italiani, e raddoppiare gli sforzi alla vittoria. Par che in questo tempo una speranza inaspettata di libertà s’offrisse ad Arrigo, Federigo ed Enzo, figli di Manfredi, per la necessità in cui era Carlo II di far ogni piacere del re d’Aragona, o per altro disegno che non saprebbesi indovinare; e che il disegno o il desiderio dì Giacomo si dileguassero prestamente per la ragion di stato che volea sepolti vivi i veri eredi del trono di Sicilia. Dicemmo già ch’essi, con la sorella Beatrice, passaron dalle fasce alle tenebre e all’oblio della prigione. Ruggier Loria alla prima vittoria del golfo di Napoli ridomandò ben la Beatrice, minor sorella della regina Costanza; non però i tre giovanetti ch’avrebbero conteso alla casa d’Aragona ogni dritto su la Sicilia, e, se non dalla corte, certamente dal volgo, si credeano spenti. Carlo II ordinava a un suo cavaliere il venticinque giugno del novantanove, che li traesse dal castello di Santa Maria del Monte; li vestisse, li provvedesse di cavalli, e liberi li mandasse alla corte di Napoli. Ma la storia nulla ci dice di loro; ed è evidente che i nipoti del gran Federigo, o furon vittima di qualche misfatto, o la loro liberazione fu contrabbandata, o tosto tornarono alla prigione, perchè non s’avviluppasse maggiormente con questi altri pretendenti la gran lite di Sicilia236.
Il re d’Aragona, che per certo facilmente s’acquetò alla sventura de’ fratelli della madre, seppe cavar moneta il più che potea dallo esausto erario di Napoli237. S’acconciò col suocero che questi gli pagherebbe il rimagnente delle spese della passata impresa, sottilmente computato tra i commissari dei due re, per ventimila quattrocento ottantanove once d’oro, obbligandovi Carlo tutti suoi domini, e specialmente l’isola di Sicilia, se avvenisse di racquistarla; e si pattuì ancora, che ripigliando la guerra, lo Spagnuolo avrebbe pronta moneta, nè si farebbero mancare i sussidi per lo innanzi238. Crebbero per cagion di sì gravi spese le penurie della corte di Napoli; ch’indi in questo tempo veggiamo, mal sovvenuta da’ popoli con mendicati doni più tosto che tasse, vender gioielli, e più precipitosamente ingaggiarsi co’ mercatanti toscani che le davano in prestanza, le maneggiavano i cambi, e, come co’ falliti si fa, toglieansi in pagamento le entrate più spedite239. Portan la stessa sembianza gli stentatissimi pagamenti alle soldatesche di Giacomo240; la sollecitudine della romana corte a farsi promettere da quella di Napoli il valsente di tanti poderi, per la massa enorme de’ debiti che si erano ammontati, di censo alla Chiesa, d’imprestiti dei suoi mercatanti, di sovvenzioni per la guerra, di sovvenzioni per la dote della figliuola, con che comperaron Giacomo re d’Aragona241. Per questi travagli ancora, re Carlo vedea nel reame di Napoli prorompere assalti e guerre private, come avviene ove mal reggasi il freno degli ordini pubblici242; avea a temer sudditi volti a praticare con quegli stessi minacciati ribelli di Sicilia243; era necessitato a porre magistrati con istraordinaria autorità nelle città più grosse, ove i consueti modi del reggimento rendeansi inefficaci244. Donde furono debolissimi in tal tempo i nerbi di guerra d’un reame, che dapprima avea armato contro la Sicilia tanti eserciti, tante flotte; nè per numero d’uomini, nè per mole di preparamenti fallò che non la domasse.
Ed or fu costretto Carlo ad accattare l’armata dallo Spagnuolo, nè vi sopperì del suo che poche galee, e remiganti, vittuaglie, attrezzi, ch’erano il frutto di quegli ultimi disperati imprestiti di moneta245. Poco men tristo fu per vero l’esercito di milizie feudali, compagnie di venturieri, e in qualche caso fanti armati dalle città246; e pur non ebbero tanta forza che sbarbassero di terraferma le nostre soldatesche, varie, ribalde, senza disciplina, senza paga. Non che nelle Calabrie sì vicine a’ nostri aiuti, non valser gli sforzi di re Carlo contro picciole castella di Principato stesso, contro le isolette a veggente di Napoli; e fa d’uopo che si volgesse a procacciar tradimenti, aiutandol Giacomo con la sua riputazione appo gli antichi suoi condottieri siciliani e spagnuoli, ch’or teneano per Federigo. Il pro Ruggier Sanseverino conte di Marsico, e quel Ruggier Sangineto che delle romane virtù imitava bene le snaturate ed atroci, or mostraronsi peritissimi a servir Carlo nelle novelle sue vie. Si pensò mandar la flotta catalana sopra Ischia, Procida, Capri, che teneano il governo angioino in molto sospetto, e sbarcarvi saccardi di Napoli, Capua, Aversa, che dessero il guasto alle campagne: e mal ritraesi se la fazione fu dismessa o fallì; certo che le tre isole resistettero fino alla sconfitta del Capo d’Orlando247. A castell’Abate, sulla meridional punta del golfo di Salerno, che i nostri per tredici anni avean tenuto con mirabile costanza, andò il Sanseverino, men a combattere che a trattar tradimento con alcuni almugaveri del presidio, spagnuoli e siciliani, che passaron di lì a poco a’ soldi dell’Angioino. Sforzato da questi sleali, o da’ terrazzani, Apparente di Villanova capitan del castello, all’entrar di marzo del novantanove pattuiva che darebbe la piazza, salve robe e persone delle sue genti, con immunità larghissime e sicurtà degli abitatori della terra, s’a capo a trenta dì non fosse soccorso da Federigo; il quale non potendo mandar alcuno aiuto, s’arrese alfine il castell’Abate, con vana mostra di venirvi i principi Roberto e Filippo e grande oste del regno248. Sembra che per simil guerra tornassero all’ubbidienza del re di Napoli, Rocca Imperiale e Ordeolo, terre in Basilicata e val di Crati, alla cui espugnazione si fece gran ressa. Tenne fermo il castel di Squillaci249. Vendè Otranto il traditore Berengario degl’Intensi, catalano, passato co’ suoi venturieri a parte nemica, e rimasovi in dubbia fede, sì che l’imprigionarono; ma poi gli ottenne mercede Giacomo, amico di sì fatti ribaldi250. Altri ne fallirono a Federigo in questo tempo medesimo; i quali, al par che l’Intensa, credean colorire il prezzo del tradimento, con farsi pagar dai nemici i loro stipendi, non soddisfatti dal re di Sicilia, o così essi diceano, non trattenendosi forse dalla menzogna poichè s’eran gittati al più vil dei misfatti. Così Giacomo trattò col castellano di San Giorgio in Calabria, e il volse a parte angioina251. Guidone Spitafora, che reggea per Federigo la terra di Taverna in Calabria, sedotto da Sangineto, la rese a tradigione, ed ebbesela in feudo. Per simil premio, il Sangineto ordiva che rendesse al nome d’Angiò Martorano anco in Calabria. Precipitavano alla corruzione i privati, tra tanti rivolgimenti e pericoli de’ governi. Precipitava alla corruzione, per troppa voglia e debolezza, lo stesso Carlo II, cui dritto animo e pietà cristiana non ritennero, non che dal trattare i tradimenti delle dette due terre, ma dal por giù ogni pudore, scrivendo in questi casi ne’ suoi diplomi latini: «Onore è ciò che toglie molestia;» che suona bisticcio miserabile in quell’idioma, e bestemmia nel linguaggio dei giusti252.
Federigo al contrario, sommo magistrato d’un popolo ritempratosi nella rivoluzione, convocando il parlamento a Messina, cospicuo nelle regie vestimenta, dal soglio esordiva con la parola del profeta, «Morire in guerra, pria che mirare i mali del popol tuo.» Vivamente ei dipinse l’ingratitudine di Giacomo, or vegnente con fresche masnade e con due principi del sangue d’Angiò, contro il fratello, contro quest’isola che il crebbe alla gloria, ed egli s’apprestava per gratitudine a guastare e depredare i campi, a rovinar le città, a versare per vil prezzo il sicilian sangue. «Or noi, dicea Federigo, salviam le ricchezze del nostro suolo, antivenendo l’assalto, mentre son intere le forze del reame; combattiamo in mare questi vecchi nemici, le cui cento bandiere veggonsi appese ne’ vostri tempi, questi nuovi avversari, assai più ingiustamente armati contro noi, onde già li sgarammo nella prima prova, e peggio or li confonderà Iddio. Per noi la ragion delle genti; noi per la patria e per le case nostre combatteremo!» Troncò questo parlare la siciliana impazienza, tuonando al solito a gran voce «Guerra»: e per tutta la nazione si fe’ un gran dire contro il protervo Giacomo, un chieder arme, uno stigarsi l’un l’altro alle battaglie ed al sangue. Indi appellati i feudatari e i borghesi, di gran volontà, frettolosi accorreano a Messina. S’apprestò la flotta, di quaranta galee: e saputo già in mare il nimico, poichè tutte le genti fur montate in nave, re Federigo ascese la capitana, riccamente ornata e dorata, e si spiegaron le vele. Il popol di Messina, affollato intorno al porto, le accompagnò con evviva, lagrime, voti253.
Navigava que’ mari nel medesimo giorno la flotta catalana, rifornita al ritorno di Giacomo, rinforzata di poche galee del reame di Napoli; che salpò il ventiquattro giugno254, e portava il re d’Aragona, con Roberto duca di Calabria, Filippo principe di Taranto e Ruggier Loria: acceso costui a vendicare il supplizio di Giovanni; i Catalani a lavar l’onta di quella sconfitta; Giacomo a finir presto le brighe di questa guerra. Erano alle isole Eolie, drizzandosi alla più vicina costiera di Sicilia, quando un legno siciliano sottile, uscito a riconoscere, tornò a vele e a remi a darne avviso alla nostra flotta, che, superato lo stretto, prendea già Milazzo. Indi i nostri a dare forzosamente ne’ remi, anelando prevenir lo sbarco; ma il tardo avviso, o i venti, o maggior arte dell’ammiraglio nemico, fecero che già guadagnati i lidi di San Marco, alla foce della fiumara Zappulla, gittate avea le ancore, rivolte le prue al di fuori, in ordine di combattere, quando la siciliana flotta, al girare il capo d’Orlando, l’avvistò. Scoppiava dalle nostre ciurme un impeto d’allegrezza all’aspetto del nemico; fean suonare infino a’ cieli il nautico grido di guerra aur, aur, tolto un tempo da que’ Catalani medesimi; e a testa alta, infelloniti e bramosi, senz’ordine arrancavan sovr’essi. Potè Federigo a stento por freno a questa temerità, tanto più cieca, quanto in brev’ora si aspettavan dai mari di Cefalù otto galee di val di Mazzara con Matteo di Termini; e ’l giorno se n’andava; le navi nimiche si vedean legate sì salde alla spiaggia e tra loro, che non la flotta veneziana e la genovese congiunte alla nostra, diceano i pratichi, l’avrebbero sforzato giammai. A’ risoluti comandi del re, le ciurme ubbidirono, non s’acquetarono; e proverbiavanlo: «Che fa? che dorme? scordò chi siam noi? Invilì Federigo; o riguarda il fratello, e vuoi torcerlo di mano!» Così gonfi da tanti anni di fortuna in guerra, dandola alle lor braccia sole, non curanti s’avessero ammiraglio, o il sol nome, nè dove fosse il gran Loria, tardava loro mortalmente quella notte di state. Placidissima sorrise nel firmamento, mentre negli animi dei mortali bollivan tante ire, tanti pazzi immaginari di combattimenti, glorie, acquisti, vendette, paure. Il cauto Giacomo fe’ sbarcar cavalli e bagaglie e quanti pareano men validi al combattere; chiamò i presidi delle castella; e la mattina a dì, sulla spiaggia, parlando d’alto tra’ suoi baroni, esortava le genti. Dicea dell’ubbidienza alla santa sede; de’ lor maggiori combattenti sempre per la fede; s’ei balenò alquanto, s’era poi ravveduto; ammonito non potersi salvar l’anima del genitore, che sarebbe cruciata da atroci flagelli, finchè non si rendesse la Sicilia: onde tra la pietà del padre e del fratello, la prima avea vinto. «Voltici al buon sentiero, aggiugnea, quante offese non patimmo da questa indomabil genìa di Sicilia, che da noi apprese a combattere! Or eccola; minor di numero, minor di legni, e pur invasa di cotanta baldanza contro gli uomini e Dio! Gastigatela, Catalani!»
Indi con tutta l’oste montò sulle cinquantasei galee ordinate in una linea di battaglia, con le ali distese, da soverchiare la minor linea nostra; e nel mezzo stette la capitana, col re e i figli dell’Angioino. A dirimpetto le s’era locato Federigo, standogli a dritta diciannove, a manca venti galee; e comandava alla poppa della sua nave un Bernardo Ramondo, conte di Garsiliato; alla prora Ugone degli Empuri, fatto conte di Squillaci; nel mezzo guardava lo stendardo reale Garzia di Sancio, con un gruppo di guerrieri fortissimi. Erano d’ambo le parti, noti, amici, congiunti; capitani due fratelli; come in guerra civile. Perciò più rabbiosamente, di qua di là mossero all’affronto, il sabato quattro luglio milledugentonovantanove, poco appresso il sorger del sole. Alle spalle de’ nemici la riva di San Marco, a dritta il capo d’Orlando; venian di fuori i nostri. S’udì squillo di trombe, fracasso di grida, tonfo di remi, e in un attimo sparve il mare di mezzo.
Con le armi da gitto trassero gran pezza, e non a voto. Ma Gombaldo degl’Intensi, giovin feroce, vago di gloria, e fors’anco di vendicare il suo nome, deturpato dal fratello traditor della Sicilia, sdegnando quel combattere da lungi, tagliata la gomona che il legava alle altre galee, la nimica fila investe. Due navi gli furo addosso dalle bande, una da prua; dan di cozzo, vengono all’abbordo: e Gombaldo, con bell’ammenda della temerità, contro tal pressa difendeasi, ancorchè ferito, e fieramente ributtava i nemici. Strettasi pertanto la mischia per tutta la fronte, incominciò più micidial furia di sassi e dardi vibrati da presso: le navi ad urtarsi di prua, di costa, a dar co’ remi su i remi dei nemici; ostinatamente infino alla sesta ora del dì, con molto sangue, senza avvantaggio d’alcuno, si combattè. Federigo cercava Giacomo; estremo orror si vedea in questa battaglia, se non si trovavan di mezzo le altre navi, ingaggiate e accanite tra loro, che tolsero di riscontrarsi a’ fratelli. Sotto la sferza del sole, nel caldo del luglio, cocente quel giorno oltre l’usato, s’accese ne’ combattenti da fatica, da paura, da rabbia, dal perduto sangue una rabida sete. Nè vino, scrive Speciale, nè acqua la spegnea. Gomabaldo, trafelante, bruciato, date tutte le forze vitali in tante ore di bollente battaglia, cercò un attimo di riposo, s’adagiò sullo scudo, e spirò. L’ardire di costui preparava, la sua morte cominciava la rotta. Guadagnano i nemici alla fine la nave di Gombaldo: avviluppate tra loro con le gomone, co’ remi, mal s’aiutavano le altre nostre galee; quando si sentiron alle spalle ferir da sei navi ordinate a ciò da Ruggiero. Allora, perduta la speranza del vincere, allenarono nella difesa; soprastettero un istante; sei galee diersi alla fuga.
Federigo, dicon le istorie, come vide piegare i suoi, risoluto a morire, chiedea di Blasco, che fianco a fianco spargessero il lor ultimo sangue; alla ciurma gridava: «Non restargli altro che la vita a dare per lo popol suo;» e per vero gittavasi disperatamente tra le navi nemiche, se non che d’un subito, vinto anch’egli da passione, caldo, fatica, stramazzò tramortito sulla tolda. Estrema ansietà allor nacque ne’ suoi più fedeli: che farebbesi della persona del re, mentre in ogni attimo era vita o morte? Il conte di Garsiliato pensava di rendere a’ nemici la spada di Federigo; Ugon degli Empuri gli die’ sulla voce; comandò di vogare a Messina; e per disperata forza di remi, la capitana involossi ai nemici, e con essa dodici altre galee. Blasco, che combattea non lasciando mai degli occhi il diletto suo principe, come vide fuggir la nave, posposto a lui ogni cosa, comanda a’ remiganti che il seguano, al suo alfiere che ravvolga lo stendardo; e l’alfiere, rispondendogli che non vedrebbe mai Blasco Alagona lasciar la battaglia, die’ del capo rabbiosamente sull’albero della galea, e cadde semivivo; la dimane spirò. Ferrando Perez il suo nome. Seguirono altri strani casi nella sconfitta. Vinciguerra Palizzi, testè creato gran cancelliere del regno, in cambio di Corrado Lancia che fu sì avventuroso da morire innanzi questo misero giorno255, Vinciguerra, per antico rancore cercato a morte dall’ammiraglio, sopraffatto da quattro galee, dopo bella difesa, saltò sopra una barchetta vicina a caso, e rifuggissi ad altra nave. Così ancora Alafranco di San Basilio e altri nobili, gittatisi a nuoto. I più, soverchiati dal numero, pugnarono con cieco furore, finchè saliti sulle navi i nemici, incominciò un macello. Perchè l’ammiraglio con sinistra voce urlava: «Vendicate Gian Loria!» e nobili e plebei immolati cadeano, con mazze, coltelli, mannaie, o scagliati in mare: tanto che sostarono i soldati per pietà; e l’ammiraglio pure a comandar sangue, a percorrere le prese navi, più atroce contro i Messinesi, dei quali fu grandissimo lo scempio. Federigo e Perrone Rosso, Ansalone e Ramondo Ansalone, Jacopo Scordia, Jacopo Capece e altri nobili di Messina perironvi; poi per istanchezza si cominciò a far prigioni, a dar di mano al bottino. Pier Salvacossa, fuggitosi non a Messina col re, ma ad Ischia, vilmente cercò la grazia de’ vincitori con render l’isola, ch’avea tre anni prima difeso con singolare virtù256
206
Federigo rimeritò la lealtà di Randazzo con alcune franchige nelle dogane di terra e di mare, per diploma del 15 giugno 1299, pubblicato dal Testa, op. cit., docum. 17.
207
La fellonia di Tommaso di Lentini è confermata da un diploma del 18 febbraio 1299, col quale Federigo die’ in feudo a Bartolomeo Tagliavia la terra di Castelvetrano, posseduta da quello. Nei Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 3.
208
Nic. Speciale, lib. 3, cap. 22.
Anon. chron. sic., cap. 57.
La presenza di Federigo all’assedio di Castiglione, si attesta da un diploma del 27 agosto 1297, dato nel campo sotto Castiglione, pubblicato dal Testa, Vita di Federigo, docum. 11. La dedizione del castel di Aci è da porsi nel mese di novembre 1297, perchè non tardò guari dopo quella di Castiglione ma infino al 18 novembre sapeasi in Napoli che tenesse pur quel castello; come si scorge da un diploma pubblicato dal Testa, ibid., docum. 14.
209
Sembra che questa guerra di Calabria, di che parla Speciale, sia stata la cagion della chiamata al militar servigio in tutto il reame di Puglia, della quale ci restan moltissimi diplomi dati a 19 aprile, 7, 22, 23, 25, 27 e 30 maggio, 2, 11, 17, 18, 20, 22 giugno 1297, nell’Elenco delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. II, pag. 179 a 188. Ivi si legge a pag. 180 un altro diploma del 4 maggio, che accorda once 10 a un Giovanni pro sumptibus itineris ad exercitum.
210
Conferma questo attestato dello Speciale un diploma del 29 aprile 1297, col quale Roberto vicario generale dava a Riccardo de Avenis alcune terre in Calabria, dummodo infra kalendas Augusti ad Ecclesie romane et Regis fidem redeat a qua defecerat. Elenco cit., tom. II, pag. 179.
211
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 1.
212
Diplomi del 18 novembre (certamente 1297) e del 9 febbraio undecima Ind. 1298 (si legge 1297 computando gli anni dal 25 marzo), pubblicati dal Testa, Vita di Federigo II, docum. 14 e 18.
213
Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 33.
214
Diploma del 18 novembre 1297 citato di sopra, e i molti altri accennati nel seguito di questo capitolo.
215
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 2.
L’Anon. chron. sic., cap. 59, porta l’impresa di Giacomo, operante supradicto papa Bonifacio.
Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 33.
Montaner ci abbandona al tutto in queste guerre di Giacomo contro Federigo. Porta gli armamenti del primo, come fatti per amor di fermare la pace tra re Carlo e Federigo; a questo il dice venuto in Italia con centocinque galee; nè fa motto del passaggio in Sicilia nel 98, nè di quel dell’anno appresso, nè della battaglia del capo d’Orlando; ma crede aver soddisfatto all’uficio d’istorico, chiudendo il cap. 186 con queste parole: «Altri senza dubbio dirà: come dunque Montaner passa sì lieve su questi fatti? Se tai parole indirizzasse a me, replicherei che v’ha delle domande le quali non meritano risposta.»
Le trattative intorno la restituzione al re di Maiorca non appartengono direttamente al presente lavoro, ma fan vedere che Bonifazio per amor dell’impresa di Sicilia sagrificava gli interessi di Giacomo di Maiorca, e temporeggiava con Filippo il Bello che li volea sostenere. Ciò si conferma coi documenti degli archivi del reame di Francia qui appresso notati:
Diploma di Giacomo re d’Aragona, dato di Valenza a 15 febbraio 1237, permettendo a Carlo II di stabilire in suo nome, che per due anni non farebbe guerra a Filippo il Bello, e permetterebbe i commerci co’ suoi sudditi, J. 588, 20. Breve di Bonifazio dell’8 agosto 1297, pel quale temporeggia con Filippo il Bello, che insisteva a favore del re di Maiorca, J. 715, 24. Diploma di Giacomo di Maiorca, dato a Saint–Germain–des–Prés l’8 gennaio 1298, consentendo un certo differimento alla restituzione, stabilito tra i re d’Aragona e di Francia, J. 598, 1. Atto pubblico dato in Aix a 2 maggio 1298, nelle stanze di Carlo II, che stipola le condizioni coi re di Francia e Maiorca, a nome di Giacomo d’Aragona; secondo il citato diploma del 15 febbraio 1297, che anche trascrive, J. 511, 6.
216
Diploma del 15 giugno 1298, tratto da’ registri della real cancelleria di Sicilia, pubblicato dal Pirro, Sicilia sacra, pag. 409, ed. 1733.
217
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 3 e 4.
Anon. chron. sic., cap. 58, 59.
218
Il Testa, nella Vita di Federigo, porta l’armata ad 80 galee e 90 altre navi, non computatevi le sottili; a 500 cavalli e 1,156 pedoni le genti da sbarco venute d’Aragona con Giacomo. Quest’ultimo numero è tolto da un diploma del 23 giugno 1299, il quale per vero non descrive le forze portate da Giacomo, ma quelle da lui lasciate in Sicilia al fine di questa prima impresa, che poteano esser minori per cagion degli uomini perduti nella guerra, o maggiori pei Catalani e altri avventurieri che poi vi s’aggiugnessero. Picciolissimo fu in questa armata il numero delle navi napoletane, come si vede da parecchi diplomi dati tra il fin di marzo e mezz’aprile 1299, nel r. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 1 a 15.
Quanto alle forze terrestri, che furono certo assai grosse, si vegga nel seguito del presente capitolo ciò che scrive Spedale delle perdite sofferte nello assedio di Siracusa.
L’Anon. chron. sic. porta venuto Roberto con re Giacomo. Speciale. non ne parla che nel consiglio per discior l’assedio di Siracusa. E per vero si ritrae ch’ei passava in Sicilia in fin di novembre 1298, o più tardi; leggendosi in alcuni diplomi che i feudatari del regno di Napoli dovessero far la mostra alla sua presenza in Napoli il dì 20 novembre per muover contro la Sicilia. Elenco delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. II, fog 209 e 210, diplomi dell’8 e 23 novembre 1298.
219
Anon. chron. sic., cap. 59.
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 10.
Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 35.
220
Veggansi le concessioni feudali in Sicilia fatte da Giacomo a Fulcone Barresio, per diploma del 13 settembre 1298, e a Simone de Belloloco e Filippo di Porta, per altre carte accennate ne’ diplomi del 24 luglio 1299 e 28 dicembre 1300, e la intitolazione d’un atto pubblico dato di Novara il 1 luglio 1299; de’ quali diplomi, il primo e l’ultimo citansi nel seguito di questo capitolo, gli altri due nel cap, XVII. Non abbiam traccia di alcuna delegazione di tanta autorità, che facesse Carlo II a Giacomo. E però è manifesto, che Giacomo la esercitava come capitan generale della corte di Roma, la quale poco prima avea disposto di dare in feudo a Loria il castel d’Aci, come sopra si è detto. La finzione del ceder l’isola a Roma presto fu dismessa; ma non cessarono le pretensioni di Bonifazio, anzi ne nacque una timida gelosia nella corte di Napoli, come si argomenta dal diploma di concessione feudale a Virgilio Scordia, docum. XXXVI.
221
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 4.
Anon. Chron. sic., loc. cit.
222
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 5.
Anon. chron. sic., cap. 59.
223
Diploma del 8 gennaio 1299 (per errore 1297 col computo dell’anno dal 25 marzo), pubblicato dal Testa, Vita di Federigo II, docum. 9.
224
Parmi che tornino a questo concetto le parole di Speciale: plus sapere quam oportebat attentans, neque intelligens verbum illud: curo possidente possideas. Questo traditore giovò molto alla causa dei nemici, come si vede da un diploma di Carlo II, dato il 1 luglio 1299, nel quale è perdonato e redintegrato ne’ suoi feudi, perchè se nella ribellione fallì per concorso, oggi ravveduto, osservava la fede al re angioino, animo et opere. Nel r. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 158 a t. e 24 a t.
Oltre a questo, il governo angioino, per diploma dato lo stesso dì, gli concedea l’aspettativa di altre terre e feudi, del valore d’once cento annuali. Ibid., fog. 158.
Mostra ancora la importanza del Barresi, che fu seguito da un suo fratello per nome Fulcone, un altro documento. A costui Giacomo re d’Aragona die’ in feudo in Sicilia a dì 13 settembre 1298, con diploma dato di Milazzo, pe’ suoi continui e rilevanti servigi a pro della Chiesa, il castello e casal di Chila tra Mineo e Caltagirone, con mero e misto impero. Raffermò questa concessione Roberto a dì 10 settembre 1299 da Aidone; e Carlo II da Napoli a 16 febbraio 1300. Nel r. archivio di Napoli, reg. 1299–1300, C; e ne’ Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 2, fog. 88.
Il di Gregorio, nella Bibl. arag., tom. II, pag. 520, pubblicò un diploma di Federigo, pel quale furon conceduti a Blasco Alagona il castello e la terra di Naso, posseduti una volta da Giovanni e Matteo Barresi traditori. Questo documento porta la data di Palermo a 26 gennaio decima Ind. anno dell’Incarnazione 1297, e 2o del regno di Federigo; ma io credo errata manifestamente questa data, perchè la decima Ind. cadde bene di gennaio 1297 nell’anno comune, ma nell’anno dell’Incarnazione rispondeva al gennaio 1296. Indipendentemente da tal errore, si può corregger senza alcun dubbio duodecima ind. gennaio dell’anno dell’Incarnazione 1298, ossia gennaio 1299 dell’anno comune, perchè Barresi si ribellò da Federigo al passaggio primo di Giacomo, cioè tra agosto 1298 e la primavera del 1299 dell’anno comune. Il riferisce Speciale, diligentissimo nel descrivere questi tempi di Federigo, ne’ quali ei visse ed ebbe alto stato.
225
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 6 e 7.
226
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 7 e 8.
Tolomeo da Lucca, Ann. in Muratori, R. I. S., tom. XI, pag. 1303. Anon. chron. sic., cap. 60, che porta un po’ diverso il numero delle galee.
Non mi è riuscito di trovare una interpretazione plausibile di questo soprannome di Garsagnini o Garfagnini, con ch’eran proverbiati que’ prigioni catalani. Gli scrittori contemporanei non ne danno la origine; non si trova nella nostra lingua parlata; il Du Cange, nel glossario, la nota senz’altra spiegazione, che d’essere stata adoperata come ingiuria nel caso particolare narrato di sopra. Il Testa, leggendola garsagnini, spiega per sfregiati, marcati, rappiccandola con la voce garsa che suonava profondo cincischío, e così è rapportata dal Du Cange, e così resta ancora nell’idioma siciliano, in cui talvolta si pronunzia anche gassa. Ma io non so accettare che i siciliani guerrieri di que’ tempi, si beffassero delle cicatrici di altri guerrieri; a d’altronde questo combattimento del Faro non fu sì ostinato, che la più parte de’ prigioni potesse escirne con ferite. Perciò crederei più tosto leggere garfagnini per metatesi da qrafagnini, grifagnini, grifagni, o derivato da aggraffare, e in siciliano aggranfari. Ed era ben naturale che i nostri guerrieri cittadini dessero di saccardi, predoni, rapaci ladroni, a que’ soldati venderecci di Giacomo.
Non credo che questo soprannome potè trarsi in alcun modo dai Garfagnini, abitatori della Garfagnana nello stato di Modena.
227
Nel r. archivio di Napoli, reg. seg. 1271, sì legge un diploma del 12 gennaio decimaquarta Ind. (1278), col quale è conceduta a Guglielmo de Mosterio la terra di Grattieri, posseduta già dal conte Arrigo Ventimiglia, traditore, dicea re Carlo.
228
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 9.
229
Speciale dice 18,000 uomini perduti; ma sembran troppi.
230
Si vede dal citato diploma del 23 giugno 1299, Testa, docum. 16.
231
Nello stesso diploma e in un altro della stessa data del 23 giugno, citato nel seguito di questo capitolo, si fa menzione di Pietro Cornel, nominato da Speciale in questo luogo.
232
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 10 e 11.
Anon. chron. sic., cap. 60 e 61.
Per la infermità di Giacomo in Napoli e il figliuolo quivi partoritogli da Bianca, veg. Surita, Annali d’Aragona, lib. 5, cap 37 e 38.
La data del ritorno di Giacomo in Napoli dopo questa prima impresa di Sicilia, si conferma per un diploma dato di Napoli a 5 marzo duodecima Ind. (1299), nel quale, dicendosi abbisognar molto frumento pro adventu illustris regis Aragonie, il re comandava trovarne subito 2,000 salme e farne biscotto, sì che fosse pronto il 12 marzo. Nel r. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 41 a t.
Tra le terre ch’eran rimase a’ nemici in Sicilia fu anche Novara, e tenne per Loria, come si ricava da un diploma del 1 luglio 1299, dato in quella terra col titolo di re Giacomo d’Aragona…existente etiam et dominante domino nostro domino Rogerio de Lauria milite, regnorum Aragonum et Sicilia ammirato, nec non et gratia Dei et regis et per sanctam Romanam Ecclesiam inclito domino Castellionis, Francavillae Nucariæ, Linguegrossae, Cremestadis, S. Petri supra Pactas, Ficariæ, et Turturichii, sui dominii praedictarum terrarum et locorum anno primo feliciter, amen.
Dal monastero Cisterciense di Santa–Maria di Novara. Tra’ Mss. della Bibl. com. di Palermo, Q. q. G. 1, fog. 178.
Quanto a’ soccorsi di Napoli alle castella che teneansi nelle costiere settentrionali di Sicilia, dà validissimo argomento a supporli un diploma del 1 aprile tredicesima Ind. 1299, col quale è ordinato di mandarsi ad partes Sicilie per conto di Ruggier Loria 10 salme di sale. Certamente il governo di Napoli non si limitava a questa sola provvedigione. R. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 31.
233
Raynald, Ann. ecc., 1298, §. 17, breve al patriarca d’Armenia, 26 ottobre anno 4.
234
Ibid. 1299, §§. 1 e 2, brevi dell’8 e 9 giugno.
235
Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 87, 88.
236
Docum. XXIX e XXX.
237
Dei pagamenti fatti a Giacomo in Napoli dan fede i diplomi del 21, 22 e 25 marzo e 4 maggio, 15 e 18 giugno e 8 luglio duodecima Ind., nel registro del r. archivio di Napoli segnato 1299, A, fog. 24, 23, 33, 54 a t., 92 a t., 110 e 209 a t. Son quietanze ai capitani delle città di Aquila, Lucera, Guastimone e Salerno per le somme consegnate a Consalvo Garzia, commissario del re d’Aragona, e tolte da’ sussidi che quelle città avean promesso per la presente guerra.
Tre diplomi del 30 maggio, 6 giugno e 8 luglio attestano il pagamento di altre once 220 al medesimo Consalvo Garzia, su la sovvenzione che forniva la città di Napoli; e tutti questi danari furono di carlini d’argento di 60 all’oncia. Ibid., fog. 126 a t. e 138 a t.
Un altro diploma del 24 giugno duodecima Ind., porta il pagamento stipendi di alcuni uomini d’arme del re di Aragona, fatto dall’erario di Napoli per mezzo di Consalvo Garzia. Un di questi condottieri, per nome Bertirando Artus, avea 12 once al mese, e’ suoi scudieri 2 once; un altro condottiero 6 once, ec. Reg. citato 1298, A, fog. 115.
Questi pagamenti stentati e spezzati, fatti a misura che s’avea il denaro delle sovvenzioni, ancor mostrano quanto fosse esausto l’erario di Napoli in quel tempo. Veg. anche i diplomi del 25 maggio, 5 e 23 giugno nelle seguenti note.
238
Diploma del 23 giugno 1299, dal registro del r. archivio di Napoli segnato 1299, A, fog. 111, pubblicato dal Testa, op. cit., docum. 16, dal quale si ricavano i seguenti particolari:
Che Giacomo avea lasciato in Sicilia 79 cavalli alferrati (cioè uomini scelti, armati da capo a pie’, donde forse presero il nome gli alfieri o portatori d’insegna), 422 altri cavalli, e 1,156 fanti; da pagarsi da gennaio ad aprile 1299, per once 5,259; e per maggio ancora, nel numero di 78 cavalli alferrati, 426 cavalli e 1,203 fanti, per once 2,071,15.
Che la flotta catalana si dovea pagare per 5 mesi da gennaio a tutto maggio; ma si contentava di 4 mesi di soldo per once 8,951, essendo rimasta gran pezza ne’ porti.
Che tornaron di Sicilia con Giacomo alferrati 28, cavalli 425, fanti 151 ch’erano già soddisfatti in Napoli.
Che i Catalani andavan creditori inoltre di once 6,085,28, per supplimento a’ cavalli morti o perduti.
Da ciò si argomenta ancora che a tutto dicembre 1298, avea pagato queste genti il papa o re Carlo.
239
I mercatanti fiorentini, massime della compagnia de’ Bardi, prestavan danari a re Carlo, pigliando in sicurtà o in isconto la tratta de’ grani.
Diploma dell’ultimo febbraio duodecima Ind. (1299), nel quale si legge che il danaro col quale gli angioini comperarono dal traditore Berengario degli Intensi la città d’Otranto, era stato pagato in parte dal mercatante Bartolomeo della compagnia dei Bardi, la quale avea promesso dare in prestito alla corte di Napoli a tutto marzo 1299 once 4,000, e le era stata ceduta la tratta di 40,000 salme di frumento. Nel r. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 22.
Diploma del 25 maggio duodecima Ind. a Lippo Ildebrandini e altri della compagnia de’ Bardi di Firenze. Saducetto d’Adria graffiere di Carlo II, e Consalvo Garzia cavaliere di re Giacomo, erano stati deputati insieme a raccorre il danaro della sovvenzione generale per la guerra, e tutt’altro danaro appartenente a Carlo o a Giacomo. La compagnia Bardi avea promesso once 4,000 per prezzo della tratta di 40,000 salme di grano. E i due suddetti le davan questa scritta per le once 4,000, da lei veramente pagate. Reg. cit. 1299, A, fog. 185.
Diploma del 5 giugno duodecima Ind. Carlo II dà cautela per 10,000 once d’oro, pagate da alcuni mercatanti della compagnia degli Spini di Firenze, mercatanti di Bonifazio VIII. Questo danaro era stato rassegnato in vari giorni, a un cassiere dei re e a Consalvo Garzia. E Bonifazio il dovea a Carlo pro pretio quorundum jocalium. Ibid., fog. 183.
Diploma del 23 giugno. Sen vede che a tutto quel mese Giacomo dovea a Pietro Cornel condottiero, per stipendi e prezzo di cavalli, once 1,941. Per mezzo de’ Bardi ne fu pagata una parte in Provenza; il rimanente dovea soddisfarsi entro un anno. Ibid., fog. 112. Questo Cornel, citato dallo Speciale come consigliator della ritirata da Siracusa nel 1298, nella state del 1299, pria della nuova impresa, se ne tornò in Ispagna, come si vede da un altro diploma dato l’8 giugno, ibid., fog. 104, che gli accordò il permesso dell’uscita dalle frontiere.
Diploma del 23 giugno duodecima Ind., per once 1,120 date in prestito da Benedetto Bonaccorsi della compagnia de’ Bardi di Firenze, con cessione di tratta dì grani. Ibid., fog. 141.
Diploma del 23 giugno 1299, ibid., fog 96 a t., che contiene altri imprestiti e cessione della tratta di grani alla compagnia de’ Bardi di Firenze.
Diploma dell’ultimo di giugno duodecima Ind. Altri imprestiti de’ Bardi. Ibid., fog. 97.
Diploma dell’ultimo di giugno. Da questo si vede che la compagnia de’ Bardi avea casa in Marsiglia; e che avea tratto di Marsiglia e pagato in Napoli once 2,200 per tasse di Provenza, e decime ecclesiastiche di quelle chiese, concedute dal papa per la presente guerra. Ibid., fog. 185 a t.
Altro diploma del 4 luglio, ibid., fog. 147, per altri imprestiti di mercatanti italiani.
Diploma del 2 agosto duodecima Ind., ibid., fog. 167 a t., per un’altra tratta di vittuaglie alla stessa compagnia.
Altri se ne veggono sullo stesso proposito nell’Elenco delle pergamene del medesimo r. archivio, tom. II, pag. 193, 213 e 215, in data del 5 maggio 1298, 7 gennaio, 20 e 25 febbraio 1299.
Molti altri diplomi attestano che la compagnia de’ Bardi avea in affitto la zecca di Napoli; e talvolta gli ufici delle segrezie di qualche provincia.
240
Veg. la nota 238, pag. 128.
241
Diploma del 12 febbraio duodecima Ind. 1299, dall’archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 17. Vi si legge come tre cardinali da parte di Bonifazio aveano intimato a Carlo che pensasse a soddisfare i grossi debiti verso la santa sede, per imprestiti a lui e al padre, censo non pagato, e sussidi sì nella guerra, sì per lo maritaggio della figliuola con re Giacomo.
242
Diplomi del 18 e 20 marzo, 8 e 23 aprile, dai quali si ritraggono vari atti di forza privata commessi da masnade e genti armatesi popolarmente in Vico, Maddaloni, e altre terre anche in Principato. Ibid. fog. 21 a t., 23 a t., 30 a t., 51, 75.
243
Diploma del 25 marzo duodecima Ind. per le vittuaglie che si portavano clandestinamente a’ confini dei nemici in Basilicata, particolarmente dalla terra di Colubrano. Reg. cit. 1299, A, fog. 24 a t.
Diploma del 9 aprile duodecima Ind., al capitano di Bari. È la commissione del suo uficio, pel buono e pacifico stato de’ cittadini, e perchè ab hostium non ledantur insidiis. Ibid., fog., 26.
244
Diploma del 22 marzo duodecima Ind., ibid., fog. 23, nei quale si legge un capitano in Lucera.
Diploma del 26 marzo duodecima Ind., pel quale è eletto un capitano in Bari con mero e misto impero. Ibid., fog. 25.
245
Diploma del 26 marzo duodecima Ind. (1299), col quale è fornita una picciola somma per riparazione delle galee testè tornate di Sicilia. R. archivio di Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 524.
Diploma del 9 aprile duodecima Ind., perchè si fornissero di biscotto alcune galee napoletane e aragonesi nel porto d’Otranto. Ibid., fog. 31 a t.
Diploma del 12 aprile duodecima Ind., per comperarsi subito gran copia di stoppa da rispalmar le galee. Ibid., fog. 51 a t.
Diploma del 2 maggio duodecima Ind., per cinque galee catalane ch’erano a Brindisi, e si dovean vettovagliare, e armarne quattro, non bastando la gente per cagion delle malattie. Ibid., fog. 65 a t.
Diploma del 29 maggio duodecima Ind. Remiganti in gran copia assoldati in Pozzuoli, Salerno, Sorrento, e Castellamare. Ibid., fog. 85.
Vari diplomi del 30 maggio duodecima Ind., per remiganti da assoldarsi in Gaeta, Amalfi, Castellamare e altri luoghi. Ibid., fog. 93.
Diploma del 2 giugno, per armarsi dieci galee e provvedersi di viveri. Ibid., fog. 87.
Tre diplomi della stessa data, che contengono altre richieste di uomini per la flotta. Ibid., fog. 88 e 99.
Diploma del 23 giugno, per armamento di galee in Brindisi. Ibid., fog. 97.
246
Riguardo all’esercito si trovano nel r. archivio di Napoli questi documenti:
Diploma del 28 marzo duodecima Ind., per lo quale fu differita infino alla pasqua l’adunata in arme di tutte le milizie feudali a Foggia, bandita prima per marzo. Reg. 1299, A, fog. 26 a t.
Diploma del 18 aprile duodecima Ind., perchè da Principato e Terra di Lavoro si recassero in Napoli balestrieri e fanti. Ibid., fog, 51 a t.
Diploma del 27 aprile duodecima Ind., Chiamata al militar servigio in Calabria. Ibid., fog. 80.
Diploma del 2 maggio, duodecima Ind., per trovarti balestrieri e pedoni pronti agli ordini di Roberto duca di Calabria, vicario generale. Ibid., fog. 54.
Diploma dell’8 maggio, duodecima Ind. Chiamata al militar servigio e allo addoamento. Ibid., fog. 79.
In tutto il registro 1299, A, ci son molti altri diplomi per armamento de’ cavalli all’impresa di Sicilia.
247
Diploma del 18 aprile, duodecima Ind., al castellano di Pozzuoli, per aver cura che di quella spiaggia non andasser marinai a Ischia e Procida, e non si facessero segnali alle dette isole con fuoco e fumo. Reg. cit., fog. 51 a t.
Diploma del 6 maggio, duodecima Ind,, pel quale è differito l’ordine dato al comune di Aversa che mandasse 1,000 uomini, armis et instrumentis aliis decenter munitos ad rebelles insulas nostras Iscle Capri et Procide. Ibid., fog. 61.
Diploma del 5 giugno 1299. Ibid., fog. 103 a t. Per adunarsi fanti con accette e scuri da mettere a guasto le campagne d’Ischia, ove Giacomo si dovea portare con la flotta. Napoli dovea fornir 400 uomini, Aversa 300, Capua 300.
Diploma del 12 giugno, duodecima Ind. Si doveano pagare per 10 dì, alla ragione di dieci grani al giorno, i 300 fanti d’Aversa, mandati pel guasto d’Ischia. Provvedeasi che il danaro si ritraesse da una contribuzione degli abitanti d’Aversa. Ibid., fog. 128.
248
Veg. docum. XXVI e XXVII, e questi altri:
Diploma del 12 marzo, duodecima Ind. (1299), per la custodia degli statichi del castell’Abate. Reg. cit. 1299, A, fog. 45.
Diploma del 14 marzo. Il dì 20 i principi Roberto e Filippo si dovean trovare con le genti loro sotto il castell’Abate, per combatter quelle di Federigo, se venissero al soccorso. Perciò, affinchè abbian giusto numero di cavalli e fanti, è provveduto: quod de quolibet foculario mictant servientem peditem unum, munitum armis decentibus et expensis que sibi sufficient amorandum ibidem cum duce prefato. Ibid., fog. 46.
Diploma del 28 marzo. Per la medesima cagione, chiamati al militare servigio i feudatari delle città di Napoli, Capua ed Aversa pel 14 aprile. Ibid., fog. 2 a t.
Diplomi del 1 e 2 aprile duodecima Ind. (1299), per milizie presentatesi al castell’Abate, coram Roberto primogenito nostro duce Calabrie. Ibid., fog. 36.
Diplomi dell’8 e 9 aprile, da’ quali si scorge che Apparente di Villanova castellano del castell’Abate, consegnatolo agli angioini, ebbe salvocondotto a tornarsi in Sicilia. Ibid., fog. 6.
Altro diploma dell’8 aprile, per gli stipendi delle genti che avean assediato il castell’Abate. Ibid., fog. 7 a t.
249
Diploma del 2 aprile 1299, risguardante il pagamento degli stipendi a 260 cavalli di Guidone di Primerano, a’ quali doveansi once 520 al mese, computato ogni milite per due scudieri. Si comanda che vadan subito alle frontiere de’ nemici a Rocca Imperiale e Ordeolo, per cavalcar continuamente quelle campagne, dandovi il guasto. In questo diploma si parla ancora di danari pagati ai Catalani e almugaveri di Berengario d’Intensa, e d’un negozio che costui dovea compiere. Vi si fe’ molta premura per l’assedio d’Ordeolo, ove si doveano adunare altre forze, e anche aiuti procacciati dal papa. Nel citato registro 1299, A, fog. 54.
Diploma del 1 maggio, duodecima Ind., dal quale si vede che già Rocca Imperiale era venuta in man degli angioini. Reg. seg. 1299, A, fog. 69.
Due diplomi del 2 maggio, duodecima Ind. (1299), coi quali son dati altri provvedimenti per l’assedio di Ordeolo; ed è creato un capitano in val di Crati e Basilicata cum mero et mixto imperio et gladii potestate, che vada subito a quell’assedio. Ibid., fog. 66 a t. e 68.
Diploma del 14 giugno. È data autorità a Ruggier Sangineto di fermar patti con Berengario de Muronis milite, per la ricuperazione d’Ordeolo e Porta di Roseto. Ibid., fog. 128.
Diploma del 15 luglio, duodecima Ind. Provvedimenti perchè non manchi il danaro a incalzar l’assedio d’Ordeolo. Ibid., fog. 124.
Diploma dell’8 settembre tredicesima Ind. (1300), dal quale si vede che Ordeolo con Pietra di Roseto eran già in poter degli angioini. Reg. 1299–1300, C, fog. 331 o piuttosto 371.
Diploma del penultimo maggio duodecima Ind. (1299). Provvedimenti per la espugnazione del castel di Squillaci. Ibid., fog. 86 a t.
250
Diploma del dì ultimo febbraio duodecima Ind. I principi Roberto e Filippo, da parte del re, in Otranto avean patteggiato con Berengario degl’Intensi che la tenea per parte de’ nemici. Berengario indi era, dice il diploma di Carlo II, ad fidem et mandata nostra reversurus, e gli si dovean pagare, per lui e la sua compagnia, once 2,856, 7, 10, per stipendi dal 18 ottobre undecima Ind. (1297) sino a tutto agosto della stessa Ind. Reg. cit. 1299, A, fog. 22.
Diploma del 12 aprile duodecima Ind. (1299). Berengario d’Intensa avea preso statichi dalla terra di Montalto, e consegnatili a Stefano de Argat, sotto giuramento di custodirli per esso. Il re, non avendogli dato autorità a trattare, scioglie il giuramento dato allo stesso Berengario dall’Argat, e comanda che gli statichi si ritengan prigioni dal conte di Catanzaro. Ibid., fog. 49.
Diploma del 23 aprile duodecima Ind., per liberarsi alcuni Catalani e Aragonesi della compagnia di Berengario d’Intensa. ch’erano stati messi in prigione. Ibid., log. 75.
Diploma dell’8 giugno duodecima Ind., ove si dice che Otranto era tuttavia insidiata, e si sospettava di que’ medesimi Catalani della compagnia d’Intensa che l’avea consegnato agli angioini. Ibid., fog. 90 a t.
Diploma del 6 luglio duodecima Ind., per alcuni uomini d’Otranto. Da questo si scorge che Guglielmo Palotta tenea già Otranto per Federigo, che gli fu sostituito Berengario d’Intensa, e che Palotta adesso era anch’egli fedele di re Carlo. Ibid., fog. 160 a t.
Niccolò Speciale, lib. 3, cap. 15, dice chiaro il tradimento di Berengario, ch’era stato sostituito a Guglielmo Palotta nel comando d’Otranto. Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 38, afferma che Berengario degl’Intensi, preso ad Aversa, fu liberato sotto sicurtà, per procaccio di Giacomo.
251
Tre diplomi del 25 giugno, reg. cit. 1299, A, fog. 132 a t. e due del 2 luglio, ibid., fog. 119 a t. 120, svelano quest’altro tradimento. Un tal che tenne il castello di San Giorgio in Calabria, prima per Giacomo re di Sicilia, poi per Federigo, or abboccatosi col medesimo Giacomo, avea pattuito di render il castello a Carlo II, se gli si pagassero i soldi corsi, suoi e del presidio che montavano ad once 55. Non è mestieri aggiugnere che Carlo fece dar subito la moneta.
Da un altro diploma del 7 settembre tredicesima Ind. 1300, reg. seg., 1299–1300, C, fog. 372, segnato per errore 332, si vede che il nome di costui era Albagno d’Aragona. Con questo diploma si ordinava a favor di lui un altro pagamento.
Altri fallirono a Federigo, forse senza vender castella a’ nemici. Tali sembrano i casi de’ due documenti seguenti.
Diploma del 10 aprile duodecima Ind. Guidone Lombardo, già nemico, si era convertito. Datagli in feudo la terra di Monforte in Sicilia, ch’ei tenea da Giacomo e da Federigo. Ibid., fog. 13.
Diploma del 3 giugno duodecima Ind. Perdonato a Gerardo di Bonavite da Firenze, se tra 15 dì tornasse alla ubbidienza. Costui era stato disertore la prima volta dagli angioini ai nostri; ora era ad Ischia, e pensava tornare a’ primi con un nuovo tradimento. Ibid., fog. 89.
252
Honor est quod onus alleviat, leggesi ne’ due diplomi dati il 10 aprile duodecima Ind. (1299) per la tradigione che racquistava a Carlo II le terre di Martorano e Taverna. Nel r. archivio di Napoli, reg. citato 1299, A, fog, 13 e 38, a t.
253
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 12, 13.
254
Diploma del 24 giugno 1299, nel r. archivio dì Napoli, reg. seg. 1299, A, fog. 113, a t.
255
Nic. Speciale, lib. 4, cap. 14.
Il tempo della morte di Corrado Lancia si argomenta anco da un diploma del 15 giugno 1299, sottoscritto da Vinciguerra Palizzi cancellier del regno, in Testa, op. cit., docum. 17.
256
Del tradimento di costui fa fede anco un diploma di Carlo II, dato a 13 settembre tredicesima Ind. (1299), col quale son rimesse tutte lor colpe a Salvacossa, protontino d’Ischia, e agli altri abitanti che piegarono a parte siciliana, ma poi, succedentibus prosperis, dice il diploma, tornarono in fede. Nel r. archivio di Napoli, reg. 1299–1300, C.
Surita, Ann. d’Aragona, lib. 5, cap. 37, 38.