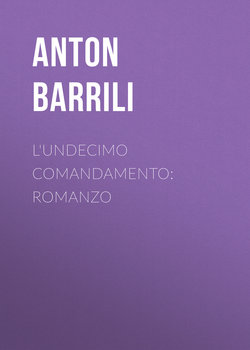Читать книгу L'undecimo comandamento: Romanzo - Barrili Anton Giulio - Страница 5
V
ОглавлениеArrivato a questo punto della mia narrazione mi par di sentire il lettore che esclama: – Un nuovo ordine monastico nel secolo decimonono! E, quel che è peggio, senza l'accompagnamento dello scopo religioso! nel solo intento di appartarsi dal mondo! Eh via!
Lettore umanissimo, e perchè no? Siamo davanti ad un caso strano, lo capisco. Ma il secolo decimonono, in riga di pazzie, va forse celebrato come la perla dei secoli? O non ne ha già fatte fin d'ora più di tutti i suoi riveritissimi predecessori? Vedete l'Icaria di Cabet, il Falanstero di Saint-Simon, il mormonismo, lo spiritismo, il comunismo, il nichilismo, e tanti altri tentativi di cataclismo. Io non voglio certamente paragonare tutta questa grazia di Dio con un povero convento di matti; mi fermo, anzi, a stabilire come esso sia il meno spiccato, il più innocente, il più roseo, tra tanti bei saggi della incontentabilità umana; i quali, germogliati all'ombra delle patrie leggi e fiorenti al sole della libertà…
Ma qui m'accorgo di metter mano ad una retorica, sulla quale il sottoprefetto di Castelnuovo Bedonia potrebbe vantare il diritto della priorità. Prior in tempore, potior in jure; lasciamo dunque la retorica al degnissimo cavalier Tiraquelli, e ripigliamo il filo del nostro racconto.
Il monastero di San Bruno aspettava in quei giorni un rinforzo. Erano cinque i nuovi ospiti, cinque le anime deluse che la seconda vocazione spingeva a cercare la pace in quel nido di laici regolari, sotto il governo temporaneo di padre Anacleto. Con questo nome era riconosciuto il priore. Fratel Giocondo aveva ricevuto ordine di dar passo ai cinque nuovi compagni, a mala pena si fossero presentati sul ponte, chiedendo d'essere avviati al convento.
La stessa mattina in cui aveva ricevuto quell'ordine del priore, il nostro converso dischiuse i battenti della torre a due ospiti. Veramente, gliene avevano annunziato cinque; ma non era poi necessario che dovessero capitargli tutti insieme. – Sono già due; – osservò egli giudiziosamente in cuor suo, – gli altri verranno dopo.
E rivolto ai due visitatori, domandò loro col sorriso sulle labbra:
– Vengono per farsi frati?
– È il nostro desiderio; – disse il più giovane dei due, mentre l'altro crollava la testa in atto di santa rassegnazione.
Erano due tipi diversi, nell'età, nell'aspetto, nella espressione. Il giovine era biondo, di belle fattezze e di proporzioni elegantissime, ma un pochettino impacciato ne' suoi abiti di viaggio. Come mai, sul limitare della vita, sentiva il desiderio di rinchiudersi in un convento? Quali dispiaceri potevano averlo colpito, con quella figura di arcangelo in vacanza, che pareva fatta a bella posta per vincere ogni resistenza? E il vecchio, così grasso, tondo, rubicondo e lucente, di che cosa poteva egli lagnarsi? Forse il cuoco gli aveva mandata a male una salsa? Ma bastava ciò per disamorare del mondo un bofficione di quella fatta?
Ahimè, lettori, pur troppo le apparenze ingannano. E nel caso presente ingannavano più che mai.
Scambiate le poche parole necessarie e pagato il contadino che aveva portate le loro valigie, i due viaggiatori seguirono il converso, a cui il più giovine dei due sorrise amabilmente, come si sorride in paese straniero ad una faccia conosciuta. Entrati nel bosco, risalirono il viale dei frassini, svoltarono tra i due poggi che sapete, videro il convento in mezzo alla sua conca di verdura, ridiscesero e finalmente giunsero al parlatorio.
– Vado ad avvertire il padre priore; – disse fratello Giocondo. – Intanto farò mettere le loro valigie nella foresteria.
– Benissimo! – rispose l'arcangelo in vacanza; e parve (mi scusi l'ombra dell'Ariosto, se guasto un verso all'Orlando) e parve Gabriel che dicesse: ave.
Prima di andarsene di là, il frate converso diede una sbirciata ai due viaggiatori.
– Sarà un bel fratino, in fede mia! – diss'egli tra sè. – Ma lo accetterà il priore, che vuole la seconda vocazione? Speriamo che il su' babbo ne abbia per due; – soggiunse, pensando al più vecchio dei nuovi venuti. – Quello là è uomo da prendere di primo acchito il posto di cantiniere. – Il parlatorio era, come tutti i parlatorii di frati, una stanza seminuda e fredda. – Nè i laici regolari, che avevano preso il posto dei Camaldolesi, si erano dati pensiero di abbellire quella parte dell'edifizio; una tavola di noce contro il muro, otto seggioloni in giro, un quadro scorniciato alla parete, erano tutti gli arredi della stanza. Il quadro rappresentava Mastino II della Scala; un uomo dalla barba di color castano, con un berrettone di pelo in testa, il sorcotto rosso sulla maglia di ferro, e la faccia veduta di profilo, forse per lodevole intendimento del pittore di far sapere alla posterità che quel pessimo arnese non aveva il tipo greco. Che diamine faceva Mastino II nel parlatorio di San Bruno? Quel che fanno tanti vecchi ritratti nelle case moderne. Avanzi di eredità trapassate più volte, compre fatte da un antenato in un momento di buona luna, non si sa il più delle volte chi siano; o quando si sa, resta il dubbio intorno alla strada che hanno fatta per giungere in casa.
Non c'era da guardar nulla, in quel ritratto, almeno cent'anni più giovane del suo originale. Veduto il nome di Mastino II, che era scritto a lettere gialle nel fondo del quadro, secondo il costume del quattrocento, il più giovane dei due viaggiatori si volse all'altro, e sorrise ammiccando, come se volesse prendersi spasso di lui.
– È proprio così? Non si ritorna indietro? – gli chiese quell'altro, con un piglio malinconico che faceva un bizzarro contrasto con la sua florida cera.
Il giovine aggrottò le ciglia in atto di chi non vuol sentire osservazioni ed è lì lì per escire dai gangheri.
– Zio, te l'ho detto; o fai a modo mio, o mando giù un veleno. Bada a te, di qui non si sfugge.
– Ma vedete un po'! – disse quell'altro, salutato col nome di zio. – Son dilemmi da farsi?
– Eh, sicuramente; quando si ha a fare con un ostinato come te!.. Al polo, no; all'equatore nemmeno…
– Ma era un'impresa da matti! – esclamò il povero uomo.
– Non esciamo dunque di strada; – ribattè il giovine, crollando la testa con un piglio d'autorità consapevole; – eccoci a casa nostra, nel convento dei matti. – Con quel biondo cherubino non si poteva vincerla nè impattarla. Lo zio fece come Giacobbe nella sua pugna con l'angelo; si diede per vinto ed alzò gli occhi al cielo, in atto di offerta e di rassegnazione, ma non senza aver data una sbirciatina malinconica all'occhiello del soprabito, che sarebbe rimasto vergine del brigidino commendatorio. E sospirò, tra un'occhiata e l'altra.
L'uscio del parlatorio si aperse e fratel Giocondo annunziò la venuta del priore. Lo zio, ricordandosi d'essere stato capitano della guardia nazionale, assunse un'aria dignitosa, se non a dirittura marziale. Il nepote scosse leggiadramente la sua zazzerina bionda, compose le labbra ad un sorrisetto malizioso e volse gli occhi all'entrata, per ricevere la prima impressione.
C'era un fil di ridicolo in quella condizione di laici che volevano parer frati. Ma bisogna dire ad onor loro che non si curavano affatto di ciò, e che la noncuranza prendeva carattere di dignità. Vivevano in quella solitudine non cercando nessuno; chi ci andava doveva accettarli come volevano essere. Frati o non frati, avevano scritta sulla porta del monastero la sentenza inventata dal Rabelais: Fais ce que voudras, e non si occupavano d'altro.
Il padre Anacleto, degno priore di San Bruno, non era grave che a mezzo, e portava con disinvoltura cavalleresca la sua tonaca lunga, di color tabacco. Aveva la barba nera, finissima, un po' rada e corta sulle guance, i capegli riccioluti e lucenti, la fronte ampia, lo sguardo aperto, il naso diritto e fine, il labbro sottile e vermiglio. Il primo sentimento che destava a vederlo, era di schietta simpatia; il secondo di stupore e di curiosità. Come poteva essere che un uomo così giovane e d'aspetto così piacente si fosse dato ad un genere di vita, che era una rinunzia anticipata a tante allegre vittorie? Ma guardandolo attentamente, nel corso della conversazione, si notavano alcune rughe sottili sulla fronte, le quali talvolta si raccoglievano a fascio nel mezzo delle sopracciglia; si vedevano certe contrazioni improvvise di labbra, certe nubi di tristezza sugli occhi, e si capiva allora che quell'uomo era vissuto molto in breve spazio di tempo, e che le burrasche della vita potevano aver fatto assai più che solcargli la fronte, o adombrargli lo sguardo.
Aveva in mano la sua berretta di velluto, e la sporse avanti, in atto di salutare, mentre con una occhiata cercava di abbracciare i due visitatori e di coglierne a volo i pensieri.
– In che posso servire le Signorie loro? – dimandò, poichè li ebbe invitati a sedere.
Lo zio aperse le labbra per rispondergli, ma non gli venne fatto di spiccicare una sillaba. Perciò, rinunziando ad una impresa che vedeva superiore alle sue forze, si volse al nepote con la muta preghiera dello sguardo. L'arcangelo in vacanza crollò leggermente le spalle, in atto di stizza non potuta nascondere, per quella che gli pareva una insigne debolezza d'animo, e rispose tutto d'un fiato:
– Signore, siamo due che vogliamo ascriverci alla regola di San Bruno. – Il priore sorrise, e, con accento pacato che non escludeva un senso d'arguzia, ripigliò:
– Si dice San Bruno per mo' di dire. Ma sanno proprio le Signorie loro di che cosa si tratta? L'ordine è forse un tantino burlesco nella forma, poichè non siamo frati, ma è serio nella sostanza, poichè abbiamo una parola d'onore, la quale ci obbliga come il più solenne dei voti.
– Lo sappiamo; – replicò l'arcangelo. – Si vien qua per vivere fuori del mondo, non curando le sue vanità dolorose.
– È vero, – disse il priore, inchinandosi, – ma non è tutto il vero. Ciò ch'Ella dice, mio giovine signore, ognuno di noi potrebbe farlo da sè, ritirandosi per sua elezione a vivere in campagna. Qui, invece, viviamo uniti, foggiandoci il nostro piccolo mondo, riveduto e corretto, senza le noie del grande, ma con tutto il buono, con tutto l'utile che può trovarsi nella vita. Rinunziamo agli affetti pericolosi che lasciano tracce di dolore e di amarezza, ma vogliamo e pratichiamo la carità fraterna, che è un santo bisogno del cuore: rinunziamo alle ambizioni, ma ci dedichiamo allo studio, che affina l'intelligenza ed è poi il naturale ufficio dello spirito.
– Lo sappiamo, padre, e Le domandiamo di poterci dedicare con Lei a questo genere di vita.
– Ma badi; – osservò il priore. – È un genere di vita più alto, o più umile, secondo si guarda, ma certamente diverso da quello che si fa generalmente e a cui c'indirizza la nostra educazione e l'ardore delle nostre passioni. Perciò, a non aver pentimenti, è necessaria una vocazione sincera, e riconosciuta tale, mercè il confronto, che può farsi solamente quando si è vissuto a lungo tra gli uomini. Non basta un desiderio onesto di pace, o una poetica aspirazione alle squisite compiacenze della solitudine; è necessario che il desiderio sia profondo e l'aspirazione provata nei disinganni della vita. Che il mondo offra amarezze e dolori in molto maggior numero e quantità dei piaceri e delle consolazioni, è cosa nota oramai, e può esser creduta anche, sulla fede dei vecchi, da coloro che non ne hanno fatta la triste esperienza in sè medesimi. Ma altro è l'accettare per vera una massima, altro il conformarvi tutta quanta la vita. Si conosce il bene e si loda, ma ci si attiene al peggio, o ci si torna quando fa comodo. Da questo rifugio, invece, non si ritorna più indietro. Donde la conseguenza che ci si debba venire… (mi scusi, ma la franchezza è necessaria)… che ci si debba venire ad una età più matura, che non sia, per esempio, la sua.
– Ho ventidue anni; – disse arditamente l'arcangelo.
– Sia pure, ma non è molto. E poi, Ella non ha neanche l'ombra dei baffi.
– Scusi, che gliene importa a lei? —
Il priore sorrise, a quella involontaria scappata del biondino.
– A me, nulla; – rispose. – Ma non vorrei aver l'aria di accalappiar minorenni.
– Son solo; non ho che mio zio; – ribattè il giovine. – E mio zio, qui presente, si fa frate con me.
– Davvero? – chiese il priore, volgendosi allo zio.
– Davvero; – rispose questi, facendo il gesto dello et cum spiritu tuo.
Il padre Anacleto ebbe un istante di raccoglimento; indi alzò la fronte, come un uomo che ha preso un partito e si dispone a parlare. Ma il pensiero del nostro personaggio doveva essere difficile ad esprimersi, anche per un uomo della sua autorità, perchè egli, dopo aver sollevata la fronte, stette parecchi secondi immobile, con gli occhi fissi sul volto del giovane cherubino. Questi arrossì fino alla radice dei capegli, ma non chinò altrimenti i suoi.
– Mi perdonano la franchezza? – incominciò finalmente il priore.
– Dica liberamente.
– Ma badino, – soggiunse, – voglio essere schietto, anche a risico di parere… scortese.
– Non le riuscirà; – disse il cherubino, che non aveva ancora ombra di baffi, ma dimostrava già di aver molto giudizio.
– Grazie; – rispose il priore, cascando e sapendo di cascare. – Volevo dire che dubiterò; e il dubbio è sempre scortese; ne conviene?
– Secondo la maniera di esprimerlo; – ripigliò il cherubino.
– Orbene, – disse il priore, stringendosi nelle spalle, – prendiamo la forma più mite. Qui vedo due cose, egualmente temibili. O si tratta d'uno scherzo… —
A queste parole, il cherubino scattò sulla sedia.
– Non c'è scherzo, qui; – interruppe egli vivacemente; – La prego a crederlo; lo giuro sul mio onore. M'ingannerò… c'inganneremo, – soggiunse, ravvedendosi tosto, – ma è un nostro desiderio sincero di viver qui, se Ella non ce ne reputa indegni. Siamo gente per bene, pronti a sopportare la nostra parte di spese, a metter fuori quanto occorre, e più ancora, per vivere in questa comunità di San Bruno. L'idea è superiore alla mia età, dice Lei. Che cosa ne sa? Scusi, veh! Non sono ancora sotto la sua tutela. Riconoscerò domani la sua autorità, la sua giurisdizione. Per oggi almeno mi lasci dire liberamente quello che penso. Che cosa ne sa? Metta che io sia vissuto nel mondo quanto occorre per capire che esso non val nulla, che è bugiardo, sciocco e noioso. Non basta, forse, per venire a rifugio quassù?
– Eh, non basterebbe; – disse il priore, crollando la testa e sorridendo. – Ma lasciamola lì. Io le aveva accennato un mio dubbio. Le è dispiaciuto e non voglio tornarci su. L'ardore che Ella ha messo a ribatterlo, mi dice chiaro che non debbo ripeterlo, neanche spiegandolo.
– Dovrebbe ritirarlo senz'altro; – replicò il cherubino. – Per nessuna cosa al mondo io mi farei lecito uno scherzo di questa fatta, e sopratutto con Lei!.. —
Non era niente più d'un complimento; ma il tono con cui fu detto turbò lo spirito del padre Anacleto.
– Rimane l'altra parte del dilemma; – diss'egli, mutando registro. – Il suo sarà dunque un desiderio sincero. Ella lo afferma ed io lo credo. Ma anche un desiderio sincero può essere… di poco durata.
– Durerà, creda anche questo, durerà.
– Oggi le pare, ma chi ci assicura del domani? Io, veda, sono obbligato a distinguere, a considerare tra i possibili, se non a dirittura tra i probabili, che il suo desiderio, vivissimo oggi, si muti un giorno in avversione. E allora? Il voto pronunziato adesso, il patto conchiuso tra noi, non rincrescerebbe a Lei solamente, e farebbe anche torto alla mia previdenza, che si sarebbe mostrata assai misera. A farla breve, sono il priore di nove (e saranno presto quattordici), tutta gente posata, che vive in una quiete esemplare. Ma Ella sa come si ottenga lo stato di quiete negli animi, materia assai più delicata e gelosa che non siano le bilance dell'oro, e come un nulla possa turbare quel felice equilibrio. Se un giorno – osservò acutamente il padre Anacleto, fissando i suoi occhi scrutatori in viso al cherubino, – se un giorno dovessero dirmi: "Signor priore, siete andato un po' leggermente nella faccenda di quella ammissione," crede Lei che non ne sarebbe turbata la nostra bella armonia, unica guarentigia di pace, unico bene che renda la nostra vita preferibile a quella del mondo? – Un'aria di profonda mestizia si dipinse sul volto del giovine. Pareva uno di quegli angeli del buon tempo antico, che, tornati al paradiso, trovarono la spiacevole novità della porta chiusa.
– Orvia, – ripigliò il padre Anacleto, dolente di aver fatto pena al suo giovine interlocutore, – non ci fermiamo a guardare tutti i casi possibili, che saranno ugualmente improbabili. Ella e suo zio mi aiutino a mettere in pace la mia coscienza; accettino di entrare come ospiti, per ora, e questa ospitalità la chiamino pure un noviziato. Tra un anno… Non le piace? Diciamo adunque fra sei mesi. Neanche? Diciamo allora fra tre, riparleremo della loro vocazione. – S'intende, – osservò il priore, – che anche dopo accettati nella famiglia, il vincolo non sarebbe indissolubile. Ma c'è sempre una parola d'onore che impegna; si è ammessi per questa parola, e la parola, pei gentiluomini, è legge. Se così non fosse, mi capiranno, il convento di San Bruno si tramuterebbe facilmente in albergo, ed io ne sarei l'albergatore, o il direttore pro tempore. Ora, nè il mio carattere concentrato, nè le mie abitudini studiose, mi consentirebbero di esercitare questo ufficio.
– Ha ragione; ma noi Le giuriamo fin d'ora…
– No, non giurino, per carità. Io non accetto il giuramento, non l'ho udito. Rimangano qui, li avremo in qualità di novizi. Finora non se n'erano accettati; ma sarà una eccezione alla regola. E prima di tutto, siccome qui ognuno si dedica a qualche lavoro, vediamo un po' che cosa sanno far Loro?
– Io… veramente… – balbettò lo zio – qualche cognizione di agronomia…
– Troverà da applicar poco; – riprese il padre; – qui non abbiamo che l'orto e il frutteto. I campi mancano affatto; i boschi sono stati decimati prima che noi si comperasse il convento. Ma infine, quel poco che c'è offrirà a Lei materia di studio, e saremo lieti di avere un agronomo in famiglia, come già abbiamo il botanico. E Lei?
– Quasi nulla; – rispose il cherubino arrossendo. – Un po' di canto… il pianoforte… Frivolezze, Ella dice bene; – soggiunse tosto, notando un atto involontario di labbra, con cui il padre Anacleto aveva accolte le sue parole.
– No, non dico questo; – notò il priore.
– Lo penserà; è tutt'uno.
– Non lo penso nemmeno. Anche la musica è una bella cosa, e più seria che non si creda generalmente. È matematica applicata ai suoni e interessa una parte della fisica, che non è certo la meno importante. Helmholtz ci ha scritto un libro, il quale è tutt'altro che frivolo, poichè ci dà una dimostrazione completa dei fenomeni del suono e delle leggi musicali che ne derivano. Herschel, studiando a fondo l'arte sua, che era per l'appunto la musica, fu gradatamente condotto allo studio della geometria e quindi alla conoscenza dell'astronomia teoretica, al perfezionamento del telescopio e alla scoperta di Urano. Amo ricordare questi fatti, – soggiunse il padre Anacleto, che si sentiva alquanto impacciato a dover conversare con quello strano novizio, – per dimostrarle che apprezzo la musica anch'io. Disgraziatamente, qui mancano i mezzi di coltivarla; abbiamo volta la chiesa ad uso di biblioteca, e non c'è neanche la fortuna dell'organo.
– So disegnare un pochino; – si provò a dire il giovane.
– Ah bene! questo è il fatto nostro; – gridò il padre Anacleto. – Oh, non dubiti, non le domanderemo i cartoni di Raffaello. I soli principii del disegno basterebbero. Abbiamo in mente di fare un giornale, una specie di rassegna mensile, per registrarvi i nostri studi, e avremo appunto bisogno di tavole illustrative; segnatamente per gli scavi delle nostre caverne.
– Ahi come il duca di Francavilla! – scappò detto allo zio.
– Lo conoscono? È un bravo signore, che ha voluto farci una visita.
Egli è qui a Castelnuovo per certi suoi studi preistorici…
– Per studi, e per altro; – mormorò il cherubino, che la sapeva lunga, anche senza aver ombra di baffi.
– Non saprei; – ripigliò il padre Anacleto, che era prudente e non andava a cercare il pel nell'uovo. – È venuto a trovarci una settimana fa e non ci ha parlato d'altro che delle sue ricerche scientifiche. Anche noi avevamo già pensato a scavare le caverne ossifere di monte Acuto; ma finora ci mancava l'uomo da ciò. Ora avremo uno studioso di queste materie, tra i cinque che verranno in settimana a far vita con noi. È un valente professore. Insegnava a Torino. Gli hanno fatto torto, a quanto pare; qualcheduno si è fatto bello di una sua scoperta; il governo non lo ha tenuto nella giusta considerazione, ed egli ha abbandonata la cattedra. Come vedono, son tutti i delusi, i disgustati delle perfidie umane, che vengono ad accrescere la nostra schiera. Metteremo il professore all'archeologia, ed Ella disegnerà gli oggetti ritrovati. Va bene?
– Sì, sì! – gridò il cherubino, battendo allegramente le palme.
Ma subito si penti di mostrarsi così bambino in faccia al priore, che lo guardava tra sospettoso e ammirato; arrossì per la terza volta, chinò gli occhi e ripigliò:
– Scusi, la prego; ma gli è che son tutto felice di trovare in me un piccolo talento, che possa tornare utile alla comunità. – Stabiliti questi preliminari, il padre Anacleto si offerse ai nuovi ospiti di San Bruno, per condurli a visitare il convento, e l'offerta fu accettata con giubilo dal biondo cherubino, che vedeva così superate tutte le difficoltà della sua introduzione in quella bizzarra clausura.
Anche allo zio era parso di escirne egregiamente. A farselo apposta, un priore, non si poteva ottenerlo più pastoso di così.
– Che sia cieco? – pensava egli, mentre seguiva il padre Anacleto e il biondino, nella loro passeggiata per tutti i corridoi del convento. – Quando egli ha messo fuori quel dubbio intorno all'età, ho subito detto: ci siamo! E come lo squadrava dal capo alle piante! Ma poi, sia lode al cielo, s'è lasciato abbindolare con tanta buona grazia! È anche vero che gli è stato risposto con un certo calore!.. Non fo per dire, ma il mio signor nepote, poichè oramai bisogna chiamarlo così, ha una eloquenza che va diritta al cuore. Non si sgomenta di nulla, lui! Vi guarda nel bianco degli occhi, e vi fa fare tutto quello che vuole; anche delle pazzie come questa. Ma saranno tutti ciechi e tre volte buoni come il padre Anacleto! Qui sta il busilli. – Il nepote, frattanto, pensava anche lui, mentre andava scambiando osservazioni col priore.
– Ha capito? Temo di sì. Per lo meno, il dubbio gli è nato. Ma egli è un gentiluomo, e non è andato più in là. Questa avventura mi piace. Ci sarà qualcosa da ridire; ma infine, si servano, io non ho da render conti a nessuno. E poi, sono con mio zio. Questo priore, che uomo! Il duca di Francavilla lo ha chiamato simpatico; ma mi pare che sia più di simpatico; un bel giovane addirittura; e senza saperlo, senza averne l'aria, come dovrebbero esser tutti. È la prima faccia d'uomo che vedo. O son tutti insipidi, svenevoli, come il duca di Francavilla, o duri, arcigni, antipatici… Che orrore! —
Vi fo grazia del resto. E non mi fermo neanche a dipingervi tutto quello che videro i nuovi ospiti di San Bruno. I conventi, su per giù, si rassomigliano tutti nella loro semplicità grandiosa ed umile ad un tempo, che credo entri per molto nella tenacità del sentimento che fa perdurare gli ordini monastici, che li fa sopravvivere alle leggi da cui sono stati colpiti. C'è una virtù arcana che attrae verso le mezze solitudini del chiostro, e quella forma architettonica stabilita, quasi invariabile, salvo nei minuti particolari, esercita un fascino sullo spirito moderno, che pure ha distrutto il pensiero onde quella forma è scaturita. Sono spariti i conventini, i monasteruzzi borromineschi di due secoli fa; il largo tipo dei chiostri antichi è rimasto, e se ne ricorda volentieri perfino… indovinate chi? il nostro soldato, che è stato così spesso ad alloggio nei vecchi monasteri tramutati in caserme.
Il convento di San Bruno, come tutti quelli del medesimo ordine, aveva i suoi quartierini, in cui ogni frate potesse viver solo, con la sua stanza da letto, l'oratorio, l'anticamera e la ruota per cui introdurre il suo pasto frugale, o metter fuori la scodella vuota. Ma la ruota, oramai, serviva soltanto per le lettere e i giornali, quando giungeva il postino; la stanza da letto non era più così nuda come al tempo dei camaldolesi; quanto all'oratorio, ognuno ci teneva la sua biancheria, i suoi abiti, e all'occorrenza i suoi libri più alla mano. Fratel Giocondo, ad esempio, ci teneva il Gattinara e il Pomino, due autori di sua predilezione, tra i quali da lungo tempo aveva istituito un confronto.
I due novizi furono condotti alle loro stanze. Il priore non aveva chiesto i loro nomi, ma li chiese allora il converso, facendosi avanti col registro dell'ordine.
– È vero; – disse il cherubino; – avevamo dimenticato di darli. Zio, incominciate. – Il vecchio prese la penna e scrisse il nome di Prospero Gentili.
Il giovine, con meno sincerità, ma con altrettanto coraggio, vi scrisse quello di Adelindo Ruzzani.