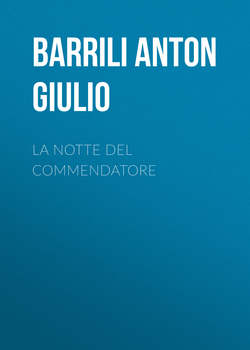Читать книгу La notte del Commendatore - Barrili Anton Giulio - Страница 3
CAPITOLO III
ОглавлениеNel quale si vede nascere un giornale e spuntare la coda d'un segreto
Nell'atrio dell'università, sotto i portici di Po, in piazza Castello, ad ogni tratto il giovane Ariberti s'imbatteva in qualche amico.
–Ah, sei tu, buona lana? E dove hai passate le vacanze?
–Io? Non me ne parlare. A Dogliani, nel «paterno ostello».—(e qui un sospiro lungo tanto rincalzava la frase).—Ma dimmi piuttosto; e tu dove sei stato?
–Ho fatto un viaggio;—rispondeva l'altro, con un'aria dimessa che volea parere modesta;—sono stato in Toscana.—
E lì il Ferrero, che così per l'appunto si chiamava l'amico, a tirar giù una filatessa di tutto quello che aveva veduto a Lucca, a Pisa, a Firenze. Senza andare di una parola più in là d'una guida, trovava il modo di ficcar dentro al discorso tutte le meraviglie dei luoghi veduti, e non la perdonava nemmanco a un muricciuolo; laonde, non è a dire se il povero confinato di Dogliani se ne sentisse venir l'acquolina in bocca. E poi l'amico Ferrero ci aveva le sue considerazioni, i suoi appunti particolari sugli usi, sui costumi e sulla lingua dei figli di Etruria; ricordava i modi, rifaceva la parlata con una grazia tutta sua. All'osteria aveva mangiato il lesso, che corrispondeva alla carne bollita, ahi troppo, della cucina domestica; aveva chiamato tavoleggiante il garzone di caffè; conosceva le uova al tegame, le uova a bere, le uova affogate, le sode e le bazzotte; insomma era diventato un'arca di scienza.
Al caffè dell'Aquila, dov'erano andati i due a sedersi, con tre o quattro amici combinati per via, un altro studente, che era conte e figlio d'un ministro, e che per solito tirava dritto salutando con molto sussiego i compagni, si era degnato di avvicinarsi a loro e di rallegrarli colla sua conversazione, per far sapere a tutti che tornava allora allora di Francia.
–E Lei, dove è stato?—domandava il signor conte, volgendo la parola al nostro Ariberti.
–A Dogliani;—rispondeva questi, avvilito.
–Dogliani! Dov'è?—chiedeva il conte, coll'aria di chi non si raccapezza.—Dalle parti di Mondovì?
–Sì, verso le inospiti Langhe;—soggiungeva un altro della brigata.
–E via, non disprezziamo tanto i nostri paesi;—interruppe il Ferrero.—Ci sono certe ragazze avvistatette, che non fo per dire… Il nostro Ariberti ha da aver fatto strage.
Il conte, strascicando l'erre con quel suo garbo nobilesco:—Quando si va in campagna, non c'è altro modo di vivere, che devastando il pollaio. Ma Parigi…. Parigi….. ecco la vita! Il palazzo Reale! il Rocher de Cancale! la Chaussée d'Antin colle sue donne adorabili! Parlez-moi de ça!
E con una leggiadra giravolta sui tacchi, il signor conte Candioli andò verso il banco, per farsi ammirare dalla padrona, pallida creatura, che aveva letto Ossian e si credeva una specie di Malvina, perchè aveva i capegli di canapa mal pettinata.
–Vedi che sciocco!—disse il Ferrero sottovoce all'Ariberti.—Perchè è stato a Parigi, insieme coi bauli del suo signor padre…
–Eh via, non sei tu forse stato a Firenze?
–In Italia, perdinci, e co' miei danari.
–Vorrai dire di tuo padre.
–S'intende; ma sono andato per mio diporto. Ma perchè non far lo stesso anche tu, scambio di chiuderti in quel tuo guscio di noce? Tuo padre non è ricco abbastanza per farti pigliare un po' d'aria di casa d'altri?
–Che vuoi? Gli sembro troppo giovane, per girare il mondo da solo. Poi, c'era l'esame di ammissione… Infine che ti dirò? Voi fortunati, che avete potuto passare il confine! Noi ce ne siamo rimasti all'ombra nelle nostre montagne, coi nostri cenci campagnuoli dattorno. Non è egli vero, Balestra?—
L'amico chiamato con questo nome rispose con un malinconico cenno del capo, che voleva dire: purtroppo.
–Benissimo; bisogna far strage!—ripigliò.
–Oh, a proposito di cenci,—ripigliò il Ferrero,—che cosa è avvenuto del tuo Bertone?
–Mio!—esclamò l'Ariberti.—Mio come tuo. Tu sai ch'egli è di Mondovì ed io per tutte le vacanze non mi sono mosso da casa. Del resto, che vuoi che abbia fatto? Sarà venuto anche lui.
–Si diceva,—notò il Balestra,—che non avrebbe più continuato gli studi, perchè la famiglia non poteva mantenerlo a Torino.
–Sfido io!—entrò a dire un altro della brigata.—Suo padre fa il maniscalco e una sua sorella va a mezzo servizio nelle case dei signori.
–Del resto,—aggiunse il Ferrero,—a Torino è venuto certamente. Almeno, io lo credo, perchè stamane, quando sono uscito di casa, i cenciaiuoli del ghetto gridavano più allegramente che mai il loro «niente da vendere?»
–Ah, ah! bella, questa!—proruppero in coro gli studenti.—Abbiamo dunque la prova provata.
–Via, non c'è umanità!—disse l'Ariberti, con aria che voleva parer rimprovero, ma che sapeva piuttosto di preghiera.—Che ci può far egli, se è povero?
–Sì, sì, hai ragione;—rispose ghignando il Ferrero;—ma che ci possiamo far noi, se è così sudicio? Spero almeno che quest'anno tu non ce lo vorrai tirare fra' piedi. Con quel coso lì in compagnia, si passerebbe tutti per altrettanti straccioni.—
L'Ariberti non ebbe animo di protestare contro questa nuova maniera d'ostracismo. E non era mica un giovine di cattivo cuore; anzi, bisogna dire che gli rincrescevan assai le parole del Ferrero. Ma in fondo in fondo, o come sarebbe egli stato possibile di sostener l'onore del giubbone color tabacco dell'amico Bertone? Segnatamente là, al caffè davanti al conte Candioli, a quel figurino di Parigi, vestito nientemeno che da Humann, cioè dal primo sartore di tutti i leoni di Lutezia, con giubba, o senza? Perciò l'Ariberti si tenne le sue ragioni in gola e il povero Bertone fu condannato senza forma di processo.
–E che faremo ora?—continuò il Ferrero.—L'anno scorso c'erano certe idee! Ma sì, ad anno così inoltrato, non bisognava pensarci. Ti ricordi, Ariberti, del nostro giornale letterario? Tu avevi già pensato alle module pei registri degli associati.
–Ah sì, sarebbe bene di mandarlo avanti;—disse il Balestra.—Io ci ho una canzone in pronto.
–Ed io,—soggiunse il Vigna, che era un altro della compagnia,—ci ho un capitolo sugli amori di Tibullo.
–Già tu l'hai sempre coi latini. Io ci ho invece uno studio sui Nibelunghi.
–Che cosa sono? Roba da mangiare?
–Tira via, sciocco, e impara l'arte nuova; ne abbiamo piene le tasche dei classici.
–Amici,—interruppe il Ferrero,—noi ci stiamo bisticciando per la pelle dell'orso. Prima di tutto, vediamo se il giornale uscirà. Avremo noi il permesso del governo?
–Perchè no?—disse l'Ariberti, mandando una timida occhiata al ricapito del figurino di Parigi;—se il signor conte si degna di spendere una parolina per noi con Sua Eccellenza, voglio sperare….—
Il signor conte, che andava farfalleggiando continuamente dal banco di Malvina al tavolino degli amici, gonfiò a quelle parole lusinghiere.
–Il signor conte—aggiunse il Ferrero,—potrebbe anche essere uno dei primi scrittori del giornale, ed anzi il più gradito alla miglior classe di lettori, che è senza dubbio quella delle lettrici.
–Io?—dimandò il contino, che non ci arrivava da sè.—E che cosa potrei scrivere io, palsambleu?
–Eh, per esempio, i ricordi del suo viaggio a Parigi. Mi sembra che l'argomento sia ghiotto; che ne dite voi altri? Ella ha certamente molto veduto e molto osservato;—soggiunse il Ferrero, dandogli accortamente la soia;—ricevimenti di corte, passatempi di strada, segreti di boudoir, occhiate tra le quinte del palcoscenico, chiacchiere di foyer, insomma, tutto ciò che forma la vita di quella capitale affascinante; ecco quello che potrebbe descrivere. Non c'è che lei, per farlo; e sarebbe la man di Dio pel nuovo giornale.—
Questa volta il pavone fece a dirittura la ruota.
–Sicuramente—rispose egli, mettendosi sul grave.—E sebbene io non abbia troppa domestichezza colla lingua…. Del resto, sentano, signori miei; bisogna confessarlo una volta; la lingua italiana è povera, assai povera.
–Che diavolo dice?—esclamò il classico Vigna. Con un vocabolario di —ottantaseimila parole!
–Sta zitto!—interruppe il Ferrero, che voleva ingrazionirsi col figlio del ministro.—Il signor Conte ha ragione, e tu gli scambi la tesi. Sicuro, c'è molta roba nel vocabolario; ma a che serve, se è lingua morta e ciarpame?
–Infatti, è proprio questo che volevo dir io;—ripigliò il signor Conte, inchinandosi.—Ed ecco un esempio che fa al caso nostro. Come tradurrebbero lor signori la parola francese regret?—
La domanda era vecchia, e certo il signor Conte l'aveva raccattata in qualche conversazione di gente sconclusionata, che non sa la sua lingua, e, quel che è peggio, non vuol confessarlo. Anche Ariberti, come il classico Vigna, si sentiva a rispondergli che c'erano in italiano almeno dieci vocaboli per esprimere tutte le gradazioni d'un sentimento, anzi meglio, i vari sentimenti che i francesi sono costretti ad esprimere con quel vocabolo solo; la qual cosa, a dir vero, non fa testimonianza di molta ricchezza nel tesoro filologico dei nostri vicini d'oltralpe. Voleva anco soggiungere, allargando la questione, che ogni lingua ha i suoi propri modi e partiti per dire il fatto suo, e che il non poter voltare col medesimo giro una frase forastiera non prova nulla a suo danno. Infine, voleva dargli pulitamente di sciocco; voleva…. Ma a qual pro? Anch'egli aveva capito che non bisognava urtare con quella ignoranza pomposa; e fu egli il primo a rispondere, con una mimica espressiva, al signor conte, che egli aveva ragione, e che quel maledetto regret era proprio intraducibile.
Il conte Candioli ricompensò l'Ariberti con un gesto di protezione.
–Se scrivessimo il giornale in francese,—soggiunse egli poscia, piantandosi la fida lente nella incavatura dell'occhio destro, come faceva sempre quando volea darsi aria d'uomo d'assai,—sarebbe forse meglio, e il giornale sarebbe più répandu.
–È verissimo;—rispose il Ferrero:—ma non tutti abbiamo famigliare la lingua francese come il conte Candioli. Via, facciamo un tanto per uno, scriviamo il giornale in due lingue.
–Soit,—disse il contino;—chacun son goût.
–Pensiamo dunque al nome:—disse Balestra;—io propongo che si chiami L'Aurora.
–Io La Minerva;—gridò il classico Vigna.
–Il primo non dice niente, e l'altro vuol dir troppo; rispose il —Ferrero.—Cerchiamo ancora.
–Cerchiamo;—ripetè l'Ariberti.—Io vorrei un titolo che dicesse anche il luogo donde il giornale uscirà.
–Il Po;—soggiunse prontamente Balestra.
–Via;—saltò su il Vigna, dandogli sulla voce; lo si chiami almeno —L'Eridano.
–Sia pure L'Eridano e se ti piace, anche Il Bodinco, per andar cogli antichi.
–Pardon!—interruppe il contino, stendendo la mano nel crocchio, come per annunziare l'arrivo d'una idea.—È già forse stabilito che il titolo debba essere in italiano?
–Ma…..—disse il Vigna sconcertato.
–Ma…—ripeterono gli altri, non sapendo che pesci pigliare.
–Il signor conte ha ragione;—aggiunse tosto il Ferrero, che era l'uomo dei ripieghi,—ci vuole un titolo che corrisponda alla cosa. Noi che facciamo? Un giornale in italiano e in francese. Ci vuol dunque un titolo bilingue.
–Sicuro, bilingue! Ah, ce diable de Ferrero! Il n'y a que lui pour avoir de ces idées là.
–Grazie, signor conte! Ed ora che ci penso, il titolo è bell'è trovato; un titolo che salva tutto; La Dora.
–Oh diavolo! la Dora!—esclamò il Vigna, che non si raccapezzava.—E non è forse un nome italiano?
–Bravo! E chi ti dice di no? E Dora non può essere femminile in francese, com'è in italiano?
–C'est juste; puisque c'est une rivière…—aggiunse il conte Candioli con aria di trionfatore romano.
–Ah bene! benissimo!—gridarono tutti in coro. Une rivière! Diciamo —dunque: La Dora.
–E sarà settimanale?
–No, c'è troppo da fare, io sto per un fascicolo al mese.
–Sentite, amici miei; diamola nel mezzo e usciamo fuori per quindicine. Noi si ha tempo a scrivere e gli altri hanno tempo a leggere.—
Qui, gettate le fondamenta, cominciarono le osservazioni minute, intorno ai necessari congegni di ordinamento interno; alle spese, ai carichi di amministrazione e a tutti gli altri amminicoli, sui quali il signor Conte era invitato a dire il suo nobile e riverito parere.
Quanto alle materie, non c'era fortunatamente da stillarsi il cervello. Gli scrittori abbondavano, e tra cattivo e mediocre ognuno ci aveva un sacco e sette sporte da mettere in comune. Ariberti incominciava co' suoi versi d'amore, inspirati dalla figlia del droghiere di Dogliani, ma che, con qualche ritoccatina, potevano tirarsi dal biondo al bruno, passare per roba di più prossima e più aristocratica derivazione. Ferrero dava fuori il suo viaggio in Toscana, col titolo pomposo: Tre mesi sull'Arno. Veramente, non c'era stato che un mese, e nemmeno nella incomoda postura del colosso di Rodi; ma già lo ha detto Orazio: Pictoribus atque poëtis, quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. La qual cosa vuol dire che pittori e poeti ebbero sempre la licenza di uscire dal seminato, e che Orazio Flacco, buon'anima sua, era un confessore di manica larga. Il Vigna, poi, ci aveva il suo capitolo sugli amori di Tibullo, e poteva tirare innanzi sullo stesso metro, mettendo in prosa quei di Catullo e di Properzio. Balestra ci aveva la canzone in pronto; un altro lo studio sui Nibelunghi, quella roba da mangiare che sapete; finalmente il Contino si disponeva a ponzare le sue note parigine, che doveano riuscire la pièce de résistance di quella indigesta accozzaglia.
E il programma? oh non dubitate, pensarono anche al programma; anzi, fu stabilito di dettarlo in francese. Non era un omaggio alla patria; ma come fare, perdinci? Il signor conte Candioli, un figlio di ministro, che si degnava di praticare con loro, e senza del quale addio speranza di far uscire il giornale, aveva fissato l'animo nel suo francese e non c'era stato più caso di rimuoverlo.
–Ah, lo dicevo io!—gridò tutto ad un tratto il Ferrero, lasciando a mezzo una sua proposta che non lo finiva poi troppo.—Il Bertone è a Torino. Guardatelo, là, sotto i portici di rimpetto.
–Dove?
–Sotto l'arcata, davanti a quella mostra di libri vecchi. Vuol fare un bel guadagno il venditore, quest'oggi!—
Gli occhi dei giovani erano corsi laggiù, dove accennava il Ferrero. Proprio com'egli diceva, laggiù, davanti alle quattro assi che formavano la bottega del libraio da strapazzo, si era fermato da pochi minuti un giovane pallido, punto in carne e assai male in arnese, quantunque non lo si potesse dire uno sciatto. La camicia era bianca di bucato; ma pur troppo non lasciava vedere i solini al collo nè i polsini alle mani. Il giubbone di un vecchio panno color tabacco, aveva un bel mostrarsi spazzolato di fresco; oltre che in quella sua continua battaglia colla spazzola ci aveva perso i peli e guadagnato un lustro particolare, si vedeva dal taglio che doveva aver servito d'abito da nozze al nonno di chi lo indossava. Il resto del vestiario era in conformità del capo principale, e non occorre dirne altro.
Anche il contino Candioli volse un'occhiata a quel poveretto e arricciò il naso, come potete immaginare.
–Comment?—esclamò egli.—Vous vous occupez de pareille engeance?
–Non faccia caso;—rispose il Ferrero.—È stato un nostro compagno in filosofia, un amico dell'Ariberti.
–Ve l'ho già detto una volta; mio come vostro!—gridò l'Ariberti seccato.
–Eh via, non andare in collera! Si dice questo perchè tu lo conoscevi prima di noi. Del resto, non c'è nessun male. Si può avere avuto a che fare con molta gente, a questo mondo; tutto sta a non strofinarcisi troppo.
–Per non appiccicarsi l'untume;—soggiunse Balestra, in mezzo alle risa degli altri.
Frattanto il giovane che era argomento di tante chiacchiere, dopo aver scartabellato parecchi volumi e comperatone uno con pochi soldi che cavò dal taschino della sottoveste, si mosse di sotto l'arcata per traversare la via, tenendo sotto il porticato di destra proprio a filo del caffè dove stavano seduti i suoi critici.
–Che voglia entrar qua?—domandò tra spaventato e scherzoso il Ferrero.—Io prendo il portante.—
Ma il giovane non aveva di queste fantasie signorili. Entrato sotto i portici, piegò con passo frettoloso a mancina. Per altro, nel passare che fece davanti alla finestra, presso cui erano seduti costoro, dovette certamente vederli attraverso i cristalli; e bene lo dimostrò la timida occhiata che volse da quella banda, come il suo tirar lungo senza un sorriso, o un cenno del capo, indicò in pari tempo che egli sentiva la miseria sua, non meno che la loro grandezza. Il poveretto ha la vista acuta. Del resto, ci voleva poco a capire, anche senza l'ingegno di Filippo Bertone, che quelli là appartenevano alla schiera dei felici, entrati per la scala d'oro nel mondo, e che non voleva dir nulla, se il caso li aveva avvicinati a lui per qualche anno su d'una panca di scuola.
Gli allegri giovani, quasi tutti suoi compagni di studio, gli avevano dato una superba guardata, senza scomodarsi altrimenti a salutarlo. Anche l'Ariberti, che era il più esposto, perchè più vicino ai cristalli, era rimasto cogli occhi in aria, facendo le viste di badare a tutt'altro.
–Sempre i medesimi stracci!—disse il Ferrero, che era di tutti il più accanito contro il povero Bertone.—Che ve ne pare, amici? Facciamo una colletta per comperargli un soprabito?
–Ah, ah! T'intenerisci per lui?—gridò il Balestra. Amici, in verità —io vi dico, o Ferrero vuol morire, o fa conto di domandare al —Bertone che gli scriva per la Dora un capitolo sulla filosofia di —Aristotile.
–Sciocchezze!—esclamò il Ferrero, crollando sdegnosamente le spalle.
Per altro, non dovevano essere sciocchezze del tutto, perchè, alle parole del Balestra, il sarcastico Ferrero si era fatto bianco in viso come un panno lavato.
Il contino gli die' una mano in buon punto, facendosi a sviare il discorso.
–E adesso,—chiese egli,—questo Bertone studierà legge anche lui?
–Non crederei;—rispose il Ferrero.—L'anno scorso raggranellò a stento i danari della minervale. Ma se ne vedono tante!…
–È fâcheux,—sentenziò il contino,—che questi villani vogliano tutti avviarsi agli studi delle classi alte in cambio di stare alla vanga. L'agricoltura ne porta le pene. È questa l'opinione di Sua Eccellenza mio padre, ed è anche la mia.—
Intorno al borioso figlio del suo signor padre, c'erano parecchi, anzi tutti, che avrebbero potuto risentirsi di quella uscita scortese. Tutti erano figli, o nepoti, di uomini venuti su dal nulla, e perciò veri stipiti della loro casata. Ma nessuno protestò. Si ama così poco voltarsi indietro a guardare le proprie origini! E il difenderle, poi, non è egli un riconoscerne la umiltà? Nè basta ancora; oltre la natural propensione a buttare sotto il banco tutto quello che non fa comodo, c'è l'altra di dar sempre ragione agli sciocchi, quando e' si trovano in alto. È il primo passo; e poi verrà l'altro, di mettersi alla pari coi tristi. Spesso accade che urli coi lupi, chi ha cominciato ad abbaiare coi botoli. I sapienti dicono esser questa la scienza della vita; grama vita e grama scienza!
Nicolino Ariberti. era rimasto sovra pensieri. Quella timida occhiata di Filippo Bertone gli stava sul cuore.—Perchè non l'ho io salutato?—andava dicendo tra sè.—Imparerò anch'io a giudicar gli uomini solamente dall'abito?
–Torniamo a noi;—gridava intanto il Ferrero.–Si pensa sul serio a metterla in luce, la Dora?
–Ma si, certamente.
–Orbene, provvediamo subito all'essenziale. Il signor conte ci fa egli la grazia di toccarne a Sua Eccellenza? Un padre come quello non vorrà certamente ricusare cosa alcuna a suo figlio.
–«A tanto intercessor nulla si niega»—soggiunse Balestra.
–Sì, parlerò;—disse il contino, con quel suo caro sussiego;—parlerò fin da domani. Oggi ho da fare un mondo di cose. Prima di tutto, debbo passar da Barale, per vedere gli ultimi capi che gli son giunti da Parigi. È un buon sarto, il Barale, e imita abbastanza bene il taglio di Humann. Quelquefois, même, c'est a s'y méprendre. Poi, verso il tocco, vado dalla marchesa di San Ginesio, che ha ricevuto da Milano una stupenda pariglia di gris pommelés, per le sue uscite di mattina. A proposito, ecco un mantello che in italiano non si sa come esprimerlo.
–O come? Leardo pomato;—disse il Vigna timidamente.
–Soit;—rispose il contino, un tal po' sconcertato; ma quando avrete detto leardo pomato, chi vi capirà? Tandis que, se voi dite gris pommelé, ecco, vi capiscono tutti.
–Eh, non dico di no;—balbettò il Vigna, confuso da quella sorte di logica.
–La marchesa di San Ginesio,—entrò a dire il Ferrero, è quella —bellissima signora, che ha il palchetto al teatro Regio, in seconda —fila, a sinistra?
–Si, proprio quella; une femme superbe.—
Ariberti, all'udire il nome della marchesa di San Ginesio, aveva teso l'orecchio, come un buon cane da fermo quando ha fiutato la starna; e intanto si era fatto vermiglio in volto, come una ciliegia, o, se vi garba, come un collegiale.
–Una vera Giunone!—esclamò il classico Vigna. Non è vero, Ariberti? —Ti ricordi che l'abbiamo veduta parecchie volte e lungamente —ammirata dal basso della platea, dove stiamo noi, miseri mortali, a —contemplare l'Olimpo?
–Si… mi pare…—farfugliò Ariberti impacciato.
–Come, mi pare? Se non potevi mai spiccar gli occhi dal suo palchetto! Povera a lei se, dove giungevano gli occhi, fossero arrivati i denti! Tu le avresti levato i pezzi a dirittura.
–Ah ah! bravo, Ariberti! Non saresti mica un cannibale?
–Non date retta; sono invenzioni di Vigna.—
E così dicendo, Nicolino Ariberti dava all'amico imprudente certe occhiate feroci, che mal per lui se avessero avuto la virtù di quelle di Medusa.
–Eh bien, vous vous troublez, jeune homme?—entrò a dire il Candioli piantando la sua lente.—Ma foi, non avreste avuto torto; la marchesa è un morceau de roi.
–Sicuro; non l'ho detto io che è Giunone?—soggiunse il Vigna.—Con quelle sue braccia e quel collo d'alabastro, con quel naso d'imperatrice e quei grandi occhi bovini, non c'è altro paragone che tenga.
–E se la vedeste poi da vicino!—proseguì il contino, alzando la fronte, come se volesse far cadere da una maggiore altezza i tesori delle sue cognizioni.—C'est dans san boudoir qu'elle est reine.
–Fortunato Lei, signor conte,—disse il Vigna—che può godere di quella vicinanza e respirare l'ambrosia della dea.
–Ah, sì, l'ambrosia; rispose il giovine, col più vanaglorioso di tutti i sorrisi che fiorissero mai sulle labbra ad uno sciocco;—d'autant plus que la marquise vous a des négligés adorables. Dopo tutto—agiunse, a mo' di correttivo,—elle est froide, ainsi que le sont géneralement toutes les grasses.—
E buttato là il suo aforismo, il contino Candidi, stette con molta gravità a vedere che impressione facesse la sua scienza sbardellata.
–Parlez-moi de la baronne Vergnani,—proseguì egli, dopo che ebbe raccolto i segni della più rispettosa approvazione,—ou bien de la comtesse Del Pozzo. Quelles femmes ravissantes, vrai Dieu! Taille de guêpe et pied d'Andalouse, voilà comme je les aime. Ma lo capisco,—aggiunse in italiano degnandosi finalmente di scendere dal suo cavallo di battaglia.—Il signor Ariberti ama le grasse e tutti i gusti sono rispettabili.
–Che! Non creda alle fandonie del mio amico Vigna!—rispose l'Ariberti concitato.—Io non mi ricordo di aver guardato più quella che un'altra. Se ne ammirano tante a teatro, e la nobiltà torinese è così ricca di bellezze!
–Ah, pour ça vous avez raison, è una vera corbeille di fiori; ce qui fait que je papillonne pas mal e finora non ho deliberato di posarmi su d'uno tra tanti. Ma non dubitate, Ariberti; rispetteremo la vostra Giunone. Ah, ah!
–Le giuro, signor conte…
–Non giurate; siete troppo rosso e lo diventate ancora di più. Du reste, mon ami—il signor conte Candioli disse proprio mon ami; la qual degnazione tutta particolare urtò i nervi al Ferrero,—ne vous fiez pas trop. La marquise a des principes. J'ai failli échouer. Sì —soggiunse poscia, notando un atto di sorpresa dei suoi compagni,—ciò mi sarebbe accaduto, se avessi risqué mon jeu; ma ve l'ho detto, taille de guêpe et pied d'Andalouse, voilà comme je les aime.—
Così parlava quel vanerello, che aveva ancora il latte sulle labbra, e s'impancava a far l'uomo.