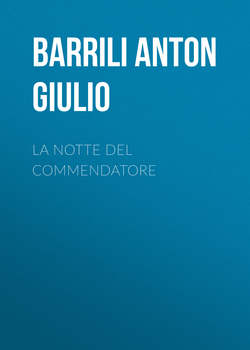Читать книгу La notte del Commendatore - Barrili Anton Giulio - Страница 5
CAPITOLO V
ОглавлениеDella gloria di Ariberto Ariberti e di qualche sciocchezza ch'ei fece.
Un mese dopo questi discorsi e gli altri del caffè dell'Aquila, Torino aveva la sua meraviglia, come Rodi, come Efeso, come Tebe, e come altre città ugualmente fortunate nei tempi antichi. Era venuto alla luce il primo numero del giornale La Dora; il più bel saggio d'ibridismo che si vedesse mai nel regno animale. Ah no, scusate, volevo dire nella repubblica letteraria.
C'era in quel primo numero tutto il banno e l'eribanno della scolaresca del primo anno di legge, con qualche rappresentanza delle altre facoltà. Il programma, intitolato modestamente Nos intentions, era stato scritto dal Ferrero in italiano e voltato in francese dal conte Candioli, che gli aveva dato (giusta la confessione del suo autore) una tournure, una noblesse, un cachet, di cui difettava pur troppo il testo italiano. Il sullodato Candioli aveva poi cominciato la stampa del suo Voyage au pays des rêves, che era il racconto della sua gita a Parigi. Il sullodato Ferrero stampava il primo capitolo de' suoi Tre mesi sull'Arno, nel quale da autore che ama i suoi comodi, egli giungeva a mala pena a Viareggio. Del Balestra c'era una canzone; del Vigna una cicalata intorno agli amori di Tibullo, con citazioni analoghe. E non mancava neppure quello studio critico sui Nibelunghi, che il Vigna aveva tolto per roba da mangiare. L'Ariberti dava fuori una trilogia lirica; nientemeno! La prima parte s'intitolava: Sotto i salici, e cantava amori contadineschi; la seconda: Sotto i pioppi, e cantava amori in villeggiatura; la terza: Sotto i portici, e l'amore, come si vede, da questa terza categoria d'alberi, entrava a dirittura in città, facendo anche una scappatina nella seconda fila di palchi del teatro Regio, per ossequiare la bella marchesa di San Ginesio.
Venendo ora ai nomi, alcuni firmavano i loro scritti, altri no. Il Candioli, per esempio, si nascondeva dietro un Comte de***; ma trovava il modo di dire cinquanta volte in un giorno che le tre stelle della Dora non avevano altro scopo fuor quello di usar riguardo ad una famiglia qui ne s'était jamais encanaillée dans les lettres.
Quanto al poeta della trilogia, egli firmava per la prima volta in sua vita; Ariberto Ariberti.
Com'era andata la faccenda? Nicolino era stato persuaso a sbattezzarsi, da un discorso dell'amico Ferrero.
–Sentimi;—gli aveva detto costui;—vuoi salire in fama di poeta? Non basta esserlo, bisogna parerlo. Ora, quel tuo nome di Nicolino non è abbastanza poetico; ti dirò anzi schiettamente che non lo è punto. Un poeta ha da avere un bel nome, che i giovani e le donne possano ripetere volentieri. Vedi, per esempio, il Foscolo. Si chiamava Nicolò come te. Nicolò Foscolo! Ti pare che quel nome potesse andare, pel futuro cantor dei Sepolcri? A lui per il primo non parve affatto, poichè incominciò un giorno dal chiamarsi timidamente, e come per via d'esperimento, Nicolò Ugo Foscolo; indi, buttata la parte inutile, trovò la vera armonia del suo nome, «Ugo Foscolo», cinque sillabe che non morranno mai più.—
Quelle ragioni erano sembrate il nec plus ultra a Nicolino Ariberti, che aveva subito pensato di ribattezzarsi a suo modo. E chi vorrà biasimarlo del suo capriccio innocente, in un mondo che è così largo di perdono a tante altre cose, niente affatto innocenti? Dopo tutto questa di foggiare il nome a somiglianza del casato, è moda antica e prettamente italiana. Per non ricordare che un esempio illustre, citerò Galileo Galilei.
La comparsa della Dora aveva fatto chiasso. Si era riso un pochino intorno a quella novità di un giornale bilingue; e un certo Messaggiere, che non la perdonava a nessuno, e neanco ai figli de' ministri, aveva posto meritamente que' signorini in canzone. La celia era parsa così grave, che i collaboratori della Dora, raccolti in solenne adunanza al caffè dell'Aquila, avevano lungamente ed altamente disputato, per vedere se non fosse il caso di andare a chiederne ragione al beffardo collega. Fortunatamente per lui, prevalse l'idea di rispondere inchiostro per inchiostro, sebbene colla giunta del sale e del pepe, che doveva, nell'animo loro, esser peggio di un colpo di spada.
Del resto, a far rimanere questa nel fodero, aveva contribuito largamente la lode che, secondo il conte Candioli, era data nei salotti aristocratici al nuovo giornale. Il avait du premier coup conquis sa place; cosa di cui non era da dubitare anche prima della pubblicazione; ma che doveva sempre dar gusto e vendetta allegra di certi lazzi plebei.
Soltanto una cosa dava molestia ai collaboratori della Dora e ne amareggiava un pochino il trionfo. Quel francese del Candioli era maledettamente scorretto, ed essi da molte parti avevano udito farne l'appunto. Per contro, il signorino sosteneva che il giornale era tutto quanto scorretto; faute d'un bravo correttore che rivedesse le bozze di stampa. Ariberti gli teneva bordone; un correttore gli parea proprio necessario, attento, di buona volontà, e che si contentasse di poco, per non aggravare il bilancio della Dora. Questa fenice dei correttori il nostro Ariberti l'aveva già in pronto, e, sentendosi sostenuto dal Candioli, ne aveva anche detto il nome.
Tutti avevano fatto buon viso alla proposta, salvo il Ferrero, la cui gratitudine perseguitava Filippo Bertone fino al punto di non lasciargli guadagnare venti lire al mese. S'intende che Ferrero parlava in nome dell'economia. C'è sempre una ragione onesta, per commettere una bricconata. Che diamine! L'economia insegnava di andare cauti fino a tanto non ci fosse la vendita del giornale in rispondenza delle spese di stampa. Soltanto quando fosse raggiunto quel modestissimo scopo, si sarebbe potuto prendere il correttore, ed anche pagarlo un po' meglio; che quanto a lui lo avrebbe voluto coi fiocchi, dovesse anche costare un centinaio di lire. Frattanto, poichè non potevano spendersi neppure le venti, si lasciasse la proposta in sospeso e ognuno dei collaboratori pensasse a correggere con maggior diligenza le sue bozze, anche a tornarci su due o tre volte.
Per altro, il conte Candioli non era rimasto persuaso, et pour cause. Nel medesimo giorno egli aveva preso in disparte Nicolino… cioè, no, diciamo d'ora innanzi Ariberto Ariberti.
–Est-ce que votre ami Berton connait le francais?
–Sicuramente; il povero giovane sa un po' di tutto, e quel poco lo sa bene, come tutti coloro che hanno dovuto imparare senza maestri.
–Eh bien, fatelo venire domattina da me; c'intenderemo. Io non ho pazienza a rivedere le mie bozze di stampa. C'est une corvée, et mon état est de ne pas en faire.—
Da questo discorso del Candidi coll'Ariberti ne avvenne che la prosa francese del contino nel secondo quaderno della Dora, uscisse stampata in forma cristiana. Ci si mostravano poi certe frasi, ci si rigiravano certe tournures, che il nobile autore non avea pur sognato di metterci. Ma egli si guardò bene dal protestare; che anzi!..
–Ce pauvre Berton! mais savez-vouz qi'il a de l'intelligence?—aveva detto egli all'Ariberti in un impeto di entusiasmo.
In un altro di questi lucidi intervalli, il conte Candioli, che, per ragione della sua povera prosa, non isdegnava di salir qualche volta le scale d'un quinto piano in via Santa Teresa, aveva perfino tentato di far smettere a Filippo il suo venerando giubbone di color tabacco. Sventuratamente non l'aveva pigliata pel suo verso, e si era impuntato ad offrirgli i suoi spogli. Filippo Bertone non era orgoglioso più del bisogno, ma non vedeva ragione di romper fede al suo povero soprabito, per far sapere alla gente che indossava gli abiti smessi dal conte Candioli. Quanto poi a farsene fare di nuovi, come il suo mecenate gli propose da ultimo, profferendosi a pagarne la spesa, egli non ne vedeva ancora la necessità. In fondo in fondo, non voleva elemosina. Guadagnava venti lire al mese per mettere in buon francese il tunisino del signor conte, e per allora ne aveva di catti.
Tornando al giornale, se la prosa del Candioli cominciava, a passare, le liriche amatorie dell'Ariberti avevano dato a conoscere un poetino di garbo, una speranza nuova della patria, un astro nascente, e tutto quel che vorrete. Il nostro giovinetto entrava anche lui nell'orto della fama, così fieramente custodito dai draghi della critica, e vi gustava (dirò così per continuare la metafora seicentistica) i primi frutti della gloria, come sarebbe quello che Orazio ha espresso in un felicissimo verso, così recato in italiano da non so quale traduttore:
Ir mostro a dito e udirsi dire: è desso.
Una sera, per venire agli esempi, una sera egli era al teatro Regio, seduto nel suo scanno presso l'orchestra. Il nostro Ariberti non poteva già più contentarsi di rimanere in platea. La cosa era buona per un filosofo; ma per uno studente di legge, per un avvocato in erba, non poteva più andare. A fare questo gran cambiamento nelle sue consuetudini, mancavano, a dir vero, i quattrini; ma la necessità rende l'uomo ingegnoso. E per comodo dello studente in angustia, nacque lì per lì un avvocato che doveva partire da Torino, per andarsi ad allogare non so dove, e che non poteva portar seco tutta quanta la libreria. Gli autori utili, anzi necessari, che si potevano avere in quella occasione e a buon patto, erano molti, da Bortolo di Sassoferrato al Deluca, e da questo al Merlin, col Pardessus (avrebbe detto Candioli) par dessus le marché. In conseguenza di questa bella trovata erano venuti per la posta da Dogliani i denari dell'abbonamento alla sedia chiusa del Regio. E perciò avvenne che, quella sera di cui si parla, il sullodato astro nascente, in giubba a coda di rondine, petto di porcellana, e cappello a stiacciata, fosse visibile sull'orizzonte del Regio, dalle otto alle undici, in quella che un'altra e più vivida stella sfolgorava da un palchetto di seconda fila. Era essa, come il savio lettore avrà già indovinato, la bella marchesa di San Ginesio; la quale, pari a tutte le belle donne l'ultima volta che si sono vedute, era in quella sera più bella che mai.
Unico cavaliere (essendo lo spettacolo appena incominciato,) stava nel palchetto della marchesa di San Ginesio un signore di mezza età, che all'aria fredda e svogliata s'indovinava essere il marito. È notevole la cura che questi signori così largamente favoriti dal codice civile pongono a far conoscere i loro diritti ed in pari tempo la fiacchezza con cui sono disposti a difenderli. Pronti, ilari e pieni di smancerie, quando vanno in giro, aliando negli orti del prossimo, costoro vi appaiono stanchi, musoni, pieni di tedio, quando l'ufficio della accompagnatura li trattiene per poco a quattrocchi colle dolci metà. Quell'aria di olimpica noia par che dica alle genti: «Signori, se credono che io ci provi gusto a star qui, s'ingannano a partito; io mi divoro i miei proprii sbadigli, come Saturno i figliuoli. Vengano liberamente e vedranno come piglio il portante. Animo, dunque, en avant les cavaliers!»
Anche la signora moglie profitta di questo matrimoniale intermezzo, per cento atti e vezzi che non riguardano punto il suo annoiato compagno. Si prova due o tre volte sul cuscino; si rassetta la veste, perchè non istia troppo tirata, e perchè faccia agli occhi dei riguardanti un bel partito di pieghe; dà una guardata in giro alle prime file e una sbirciata alle ultime; sorride di compassione, al vedere qualche veste, o acconciatura, non più nuova fiammante; si morde il labbro dall'invidia, scorgendo una collana di diamanti o un paio di gocciole che sembrino deriderla coi mutevoli e sfolgoranti riflessi; solleva con grazia il binoccolo incrostato di madreperla e lo appunta su questo o su quel palchetto rivale, non senza lasciar cadere qualche occhiata in platea e nei posti distinti, dove il suo braccio mollemente appoggiato sul davanzale di velluto è fatto argomento di dotte considerazioni e di ascetiche contemplazioni da tutta una Tebaide di scapoli. Insomma, par che canti anche lei il suo verso: «Signori, non facciano caso, è mio marito; otto anni di matrimonio ci hanno ridotti così. Se il Codice non dicesse che la moglie deve seguire il marito, quando egli la accompagna a teatro, lor signori certamente non mi vedrebbero, vittima rassegnata, misurare i miei passi su quelli del mio sacrificatore. Animo, chi si fa innanzi a consolarci quest'ora di martirio?»
Qui per altro va fatta una restrizione. Se nel palchetto della marchesa di San Ginesio il signore di mezza età appariva alla sua aria svogliata il marito di quella Giunone, la signora dal canto suo non somigliava punto a quel tipo di moglie che ho tratteggiato pur dianzi. La marchesa di San Ginesio aveva dato a mala pena uno sguardo alla sala, nell'atto di sedersi al suo posto, ed essendo giunta in principio di spettacolo (cosa piuttosto rara, che molte altre dame non avrebbero ardito di fare) era rimasta intenta alla scena, e più ancora alla musica, senza pure voltarsi, o sogguardare colla coda dell'occhio, al ripetuto cigolare degli usci e al consecutivo fruscio delle sete e dei velluti, che esercitano durante il primo atto di una rappresentazione la pazienza del colto sì, ma pur qualche volta invelenito uditorio.
Alda di San Ginesio si curava poco del volgo profano che le stava dintorno e lo lasciava scorgere senza un ritegno al mondo. Tale per fermo dovette parere la regina di Cartagine a Jarba, quando costui, alla dimanda, del suo confidente: «Qual ti sembra, o signore?» rispose ammirato il suo metastasiano: «Superba e bella».
Difatti, ella era superba. Ma superba per vano orgoglio, o per gentile alterezza d'animo? Questo venìa domandando a sè stesso il giovine Ariberti, mentre, appuntando il binocolo a caso tre o quattro palchetti più indietro, stava di soppiatto ammirando le forme scultorie (è questa la frase moderna, e l'adopero anch'io senza scrupolo) della sua bella Giunone, che parte emergevano e parte trasparivano dai pizzi, dalle trine e da tutti gli altri intessuti nonnulla, di cui si copre la bellezza, ma senza troppo nascondersi.
Verso la fine del primo atto, l'uscio del palchetto che l'Ariberti non perdeva di vista si aperse, e il voltarsi leggermente che fecero le teste dei coniugi verso il fondo indicò l'arrivo di un visitatore. Le visite lassù erano la gran seccatura del nostro innamorato, che vedeva la marchesa costretta a rimaner lungamente colla faccia rivolta dall'altra banda, le spalle contro la parete, e la persona quasi nascosta a lui nella penombra del palchetto. Inoltre, chi erano essi e con quali intenzioni andavano, tutti quei bene inguantati Achei, a intrattenerla mezz'ora per ciascheduno di cento sciocchezze e a respirare la loro parte d'aria a due spanne dalla sua bocca? Fossero state dame, alla buon'ora; ma uomini!
Per questa volta, sebbene si trattasse di un uomo, l'Ariberti non uscì fuori dai gangheri. Era apparsa dal fondo e si illuminava beatamente in mezzo a quelle dei due coniugi la faccia gloriosa del contino Candioli; un paio di baffi biondi che andavano a smarrirsi nella cascata di due ventole bionde, uscenti senza soluzione di continuità da una bionda zazzera, spartita a mezzo il cranio e tagliata sui lati a punta di spazzola: poi, nei vani lasciati da questa ricca vegetazione di canapa, un fronte piccino e un paio d'occhietti grigi, un naso e un mento angolosetti anzi che no; a farla breve, un bel tipo di cagnolino inglese, che, coll'aiuto del parrucchiere e del sarto, ma più ancora per aver noi fatto l'occhio alla estetica nuova, può anche dirsi ai tempi nostri, un bel giovine.
E questo bel giovane, entrato pur dianzi nel palchetto della marchesa di San Ginesio, non aveva, siccome ho raccontato, fatto dar ne' lumi il nostro Ariberti. Egli ricordava tuttavia due sentenze ed una promessa del conte Candioli. Le sentenze dicevano: «froide, ainsi que le sont généralement toutes les grasses; taille de guêpe et pied d'Andalouse, voilà comme je les aime». La promessa poi era questa; «non dubitate, Ariberti, noi rispetteremo la vostra Giunone». Ora, se la promessa non lo raffidava poi troppo, ben gli parevano sufficiente malleveria le due sentenze del contino, per quanto, a suo giudizio, una fosse bugiarda e l'altra dinotasse un pessimo gusto, almeno nella sua prima metà. Chiedo scusa alla taille de guêpe; non son io che giudico in via sommaria; ho un personaggio alle mani, che pensa a suo modo, e gli fo il dragomanno.
Il cagnolino inglese fu accolto con affabilità dalla dama e con lieta dimestichezza dal marito. Nè poteva essere altrimenti, perchè il contino Candioli era uno dei loro, poi il figlio di un ministro, poi (che serve il tacerlo?) un primo Cireneo, che avrebbe aiutato il marchese a portare per quella sera la sua croce, e fors'anco a deporla un tratto, permettendogli di andare in un palco di bocca d'opera a studiare più da vicino il corpo di ballo. Il marchese di San Ginesio ci aveva due ragioni per coltivare gli studi coreografici; era marito e consiglier comunale. Ne trovi delle altre il lettore, se queste due non gli sembra che bastino.
Io dirò intanto che la presenza del nuovo venuto portò come un pizzico d'allegrezza in quella musoneria maritale. Il contino Candioli, del resto, recava nel terzetto la maggior quantità di parole. Il marchese ad ogni tanto entrava nella conversazione con una frase, per dare lo addentellato al suo interlocutore. La marchesa, colla testa leggermente china e col ventaglio ritto che le sfiorava il mento, pareva intenta al dialogo de' suoi cavalieri. Forse era svogliata e distratta; e quell'atteggiamento e un sorrisetto a fior di labbro erano pretta cortesia, non attenzione vera, alle inezie di cui certamente si componeva il discorso.
L'infranciosato patrizio doveva passare in rassegna le donne e i personaggi più notevoli dell'uditorio, poichè il marchese di San Ginesio a volte alzava il binoccolo per guardare qua e là, e la marchesa dal canto suo faceva in pari tempo un mezzo giro del capo, per dare uno sguardo fuggevole là dove egli sicuramente accennava. Poi venne la volta dei posti distinti, aia pulita e lucente su cui dimenavano gloriosamente il collo e facevano la ruota i signori del mondo elegante.
Pensando allora che l'attenzione dei tre nobili osservatori poteva da un momento all'altro rivolgersi sulla sua modesta persona, lo studente assunse un'aria sbadata. Era in piedi, e dava le spalle al palcoscenico; epperò fece le mostre di guardare qua e là senza fermarsi in nessun luogo, distratto, anzi svogliato, come è debito d'ogni gentiluomo che si rispetti un tantino. Per altro, s'intende che ad ogni tratto nel vagabondare a destra e a sinistra, gli occhi dell'innamorato ricorrevano al loro centro d'attrazione, e gli giravano intorno con una rapida volta, come farebbe una cometa col sole.
Per tal modo egli potè avvedersi in tempo di essere stato notato dal Candioli ed anche (oh Numi!) d'essere indicato da lui alla dama. Giunone volse allora lentamente la testa, abbassò le ciglia dal suo Olimpo, e il poeta dei salici, dei pioppi e dei portici, sentì che il suo cuore rispondeva con un palpito all'appressarsi di quella gran luce. Sbirciando colla coda si avvide di ben altro. La signora aveva stesa la mano alla mensoletta di velluto che reggeva il suo binocolo incrostato di madreperla, e rialzando leggiadramente sul gomito un braccio tornito dalle Grazie, si degnava di recare il bel trovato di Galileo all'altezza degli occhi. Oh miracolo inaudito! Oh fortuna insperata! Quelle due lenti, piene di arcani bagliori, erano appuntate su lui.
Qual fosti allora, per dirla con una frase prediletta di Giacomo Leopardi, qual fosti, o Ariberti? Aver meritato uno sguardo di quella donna, pensare che quella donna sapeva il suo nome, e che egli, umile e sconosciuto il giorno addietro, entrava di primo acchito nel settimo cielo de' suoi desiderii; o non era quello il caso di andare in visibilio?
Balenò un tratto, come se lo avesse colto una vertigine; indi, cercando di pigliare un contegno, fece per alzare il binoccolo a sua volta e guardare in qualche luogo. Ma nell'atto di alzare il gomito, gli parve quello un cattivo espediente. Diffatti, se la marchesa guardava lui, con che animo avrebbe egli fatto le viste di guardare un'altra? E così avvenne che, tra il sì e il no, rimanesse a mezz'aria. Avrebbe voluto mettersi due dita nel solino, per rassettarselo intorno al collo, ma si ricordò in tempo di Don Abbondio, e finì per lasciar ricadere il braccio disteso, lungo la costura dei calzoni, nella posizione del soldato senz'armi. Frattanto, al caldo che sentì salirsi alla faccia, gli parve di arrossire come un coscritto che si vede guardato la prima volta dal suo colonnello.
Sicuramente, lassù si parlava di lui. Nel volgersi che fece macchinalmente alcuni secondi dopo, si avvide che anche il marchese di San Ginesio aveva chinato gli occhi a guardarlo. Ariberti lo avrebbe liberato volentieri da quella molestia. A lui non premeva punto di destar l'attenzione del tiranno prima del tempo. Scellerato Candioli! Non poteva aspettare a metter fuori le sue indicazioni quando il tiranno sullodato fosse uscito di là?
Ma la tortura del nostro innamorato non era finita con quella guardata del marchese. Ariberti doveva bere fino all'ultima goccia il calice amaro della sua gloria. La conversazione intorno ai fatti suoi (che non poteva essere altrimenti con tutto quel lavoro di binocoli) era interrotta o conchiusa con una risata della signora. Il povero studente, impacciato come un pulcino nella stoppia n'ebbe una stretta dolorosissima al cuore. Come mai una dama di quella sorte, per solito così severa e contegnosa, dava in uno scoppio di risa? Imperocchè, non c'era da sofisticarci su, gli era stato uno scoppio; argentino, se vogliamo, ma l'epiteto non toglieva nulla al sostantivo. E proprio nel guardar lui; e proprio nel ragionare di lui!
Che diamine le aveva detto il cagnolino inglese? Forse si era fatto beffe de' suoi versi? O del nome di Nicolò mutato in Ariberto? O della sua qualità di provinciale? Comunque fosse, la sua vanità aveva toccato un colpo profondo; comunque fosse, poi, la bella e severa Giunone aveva dato in uno scoppio di risa, come avrebbe fatto la più umile, la più volgare tra tutte le donne di questo basso mondo, poniamo la signora Giuseppina Giumella, fiorista in via Doragrossa.
S'intende che tutti questi ragionamenti il nostro eroe non li faceva lì per lì dal suo sedile, ma per via, nel tornarsene a casa, torbido e sbuffante come una belva ferita che si ripara nel suo covo. Là, in teatro, fu solamente cruccioso e impacciato. Non volse più gli occhi al palchetto di seconda fila; anzi, rannicchiatosi nella poltrona, col collo tirato in dentro come le tartarughe e colle ginocchia alla sciamannata contro la spalliera della poltrona che aveva davanti a sè, rimase per tutto il rimanente dello spettacolo voltato dall'altra parte.
Giunone non si avvide di quel broncio terribile. Anche lei, come portavano le consuetudini della civil compagnia, dato al signorino quell'istante di attenzione che era consentito dal discorso, non aveva più posto gli occhi su lui.
La notte di Ariberti fu inquieta. Mulinò sul guanciale truci pensieri e propositi di arcane vendette. Voleva salire in fama, farsi amare da quella donna e poi disprezzarla, come aveva letto d'un eroe da romanzo; ma pensò con ragione che queste peripezie facili a svolgersi in una tela da romanzo, non lo erano del pari nella vita comune, dove le signore donne sogliono curarsi poco, assai poco, degli uomini illustri. Pei giovanotti, che si sono bene o male educati a questo culto, studiando il De Viris e la storia della letteratura, non c'è che dire, un grand'uomo è un grand'uomo; per le donne è tutt'altro; qualche volta, per esempio, è un noioso, e si sospetta generalmente che prenda tabacco.
Piuttosto, avrebbe dovuto darsi alla gaia vita, diventare uno zerbinotto, celebre per le sue avventure e per qualche elegante capestreria. Ma di questi Don Giovanni ce n'erano già tanti in ordine di marcia, che il nostro Ariberti correva il rischio di giunger l'ultimo, e quando non ci fosse stato più sugo a tentare l'impresa. Voleva una vendetta più spicciativa, lui; ma sì, pigliala! Tra l'altre belle invenzioni, pensò di non guardar più quella donna, di andare a farsi trappista, per raccontare la sua storia a qualche giramondo francese, il quale vi avrebbe tessuto un capitolo d'Impressioni; le quali sarebbero cadute sotto gli occhi di lei; la quale… Insomma, un monte di scioccherie, sulle quali si addormentò finalmente, ma per sognare di guardate superbe e beffardi scoppi di risa.
Il giorno dopo era venerdì, e quella sera il teatro Regio era chiuso. Giorno nefasto! Ariberti non si accostò nemmeno all'atrio dell'università; ingoiò dell'assenzio, bevanda de' forti, e scrisse a sfogo un centinaio di giambi. Venne il sabato e tutta la sua rabbia era smaltita; non gli era rimasto nel cuore che un dolor sordo, che io paragonerei volentieri a quello del mal di denti quando è per andarsene, se non temessi di farmi mettere al bando dalle anime innamorate. Quella sera il teatro era aperto, anzi v'era spettacolo nuovo, e il gran concorso degli spettatori, collo scintillìo di tutte le stelle di prima e di seconda grandezza sul meridiano del Regio, oscurò la luce tapina di quel povero satellite che si chiamava Ariberti. La metafora vuol dire che la marchesa di San Ginesio non mostrò di avvedersi che egli fosse al mondo. Rinunzio a descriver la notte; animus meminisse horret, luctuque refugit.
Venne la domenica. Ma le domeniche la marchesa non andava a teatro, salvo che in certi casi eccezionali. E quella sera il caso eccezionale mancava; nè l'Ariberti poteva gloriarsi di esserne lui uno. Gli bisognò dunque aspettare il lunedì sera. Ma ohimè! per quanto lo spettacolo non avesse più il pregio della novità e la sala non offrisse più le distrazioni dell'altra volta, madonna non pose mente a lui, nè si accorse de' suoi atti, o delle sue giaculatorie, rincalzate dal più operoso binocolo che uscisse mai dalle vetrine di Fries.
Come fare a destar l'attenzione di quella superba? L'Ariberti avrebbe rotto volentieri un bracciuolo della poltrona, o invitato ad alta voce il contrabasso a scorciare di due palmi il braccio del suo molesto istrumento. Fece in cambio la ragazzata di applaudire una seconda ballerina di contrattempo, e senza che un cane gli tenesse bordone.
Lo zittirono, com'era naturale, e tutti gli sguardi si volsero a lui, che si provò a star duro come un milorde inglese, quantunque si sentisse venir rosso fino alla radice dei capelli. Per altro, non andò guari che dovette allibire, avendo veduto con quella benedetta coda dell'occhio che la signora, seguendo il moto delle teste, aveva posto lo sguardo su lui e lo considerava coll'aria attonita di chi non capisce la ragione di un atto, o di una parola, che potrebbe anco esser l'atto, o la parola di un pazzo. Questo, nella sua foga giovanile, non aveva preveduto l'Ariberti; il quale giurò in cuor suo di non far più capo a così eroici spedienti.
Finito il ballo, che gli parve assai lungo, uscì dal teatro, senza volerne saper altro. Voleva in quella vece andare al caffè, e bere del pònce. Nel vestibolo incontrò il conte Candioli, che scendeva allora dalla scala dei palchetti.
–Arrêtez donc? Où diable courez-vous si vite?—gli gridò il contino alle spalle.
Ariberti lo avrebbe mandato lui al diavolo; ma bisognava adattarsi alla necessità e far bocca da ridere.
–Vo a prender aria;—rispose egli, dopo aver stretta la mano che il signor conte si degnava di porgergli.
–Aspettate quella della prima donna, perbacco!—sclamò il Candioli, felice d'avere imbroccato un bisticcio.—Il terz'atto è il più bello dell'opera.
–Ma io, veramente….
–Sì, capisco—interruppe l'altro ridendo;—voi andate ad appostarvi sull'uscita del corpo di ballo. Avouez-le, heureux fripon; voi aspettate la piccola Diavolina.—
Diavolina era il nome che portava nel ballo la danzatrice «di rango italiano» applaudita pur dianzi dall'Ariberti.
–Io? Non la intendo;—diss'egli confuso.—Andavo a bere un pònce; ed anzi, se il signor conte vuole onorarmi…
–Grazie, non posso. Questa sera son di servizio; ho da accompagnare a casa la baronessa Vergnani, che ha il marito in missione a Monaco e che offre un tè ai suoi cavalieri di quest'inverno. Vous voyez ça d'ici; Penelope che convita i Proci! Ma a proposito della piccola Diavolina, che diamine v'è saltato in mente, mio caro, di applaudirla a quel modo? Siete il suo valet de coeur?
–Che! non la conosco neanche per prossimo.
–Ah, meglio così; perchè, a dirvela qui entre nous deux, quella piccina non val proprio nulla. E poi c'è il suo re di danari, il cavaliere di Grugliasco, che ve la contenderebbe à outrance. Intanto, vedete, voi ve ne siete fatto un nemico mortale, poichè con quell'applauso avete esposta la sua bella a pigliarsi dei fischi.
–Ah sì? Non me ne importa proprio un bel nulla.
–Prenez garde! Il cavaliere passa per la prima lama di Torino.
–Le ripeto, signor conte, che ciò non mi fa caldo nè freddo. Col mal umore che ho in corpo, la romperei anche con il gran lama del Tibet.
–Pas mal, pas mal!—disse Candioli, con un cenno del capo che indicava il buongustaio.—Mais quelle mouche vous a piqué? Sareste in collera con Giunone?—
Ariberti si rabbruscò a quel ricordo dei loro discorsi di caffè.
–Le ho già detto, signor conte, che in tutta quella chiacchiera del Vigna non c'era una parola di vero.
–Eh via! Non sofistichiamo. Se non c'era allora, ci può essere adesso. L'altra sera vi ho colto in flagranti di contemplazione.
–Sì, non lo nego, l'ho guardata;—balbettò l'Ariberti, confuso;—ma come ne ho guardate tante altre, e non ci sono più tornato.
–Davvero?
–Glielo assicuro.
–Tant mieux! Mi pare di avervelo già detto; è una donna troppa fredda. On ne lui connait pas la moindre aventure.
Quella frase, buttata là a caso dal contino, suonò dolcemente all'orecchio d'Ariberti. Egli, per vero, non avrebbe saputo dirne il perchè, quando pure si fosse fermato a pensarci; ma provava una certa consolazione a sentire che quella superba donna, la quale rideva di lui, facesse piangere gli altri; che certamente erano in molti a sospirare per lei.
E tuttavia, quella risata gli stava sempre sul cuore. Avrebbe voluto chiederne al conte, e saperne, come suol dirsi, l'intiero. Ma sì, per riuscire al suo fine, gli sarebbe bisognato scoprirsi troppo, confessare ch'era stato tutt'occhi per la marchesa, che si era avveduto dall'accenno a lui, e via via tutta una filatessa di cose da non dirsi al Candioli. E poi, anche disponendosi a ciò, il nostro provinciale non avrebbe saputo come prenderla.
Così avvenne che rimanesse colla voglia e colla stizza, non bene affogate più tardi nel pònce, che fu ad un pelo di scottargli il palato. Di tornare in teatro, dopo quella memoranda impresa dei battimani, non sentiva più il desiderio. Anche quella vergogna gli stava sul cuore, e in quel momento poi, anche la marchesa gli era venuta in uggia, per quella sua attonita e altezzosa guardata.
A farla breve, il nostro innamorato era in quella sera un tal misto di contradizioni, che io rinunzio a descriverlo, per non sembrarvi più matto di lui.
In casa, dove finalmente si ridusse colle sue stravaganze, lo aspettava una novità. Sul suo tavolino da notte, appoggiata al piattello del candeliere perchè avesse a dargli subito nell'occhio, stava una lettera per lui. La soprascritta, di mano evidentemente femminile, oltre la calligrafia poco sicura dimostrava un'ortografia male in gambe. E non era qui tutto, poichè l'Ariberti nel rivoltare la lettera, vide che era sigillata colla metà d'una volgarissima ostia.
–Chi diavolo ha potuto scrivermi?—domandò mentalmente a sè stesso.
Al nostro eroe era passato per la fantasia un nembo di lettere profumate in carta di seta, collo stemma impresso a colori sulla ripiegatura, e con una mano di scritto affilettata all'inglese; sogni tutti e desiderii della sua giovinezza precoce. Ed ecco, gli capitava in quella vece alle mani una letteraccia in carta comune, mal ripiegata, peggio sigillata, e probabilmente piena di scarabocchi, sul fare di quelli che la soprascritta portava ad insegna.
Basta, non è tutto oro nel mondo, e Ariberti doveva contentarsi per quella volta agli spiccioli di rame. Chi sa? poteva anche essere oro misto. Imperocchè dopo tutto ci son pure delle care e belle donnine, che hanno una brutta calligrafia e che suggellano le lettere coll'ostia.
Il giovine aperse tra rassegnato e curioso quella che gli mandava per allora il destino. Essa incominciava «illustrissimo signor Riberti» che gli fece di scoppio «rizzar le chiome sul crin», come cantò elegantemente un poeta di mia conoscenza.
Oramai, non c'era più da sperare. Ariberti corse cogli occhi in fondo alla lettera. E qui, s'egli avesse avuto la memoria più pronta, non ci sarebbe stato neanche da stupirsi. La firma era quella della «sua devotissima serva, Giuseppina Giumella» di quella fiorista in via Dora Grossa e pigionale della signora Paolina, in via degli Argentieri, che i lettori conoscono.
Il primo atto che fece egli al leggere quella firma, voleva dire: che nome prosaico! chi sarà mai questa devotissima serva? E stava rigirandosi il foglio tra le dita, ma senza cavarne un costrutto. Laonde, si appigliò allo spediente più ovvio, che era quello di leggere, o, per dire più veramente, di decifrare quei geroglifici.
La signora Giuseppina lo ringraziava del bene che aveva avuto da lui e giurava che gliene sarebbe stata riconoscentissima «fino all'estremo anelito»; la qual frase faceva testimonianza d'una certa coltura letteraria, raspata nei libretti d'opera. Finiva pregandolo caldamente a voler passare da lei, per una cosa di molta importanza che aveva a dirgli.
Ariberti si ricordò allora della pigione pagata, e gli tornò anche in mente, sebbene veduto alla sfuggita, il tipo della ragazza che aveva occupato l'antico domicilio di Filippo Bertone.
Ma che cosa voleva costei? La vanità nascente non permise al giovine di dare al fatto la spiegazione più naturale. Di certo, quella ragazza gli aveva a parlare per conto d'altrui, e molto probabilmente d'una donna. A quella supposizione che gli faceva intravedere un intrigo donnesco, si sentì battere il cuore. Infatti, e non poteva esser proprio così? Non faceva essa la fiorista in uno dei più riputati negozi di Torino, dove certamente praticavano le più eleganti signore della città?
Di questa guisa, tra l'immagine della marchesa e quella di Giuseppina Giumella, che la sua ferace fantasia accoppiò per alcuni momenti in un medesimo intrigo, tra gli zitti della vigilia e la visita del giorno imminente, il nostro eroe dormì poco e balzò dal letto più presto del solito.
Quella mattina si vestì con una ricercatezza che mai la maggiore, si profumò, si lisciò un'ora allo specchio, come se si fosse trattato di un ripesco amoroso. Si è detto che ogni donna, alle sue ore, è un pochino civetta; ma io vi so dire che l'uomo è un civettone senz'altro. Il mio eroe uscì di casa azzimato come un vero damerino e si avviò verso quella benedetta strada degli Argentieri, che gli pareva tutt'altra da quella di prima. Salì le note scale con un po' di rimescolo nel sangue; chè non si era mai trovato fino allora in un caso simile. Per altro, siccome non era un andare alla morte, si fece animo come potè, e ravviati colla mano i morbidi capegli sul fronte, e tirate due punte, o per dir meglio, due ombre di baffi, diede una scossa al campanello che sapete.
L'uscio si aperse prontamente, e la signora Giuseppina Giumella, fatto entrare il visitatore, fu pronta del pari a richiuderlo. Certo ella era stata in ascolto colla mano sul catenaccio, e avea fretta di chiuder quell'uscio, perchè quella curiosaccia della signora Paolina, facendo capolino dal suo, non vedesse lo studente. Anche lei era vestita con una certa attillatura, e i suoi capegli biondi, indocili al pettine, apparivano assettati con cura. Ed anche lei si vedeva confusa, e dopo avergli additato una scranna presso l'abbaino, stette lì cogli occhi bassi e in silenzio, quasi non sapesse neppur lei da che parte incominciare.
C'era, a diportarsi in tal modo, il suo bravo perchè. L'accorta ragazza voleva piantare un chiodo, e le premeva di non parergli sfacciata. Dai discorsi della padrona di casa, aveva fiutato subito la selvaggina e non voleva lasciarsela fuggire di mano. C'era di mezzo un certo giovinastro, studente di medicina, frequentatore di bische, il quale non le avrebbe anche levati quei pochi che ella guadagnava col suo lavoro di tutta la settimana. Ora, senza contare ch'ella era già stanca di quell'arnesaccio e lo avrebbe volentieri mandato a quel paese, la fiorista cercava un'anima gentile, un cuore ben fatto, che sapesse intendere il suo e le prestasse lì per lì una cinquantina di lire. Come si vede, era modesta ne' suoi desiderii, e una così piccola somma l'avrebbe trovata soltanto a scendere in istrada per chiederla al primo che fosse passato di là. Ma questo forse non faceva comodo alla signora Giuseppina. Ci aveva il ricordo fresco della cortesia d'Ariberti, cortesia fatta senza pur conoscere a chi la usasse. E questo era un precedente degno di nota.