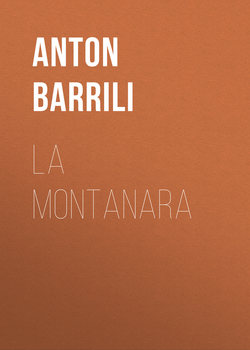Читать книгу La montanara - Barrili Anton Giulio - Страница 3
Capitolo III.
Tra l'Ariosto e il Tasso
ОглавлениеFigura di donna, ho detto, e aggiungerò di donna giovane, quantunque lo avrete già argomentato da certa disposizione di effetti, che del resto è proprio casuale, e perciò senza merito mio. Quella giovane donna veniva ultima nella sala da pranzo, perchè era l'ultima di fatti nell'ordine gerarchico della famiglia e in quella legge della precedenza, che non è solamente a Corte, ma si ficca un po' da per tutto: perfino, che vi dirò?.. perfino in un branco di pecore. Ma che importa esser gli ultimi, per certi rispetti, se per altri ed essenziali si può essere i primi? Quella figura di donna, apparsa ultima nella sala, fu facilmente, trionfalmente la prima, agli occhi del conte Gino Malatesti.
Come, direte voi, già a questi punti? Nossignori, non c'è già che tenga. È permesso di ammirare, anche senza cadere innamorati sul colpo. E poi, queste son sottigliezze che vanno lasciate in disparte. In ogni ordine di cose c'è quel che si vede, e quel che si guarda; che ci possiamo far noi? L'ultima di casa Guerri era di quelle che si guardano.
Vorrei descriverla; ma le descrizioni sono così poco efficaci! S'infilzano parole l'una a fianco dell'altra, si girano frasi, si rigirano periodi, si riesce a far della prosa robusta, desolazione ed abominio dei popoli. La descrizione, checchè faccia, non sarà mai la pittura. Nondimeno, anche nei passaporti c'è il desiderio di dipingere in qualche modo, e nessuno ignora che in una descrizione qual si sia, certi tocchi particolari hanno la virtù di richiamare alla mente del lettore una immagine piuttosto che un'altra. Quando, ad esempio, si dice capegli biondi, capegli rossi, vengono subito agli occhi due tipi distinti di carnagione, il bianco fino e pallido, o il bianco vivace e lentigginoso. Se vi dicono capegli castagni, la carnagione vi si offrirà subito agli occhi d'un bianco traente al bruno, non senza riflessi dorati; se vi dicono capegli neri, d'ebano, o d'ala di corvo, vedete prontamente una carnagione alabastrina e perlata. Così, per via di naturali richiami e associazioni d'idee, il povero narratore si aiuta.
Or dunque, non per voler descrivere, e molto meno per gareggiare con la pittura, vi pregherò d'immaginare una figura di donna piuttosto alta, snella, ma dal fianco prominente, su cui si disegna con castità medievale ed incomincia ad abbozzar le sue pieghe una veste di lana colorita a larghi quadri scozzesi. La vita risale tutta chiusa fino alla radice del collo, donde esce e biancheggia una piccola gorgiera di mussolina; le maniche, strette fino ai polsi, vi fanno sentire la greca modellatura delle braccia. Nel complesso, eccovi una figura di giovane castellana, a cui non manca che la borsellina di seta, pendente da una cintura molleggiante di cuoio, per darvi l'illusione perfetta.
Le mani son belle, e guai se non lo fossero, uscendo da quelle maniche così strette. Il volto è di contorno romano, ma con lineamenti raffinati, raddolciti dall'espressione moderna. Le sopracciglia son nere, diritte, segnate senza fiacchezza, ma altresì senza le esagerazioni del classicismo di seconda mano, e di sotto a quelle sopracciglia gli occhi grandi sfavillano nerissimi, circonfusi di una luce bianca azzurrognola. Nel naso profilato, nelle labbra di vermiglio pallido, sottili di forma e a mala pena incurvate sugli angoli, nel mento pieno e risentito, nella rotondezza eretta del collo, il moderno antropologo vedrebbe una grande fermezza di volontà, come nell'orecchio piccino e nella vivacità dello sguardo una rara delicatezza di sentimento. Ma che dire della carnagione, che è pregio essenziale nella bellezza femminile, tanto che senza di questo la medesima purità dei contorni si riduce ad un accozzamento di linee, felice sì, ma spietatamente geometrico? La dicono bianca come la neve, sì, per seguitare l'usanza; ma come la neve, quando il primo raggio di sole la tinge di rosa sulla vetta di un'Alpe. E questo, ancora, è l'effetto da lontano; per descrivere la cosa veduta da vicino bisognerebbe chiedere i paragoni alla superficie interiore di certe conchiglie orientali; donde per altro si avrebbe l'idea di una durezza vitrea, laddove sarebbe necessario rendere l'impressione del delicato, del pastoso e del morbido.
Lettori, badate a me, qui si va fuori di strada. I nostri vecchi non avevano tante sfumature di discorso, e quando vedevano una fanciulla sul far di questa, sgranavano tanto d'occhi, esclamando: «Dio… misericordioso, che bel tocco di ragazza! che occhio di sole!» Ciò è volgare in parte, e in parte sbrigativo, lo so, ma per contro è sincero. Ed una bella esclamazione, che dica lì schietto schietto il senso fatto su di noi dalla vista di una bella persona, val più di tutti gli artifizi del discorso, di tutte le ricercatezze della parola, di tutte le capestrerie della frase.
I capegli della fanciulla, lo avrete già indovinato per la solita associazione d'idee, erano neri nerissimi; ed anche lucenti, riccioluti, come quelli del suo fratello Aminta. Ma se ne vedevano pochi, di quei capegli maravigliosi, poichè il loro volume era imprigionato in un gran fazzoletto di seta, rigirato a casco dalla fronte alla nuca. Vi parrà una moda strana, ma il costume dei monti in cui siamo vuol proprio così. È un costume antico, se permettete, e s'accorda con ogni forma d'abbigliatura. Quando la testa è ben formata, e ricca la capigliatura imprigionata là dentro, vi par di vedere Minerva, con quel suo elmo ateniese, che tondeggia sul collo e fa punta sulla fronte, lasciando libere a mala pena due ciocche di capegli che scendano dalle tempie ad accarezzare le guance e a coprir mezzi gli orecchi.
Bellezza, tu sei veramente la cosa più maravigliosa, il bene più invidiabile che al mondo sia; nè l'ingegno ti vale, nè la ricchezza ti agguaglia. Tu sei la forma divina che l'uomo intravvede, poichè nell'interno d'ogni uomo c'è il principio d'un artista, che si svolgerà o non si svolgerà, poco importa, ma che riconoscerà, sentendola quasi istintivamente, una legge d'ordine e d'armonia, la quale è da per tutto, ma in nessun'altra cosa si estrinseca meglio e s'incarna, che in una figura di donna. L'ingegno, lo so, potrà celebrarti degnamente; ma che serve? Tu sei egualmente, e puoi stare senza inni di poeti, avendo le adorazioni d'una moltitudine che ti sente e s'inchina. La ricchezza, so anche questo, può coprirti di diamanti. Ma son proprio necessarii i diamanti? Non lo erano per esempio alla fanciulla dei Guerri.
Infatti, lettori, ecco qua un punto per cui la nostra eroina non somiglia a tante altre. Ci sono delle bellezze a cui stanno bene gli ori e le gemme; delle altre, invece, che con questi amminicoli non s'intenderebbero più. Gli antichi Greci diedero i pendenti di tre gocce agli orecchi di Giunone, non agli orecchi di Venere, e meno ancora agli orecchi di Minerva. Certe armonie delicatissime di forma non sopportano frastaglio d'ornamenti; certe sfumature di tinta, pari alle tenerezze giovanili dell'alba, sarebbero oppresse da tutto quel luccichìo di brillanti, che fa un po' troppo ricordare i pendagli cristallini dei lampadarii nelle feste da ballo. Ah, le bellezze di un collo semplicemente vestito del suo candore e della sua morbidezza! Signore mie dolci, seguite il consiglio di un ignorante; lasciate il collare ai cani, agli uomini politici e alle bocce d'assenzio di Neufchâtel. Quanto agli orecchini, pensate che un bell'orecchio piccino e trasparente, vale tutti i brillanti dell'India e del Capo, e che il non averlo neanche forato, come può fin d'oggi dimostrare l'abbandono di una usanza selvaggia, così potrà essere un giorno il contrassegno d'una classe più elevata.
– Fiordispina, la mia figliuola! – disse il signor Francesco, presentando l'ultima venuta al suo ospite.
Gino fece una gran riverenza. E quantunque fosse colto da un senso di maraviglia, non potè astenersi dal fare una delle sue solite osservazioni. Egli osservò, infatti, che i nomi lassù erano tutti presi dai classici. Il nome di Aminta veniva dal dramma pastorale del Tasso; Fiordispina. Angelica, Olimpia, escivano dai canti dell'Ariosto. Di nomi comuni egli non aveva sentito ancora che quello del signor Francesco, del padrone di casa. Ma questo si capiva facilmente, ricordando che nelle famiglie il primogenito suol prendere il nome del nonno; donde avviene che due soli nomi si alternino per parecchie generazioni, mentre per tutti gli altri nati di una casata ci sia libera scelta, e in questa scelta la moda e i gusti particolari trionfino. Lassù la moda non era giunta, o non aveva attecchito; i gusti particolari favorivano l'Ariosto ed il Tasso. Gino Malatesti s'aspettò di veder capitare da un momento all'altro Bradamante e Clorinda, Ginevra ed Erminia.
Ma nessuna altra donna apparve nella sala da pranzo, e non fu neanche il caso di veder comparire nessun Ruggero o Mandricardo. La famiglia era tutta radunata, tranne quei due uomini, fratelli del signor Francesco e da lui accennati poc'anzi, uno dei quali era alla serra, e sarebbe capitato più tardi, e l'altro era a Sassuolo, nè sarebbe venuto altrimenti.
Venne in quella vece il momento di prender posto a tavola. L'uso moderno avrebbe portato di mettere la signora Angelica al posto di mezzo, e il signor Gino alla destra di lei. Ma lassù regnava l'uso antico, e il posto d'onore fu dato all'ospite, che ebbe alla sua destra la signora Angelica, il signor Francesco alla sinistra. Fiordispina sedeva accanto a suo padre; Aminta dall'altro lato, presso la signora Olimpia; tutto il resto della tavola rimase vuoto, chè i commensali non si potevano inventare, per compimento della scena.
Il pranzo fu copioso, in piena armonia con l'abbondanza dei principii. Dominarono, come potete credere, i piatti di cacciagione, ma non mancarono quelli di pesce, in un luogo così ricco d'acque correnti. E a proposito di correre, i vini prelibati non furono lenti, come non erano scarsi. A mezzo il pranzo, entrò nella sala il secondogenito dei Guerri, e fu presentato col nome di Orlando. Evidentemente, quella era una casa ariostesca, e il nome del nuovo venuto confermava la teorica foggiata lì per lì da Gino Malatesti. Per il signor Orlando non c'era che il guaio di essere stato innamorato di Olimpia, e di averla sposata; ma come evitarlo, quel guaio?
Angelica era sua sorella, e se anche non lo fosse stata, avrebbe dovuto amar piuttosto Medoro. Egli, poi, non avrebbe voluto cambiare il suo nome in quel di Bireno, che fu il nome di un traditore. Il signor Orlando, adunque, si era adattato a quel piccolo guaio, della poca corrispondenza dei nomi, o non ci aveva neanche badato. Innamorandosi d'una Olimpia, poteva anzi rallegrarsi, di essersi imbattuto in un altro nome ariostesco, da tirare in famiglia.
Nomi ariosteschi, adunque, con qualche spruzzatina di Torquato Tasso; ma tutt'insieme una famiglia patriarcale, in mezzo a cui si riposava, espandendosi, lo spirito di Gino Malatesti. Il giovanotto, che aveva già pensato tante cose e fatto tanti raffronti, non potè neanche astenersi dal meditare su quel pranzo magno, alle falde del monte Cimone, in quella casa di povero aspetto contadinesco, dove si era immaginato di dover fare un pasto magro. Ora è chiaro che le lezioni dell'esperienza debbano servire a qualche cosa, se l'animo che le riceve non è foderato di sughero. Proprio allora il conte Gino fece giuramento a sè stesso di non giudicar più dalle apparenze e di aspettare in ogni cosa la fine.
Ma non aspettò che finisse il pranzo, per giudicarlo eccellente; che questo gli sarebbe parso magnifico, anche senza tanto contrasto di condizioni e chiaroscuro di circostanze, per cui dalla triste via dell'esilio tra i monti era capitato davanti alla scodella di minestra fuligginosa del mugnaio, e finalmente alla tavola ospitale dei Guerri. Per i quali tutti egli ebbe parole di somma cortesia. Educato com'era, esperto di tutte le delicatezze del conversare, Gino Malatesti innalzò quel giorno tutte le sue piccole qualità aristocratiche al grado superlativo. Voleva piacere a' suoi ospiti: unico modo di mostrar loro la sua gratitudine.
– E dopo ciò, – diss'egli alle frutta, – triste cosa sarà dover andare a
Querciola.
– Ma sì, triste cosa! – ripetè il signor Francesco. – E si potrebbe ancora, con sua licenza, o usando della libertà che gli anni concedono, chiamarla una pazzia. A Querciola, mio signore, non troverà nulla di ciò che è necessario per vivere, quando non si è taglialegna o caprai. Non ha una casa laggiù dove ci sia una camera a mala pena abitabile. Ci sarebbe quella dei Paoli; – soggiunse con atto di concessione il signor Francesco, rivolgendosi al fratello Orlando. – Ma i Paoli, che ebbero un figliuolo medico e professore di chimica all'Università di Modena, vivono poveramente anche loro.
– Verissimo; – disse Orlando. – Ho avuto occasione di entrarci l'altro giorno, per dire qualche cosa al vecchio Azzolino, Vuol crederlo? Non c'era neanche una sedia che si reggesse sulle gambe.
– Eppure, – disse Gino, sospirando, – dovrò andare a Querciola. L'ordine parla chiaro; – soggiunse, volgendo alla signora Angelica, sulla sua destra, un discorso che era incominciato con la sua brava direzione a Fiordispina, sull'estrema sinistra.
– L'ordine! – esclamò la signora Angelica. – C'è un ordine, per Vossignoria?
– Ne giudichi Lei; – disse il giovane, cogliendo la palla al balzo. – Gino Malatesti, figlio del conte Jacopo, di Modena, si recherà a confine in Querciola, ed ivi rimarrà fin tanto che al nostro Venerato padrone non piaccia disporre altrimenti. Così scriveva ier l'altro a mio padre il signor direttore di polizia. Come ella mi vede, signora Angelica, sono un condannato politico… e condannato senz'ombra di processo. —
Ciò detto, gli parve di respirare più libero. Era finalmente venuto a capo di palesare il suo nome.
La signora Angelica aveva fatto un gesto di commiserazione, ma non aveva proferito parola. Il signor Francesco, capo della famiglia, l'unico a cui sarebbe toccato di dire qualche cosa, era rimasto pensieroso, e, forse per non essere obbligato a parlare, aveva in quel punto afferrato il suo bicchiere di lambrusco, e lo tracannava d'un fiato.
– To'! – disse Gino tra sè. – Son caduto in mezzo a duchisti. Il re della montagna è un buon suddito di Casa d'Este, come mio padre. —
Per altro, se erano duchisti com'egli pensava, i Guerri non erano scortesi coi loro avversarii, quando questi rivestivano la qualità di ospiti, e le attenzioni di quella gente al forastiero nè crebbero per il suo titolo conosciuto di conte, nè diminuirono per il suo peccato egualmente conosciuto di cospiratore politico. La signora Angelica, riavutasi certamente dalla prima sensazione spiacevole, parlò del dolore che il signor Gino aveva dovuto provare, separandosi da suo padre e da tutta la sua cara famiglia. Gino riconobbe che infatti il dolore era stato a tutta prima fortissimo, ma che poi lo aveva temperato grandemente un pensiero di riverenza per suo padre. Il conte Jacopo era un fedelissimo suddito, e certamente, se poteva dolergli che il figliuolo, per qualche atto o parola che accennasse ad altre idee, avesse destato il sospetto dell'autorità, doveva anche piacergli, che quel figliuolo andasse confinato tra i monti, anzi che rimanere a Modena, sotto la vigilanza della polizia, e col pericolo di dare altri argomenti alla severità del governo ducale.
– Dunque, signora mia, – conchiuse Gino, – bisogna ripetere col proverbio antico, che tutto il male non vien per nuocere. Mio padre è più tranquillo, ed io debbo esser felice della tranquillità di mio padre. Infine, ho fatto il male, ed è giusto che faccia la penitenza; una penitenza che, come vedo dai principii, non è punto dolorosa! – soggiunse egli, ridendo. – Resta sempre la necessità di andare a Querciola, lo so; ma per un buon vicinato si può anche accettare una cattiva residenza. Ella mi ha detto, signor Aminta, che Querciola è distante a mala pena un'ora di cammino dalle Vaie, non è vero?
– Fortunatamente; – rispose Aminta. – E non credo che l'ordine del governo le vieterà di passeggiare nei dintorni.
– Tanto più che io qui non avrò occasione di cospirare; – ripigliò il conte Gino. – La politica è bandita dai monti.
– Eh, chi lo sa? – disse il signor Francesco, levando il suo bicchiere nuovamente pieno all'altezza dell'occhio, e guardando attraverso il cristallo la bella tinta del vino. – Se sui monti è aria libera, come sfuggirne il contatto? come evitar la politica? Politica d'analogia, lo capisco, ma sempre politica! —
Qui il conte Gino si avvide di non aver mantenuto il suo giuramento, e di essere ricascato subito nel fallo di giudicare dalle apparenze. Peggio ancora, si era mostrato scortese coi monti, dicendoli alieni dalla politica, e il signor Francesco, pensatamente o no, aveva rivendicata la loro nobiltà di sentire. Il monte è l'aria libera, è l'abito, è l'istinto medesimo della libertà. Può dire altrettanto di sè la pianura?
Ma il signor Francesco Guerri, avesse o non avesse rilevato il piccolo e sicuramente involontario errore del suo ospite, si era tenuto con la sua risposta assai alto, e proprio fra le nuvole, come qualche volta usava fare il Cimone. Si sa, la politica del monte non è intieramente quella del piano. Il conte Gino, del resto, anche senza badare a quelle sottigliezze di distinzione, non reputò necessario di tirare il re della montagna nei bassi strati delle applicazioni, delle necessità, degli ostacoli, della ragione storica e della topografica, in cui vanno spesso a battere e a naufragare i principii. Ricondusse abilmente il discorso alla vita e alle costumanze della città, avendo il piacere di tornar più gradito alle signore che lo ascoltavano.
C'è nell'uomo una inclinazione naturalissima a dir male degli assenti. Ciò forse avviene perchè da lontano si vedon meglio le cose, e nella natura umana c'è più da criticare che da ammirare. Gino cedette alla tentazione, e disse male degli usi e delle mode cittadine: garbatamente, si capisce, sfiorando l'argomento, passando dall'uno all'altro come una farfalla spensierata, per il gusto di provar l'ali e di farle risplendere al sole. Allora, lo ricordate, usava il crinolino, quell'orrida gabbia fatta a campana, ma non tanto orrida come la gobba d'oggidì, che fa parer le signore tanti dromedarii rizzati sulle gambe posteriori. La critica del crinolino fece ridere Angelica, Olimpia e Fiordispina. È forse vero che i nomi imprimano carattere? Quelle donne che davano nei nomi loro l'illusione di essere uscite dal mondo poetico dell'Orlando Furioso, non potevano sicuramente non ridere delle goffe usanze del mondo moderno. E risero, come avrebbe riso Elena, sulle rive del patrio Eurota, se il dottor Fausto, scambio di parlarle il linguaggio eterno dell'amore, si fosse fermato a descriverle certe fogge d'allora, verbigrazia quel cartoccio da confetti che portavano sul cocuzzolo le donne tedesche del Quattrocento.
E i cappellini, a proposito, i cappellini di quell'anno!.. Le piume di struzzo non si usavano più tanto; i fiori, partiti in due cascatelle e piantati tra l'ala del cappellino e la guancia, erano ancora in onore; ma i frutti accennavano già a voler prendere il posto dei fiori. Una moda fresca fresca era quella dei grappoli d'uva alle gote. Ne veniva la necessità di allargare a cerchio le falde laterali, sicchè la faccia delle donne paresse una luna in quintadecima. Si poteva dare di peggio? Ah, meglio, cento volte meglio, un fazzoletto di seta rigirato intorno alle tempia!
– Vivaddio, se è una moda, – conchiuse Gino, – questa almeno si capisce. Io intendo l'ornamento della persona, ma voglio che non sia tale da aggravare, da trasformare la figura umana.
– Non è una moda, per altro; è una necessità del nostro clima; – osservò Fiordispina. – Qui si è fuori di casa ad ogni momento, e l'aria di questi monti è sottile.
– Ebbene, signorina, – riprese Gino, felicissimo di aver da disputare un pochettino con lei, – veda come la necessità è stata più graziosa della libera scelta. Ne è venuta fuori una foggia d'acconciatura, che ha un solo difetto, quello di nasconder troppo i capegli, ma che seconda benissimo i contorni della testa, non ne guasta le proporzioni, non ne turba i rapporti con tutto il rimanente della persona. Quel cappellino a cuffia, dalle ali larghe e tondeggianti, che si usa laggiù, con tanta esposizione di erbaggi al posto degli orecchi, e con quel gran fiocco di nastri sotto il mento, è una vera iniquità. Le madonne bisantine non sono niente più goffe, esteticamente parlando, dalle nostre signore, vestite all'ultima moda di Parigi. —
Marchesa Polissena, e voi passavate per la Dea delle ultime mode, nella città della Bonissima! La vostra immagine, aggravata dall'aureola bisantina del cappellino a cuffia, coi grappoli d'uva alle guance, col gran nastro diffuso in due larghe staffe sotto il mento e in due non meno larghi capi pendenti sul petto, con la vasta mantiglia di velluto, ornata di trine e di frange, scendente con ampio giro sulla cerchia mostruosa di una veste che s'accostava al diametro della campana maggiore della Ghirlandina, la vostra immagine, dico, non si offerse in quel punto agli occhi di Gino Malatesti?
Pare di no. Il conte Gino, vivendo a Modena, nelle consuetudini eleganti de' suoi pari, non aveva avuto mai occasione di meditare sulle esagerazioni della moda. Solamente lassù, tra quei monti, dove la bella natura regna sovrana e vuole ogni cosa accomodata, proporzionata a sè, Gino Malatesti si accomodava, si proporzionava all'ambiente anche lui; era perciò naturale che certe esorbitanze, non vedute, o non osservate da prima, gli saltassero agli occhi, gli strappassero dalle labbra una parola di critica. Le critiche, poi, sono come le ciliegie; quistion di stagione per queste, e di momento opportuno per le altre.
Era dunque dimenticata, per allora, la marchesa Polissena. Lo spirito dell'uomo ha le sue interferenze come la luce del sole. E in quei discorsi allegri parve anche dimenticata la storia del condannato politico. I discorsi, finalmente, furono interrotti dall'arrivo del prete, accolto a festa, mentre la bella Fiordispina preparava il caffè.
– Don Pietro! – gridò il re della montagna. – A quest'ora si viene?
– Che dirle, signor Francesco? Sono stato chiamato in fretta, per il mio ministero di pace.
– Ah! – disse il re della montagna, con accento di rammarico. – È stato un caso grave?
– Speriamo ancora; – rispose il prete. – Ma siamo oltre i novanta.
– Si tratta del vecchio Lorini, dunque?
– Sì, e com'Ella vede, signor Francesco mio, i giorni possono dirsi contati. Morbus et ipsa senectus. Ma non parliamo di cose tristi. Ho fatta la mia corsa fin sotto a Monticelli, ed ecco la cagione del ritardo.
– È venuto almeno in tempo per fare un brindisi; – disse il signor Francesco. – Le presentiamo, caro Don Pietro, il signor conte Gino Malatesti, di Modena. Egli ha voluto dirci il suo nome, ed abbiamo saputo nel medesimo tempo che egli, per causa d'opinioni politiche, è stato mandato a confine in Querciola.
– Brutto paese! – esclamò Don Pietro. – Perchè non alle Vaie?
– Ma sì! – ribattè il signor Francesco. – Glielo domandi un po' Lei.
Perchè non alle Vaie?
– Signori miei, – rispose Gino, sospirando, – se il nostro venerato governo avesse saputo che Querciola era ad un'ora di cammino dalle Vaie, mi avrebbe mandato anche più in là. Il confine che lor signori avrebbero voluto per me, non sarebbe stato un castigo, ma un premio.
– Non gli faremo dunque saper noi quello che ignora; – rispose il signor Francesco, ridendo. – E deve ignorarlo, sicuramente, se pensiamo al conto che fa di noi montanari. Ma c'è anche il suo lato buono, in questa sua ignoranza. Qui il governo si sente meno, ed anche ce n'è meno bisogno. Qualche strada di più sarebbe desiderata, non lo nego; qualche argine, qualche ponte, non tornerebbero inutili. Ma infine, quel che occorre a noi, bene o male, lo facciamo coi nostri denari, e, non chiedendo nulla, ci avvezziamo a non aver bisogno di nessuno. Ma ritorniamo al nostro ospite. Don Pietro, Lei è oratore; faccia un brindisi Lei, uno di quei brindisi che sono discorsi, e di cui Ella ha il segreto.
– Perchè no? perchè no? – disse il prete, che non era insensibile alla lode.
– Bravo! – gridarono le signore. – Ci faccia il discorso. Don Pietro! —
Fiordispina, presso alla quale si era seduto il vecchio ministro dell'altare, gli versò il vino nel bicchiere. Don Pietro alzò il calice, osservò attraverso il cristallo la bella tinta di topazio del suo vino, lo fiutò da conoscitore provetto; poi, levatosi in piedi, parlò in questa forma:
– Vin santo! O ben nomato, poichè mi reca una buona ispirazione! Veramente, miei signori, il brindisi, usanza pagana, disdirebbe a un sacerdote. Ma come è santo questo vino, non sono santi forse tutti i doni della terra? E non è memoria nelle Sacre Carte che delle loro primizie si facesse offerta nei luoghi eccelsi all'Altissimo? Anch'io offrirò a Dio il liquore ch'egli ha infuso nel tralcio delle nostre colline, e pregherò (si può infatti pregare da per tutto) e pregherò al vostro ospite tutte le benedizioni del cielo. Sia salva la sua casa; sia prospera la sua famiglia; siano adempiuti tutti i suoi voti.
– Tutti? – mormorò Gino, mentre s'inchinava all'augurio.
– Tutti, certamente! – rispose Don Pietro. – Non sono essi onesti e nobili? E può il conte Malatesti averne di altra ragione? Possiamo noi immaginare che ne abbia altri, conoscendo la cagione per cui egli è venuto pellegrino quassù? Mi confido adunque nella rettitudine dell'animo suo, ed offro i suoi voti, e domando e prego che siano esauditi da Dio, nel suo gran giorno di giustizia e di pace. Non ha egli fatto alleanza col suo popolo? Così possa esser vicino quel giorno! Così possiamo anche noi vedere il nuovo Israele posar libero e felice nelle sue sedi, da Dan fino in Betsèba!
– Ah! – esclamò Gino, che aveva capito… l'ebraico.
– Sì, – riprese Don Pietro, commentando la sua frase nella forma della ripetizione, – dico il nuovo Israele. Non c'è qui una immagine di popolo eletto? E non ce ne affida questo doppio raggio di gloria e di sventura che illumina la fronte della patria? E l'aver tanto sofferto non è segno di aver bene meritato da Dio? Esaudite, Signore, i voti dell'ospite! Rivolgete i vostri occhi all'Italia! —
In quel momento, col suo calice levato, Don Pietro Toschi, parroco delle Vaie, sembrava Melchisedec, il re sacerdote, quando offriva l'olocausto all'Altissimo sovra il poggio di Salem.
Gli astanti erano commossi; Gino Malatesti aveva le ciglia umide. Si levò tuttavia e rispose:
– L'augurio muove da un pensiero che non mi giunge nuovo in questa nobile casa, quantunque io ci sia ospite da poche ore soltanto. Ricorderò che il signor Francesco Guerri ha cortesemente raddrizzata una mia storta opinione, dicendomi: «Se sui monti è aria libera, come sfuggirne il contatto? come evitar la politica?» Mando un saluto a quest'aria libera, dove non sono o non si conoscono tiranni, ed auguro al mio paese di liberarsi dai suoi.
– E di non meritarne degli altri! – soggiunse Don Pietro. – Sia questa la seconda parte del voto!
– Certamente! – rispose Gino. – Le ricadute son gravi, e noi ne abbiamo fatta una triste esperienza. Speriamo che questa abbia insegnato qualche cosa agli afflitti di quindici secoli. Ed ora, o signori, permettete che io beva alla salute vostra, alla prosperità di questa casa ospitale, che ho trovata sul mio cammino, come un'oasi benedetta in mezzo al deserto. Signor Guerri, – conchiuse Gino, volgendo il discorso al suo ospite, ma tosto mandando gli occhi in giro, fino ai suoi figli, – poichè siamo nell'oasi, Dio prosperi le vostre giovani palme. —
Una stretta di mano, ma vigorosa, fu il discorso del re della montagna, in risposta alle parole affettuose di Gino Malatesti.
– Ella è un amico di casa, se ne ricordi.
– Ahimè! – disse Gino… – Che è ciò? Son sceso di grado?
– Perchè? – domandò il re della montagna, non intendendo lì per lì l'allusione del suo ospite.
– Perchè, signor Francesco mio, dianzi era stato adottato per figlio.
– Ah, sì; – rispose il vecchio, sorridendo; – quando ignoravamo ancora l'esser suo e non vedevamo in lei che la sua qualità d'ospite. Ma Lei ha voluto farsi conoscere, ed ora sappiamo il suo nome e il suo titolo.
– E per questo che Ella sa, – ribattè Gino Malatesti, – mi leva quello che mi aveva accordato? Io me ne lagno, e chiedo alla regale ospitalità delle Vaie di non mutar nulla dai suoi cominciamenti per me.
– Sia pur come vuole! – rispose il signor Francesco. – Non è sua, la casa? Prenda il posto che le piace, al focolare domestico dei Guerri. —
La sala era vasta, e mentre i commensali, alzatisi da tavola, stavano chiacchierando in un angolo, quattro fantesche, giovani e forti montanine, sparecchiarono in un batter d'occhio. Gino si avvide del cambiamento di scena, quando ogni cosa era fatta. Lasciato il signor Francesco a discorrere col vecchio parroco, si accostò allora a Fiordispina, e le chiese in grazia di far sentire qualche cosa sul pianoforte, se, come aveva immaginato, era lei la musicista di casa.
La bella figlia dei monti arrossì un pochettino, ma non istette a farsi pregare, come fanno le dilettanti della pianura; non si scusò neanche con la solita ragione del non ricordare che musica vecchia, ben sapendo che la vecchia è molto spesso la buona, e andò di buon grado a sedersi davanti al suo Erard, di cui il conte Gino sollevò prontamente il coperchio. Si fece silenzio nella comitiva, quando la fanciulla dei Guerri alzò la ribalta e posò le dita sulla tastiera, traendone i primi accordi, un po' timidi, ma precisi.
Il pianoforte è molesto nelle città, come tutte le cose delle quali si abusa. C'è un modo di far soffrire il mio amico Arnaldo Vassallo: basta suonargli la Stella confidente. Il pianoforte, strimpellato in ogni luogo e a tutte le ore del giorno, è una vera afflizione dell'umanità, e non si capisce come Mosè, che era profeta e poteva prevederlo, non lo abbia fatto figurare tra le piaghe d'Egitto. Ma questo istrumento, che è di tortura in città, può riescir di piacere in montibus altis, dove manca ogni musica, anche quella dei grilli, e dove infine, a mente fresca e serena, osservando le cose di questo mondo da una sommità ragguardevole, sareste capace di riconciliarvi col peggiore dei vostri nemici.
E le campane, del resto? Non succede lo stesso con le campane? Questo sacro ma uggioso bronzo, che co' suoi rintocchi medievali urta i nervi alle nostre generazioni ammalate d'emicrania, è piacevole in villa, dove il suono si diffonde all'aperto, risvegliando pensieri di festa; è giocondo, poi, è divino sulla vetta di un'Alpe, dove il suono vi giunge affievolito, ma sempre argentino all'orecchio, senza che pur vediate la chiesa e il campanile, perduti nella nebbia luminosa della valle sottoposta.
Ritornando al pianoforte, non sarà mai considerato nemico un istrumento come quello, se ne traggono suoni le dita di una bella ragazza. Il pensiero melodico sarà di Chopin, o di Mendelssohn; ma esso è passato nella mente di lei, dove vorreste regnar voi; ha vibrato per tutti i suoi nervi, prima di tradursi in quella pioggia di note.
Gino Malatesti, seduto accanto al piano, guardava. Guardava lei, si capisce, e ad un certo punto la fanciulla se ne avvide, si confuse, perdette il filo, e fece, come si dice volgarmente, un pasticcio.
– Ebbene, signorina? – diss'egli, vedendo che la suonatrice rimaneva in tronco.
– Ah, non so più! – mormorò Fiordispina. – Non sono avvezza…
– No, continui, la prego! —
E c'era tanto arder di preghiera in quelle poche parole, che Fiordispina ripigliò la suonata, andando fino alle ultime note senza fermarsi.
Poi venne Don Pietro, che volle un motivo del Verdi, il coro famoso dei Lombardi, e poi l'altro, non meno famoso, del Nabucco. Voi già capite dove s'andasse a finire: con gli inni del Quarantotto. Don Pietro Toschi era un quarantottista travestito.
Ora paiono cose dell'altro mondo; ma allora, nel periodo acuto dei dolori italiani, era così, come io vi racconto. Tutti li avevano in mente, gli inni del riscatto, e li canticchiavano tutti tra i denti. Anche quando si diceva male del Quarantotto, de' suoi canti, delle sue piume, delle sue coccarde e dei suoi discorsi in piazza, era facile sentire nell'amaro della critica il dolce dell'amore profondo, indimenticabile, eterno. Infine, si erano commessi errori su errori, ma si era vissuti, si era allargato il cuore alle divine speranze, e tutti i ceti, tutti gli uffici sociali, si erano fusi in quel sacro entusiasmo. Anche Don Pietro Toschi, si era riscaldato il cervello; aveva veduto molti giovani passare da Fiumalbo, per correre alla Guerra Santa, e aveva gridato: «bravi! che Iddio vi benedica!» Poi erano venute le disgrazie; ma la reazione, che aveva dilagato al piano, non si era potuta spingere fino a quei monti, dove i cuori erano uniti e le labbra chiuse. Qualche commissario, capitato lassù, era stato affogato nel lambrusco dell'ospitalità. – «Brava gente! – aveva dovuto riferire ai superiori. – Pensano ai fatti loro, amano il vin buono, e lo fanno bere agli amici.»
Così la tirannide si spegneva, o rimetteva della sua ferocia in quegli alpestri confini. Il monte Cimone non conosceva impiegati ducali, e i suoi echi potevano liberamente ripetere le note degli inni patriottici. Il conte Gino gustò molto quella musica. Conosceva quegli inni, uditi da giovinetto; sentì che erano ricordati in onor suo, e non si dolse davvero di una disgrazia che gli meritava quella dimostrazione di stima affettuosa. Gran serata, che egli non si aspettava certamente nel mattino, muovendo da Pievepelago! Il nostro giovanotto aveva il cuore pieno, riboccante di affetto, di poesia e di gloria.
Quella notte, nel letto ospitale dei Guerri, il conte Gino Malatesti sognò grandi cose. Il duca di Modena era fuggito; la sua città natale era libera, e giurava una lega con tutte le altre città italiane. Egli poi, montato a cavallo, inseguiva il tiranno, fuggente come Serse a Salamina, o come il Barbarossa a Legnano. Il conte Gino non era solo; molti venivano con lui, tra gli altri suo fratello Aminta. E al fianco gli galoppava Minerva galeata; ma l'elmo della Dea somigliava molto ad uno di seta, che il conte Gino aveva ammirato il giorno prima alle Vaie.