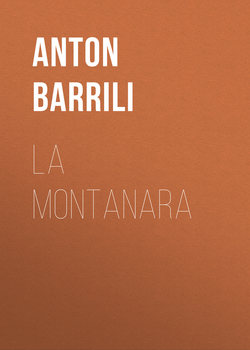Читать книгу La montanara - Barrili Anton Giulio - Страница 4
Capitolo IV.
La vita alle Vaie
ОглавлениеVenne il mattino, tiepido e fragrante mattino, uno di quelli che fanno così grato il muoversi, quando non si sta bene in un luogo, o si spera di trovar meglio, ma che per contro fanno così dolce il restare dove il soggiorno è piacevole. E il conte Gino Malatesti doveva andare a Querciola. Era l'obbligo suo, e lo aveva accennato ai signori Guerri, prima di ritirarsi nella camera ospitale.
Perciò, all'alba del giorno seguente, erano già pronti due cavalli nel cortile: i due cavalli che Gino conosceva, il suo del giorno avanti e quello del signor Aminta, o, se piace meglio a voi, come piaceva al conte Malatesti, di suo fratello Aminta.
Il signor Francesco, alzato anch'egli per tempo, diede il buon viaggio al suo ospite. Ed anche il felice ritorno, come potrete immaginare, poichè queste cose si dicono sempre. Le signore non si erano presentate nel salotto, ma il conte Gino, come fu in sella, ebbe il piacere di vederle apparire sopra un terrazzo scoperto, a fianco della casa, e di mandar loro un rispettoso saluto. Tra esse, naturalmente, e quasi sarebbe inutile il dirlo, era anche Minerva galeata.
I nostri due cavalieri, fatta una breve salita, andarono costeggiando la montagna per un sentiero sassoso, all'ombra dei soliti cerri; guadarono due o tre torrentelli, e dopo mezz'ora di cammino scopersero le prime case di Querciola.
Veramente, il nostro Gino Malatesti non aveva scoperto nulla. Querciola aveva i tetti di legno o di falde di pietra; e falde e tavole, essendo tutte coperte di musco, si confondevano facilmente col verde grigio della costiera. La scoperse Aminta e la indicò al suo compagno di viaggio, che la distinse a sua volta ed intese non trattarsi d'altro che d'una doppia fila di casipole, mezzo nascoste in una piega del monte.
– Quella, – disse Aminta, – è Querciola sottana, e ci arriveremo in un quarto d'ora.
– Come'? – esclamò Gino. – C'è ancora una Querciola soprana?
– Sì, un quarto d'ora di cammino più su, dietro quella macchia di roveri.
– In verità, – disse Gino, ridendo, – non avrei creduto necessario che ci fossero due Querciole. Una bastava, se non era d'avanzo.
– E dobbiamo andare a quell'altra, – rispose Aminta, – se Ella vuol trovare un alloggio meno orribile degli altri, nella casa dei Paoli.
– Che! Non occorre; – disse Gino. – Orribile più, orribile meno, sceglierò il più vicino.
– Ma badi! – osservò Aminta. – L'orribile più sarà orribile troppo.
– Ebbene, – replicò Gino, – che importa? Sia pure il peggio dei peggi. Non debbo io anche interpetrare degnamente le intenzioni del governo ducale? Mi vuol confinato a Querciola, in punizione de' miei peccati; sarà edificato di sapermi ad alloggio nella Querciola peggiore. Anzi, se non le dispiace, Aminta, la chiameremo sempre così: Querciola peggiore, per non far onta ad un grazioso indumento di cui la Querciola sottana è ben lungi dal ricordare la bianchezza. —
Si rise, a quella trovata, e l'allegria fece parere meno lunga la salita. Quindici minuti dopo, come aveva detto il signor Aminta, i cavalli giungevano trottando davanti alle prime case di Querciola peggiore.
Il giovane Guerri conosceva tutti i capi di famiglia delle due Querciole e non gli era difficile di trovare un alloggio per il conte Malatesti, poichè tutti erano cattivi ad un modo, e non sarebbe stato neanche il caso di scegliere. Si fermò pertanto alla prima del villaggio, con grande soddisfazione del suo compagno, il quale promise a se stesso che per sua propria elezione non avrebbe mai fatta la traversata del paese. E questo si capisce benissimo, non essendo bisogno di traversare Querciola, per uno che volesse andare alle Vaie.
La casa Mandelli, poichè questo era il suo nome, poteva chiamarsi egualmente una catapecchia. Buono, per chi doveva abitarci, che la scala era di fuori, tutta a lume di sole, poichè altrimenti non si sarebbero veduti gli scalini, così rotti e sconnessi com'erano, e uno meno pratico avrebbe potuto fiaccarcisi il collo. Gli usci sgangherati, l'impiantito logoro, le mura con certe crepe lunghe fino al tetto, raffidavano poco, facevano pensare che la vita dell'uomo è sospesa pur troppo ad un filo. Pure, vedete, tanta è l'abitudine di star lì, quelle case si tengon ritte. È vero altresì che quando cascano, son mucchi di rottami, tra cui cerchereste inutilmente, tra legno o pietra, due palmi di buono.
Casa Mandelli poteva appigionare una camera. C'era un letto, in quella camera, e largo abbastanza; ma Gino Malatesti fremette involontariamente, guardandolo. Ci sono dei letti terribili, anche senza pensare al romanzo inglese che da uno di questi s'intitola; letti assassini, dove si appiatta una banda sitibonda e famelica, banda invisibile nel giorno, ma operante, e come! nel cuor della notte. Son là, i nemici striscianti e i nemici saltanti; non sono lontani quegli altri che caleranno dal cielo con la tromba, ma non a guisa d'angeli che debbano risvegliarvi per l'ora solenne del giudizio, bensì di tormentatori esimii, che v'impediscano di prender sonno, e vi lascino, vittima consapevole e invano repugnante, in balia dei loro amici e commensali, dopo avervi succhiato essi medesimi qualche oncia di sangue.
Il signor Aminta aveva tirato in disparte il padrone di casa e gli stava facendo sottovoce un lungo discorso. Il conte Gino capì che egli raccomandava al contadino qualche utile novità, per rendere abitabile quel bugigattolo, e discretamente si tenne lontano; anzi andò verso la finestra, da cui si aveva una veduta ristretta di cielo, ma per contro abbastanza bella, per il verde intenso della montagna.
Poco stante, il suo compagno gli venne accanto, poichè aveva finito di ragionare con quell'altro.
– Che cosa le avevo detto io? – incominciò. – Non si sta bene, a Querciola. Ma oramai, sia bene o male, l'alloggio lo abbiamo, ed ogni commissario che il governo ducale può mandare quassù ad accertarsi della osservanza dei suoi precetti, troverà il condannato nel suo carcere. Ma per ora, siccome Ella non è condannato a morire di fame, venga a far colazione.
– Andiamo; – rispose Gino. – C'è un oste a Querciola?
– No, – disse Aminta, – ma Ella ha qui il suo cavallo. —
Il conte Gino sorrise, e solamente le buone creanze lo trattennero dal fare una matta risata. La risposta del signor Aminta gli richiamava alla mente gli esercizi del tedesco, insegnati col metodo dell'Ollendorf. – «Avete voi veduto il mio caro zio? – No, ma io ho trovato il vostro buon temperino.»
– Che c'entra il cavallo? – domandò egli allora.
– C'entra, – rispose Aminta, – per escire da Querciola e ritornare alle Vaie. In un'ora siamo venuti quassù; in tre quarti d'ora saremo di ritorno a casa.
– Ma, veramente… – balbettò Gino. – Non sarà un abusare della loro cortesia?
– Che! – disse Aminta, – In primo luogo ci aspettano. In secondo luogo, la farebbe magra, a star qui fin d'oggi, ed è già molto che venga a dormirci stasera. In terzo luogo, spero bene che accetterà di venire tutti i giorni a desinare da noi. È il desiderio di mio padre, che aspettava per l'appunto a dirglielo quest'oggi.
– Tutti i giorni, poi! – esclamò Gino, confuso.
– Ebbene? Che difficoltà ci trova? Il cavallo sarà sempre a sua disposizione qui sotto. Mi sono inteso col bravo Mandelli, perchè faccia subito un po' di pulizia nella stalla, e credo, – soggiunse Aminta, ridendo, – che la cosa gli riesca molto più facile dell'altra, di mettere in assetto questa camera. Ella dunque non avrà che due corse da fare ogni giorno: una per aguzzar l'appetito, e l'altra per avviare la digestione. Badi a me, signor conte: in questi luoghi bisogna andare, andar sempre; è l'unico rimedio per non morire di noia, e per non diventar scimuniti.
– Capisco; – disse Gino. – Se non incontravo ieri la provvidenza dei Guerri, povero a me! finivo male, con questa bella alternativa. —
E rimontò a cavallo e si avviò per la discesa, col suo gentilissimo ospite, a cui propose subito di lasciare da banda le cerimonie, passando dal noiosissimo lei al grato e italianissimo tu. Del resto, non era egli stato accolto come figlio, nella casa dei Guerri? E non doveva trattare Aminta come un fratello?
Vi ho detto dianzi, quando eravamo nella casa Mandelli, che la veduta era molto ristretta. Ma la prospettiva oramai si allargava, per il conte Gino Malatesti. Di lassù, anche tra i cerri e gli abeti, vedeva già tante cose in lontananza! La bella Minerva galeata, per esempio; e mi pare che basti.
Così sempre avviene, del resto, e non c'è da maravigliare per questo fenomeno di ottica, che è la cosa più naturale del mondo. Non sono soltanto i colori, che hanno la loro sede nel nostro occhio, come vogliono i fisici. Noi facciamo spesso la nostra prospettiva aerea nel profondo del cuore, e non abbiamo mestieri dell'azzurro dei cieli, quando il sereno è nell'anima nostra.
Gino fu accolto con gran festa alle Vaie. Come aveva trovato il soggiorno di Querciola? Brutto, naturalmente; ma tanto meglio per i Guerri, che avrebbero avuto la fortuna di vedere il loro ospite più spesso. Si capisce che tornò in campo la proposta già fatta da Aminta, e che il conte Malatesti credette obbligo di piccola cortesia schermirsi un pochino, ma obbligo di vera riconoscenza accettarla. Per intanto, volendo adattarsi agli usi della famiglia, ricusava di far colazione. I Guerri pranzavano a mezzodì, e cenavano alle sette Erano allora le dieci, ma Gino non aveva fame, poteva aspettare, sarebbe stato felicissimo di aspettare il mezzodì. Per la cena, s'intende, avrebbe dovuto contentarsi di farla a Querciola.
Tutte queste cose furono presto discusse e concertate. Poi il signor Francesco e suo figlio Aminta si ritirarono, avendo qualche negozio da sbrigare, e il conte Malatesti se ne andò in giardino, anche per lasciar libere le signore di attendere alle faccende domestiche da quelle buone massaie che erano certamente, e desiderose di dar occhio a tutto nel governo della casa.
Poca cosa, il giardino, non essendo la stagione ancora molto inoltrata. Quella primavera, il Cimone aveva raccorciato, ma non buttato via, il suo mantello di neve, e le notti delle Vaie erano ancora freddine, ma accanto al giardino scarno si vedeva la stufa, e questa era piena di vasi d'ogni grandezza, disposti in ordine, a scaglioni, tra cui si poteva passare comodamente, ammirando una bella varietà di piante, anche delle specie più rare. Gino Malatesti ammirò una graziosa raccolta di eriche, coi fiorellini fitti fitti, foggiati a campanule bianche e vermiglie.
Mentre stava osservando quelle eriche, non sapendone il nome e la provenienza, ma indovinandone il pregio, gli baluginò davanti agli occhi la fanciulla dei Guerri, escita allora dal porticato della casa alla luce aperta del giardino. Lasciò subito di guardare le piante e si avanzò verso l'invetriata della stufa, per veder meglio la gloriosa apparizione, che incedeva snella e leggiera tra le aiuole deserte di fiori. Era essa il fiore del giardino, il giglio delle convalli, e la sua bellezza verginale si accordava maravigliosamente con quella dell'agreste natura.
– Bella ragazza, in fede mia! – disse Gino tra sè. – Chi sarà il felice mortale che la sposerà? Mi pare che abbia l'età da marito, oramai. Ma qui ci saranno partiti per lei? Questi re della montagna son ricchi, sicuramente; ma le loro pretese, dato il luogo, non possono mica essere troppo alte, o lo saranno solamente… sul livello del mare. —
Quella scappata del suo pensiero lo fece sorridere; ma non s'indugiò, il pensatore, e riprese subito il filo del suo ragionamento.
– Bella ragazza, in fede mia! – ripetè egli, come per pigliar la rincorsa. – L'uomo che la sposerà può dirsi fortunato fin d'ora. Ma forse, come troppo spesso avviene, sarà un uomo che non intenderà la propria fortuna. Questa fanciulla è un fiore alpino, ma cresciuto in una stufa, come queste eriche maravigliose. Suona con grazia e sentimento; conosce parecchie lingue; ha avuto certamente una educazione inferiore a questo livello barometrico, ma superiore a questo livello sociale. Dove sarà stata in conservatorio? A Modena, o a Reggio; fors'anche da quest'altra parte, in una città di Toscana. Mi pare d'indovinarlo da una certa rotondità di pronunzia, da una certa scioltezza di frase. Questi fiori umani, educati con gran cura per la vita elegante di una città, vengono ad avvizzir qua, tra boscaiuoli e caprai. Povere fanciulle! Vivono in un ambiente che non dovrebbe più essere il loro; risplendono inutilmente, nella delicatezza delle loro forme, ad occhi che vedono grosso come quelli de' buoi; spandono soavità di profumi per nari disavvezzate nel grave odore della terra smossa. E qui, care angiole, fanno delle torte, come la Carlotta del Werther, quando non lavano i pannilini al torrente, come la Nausicaa dell'Odissèa. Sì, ma poi fanno anche dei figliuoli robusti e belli come il signor Aminta, destri cavalieri e gran cacciatori, induriti al sole dei campi e all'aria sottile delle Alpi. Buona razza montanara, veramente italiana, all'antica! E infine, la vita non è meglio così, con una mente sana in corpo sano? Ma allora, tra questi usi patriarcali, a che serve la coltura dello spirito? Che sciocco son io! Serve per chi l'ha, gli tien buona e fidata compagnia, lo aiuta a vivere, facendogli intendere la rara bellezza di tutto ciò che lo attornia. Io stesso, che ho studiati i classici, non sento più profondamente il bello di questa natura agreste, e meglio che non faccia il popolo che ci è nato? Bella fanciulla dei Guerri, salute a voi! Possiate trovare la pace dell'anima su questi monti, goderne l'aspetto e l'aria balsamica, senza desiderare di più! Possiate trovare a marito un uomo non troppo zotico e materiale, che si mostri degno di possedere la bellezza della vostra persona, intendendo meglio la delicatezza del vostro pensiero! —
Era un monologo in tutte le regole, il suo. Ma noi li stendiamo sulla carta, i monologhi, e dobbiamo tirarli a fil di logica, mentre nel fatto essi procedono più rotti nell'argomentazione e più snelli. Molte cose, necessarie nella scrittura, lo spirito le vede e le tralascia, non dicendo a se stesso se non quel tanto che gli piace di più.
Il conte Gino, per altro, non fu molto contento del suo soliloquio. E perchè, Dio buono, se lo aveva fatto egli? L'uomo è di sua natura egoista. Si può senza troppo sforzo di educazione arrivare al punto di non desiderare la casa e la fortuna del prossimo; ma nessuna educazione può condurci a vedere di buon occhio che altri s'impadronisca e goda il pacifico possesso d'un fior di bellezza che abbiamo osservato ed ammirato noi. Noi, capite? Noi persona prima del singolare, quantunque i grammatici, buona gente, l'abbiano assegnata al plurale. L'ammirazione nostra è una specie d'ipoteca che prendiamo sulla cosa che ci ha colpiti e che farebbe tanto bene ad appartenerci. Ora, per un sentimento di questa natura, il conte Gino era triste? Lo sospetto fortemente, ricordando che nella chiusa del suo monologo egli fece una spallata, come se volesse con quella scacciar l'uomo «non troppo zotico e materiale», a cui in una spensierata liberalità di discorso aveva concessa la fanciulla dei Guerri.
Dopo quella spallata, il giovinotto escì dalla stufa. Fiordispina, traversando le aiuole, veniva dalla sua parte; era già abbastanza vicina, e poteva entrare nella stufa, ed anche rasentarla soltanto; ma nell'uno e nell'altro caso avrebbe veduto l'ospite, ed egli avrebbe avuto l'aria di essere stato ad osservarla, a spiare i suoi passi. Escì, dunque, ed ella lo vide e gli sorrise.
– La signorina, – disse Gino, muovendo verso di lei, che si era fermata, – veniva a vedere i suoi fiori?
– No, veramente; – rispose ella; – andavo più in là. Non cerco fiori, porto foglie; – soggiunse, mostrando il suo grembiale, che teneva raccolto per i due capi.
– Ah! – esclamò Gino. – Un pasto mattutino! E dov'è la famigliuola che lo avrà dalle sue mani?
– Qui presso. Vuol vederla?
– Volentieri, se permette.
– Bene, venga allora con me. —
Gino s'inchinò e la seguì. Fiordispina andava leggiera lungo le invetriate della stufa. Sicuramente, se egli fosse rimasto là dentro, ella lo avrebbe veduto allora, poichè rivolse, passando, un'occhiata curiosa alle piramidi dei fiori.
– Ah, signorina! – disse Gino. – Che stupende eriche ho vedute or ora!
– Son belle davvero; – rispose Fiordispina. – Eriche del Capo di Buona Speranza.
– Niente di meno! – esclamò il giovinotto.
– E delle prime che siano venute in Europa; – replicò Fiordispina.
– Ed io, abitante del piano, – disse Gino, – dovevo venire a trovarle fra i monti!
– Mah! Segno che c'è qualche cosa, anche tra i monti! – ribattè la fanciulla.
– Lo so, signorina, lo so, e non potrei dimenticarlo mai più. Ma parlavo delle eriche del Capo.
– Infatti, – ripigliò Fiordispina, – c'è una ragione naturalissima, che spiega la novità della cosa. Un amico della famiglia, che ha viaggiato molto, le ha portate in dono a mio padre.
– Buona Speranza! – mormorò Gino. – Buona Speranza! —
E cercava il filo di un madrigale; ma non gli venne, ed egli ci rinunziò, anche per il fatto che si era giunti davanti ad un porticato rustico, e che la fanciulla metteva il piede là dentro.
Erano le stalle. Perdonate il vocabolo, o lettrici garbatissime, e sopratutto non arricciate il naso, dovendo seguire fin là i nostri due personaggi, perchè altri vi avranno condotte, letterariamente parlando, in luoghi peggiori di questi. La stalla, in fin de' conti, è sana, e non c'è caso che sia male abitata: o se lo è qualche rara volta, si manda per il veterinario, la cui diagnosi e la cui terapeutica sono assai meno complicate di quelle del fisiologo, dell'antropologo e del moralista.
La fanciulla dei Guerri aperse l'uscio di una stanza bene illuminata da due finestre alte, e dove, oltre la paglia sparsa sul pavimento, si vedevano lungo la parete alcune casette di legno.
– Richiuda, la prego; – diss'ella a Gino, che l'aveva seguita. – Le mie bestiuole mi vogliono bene, ma sarebbero anche capaci di antepormi la libertà.
– Cattive bestiuole, allora! – rispose il giovanotto.
– Che vuole? Sono irragionevoli, e non intendono la loro grande fortuna; – replicò ella, dando in uno scoppio di risa argentine.
– Come lo dice! – esclamò Gino. – Pare che non ne sia persuasa.
– Anzi, ne sono persuasissima; – disse la fanciulla ripigliando la sua gravità. – Le mie bestiuole hanno fortuna davvero, perchè vivono qui ben riparate dalla neve, dalla pioggia, dai venti, con la sicurezza del cibo ogni stagione dell'anno, e senza alcun timore delle martore. Poi, hanno tutti i giorni un po' di foglie verdi, come ora. Vede? Anche nel cuore dell'inverno, perchè non ne manchino mai, si pianta l'insalatina dentro la stufa. —
Mentre ella così parlava, erano escite dai loro abitacoli di legno parecchie coppie di conigli, tutti bianchi, senza la più piccola macchia di nero o di bigio, con gli occhi grandi e mobilissimi, i musi rosei, le orecchie lunghe e morbide. Vennero saltellando verso Fiordispina, ma videro quell'altro che si accostava anche lui, e scapparono tutti alla lesta. La fanciulla li richiamò, chinandosi a terra con le sue provvigioni, e quei graziosi animali, via via rinfrancati, tornarono, per avere la parte loro in quella distribuzione di foglie di cavolo. Brassica sativa, che diamine! Il nome latino sarà più difficile, ma un po' meno prosaico. E intanto che addentavano allegramente le foglie verdi, quei timidi animali si lasciavano correre la mano carezzevole di Fiordispina sulle orecchie e sul dorso. Uno di essi, certamente beniamino, si lasciò anche prendere di soppeso, ma senza abbandonare la foglia, che continuò a sgranocchiare tra le braccia della sua bella padrona.
Gino potè ammirarlo anch'egli e carezzarlo un poco. Ma stando egli a così breve distanza dalla portatrice, vedeva anche molto bene la graziosa testina di lei e le ciocche morbide, ricciolute, finissime, che sbucavano fuori dalla cerchia gelosa del suo fazzoletto di seta. Aveva tralasciato di accarezzare il coniglio; taceva; non respirava neanche; forse aspirava le fragranze giovanili di Fiordispina. Le donne, lo sapete, anche stando ad occhi bassi, vedono, in simili casi, o indovinano tutto quel che succede. Fiordispina calò a terra il suo piccolo beniamino, che seguitò a sgranocchiare, come se nulla fosse; quindi, risollevata la persona, si tirò con molta naturalezza due passi indietro.
– Dunque, – diss'ella, rompendo il silenzio, – le piace la mia famiglia?
– Signorina, – rispose Gino, scuotendosi, – tutto ciò che la circonda mi piace.
– Complimenti?
– Io? Non so farne.
– Badi; allora le vengono alle labbra spontaneamente.
– Se lo dice per questa volta, badi anche lei, signorina: non è stato un complimento. Sarei disposto a provarglielo.
– Sentiamo; – disse Fiordispina, senza levar gli occhi dalle sue candide bestiuole.
Il conte Gino incominciò:
– Che cos'è, prima di tutto, quello che la circonda? Le cure dei suoi, del babbo, delle zie, del fratello; non è vero? Ella ora mi permetterà di dirle, e mi crederà quando io le dico che queste amabili persone mi piacciono. Allarghiamo il cerchio intorno a Lei: viene la casa, ed io sarei un ingrato, se non amassi il luogo dove ho ricevuto una così gentile accoglienza, una così schietta e cordiale ospitalità…
– C'è dell'altro? – interruppe Fiordispina.
– Sicuro, perchè la cerchia s'allarga ancora; – rispose Gino. – Intorno a Lei, ai suoi parenti, alla, casa, ci sono le Vaie, c'è questa convalle così verde e così fresca, con le sue belle boscaglie, le sue cascate cristalline, il suo stupendo Cimone che fa la guardia lassù. Signorina, – conchiuse il giovane, – tutto ciò che la circonda è bello; sarà forse un complimento, e non un omaggio reso alla verità, il dire che mi piace? —
Fiordispina rimase un istante sopra di sè, non sapendo che opporre a quella argomentazione serrata. Ma una donna, saprete anche questo, non può restare troppo a lungo senza ragioni con cui schermirsi da un attacco di parole.
– Sì; – diss'ella, dopo quell'istante di pausa; – ma Ella non ha risposto alla mia prima domanda. Le parlavo de' miei conigli; se ne ricorda? Capisco; – soggiunse ella subito, non lasciandogli tempo a rispondere; – questa mia le sarà parsa un'occupazione volgare. Ma l'avverto, signor conte, che non ci sono solamente i conigli. Passeremo poi alle galline, ai colombi…
– Ed anche ai buoi! – gridò Gino, interrompendo a sua volta. – Son belli anch'essi, e i loro occhioni umidi piacquero tanto ai Greci, che essi ne fecero una particolarità della bellezza di Giunone, della regina di tutti gli Dei. I buoi, si dice, non sono intelligenti. La cosa non è provata; ma, se anche lo fosse, che importerebbe? Questi animali sono operosi e buoni; vivono nel campo e per il campo; hanno la pazienza dignitosa, che non è facile trovare in altre bestie, e neanche tra gli uomini; formano parte integrante del paese, componendosi stupendamente con la sua prospettiva, e completano, direi quasi, il sentimento morale che sorge spontaneo dalla sua agreste bellezza.
– Ho piacere che senta la poesia dei nostri monti, delle nostre convalli, com'Ella diceva poc'anzi.
– E che crede, signorina? Che della poesia non ne nasca più, nelle nostre pianure?
– Ah, bene! – esclamò Fiordispina. – Questa è una restituzione.
– Per esser pari; – disse Gino umilmente.
– E lo siamo ora; – rispose la fanciulla. – A me piace molto la sincerità.
– In ogni cosa?
– In ogni cosa. Perchè mi fa questa domanda?
– Per aprirmi la via a fargliene un'altra.
– Interroghi pure; son qua; – disse Fiordispina con quella sua gravità che mal nascondeva la voglia di ridere.
– Orbene, – riprese Gino, – per la sincerità… Ella non ignora che sono stato accolto dal signor Francesco come un figliuolo della famiglia. Fratello con Aminta, lo sono del pari con Lei. Per la sincerità, dunque, mia sorella Fiordispina dovrebbe dirmi una cosa.
– Anche due.
– Non sarò tanto indiscreto. Le domanderò solamente come passa la sua vita alle Vaie.
– Ma… Come vuole che la passi? Come la passerei dovunque: cioè molte ore del giorno in casa, a cucire, a curar le faccende di casa, a leggere, a suonare il mio pianoforte, e poi, mattina e sera, un pochettino a passeggio.
– Ah sì! – disse Gino. Il passeggio… Che passeggio può essere il suo, alle Vaie?
– È bello anche qui, e piacevolissimo; – rispose la fanciulla. – Ci sono, sparse in questi dintorni, tutte le bellezze naturali che nelle città si ottengono a forza di imitazioni e d'artifizi. Stamane, andando a Querciola, non l'ha veduta, la cascata del Chiuso? Dicono che somigli tanto all'orrido di Varenna, sul lago di Como. E la salita del Poggio? Dev'essere una specie di Montagnola, col suo bel colmo all'aperto, meno la vista di Bologna nel basso.
– E meno la gente a passeggio per i suoi larghi viali; – osservò il conte Gino.
– Che importa? – replicò la fanciulla. – Si è più soli, qui, ma si è per compenso più liberi. Cerca la compagnia della gente chi ha ragione o desiderio di farsi vedere.
– Per il desiderio, passi; ma la ragione, nel caso suo, ci sarebbe davvero. Ma lasciamo stare questi discorsi, che avrebbero l'aria di preparare un complimento…
– Non hanno più l'aria; – interruppe Fiordispina, ridendo. – Il complimento è già fatto.
– Ah sì? Non me n'ero avveduto; – rispose candidamente Gino. – Ma l'orizzonte di queste sue passeggiate?..
– È breve, e mi basta.
– Le basta? Le basta? Mi permetta di dirle che ciò è molto strano.
– Perchè?
– Perchè… Non saprei come dirglielo, ma sento così. Ci sono i momenti, nella vita, che l'anima non si contenta della sua prigione, e vorrebbe spaziare in più libera cerchia; dei momenti che il pensiero va lontano, di là dai monti, cercando.
– Per trovar che cosa? – domandò Fiordispina.
– Non so; forse altri monti. Ma questa è colpa del mondo, che è fatto così, non dell'anima nostra, che anela a cose migliori. E poi, signorina, anche ignorando la meta, si cerca, si desidera, si aspira, per un'idea confusa di ciò che sarà, o di ciò che dovrebbe essere un giorno. —
Fiordispina levò gli occhi, mandando anch'ella uno sguardo, lo sguardo dell'anima, di là dai mari e dai monti; poi disse:
– C'è una ballata di Goethe, che esprime un sentimento come questo.
Nel Wilhelm Meister, mi pare. —
Il conte Gino Malatesti non era così forte di letteratura straniera.
– Ho piacere d'incontrarmi con un tant'uomo; – diss'egli; – ed ho piacere che Ella possa citarlo così. Ma anche questo è strano, nelle convalli del Cimone; e sia detto senza offendere la dignità di questo bel monte. Dovrà Ella, signorina, vorrà e potrà viverci sempre? —
La fanciulla rimase un istante sovra pensiero. Non c'era qui nessun autore da citare? Io penso piuttosto che Fiordispina non era pedante, come son troppi, uomini e donne che hanno studiato, e che non condannava la gente a sentire ad ogni tratto un saggio delle sue letture predilette.
– Non mi risponde nulla? – ripigliò il giovanotto.
– Che cosa rispondere a questa domanda? Non è in mio potere; – disse Fiordispina. – Sarò io la foglia che vola dove il vento la porta? Sarò io l'umile pianta che muore dove è nata? Certo è che bisogna rassegnarsi. Foglia o tronco, ci governa il destino.
– È fatalista?
– No davvero; dico il destino, per modo di dire, ed intendo una volontà superiore. Ma lasciamo la filosofia, per carità; – soggiunse ella, con un gesto di terrore. – Vede, signor conte? I miei conigli scappano. Queste povere bestiuole non hanno meritata una lezione così severa. Del resto, non la intenderebbero neanche. Basta a loro di aspettare ogni giorno la provvidenza mia, come l'aspetteranno a quest'ora le galline e i colombi.
– Andiamo! – disse Gino. – Se possiamo adoperarci per la felicità di qualcheduno, sulla terra, non dobbiamo farci pregare.
– Ecco un bel pensiero, signor conte. —
Così dicendo, la fanciulla dei Guerri si avviò verso l'uscio. Gino la seguì, e richiuse diligentemente la porta, senza farselo dire da lei. Vedrete da questo piccolo particolare che il conte Malatesti non era uno sventato, e che entrava con molta sollecitudine nella gravità dell'ufficio.
Per quella mattina non più ragionamenti con la fanciulla dei Guerri; fu solamente quello scambio di parole che era necessario nelle piccole vicende, nelle insignificanti peripezìe d'una visita al pollaio e alla colombaia. Poi venne l'ora del pranzo; ed anche a tavola non furono che discorsi vani, o senza importanza, tra i quali il nostro giovanotto se la cavò discretamente, nascondendo il sentimento di tristezza che si era impadronito di lui.
Che cos'era avvenuto? Esplorare i segreti di un'anima è cosa difficile assai, e meglio varrebbe inventare di sana pianta. Ma le invenzioni non giovano che a patto di essere verisimili. Voi per esempio avrete sentito dire le mille volte che spesso avvenga di esser tristi senza ragione. Ma è proprio vero, questo? E non è a vederci piuttosto un effetto della nostra ignoranza, per difetto d'indagini? In quei momenti di tristezza, chi ben cerchi, c'è sempre il fatto d'uno squilibrio morale tra ciò che siamo e ciò che vorremmo e dovremmo essere. Sia luogo o genere di vita, o sentimento più intimo, se ciò che noi siamo per necessità, o che la nostra stoltezza ci ha condotti ad essere, non corrisponde a quello che intravvediamo di meglio, è naturale che la tristezza ci offuschi lo spirito. Ma se fossimo quel che vogliamo, o dobbiamo, saremmo poi più felici? Altro errore, pur troppo, altro inganno di prospettiva, poichè non ci contentiamo mai di quello che abbiamo, e desideriamo sempre ciò che è da raggiungere ancora. Così l'uomo è triste, e di simili tristezze è tessuto il drappo funebre della nostra esistenza.
Il conte Gino aveva poi, per argomento di tristezza, tutto quello che non diceva a sè stesso. Vi è occorso mai di ricevere una lettera e di lasciarla per qualche tempo chiusa sul tavolino, sperando che qualche noia più grande, magari una vera disgrazia, vi levi l'incomodo di leggere quello scritto, in cui fiutate il rimprovero, o una seccatura a cui non potrete sottrarvi senza venir meno a tutte le norme dell'onestà? Con pari sospensione d'animo viveva il conte Gino, a cui una parte della sua vita avrebbe potuto rimproverare quella avventura sui monti, quella volata al sereno, quella ebbrezza (chiamiamola pure così) quella ebbrezza di ossigeno. Ah, se gli fosse riescito di cancellare!.. Ma che cosa? Dio buono! Era qui il nodo della quistione, il punto che ricusava di guardare, la cosa, che non osava dire a sè stesso.