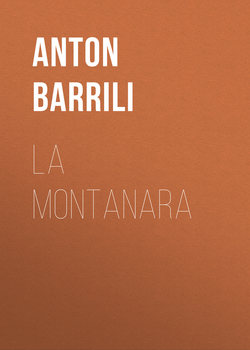Читать книгу La montanara - Barrili Anton Giulio - Страница 5
Capitolo V.
Il commissario e l'applicato
ОглавлениеRitornato quella sera a Querciola, il conte Gino Malatesti indovinò la ragione dei discorsi che il signor Aminta aveva fatti sottovoce al Mandelli. E ancora indovinò perchè il signor Francesco Guerri e suo figlio, ritiratisi a colloquio d'affari, lo avessero lasciato solo, fino all'ora del pranzo, in quella dolce libertà che gli aveva permesso di scendere nella stufa e di aver poi quella lunga conversazione con la bella Fiordispina.
La sua camera, in casa Mandelli, era completamente trasformata. Gino incominciò a vedere un letto nuovo, di ferro, col suo tappeto da piedi, il suo comodino accanto, il suo candeliere e perfino il grazioso arnese di velluto su cui posar l'orologio. Più in là era un cassettone, e vicino a questo, in un angolo, l'attaccapanni. Di rincontro alla finestra era una piccola scrivania, con carta, penne, calamaio, ed anche dei libri. Guardò quei volumi, e riconobbe la Divina Commedia, la Bibbia, un compendio di Storia romana, e finalmente un dizionario storico-geografico del Ducato di Modena.
Tutta quella roba era stata caricata, portata e messa a posto nella giornata. Parecchie persone, di certo, avevano lavorato all'impresa, sotto la scorta di Aminta, che infatti, appena finito il pranzo, era sparito da casa, non ritornando che verso sera, quando per il conte Gino era venuta l'ora di ritornare a Querciola. Ottimo fratello Aminta! Ma se egli aveva lavorato con tanta sollecitudine lassù, non mancavano traccie del pensiero di Fiordispina. I libri, sicuramente, li aveva scelti lei. Quel copertoio trapunto, che si vedeva disteso sul letto, quel grazioso arnese per deporvi l'orologio, quel piè di lampada ricamato che stava sulla scrivania, non erano forse opere sue? Aggiungete che a pian terreno, nella stalla del Mandelli, dov'era stata rinnovata la paglia, riposava il cavallo su cui Gino Malatesti aveva già fatto tre corse. Un famiglio dei Guerri, destinato al governo del cavallo, doveva rimanere a Querciola, come servitore di Gino.
Un sentimento di gratitudine si associò naturalmente nel cuor suo alla sensazione di piacere che gli aveva destato la vista di tante novità. Quella notte, sdraiato nel soffice letticciuolo, al tepore delle morbide coltri, al profumo delle lenzuola di lino (le aveva prevedute di canapa, e con molti stecchi per giunta), il nostro giovinotto sognò beatamente i suoi ospiti e benefattori delle Vaie. Era più che mai il figlio prediletto dei Guerri. Aminta gli aveva stretta la mano, giurandogli eterna amicizia; Fiordispina lo amava; il signor Francesco gli sorrideva, e Don Pietro Toschi, parroco delle Vaie, lasciata la pipa in canonica, si disponeva ad andare nella sagrestia, per vestire i sacri paramenti e dar la benedizione di rito. Così almeno pareva a Gino, perchè nel sogno non vediamo solamente gli atti, ma leggiamo anche nei cuori e indoviniamo le intenzioni della gente.
Per intanto, mutata facilmente la scena, egli passeggiava in un bosco di cerri, e Fiordispina era sospesa al suo braccio. Che pace, Dei immortali, che soavità, che fragranza d'idillio! Ecco, si erano fermati, e con le punte dei coltelli incidevano i loro nomi nei tronchi degli alberi: egli il nome di Fiordispina; ella il nome di Gino. Ma che malìa era quella? Aveva proprio scritto egli? La fanciulla dei Guerri veniva accanto a lui, per leggere il suo nome, e scambio di quello, vedeva inciso nella corteccia un altro nome, e ben chiaro: il nome di Polissena. – Che è ciò? domandava turbata. – Non so; come può essere avvenuto questo cambiamento? Io avevo pure scritto: Fiordispina. – Ebbene, quel che tu fai, conte, è ben fatto. Purchè non sia il nome di un'altra!..
Fremeva egli a quelle parole di lei; smaniando, si affrettava a cancellare; ma quel nome, che egli non intendeva come si fosse formato sotto la punta del suo coltello, quel nome restava, anche inciso nelle bianche fibre del tronco, dopo che egli ne aveva strappata la corteccia. E si disperava, tempestando di colpi quelle lettere fatali; ma Fiordispina non era là più a vederlo, Fiordispina era sparita; ed egli, gettato sdegnosamente il coltello, dava in uno scoppio di pianto.
Destatosi da quel brutto sogno, riebbe un po' di calma, non intieramente la serenità dello spirito. Oramai poteva capire come e perchè fosse rimasto malinconico, dopo il suo colloquio con la fanciulla dei Guerri. Ma infine, sorgendo il sole e cacciando davanti a sè le torpide nebbie della vetta del Cimone, infine, che cosa aveva egli fatto di male? Si era forse innamorato alle Vaie, mostrandosi infedele al suo amore di Modena? Il sole incominciava ad apparire dal monte, e un primo raggio batteva alto sulla finestra della sua camera. Gli parve allora che un simile dubbio non fosse neanche possibile. Maledettissimo sogno! Come lo aveva spaventato! Fortunatamente, nel suo esame di coscienza, fitto alla bella luce del giorno, il conte Gino Malatesti non trovò che cortesie e gentilezze, risposta naturale a gentilezze e cortesie. La gioventù, l'innocenza, la grazia, si sa, ispirano sempre un pochino di tenerezza, domandano qualche piccolo omaggio. È da cavalieri, poi, servire a tutte le dame, non amando che una. Egli non aveva detto niente di particolare alla fanciulla dei Guerri, niente che potesse apparire una dichiarazione d'amore, e da questo lato la marchesa Polissena poteva vivere pienamente tranquilla.
Doveva esser bella, in quell'ora del sonnellino d'oro, la regina de' suoi pensieri. Perchè ella certamente riposava ancora, in quel punto. Era una gran dormigliosa, la marchesa Polissena. E doveva star così bene, con la sua cuffiettina di pizzi, donde sbucavano le ciocche de' capegli dorati! Gino ripensò allora i bei giorni, le ore liete, e quella famosa corsa in Piemonte, che sicuramente aveva fornito al sospettoso governo ducale uno dei più forti capi d'accusa contro di lui. Strana donna, la marchesa Polissena! Curioso impasto di paure e di audacie, di rispetti umani e di cieche temerità! Perchè spesso, quasi sempre, egli era obbligato ad infingersi, a fare il cerimonioso, in obbedienza agli ordini della bionda signora. In casa di lei convenivano ufficiali dell'esercito ducale, consiglieri, magistrati, senza contare tutti i nobili, vecchi e giovani, pari di grado e d'importanza al conte Gino Malatesti. C'erano delle serate che la marchesa gli rivolgeva appena il discorso. Ma guai se egli, adattandosi a quel giuoco e volendo pur secondarlo, faceva il galante intorno a qualche altra. Passando daccanto a lui, con un pretesto, o chiamandolo per suo aiutante nella distribuzione del tè, gli gettava una di quelle parole che lo facevano tremare per ogni vena.
Dopo una di quelle collere, per l'appunto, era cascato il viaggio a Torino. Doveva fingere di avere anch'egli necessità di andare a Piacenza, ultima città dello Stato limitrofo ed amico; ottima occasione per accompagnare un tratto di strada la signora marchesa Baldovini, che noti interessi di famiglia chiamavano allora a Torino. Da Piacenza era sconfinato sul territorio piemontese, cedendo così volentieri ad un bel capriccio di lei, che era in uno de' suoi momenti di audacia, di temerità, di pazzia. Ma da Torino la marchesa Polissena era ritornata sola a Modena, ed egli aveva dovuto, per rispetto a lei, rimanere dell'altro in Piemonte. Non a Torino, veh! per causare il pericolo delle distrazioni. Polissena si era fatta accompagnare fino ad Alessandria, e là aveva condannato il conte Gino a rimanere tre giorni, a contemplare i rossi baluardi della cittadella, o a contar le ore sul quadrante del palazzo comunale. Questo rimanere più a lungo e da solo nel territorio scomunicato, aveva certamente insospettito il governo ducale. Francesco V poteva creder benissimo che quello del giovane conte Malatesti non fosse un viaggio a Citèra, per offrir sacrifizi alla madre d'Amore, ma un vero e proprio pellegrinaggio a Delfo, per consultare gli oracoli della Patria.
Ahi, Polissena! Da quel giorno gli sgherri avevano posto gli occhi su lui. Se egli soffriva il confine a Querciola, si poteva benissimo accusarne un discorso tra amici in festa, ma non senza farne risalire l'origine a quel viaggio, e per conseguenza all'amabile capriccio della marchesa Baldovini. Lassù, nei pressi del monte Cimone, gli era avvenuto di trovarsi solo, di respirare un istante più liberamente, senza il pericolo che la marchesa gli passasse daccanto e gli gittasse una di quelle parole che lo facevano tremare. Ma infine, come prima, nel salotto di lei, anche allora, alle falde del Cimone, egli non si sentiva in colpa. E perchè, poi, le sarebbe stato infedele? Gratitudine, sì, ne aveva molta ai signori delle Vaie, e doveva in qualche modo dimostrarla. Quelle cure amorevoli, quegli inviti a pranzo, erano cose di tutti i giorni; ma egli, nella condizione in cui era, non poteva neanche ritrarsene. Per altro, si sentiva sicuro di sè, avrebbe anche fatto buona guardia al suo cuore, contro gli inganni della fantasia, contro le tentazioni del tempo e del luogo. La cosa era necessaria altresì per riguardo a quella gentile fanciulla, così bella, così intelligente, ma pure così inesperta delle cose del mondo. Sarebbe stato brutto, indegno di lui, turbar la pace di quell'anima verginale. Al posto, adunque, signor Gino degnissimo, al posto! È così facile, quando si vuole davvero!
Chi gli diceva di no? Chi mai gli bisbigliava nel cuore che certe cose è più facile immaginarle che farle? Sicuramente un genio maligno, uno spirito noioso, che vive dentro di noi e fa la critica di tutti i nostri pensieri. Dovrebb'essere il diavolo della logica: un diavolo arguto, dopo tutto, e non cattivo come sembra; ma riesce ordinariamente antipatico, perchè contraddice volentieri e ci mette alla disperazione con le sue ironie sanguinose.
Ah sì, spirito malnato? Credi proprio che sia tanto difficile il fare una cosa, quando si vuole davvero? Aspetta un pochino anche tu, e vedrai come ci si riesca.
Davanti a quel fermo proposito, il genio maligno taceva, quasi umiliato, e ritirava le corna. Gino, frattanto, inforcava il cavallo, per ritornare alle Vaie.
Ci andò per due giorni ancora, abbastanza contento di se medesimo. Oramai, forte della sua risoluzione, il nostro giovinotto poteva credersi agguerrito al pericolo. Parlava liberamente con Fiordispina, non cercando mai, ma neanche sfuggendo l'occasione di trovarsi solo con lei. Più volentieri restava in conversazione con la famiglia riunita, e allora faceva pompa di tutto quello che sapeva, ragionando con garbo, girando le frasi con arte, dando alle parole tutte le più dolci inflessioni di voce. Non è forse lecito, questo? Non è anzi un dovere, quando vogliamo farci ascoltare senza troppa noia da un numeroso uditorio? Cercar di piacere alla gente non fu mai un delitto; è anzi una bella cosa, quando è l'unica che possiamo fare, a ricambio di tante gentili attenzioni che ha la gente sullodata per noi.
La sua presenza era molto gradita, nella casa dei Guerri. Anche i re conoscono la noia, e un discorritore ameno, che parli gravemente di mode e gaiamente di cose scientifiche, buon dilettante per ragionare senza sussiego di arte e di lettere, diplomatico raffinato per toccare, senza scoprirli, i segreti dei gabinetti, e per dipingere con un rapidissimo tocco i piccoli difetti dei sovrani esteri, che sono fratelli e cugini del padrone di casa, è veramente la man di Dio in un circolo intimo, donde il cerimoniale è per due ore sbandito. Per i re della montagna, il conte Gino era come una gaia nota di sole nel fosco della macchia; la sua presenza una bella meteora, la sua conversazione un fuoco d'artifizio. Anch'essi, tanto buoni e ricchi di quella gentilezza che non s'impara lì per lì, ma che è il frutto di una lunga educazione, fors'anco eredità di famiglia, anch'essi, dico, si facevano più amabili al contatto dell'ospite, fresco degli usi e delle garbatezze cittadine, brillavano anch'essi di quella vernice, che, a dirvi la cosa molto volgarmente, tutti i corpi son capaci di prendere per sola virtù di strofinamento. Ed avveniva allora nella casa dei Guerri ciò che spesso accade in una brigata di persone civili, quando, per opera non avvertita di uno, che abbia garbo e misura, tutti si accorgono con meraviglia di avere avuto più spirito. – Come è passato il tempo! si dice. E siamo proprio noi, che ci siamo divertiti così? —
Vi ho detto che Gino fu ancora per due giorni alle Vaie, con molta sicurezza di sè. Ci era andato il terzo giorno; ma la sua tranquillità era stata turbata sul più bello. Si stava appunto per prendere il caffè, quando vennero a chiamare il signor Aminta, che andò subito fuori, e ritornò dopo cinque minuti.
– Sai? – diss'egli a Gino. – Ci sono due signori a Pievepelago.
– Ah! – esclamò Gino, turbato. – Cercano forse di me?
– Lo credo, perchè hanno domandato la via di Querciola. L'uomo che è venuto ad avvertirmi in fretta mi dice che all'aria gli sembrano due impiegati del governo ducale.
– Due commissarii! Troppo onore; – borbottò Gino. – E come ne sei stato avvertito?
– Prevedevo la visita, – rispose Aminta, – ed ho stabilito il mio servizio di esplorazione.
– Grazie, mio buon amico e fratello! Ed ora, potranno esser qua da un momento all'altro.
– No, perchè si erano messi a tavola, quando il mio esploratore montava a cavallo. Del resto, puoi riceverli qui.
– Che! Non mi conviene davvero.
– E perchè? – domandò il signor Francesco. – Ella è in casa sua.
– Appunto per questo che a Lei piace di dire; – rispose Gino, ridendo. – I satelliti del tiranno vedrebbero che sto troppo bene, fra queste montagne. Cattivi come le scimmie, mi farebbero subito un brutto servizio presso l'autorità superiore, e questa, con un suo nuovo rescritto, mi manderebbe Dio sa dove.
– Allora scappi subito! – dissero le signore.
Aminta corse nella scuderia, a far sellare il cavallo di Gino. Per quel giorno, intanto, addio conversazione!
– Ci porti notizie, quando saranno ripartiti; – disse il signor Francesco, stringendo la mano al suo ospite.
– Oh, sicuramente; non dubiti. Signore mie, compiangano un povero condannato, che deve obbedire al precetto. —
Cinque minuti dopo, era a cavallo, e Aminta lo accompagnò fin sulla strada.
– Non correre tanto; – gli disse. – Per venire a Querciola debbano passare di qua. Se anche hanno trovato muli a Pievepelago, non c'è pericolo che vengano al trotto. Comunque, noi non offriremo loro i cavalli per raggiungerti. Quando ci rivedremo?
– Se mi lasciano, – disse Gino, – fo una trottata stasera.
– Bravo! Ti hanno guastata la fine del pranzo; vieni a cena.
– Eh! Perchè no? A rivederci. Se non posso liberarmi, ti mando Pellegrino con le mie notizie. —
Pellegrino era il famiglio dei Guerri, collocato da questi al servizio di Gino Malatesti.
Il nostro confinato era già da due ore nel suo eremo di Querciola, e incominciava a credere che quello di Pievepelago fosse stato un falso allarme, quando sentì un batter di ferri sul selciato della strada.
– Ah, ah, ci siamo! – disse Gino tra sè. – Ed hanno anche trovate le cavalcature, quei manigoldi! —
Lo scalpitìo, frattanto era cessato, perchè i cavalli, o muli che fossero, avevano raggiunto il colmo della salita, davanti alle prime case di Querciola. Non andò molto che Gino sentì un rumore di passi su per le scale.
Il vecchio Mandelli precedeva i forastieri. Affacciatosi all'uscio della camera, che Gino aveva lasciato socchiuso, disse al suo inquilino:
– Signor conte, son qua due signori che cercano di Lei.
– Entrino pure; – rispose Gino, smettendo di leggere, ma lasciando aperto sulla scrivania il Dizionario storico geografico dello Stato di Modena.
Il vecchio Mandelli si ritirò, e in sua vece si presentarono le due facce proibite che avevano guastata la digestione del conte Gino, facendolo correre con tanta fretta dalle Vaie a Querciola. Dico facce proibite per far piacere al nostro eroe; ma nel fatto erano due facce insignificanti; completamente rase, perchè a que' tempi non si amavano le barbe, e i pizzi e i mustacchi erano proibiti come le pistole corte, anzi come le pistole d'ogni misura e le armi d'ogni genere. I due possessori di quelle facce erano vestiti di nero, e i loro atti apparivano molto cerimoniosi, ma non senza quel po' di sussiego che ha sempre indicata la dignità di un ufficio governativo. Dal contegno dell'uno rispetto all'altro, dalla distanza che il secondo mantenne venendo dietro al primo, si capiva facilmente che quegli era inferiore di parecchi gradi al suo compagno di viaggio.
– Ella ci perdonerà, signor conte, se veniamo a scomodarla; – disse il superiore. – Adempiamo un incarico del governo.
– Facciano pure; – rispose Gino, accennando due seggiole, ma non degnandosi di domandare in che consistesse l'incarico.
– Niente di noioso o di lungo, per altro; – ripigliò l'oratore. – Una semplice ricognizione, e punto offensiva. Sua Eccellenza desiderava di sapere se Vossignoria ha trovato modo di collocarsi a Querciola.
– Ci sono venuto subito, appena ricevuto l'ordine; – rispose Gino, niente ingannato dalla forma garbata in cui quell'altro gli presentava la cosa.
– Veramente, – disse il commissario, – questo è un paese poco abitabile, se debbo giudicarne dalla strada che abbiamo fatta per giungerci, e dalla meschina apparenza delle case. M'immagino che Sua Eccellenza non lo conoscesse altrimenti che sulla carta. —
Gino rispose con un cenno del capo, che voleva dire e non dire. A quel discorso del signor commissario, in verità, non c'era nulla da rispondere.
– Siamo tra contadini a dirittura; – continuò il commissario. – Ed Ella, signor conte, non ci avrà distrazioni. —
Gino sospirò; poi rispose al signor commissario:
– Che farci? Il confine è una punizione, e come tale non ammette passatempi, oltre quelli che un uomo industrioso, ed anche di facile contentatura, sa trovarsi da sè.
– Studiando, non è vero? Ha qualche libro, come vedo.
– Poca roba, signor mio: la Bibbia, la Divina Commedia, una Storia Romana antica…
– Ah, buono studio! – esclamò il signor commissario.
– Certamente! – disse Gino. – È molto interessante. Par di vivere in tempi migliori.
– E stava per l'appunto vivendo cogli antichi, quando noi siamo venuti a disturbarla.
– No, per il momento facevo dell'altro; cercavo qualche notizia in questo Dizionario storico e geografico del Ducato. Desidero di conoscere questi paeselli di montagna, per fare qualche passeggiata.
– Ottima cosa, poichè si è in campagna; – disse il commissario. – E qui ci ha una bella prospettiva?
– Ne giudichi Lei, signor commissario. Si affacci pure alla finestra.
Vedrà molto verde. —
Il signor commissario si degnò di andare alla finestra, e di metter fuori il suo naso.
– Sì, veramente, molto verde; – diss'egli ridendo. – Nient'altro che verde. —
Gino, frattanto, si sentiva cacciar tra le dita qualche cosa, come una lettera, o un foglio di carta ripiegato.
Si volse a guardare il compagno del commissario, l'inferiore di grado, il semplice applicato, e vide ne' suoi occhi un lampo, un cenno d'intelligenza, una raccomandazione muta. Poi quel lampo si estinse; il cenno e la raccomandazione si smarrirono nella tinta scialba della sua faccia marmorea.
Il giovanotto ebbe a mala pena il tempo di far scorrere in tasca il foglio di carta, perchè il signor commissario si era già ritirato dal vano della finestra, per rivolgersi a lui.
– Del resto, – disse l'oratore del governo ducale, dopo aver data una guardatina in giro, – Ella è abbastanza bene, in questa cameretta.
– Con qualche mobile preso in affitto; – rispose Gino umilmente.
– Difatti, – riprese il commissario, – questi mobili non somigliano punto agli altri della sala d'ingresso, e stuonano anche con la misera apparenza della casa. Mi maraviglio che abbia potuto trovarne in questi dintorni.
– Appena giunto a Querciola ne dubitavo anch'io; – rispose Gino, seccato da quel discorso, ma vedendo la necessità di condurre il suo interlocutore fuori di strada. – Ma offrendo danaro… Ella mi capisce!
– Buona cosa averne molto; – osservò giudiziosamente quell'altro, che forse pensava in quel punto al magro stipendio per cui faceva da tanti anni un ingrato mestiere. – Ella è felice, signor conte!
– Ma sì, ma sì! Non mi lagno.
– Ed ha notizie di suo padre, di quell'ottimo conte Jacopo?
– Nossignore, e di nessuno della mia famiglia; – rispose Gino, contentissimo di essere uscito salvo dalla rassegna dei mobili. – I miei parenti mi tengono il broncio, e si capisce, perchè il governo mi ha preso in sospetto come un reprobo.
– Eh via! – disse il commissario, con accento di benevolenza somma. – Non chiami castigo una correzione paterna, per una colpa giovanile… che forse non sarà nemmeno una colpa.
– Dice bene, e levi pure il forse.
– Tanto meglio, e me ne congratulo con Lei; – ripigliò il commissario. – Allora è da sperare che tutto venga in chiaro tra breve, e che, per conseguenza, dopo un paio di mesi… dopo tre…
– Metta anche sei; – interruppe Gino. – Non è privilegio della verità il venire così presto alla luce. Ella sa, signor commissario, che questa bella signora l'hanno relegata nel fondo di un pozzo. —
Il vecchio funzionario sorrise. Capiva anch'egli benissimo che il confine non sarebbe levato così presto e che il conte Malatesti non poteva pascersi di troppe speranze in proposito.
– Speriamo almeno, – diss'egli, – che per i meriti del suo signor padre…
– Ecco, veda; – replicò Gino, mozzandogli le parole in bocca. – Per i meriti di mio padre possono dare un'altra decorazione… a mio padre. Il figlio, se ha errato, paghi; se non ha errato, riconoscano la sua innocenza. Non Le pare?
– È la logica, lo riconosco; – rispose il commissario, che incominciava a seccarsi di quella disputa, in cui il conte Gino voleva aver sempre ragione. – Ma Ella vuol troppo severo il nostro venerato governo, ed amo credere che ciò sia perchè Ella non ha ragione di meritarne i rigori.
– È così; – disse Gino.
– Dunque, signor conte… vuol notizie di Modena? —
Gino aveva sperato che il commissario si disponesse a prendere commiato, e già era per alzarsi. Il resto della frase lo trattenne. In fondo, meglio così; la conversazione prendeva un tono migliore, e le notizie di Modena erano sempre buone a sapersi.
– Mi fa un favore; – diss'egli inchinandosi.
– Prima di tutto, il suo signor padre sta bene. L'ho veduto ieri mattina in via Emilia, che andava a fare la sua solita passeggiata. Gli altri di casa sua, tutti bene egualmente. È ammalato il conte Azzolini, canonico del Duomo; ma quello ha ottantasei anni, poveretto, ed è pieno di acciacchi. Il marchese Frassinori è caduto ier l'altro da cavallo, ma senz'altro danno che qualche contusione. Le belle signore di Modena son tutte in grande fermento, per la riapertura del teatro.
– Diamine! – esclamò Gino. – E perchè si riapre il teatro?
– Caso strano, signor conte, caso eccezionale! È venuta a passare qualche settimana in patria la nostra famosa Venturoli, stella di prim'ordine nel cielo dell'arte, reduce dai suoi trionfi di Pietroburgo. Ella ha accettata la proposta di farsi sentire dai suoi concittadini, e darà quattro rappresentazioni, due della Lucia di Lamermoor e due della Sonnambula, che sono, come Ella sa, i suoi due cavalli di battaglia. Grande aspettazione, perciò, e si prevede che verrà molta gente, anche da Guastalla e da Reggio. Noi siamo debitori di questa fortuna insperata alla signora marchesa Baldovini.
– Ah, bene! – disse Gino. – È una dama di buon gusto, la signora marchesa. Strano, per altro, che non mi abbia detto nulla di tutto ciò, l'ultima sera che ebbi l'onore di andare alla sua conversazione.
– Si capisce: la cosa è nata lì per lì, appena si seppe che la Venturoli era giunta. La marchesa ha conosciuta la celebre cantante a Milano. La conosceva già da ragazza, io credo; ma deve aver rinnovata la conoscenza, quando la nostra insigne concittadina fece quel gran fanatismo alla Scala, sei o sette anni fa. L'altra sera, in conversazione, fu detto alla marchesa che la Venturoli era a Modena. So la cosa dall'illustrissimo signor presidente del tribunale, che ha qualche bontà per me, ed è così bravo dilettante di violino. La marchesa ebbe allora l'idea di farla cantare a Modena. Detto fatto, andò la mattina dopo a trovarla, e venne a capo di tutto, È onnipotente, la signora marchesa! Ier l'altro era già ottenuto il permesso e combinato ogni cosa. Si aspetta un tenore, con un baritono e alcune seconde parti, mandato a cercare in fretta a Milano. Quanto al basso, c'è l'Orlandi, nostro modenese anche lui, che fortunatamente era a casa, in attesa di scrittura. Ah, saranno quattro serate magnifiche, quattro serate deliziose!
– Ella ama molto la musica, signor commissario?
– Dica che ne vado pazzo, signor conte. Che si fa celia? Un po' di buona musica, è il maggiore dei conforti.
– Sarà dilettante, m'immagino; suonerà qualche istrumento.
– Nelle ore d'ozio, e piuttosto male, il violoncello; – rispose il commissario, con l'atto e l'accento di finta umiltà, per cui vanno distinti i virtuosi seguaci d'Euterpe… e d'altre Muse parecchie.
– Ottimamente! – disse Gino, salutando.
E sorrise, pensando alla bella figura che doveva fare il signor commissario, con quell'enorme violino ritto tra le ginocchia. Ma sorrise per poco, ritornandogli a mente la signora marchesa Polissena, che pensava a metter su spettacoli teatrali, e proprio in quel giorno che egli correva da Modena a Pavullo, per recarsi al suo luogo di esilio. Ahimè! Così va il mondo. Anche quel povero Ovidio, cavaliere e poeta, veleggiava tristamente verso l'Eusino, e frattanto le belle dame romane, amate e cantate da lui, andavano allegramente a teatro, non cercando più l'elegante profilo del poeta nella precinzione dell'ordine equestre.
– Beati loro che si danno bel tempo! – soggiunse Gino, dissimulando l'amarezza del ricordo particolare sotto quella espressione di rimpianto generico.
– Che vuole, signor conte? Si fa il possibile per tener lontana la noia. Il paese è tranquillo e contento e speriamo che le cose vadano di bene in meglio. Quando il raccolto è buono e la gente ha lavoro, che desiderare di più, se non qualche ora di svago intelligente, nel culto delle arti belle?
– Ha ragione; – disse Gino. – E tutto sia per il meglio, nel migliore dei mondi possibili. —
Così dicendo, si alzò per davvero, volendo farla finita. Il nostro giovinotto non ne poteva più; aveva un diavolo per occhio.
– Mi duole, signor commissario, – riprese, – di non aver nulla da offrirle.
– Oh, non s'incomodi; abbiamo desinato a Pievepelago.
– Ma neanche un bicchier di vino che meriti questo nome. Il raccolto dell'altr'anno dev'essere stato scarso, perchè qui non han nulla di nulla.
– A proposito: e che mangia?
– Vivono le galline, fortunatamente; – rispose Gino. – Ova sode, ova a bere, ova fritte, ova in tegame; questo è il fondamento del pranzo. Vien poi qualche vecchio gallo, che sacrifico ad Esculapio, per ottenere un po' di brodo.
– Via! – esclamò il commissario. – Osservo con soddisfazione che non le manca il buon'umore: segno che sa adattarsi alle circostanze. Lo dirò, se permette, a Sua Eccellenza.
– Dica pure, dica pure; – rispose Gino; – aggiunga, per altro, che non mi lagnerò, se mi richiamano a casa.
– Capisco, ed anche in tempo utile per assistere ad una rappresentazione della Sonnambula; non è vero, signor conte? Questo mi par difficile, non glielo nascondo; ma creda pure che dal canto mio gliel auguro di tutto cuore. La mia servitù! —
Gino stese la mano al signor commissario. E non tanto per lui, che gl'importava pochino, quanto per aver argomento a stringer poi quella dell'applicato, personaggio muto, ma più amico dei fatti che non delle parole, come abbiamo veduto testè.
Quando finalmente fu solo, diede una rifiatata di contentezza; maravigliandosi, per altro, di aver saputo dire tante bugie. Ma è la necessità che fa l'uomo industrioso, e con quelle bugie così naturalmente infilate, il nostro giovanotto aveva custodito il segreto dei piccoli vantaggi materiali e morali che si era procacciati nel suo luogo d'esilio.
Udito il batter dei ferri sul ciottolato della strada, discese per chiamar Pellegrino.
– Ho bisogno di sapere se i due che sono partiti si fermano alle Vaie.
Dovrei ritornarci io, e non mi piacerebbe d'incontrarli laggiù.
– Vado a vedere; – disse Pellegrino.
– Ma senza farti scorgere!
– Non dubiti; conosco tutti i sentieri, e non ho neanche da seguirli fin là. In un quarto d'ora sono alla Pietra Aguzza, donde si vede netta la strada delle Vaie e il portone della casa Guerri.
– Ottimo osservatorio! – disse Gino. – Va dunque, e ritorna appena vedrai quei signori avviati a Fiumalbo. —
Pellegrino escì sulla strada, e il conte ritornò nella sua camera, sorridendo ai mobili che avevano destata la maraviglia del signor commissario.
– Miei buoni amici delle Vaie! – diss'egli in cuor suo. – Vi ho fatti passare per gente che dà la roba a pigione. Scusatemi! Lì per lì non sapevo che altro inventare, e mi sembra già molto di aver trovata questa gretola, per cavarmi d'impiccio. —
In fondo, poi, non gli era capitato a Querciola il peggiore dei commissarii possibili. Un altro arnese della sospettosa polizia ducale avrebbe potuto spingere più avanti le indagini: voler vedere tutta la casa, per esempio, scoprire nella stalla un bel baio ancora sellato e domandare dove mai il conte Gino avesse preso in affitto quel generoso cornipede. Per fortuna sua, il signor commissario non era stato troppo curioso; era anche un dilettante di musica, un suonatore di violoncello a ore avanzate, e i cultori delle arti hanno sempre un lato buono, moralmente parlando, anche se quel lato è artisticamente il cattivo. Ma forse, a proposito di musica, si poteva sospettare che il signor commissario fosse stato un pochino malizioso. Con troppa compiacenza aveva data la sua notizia teatrale! E non era da supporre che conoscesse le relazioni del conte Gino Malatesti con la marchesa Polissena Baldovini? Forse no, e il caso ci aveva avuta la parte sua, come in tante cose di questo mondo. La città, veramente, non era grande, ed anche un semplice commissario di polizia poteva aver conosciuto quel segreto galante del confinato di Querciola; ma in casa Baldovini ci andava Gino come ci andavano cento, a dir poco, dei più ragguardevoli cittadini di Modena, e in questo caso il numero dei frequentatori era piuttosto fatto per confondere lo spirito di un osservatore, che non per guidarlo nelle sue ricerche indiscrete. Finalmente se la marchesa Polissena si era presa in quei giorni tanta cura per quattro rappresentazioni straordinarie, se a lei si doveva che la celebre Venturoli si disponesse a cantare, a deliziare i suoi concittadini con le immortali melodie della Sonnambula e della Lucia di Lamermoor, niente era più naturale del dirlo, quando il discorritore era un dilettante di musica.
Ahi, Polissena! E questo doveva udire dei fatti vostri il povero confinato di Querciola? Doveva egli vedersi dimenticato, trascurato a tal segno? Certamente egli non si aspettava di sapere che aveste preso il lutto, o che vi foste confinata in villa, inconsolabile come Calipso per la partenza di Ulisse. Simili prove di affetto e di dolore veemente si lasciano alle Immortali, che possono far ciò che vogliono, senza badare a rispetti umani, e mandando a quel paese la piccola diplomazia di società. Ma se la marchesa Polissena voleva dissimulare, conveniamone col conte Gino, ella poteva appigliarsi ad un pretesto più ovvio, ad uno espediente meno chiassoso, che non fosse quello di promuovere una stagione teatrale a primavera inoltrata.
– Leggiamo la lettera! – disse Gino, dopo aver fatte, in due o tre o giri per la sua camera, tutte queste considerazioni melanconiche. – E vediamo chi l'ha scritta. Forse è Polissena, che ha trovato il modo di mandarmi una parola di conforto. —
Cavò di tasca il foglio, che era suggellato, ma non portava soprascritta. Lo aperse, e vide subito che quello della lettera non era il carattere di Polissena, bensì di Giuseppe, del servitore che lo aveva accompagnato a Paullo.
Ah, bene! Il suo Carbonaro! E come era venuto a capo di mandargli la sua lettera, proprio per le mani di un impiegato di polizia? Gino Malatesti era giovane; viveva, anche da liberale in un modo tutto suo, e non conosceva i particolari andamenti delle società segrete, che correvano allora per sottilissime fila tutte le città e borgate della penisola italiana. Tra i loro accorgimenti più fini, le società segrete avevano questo, per l'appunto, di mettere uomini fidati in uffici anche umili, ma di grande utilità, intorno al grande avversario comune. A queste loro creature domandavano poco, e solamente nei casi di stretta necessità. E dal canto loro, questi servitori devoti si sentivano molto sicuri, poichè il loro ufficio particolare non era noto che a pochissimi, aiutando a ciò la stessa costituzione delle società segrete, i cui affiliati non si conoscevano tutti fra di loro. La catena era lunga, ma ognuno sapeva del suo vicino di destra e di sinistra, e tutti gli altri anelli si perdevano nell'ombra; nè importava cercare di più, sapendosi spalleggiati e immaginando anche un ordinamento più forte, una catena più lunga e una rete più fitta.
Comunque fosse riescito il suo bravo Giuseppe a fargli pervenire la lettera, egli era un uomo prezioso. Quali notizie gli avrebbe recate la lettera? Gino si dispose a leggere con uno strano batticuore.
– Ecco, – diceva egli tra sè, – qui forse c'è la spiegazione di certe cose che mi hanno fatto un senso così triste, buttate là dal signor commissario. Il mio tormentatore non lo immaginava di certo che accanto al suo veleno, distillato con tanta voluttà, venisse così pronto l'antidoto. —
Così pensando, incominciò la lettura:
«Illustrissimo,
«Eccomi a renderle conto della mia commissione. Appena giunto a palazzo sono andato nella camera di V. S. ed ho trovato il libro che mi aveva detto di portare in quel luogo. Ne ho fatto un involto, e volevo metterci anche la lettera; ma ho pensato che l'involto poteva essere inavvertentemente aperto in presenza di altre persone, e me ne sono astenuto…»
– Bravo il mio Giuseppe! – esclamò a questo punto il lettore. – Ecco qui il vero tipo del cospiratore, che medita su tutto e prevede le più piccole circostanze. —
«Andai verso il tocco – (proseguiva lo scrivente) – dalla nota persona, cioè quando mi fui accertato che era sola in casa, e domandai di parlarle, perchè avevo da consegnarle un libro. La cameriera mi disse che la signora non riceveva. Io allora diedi il libro, accennando che venivo da accompagnare V. S. e che desideravo anche di portarle i suoi saluti, insieme con una sua lettera, per una certa commissione, che non sapevo qual fosse, ma che credevo importantissima, per il modo con cui mi era stata raccomandata da lei la massima sollecitudine. Con questo mezzo, dopo due andate e ritorni della cameriera, potei essere ammesso alla presenza della signora; anzi fu lei stessa che si degnò di venire in anticamera. Consegnai la lettera, ed ella, dopo aver data una scorsa allo scritto, mi disse: – Grazie; sta bene. – Domandai se avesse niente da comandarmi, e mi rispose di no. Mi arrischiai a dirle (scusi se in questo ho arbitrato da me) che avrei trovato il modo di far giungere a V. S. lettere, carte ed altro che mi fosse consegnato; ma ella non mostrò di gradire l'offerta. Avrò fatto male, e gliene chiedo scusa, signor padrone; ma la mia intenzione era di far bene per il suo servizio. Ora, se debbo dirle tutto quello che penso, mi pare che la sua condanna al confine abbia raffreddato molte persone, di quelle che V. S. credeva più amiche, o con le quali andava più spesso. Il conte Nerazzi, per esempio, il marchese Landi, quando ho dato loro un cenno del suo viaggio, mi hanno risposto con un semplice monosillabo. Sarà forse perchè non hanno confidenza in un povero servitore; ma una notizia almeno potevano chiederla e mostrare un po' di amicizia per la sua persona. Oso sperare che in questo Ella non troverà sbagliato il mio umile ragionamento.
«Altro non mi resta a dirle, signor padrone, e mi rincresce davvero di non aver niente di meglio. Il signor conte, suo padre, sta bene al solito; mi ha chiesto fin dove l'avessi accompagnato, e poi mi ha rimandato senza aggiungere altro; ma mi è parso di leggergli negli occhi qualche cosa che il suo cuore di padre non aveva da dire a me, e che Ella, del resto, indovinerà molto bene.
«Mi comandi, signor padrone, che andrò nel fuoco, per poterla servire, e mi creda sempre il suo ubbidientissimo servo
«GIUSEPPE.»
Il conte Gino rimase male, dopo quella lettura. Ahimè l'antidoto sperato! Giuseppe, nella sua piccola diplomazia epistolare, lasciava indovinare assai più che non scrivesse. Ci si vedeva, nel suo racconto minuzioso, la gran dama seccata di dover concedere un'udienza all'inviato di Gino; alle cui notizie, poi, dava tanto poca importanza, da andarle a ricevere in piedi, sull'uscio di un'anticamera. La bionda Polissena si era mutata per lui, come il Landi e il Nerazzi, ricordati in buon punto dallo scrivente, per illuminar la figura della signora marchesa. I tiepidi amici facevano più che un riscontro, davano risalto alla freddezza dell'amica. Già, non era di Gino, la colpa? Che pazzia era stata la sua, di farsi mandare a confine? In quelle sciocchezze del giovanotto la signora marchesa non ci aveva che vedere, non essendosi mai occupata di politica. L'amore, infine, non vuol saperne di quella cattiva compagnia, e un uomo che veramente ami una gran dama non deve compromettersi con quella femminaccia. Neanche lei, la bella e savia marchesa, voleva compromettersi per il conte Gino Malatesti. Che diamine! Con tanti personaggi eminenti, di cui era composta la sua conversazione, magistrati, ufficiali del Duca, nobili ciambellani, signori ammessi a Corte, che si sarebbe detto di lei? E forse per protestare contro simili giudizi, contro simili sospetti, la marchesa Polissena aveva colta a volo la prima occasione, mostrandosi tutta invasata di artistici furori. Poteva credersi dolente per il caso di Gino Malatesti una bella dama che si adoperava tanto per far cantare la celebre Venturoli?
Ah, come vedeva da quelle considerazioni balzar fuori netta e spiccata la figura morale della marchesa Polissena! Furente (sicuro, proprio furente, e mettete pure che quella esagerazione di sentimento non fosse senza una certa dose di voluttà), il conte Gino andò a sedersi davanti alla sua scrivania, e la penna incominciò a scorrere sulla carta. Il giovanotto non scriveva alla marchesa; scriveva a Giuseppe, suo servo fedele, innalzato di punto in bianco al grado di confidente. Anch'egli, senza avvedersene, prendeva le forme del cospiratore, e l'esordio della sua lettera veniva fuori misterioso e guardingo come un coro di congiurati. Per sue ragioni particolari gli premeva assaissimo di conoscere tutti gli andamenti della nota persona. Aveva veduto dalla prima lettera di Giuseppe come egli fosse intelligente; continuasse ad esserlo per utile suo. Da ciò che la nota persona faceva, egli, il conte Gino, avrebbe argomentato quel che pensava, e sugli atti e sui pensieri di quella avrebbe regolato il suo modo di pensare e di operare. La cura amorosa traspariva dalle frasi; ma non era detta apertamente, e questa era già una bella diplomazia. Inoltre, la nota persona poteva anche essere un uomo, e le apparenze erano salvate a buon prezzo.
– Come manderò io questa lettera? – disse Gino, dopo averla suggellata. – Se fosse ancora qui l'applicato! —
Ma l'applicato seguitava il signor commissario sulla via di Fiumalbo, e il conte Gino pensò che il mettersi sulle tracce dei due personaggi, anche col pretesto di mandar notizie a suo padre, non sarebbe stato senza pericolo.
– Ebbene, – ripigliò, – di che cosa m'impensierisco? Non è qui vicina la provvidenza dei Guerri? Aminta, il mio fratello Aminta, ci penserà egli a farla ricapitare. —
Poco dopo la chiusa del soliloquio giungeva Pellegrino. Egli aveva veduto i due signori di Modena discendere dalle Vaie, senza fermarsi, e prendere la via di Fiumalbo.
– Benissimo! – disse il conte. – Allora è tempo di sellare il cavallo. —
Mezz'ora non era passata, e Gino scendeva alle Vaie, con la fretta di un uomo che ha tante notizie da dare di sè, a persone che le udranno con piacere, e non vede l'ora di consolarsi in quella dolce «corrispondenza d'amorosi sensi.»