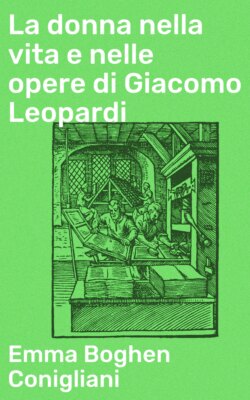Читать книгу La donna nella vita e nelle opere di Giacomo Leopardi - Emma Boghen Conigliani - Страница 7
FERDINANDA LEOPARDI MELCHIORRI.
ОглавлениеIl severo palazzo dei conti Leopardi fu poche volte lieto di così gaie e magnifiche feste come nel 1777; una bimba era nata al conte Giacomo e a la marchesa Virginia Mosca, e con la pompa e lo sfarzo insolito si voleva soprattutto far onor al compare che tenne la piccina a battesimo e da cui ella ebbe il nome, Ferdinando di Borbone duca di Parma, a la corte del quale il marchese Mosca, fratello de la giovane madre, aveva dimorato lungamente.
Dopo Monaldo, il primogenito dei Leopardi, venne al mondo questa piccola Ferdinanda e dopo di lei Vito ed Enea, rimasti tutti in tenerissima età (il maggiore non aveva ancora cinque anni) orfani di padre. Così dopo le feste lietissime suonò sollecita l'ora del lutto per l'antico palazzo, per la giovine signora e pei teneri bambini, fra i quali quella che ne patì di più fu forse la Ferdinanda, intelligente ed affettuosa più che nol comportasse l'età; i ragazzi soffrono spesso ne le avversità quanto non immaginiamo, la loro forza di sentimento pareggia non di rado quella degli adulti, e di più essi non sono abituati a la sventura, la quale li colpisce come qualche cosa di innaturale, di mostruoso.
La contessa Virginia, quantunque vedova assai giovane, non volle rimaritarsi, affezionatissima com'era a' suoi figli; e rimase tutta dedita ad essi e al governo de la casa, retto con generosità, anzi con lusso, per volere dei fratelli del defunto, i quali si attribuivano certi diritti, perchè a lui avevano ceduto gran parte del patrimonio a lo scopo di costituire un maggiorascato. I fanciulli crescevano fra tutti gli agi de la vita, accarezzati da l'indulgenza materna e da quella di parecchi familiari, tra cui il cappellano di casa Don Vincenzo Ferri, bruttissimo uomo da la tinta affricana, con gli occhi di gatto e la bocca larghissima, ma buono quanto brutto, che sapeva con la sua inalterabile piacevolezza rallegrare quei ragazzi ed anche sopportarne, inalterabilmente rassegnato, le non poche impertinenze. Ferdinanda era una affettuosa bambina, e non pure la madre, ma i fratelli l'adoravano, tanto che quando nel 1790, a tredici anni, ella fu posta in monastero a Pesaro, la casa parve rimasta vuota e non poco ci volle prima che la famiglia si abituasse a l'assenza di lei. Monaldo narra di non aver mai versato lagrime più dolenti e più sincere di quelle che gli costò la partenza de la sorellina. Due anni più tardi andò con la madre a trovarla e un altr'anno di poi ella ritornò in casa, e con lei parve tornata la grazia, quasi direi la luce, ne le antiche sale, dove tutti vivevano in mirabile armonia, benchè la famiglia fosse numerosa. Ne facevan parte la madre, il prozio canonico Carlo, i quattro zii Luigi, Pietro, Ettore, Ernesto, e i tre figliuoli Monaldo, Vito e Ferdinanda (Enea era morto bambino), senza dire che in casa e a la stessa mensa stavano pure il precettore Torres, il cappellano Ferri, il pedante Diotallevi, il canonico Pascal, francese emigrato raccolto per carità. Sola giovine donna fra tanti uomini, presso a una madre amorosa, Ferdinanda, vezzeggiata da tutti, cresceva di carattere dolcissimo: ella la confidente de la contessa, per quanto lo permettevano i rigori de l'antico metodo d'educazione; ella l'amica dei fratelli, ella la padroncina venerata.
I suoi studi erano superficiali, elementarissimi; con l'osservazione, la lettura, la riflessione costante però, ella si formò un corredo non meschino d'idee; ma la sua scienza fu soprattutto nel cuore, fu la scienza di amare, di viver per gli altri, di trovare la gioia più cara nel far del bene: e non pure nel compiere veri e propri benefizi, ma ancora nel ridestare un sorriso, nel richiamare un'amabile parola su le labbra di quanti l'avvicinavano, nel godere di veder tutti lieti intorno a sè, anche quando nel suo cuore c'erano de le lagrime e poteva parerle cosa consolante ch'altri piangesse con lei.
Non bella, ma graziosa nel portamento, soave ne lo sguardo pensoso dei miti occhi azzurri, a sedici anni era un delicato fiorellino, cui avrebbe giovato il rimaner ancora sotto la protezione de l'ombra materna: vollero maritarla invece, e Monaldo, da poco messosi a capo de la famiglia, acconsentì di buon grado a darle la dote di otto mila scudi, più di quel che avrebbe potuto. Lo sposo fu il marchese Pietro Melchiorri di Roma,[11] bel nome, onestà perfetta, ingegno non volgare, che si dilettava soprattutto di studi architettonici, ma scarso patrimonio e cuore non in tutto rispondente a quello d'un'appassionata giovinetta sedicenne. La sposa entrò nel 1795 con poco lieti auspici ne la casa maritale, quel palazzo Melchiorri, presso la Minerva, oggi detto de la Palombella e sede di ben nota scuola femminile; vi trovò con la matrigna, nove tra sorelle e fratelli del marito, coi quali la mitezza de la sua indole la fece viver d'accordo, benchè il dissesto economico di quella casa potesse offrire non poche occasioni, o se si vuole pretesti, a la discordia; ma ella ebbe forse a desiderare più d'una volta la pace e le dolcezze de la casa materna.
Si fece una cara abitudine de la lettura, che continuava indefessamente, finchè gli occhi deboli e spesso ammalati glielo permettevano; scriveva con piacere e con facilità lettere, che, se non sono un modello di perfezione letteraria, rispecchiano nitidamente ne la loro sincerità la sua anima gentile; amava anche occuparsi in qualche ricamo od altro lavoro piacevole, il quale lasciasse libertà di meditazione a la mente, che veniva coltivandosi da sè stessa con l'acume naturale.
Le contrarietà e i dolori, l'esperienza de la vita e de gli uomini, lungi da l'affievolire, affinarono la sua tenerezza squisita, che non si smentì mai. Aspetto e modi aveva tutti gai ed affabili, senza affettazione e senza vivacità soverchia; rifuggente dai complimenti e da le espansioni non sincere, era tuttavia graziosa in famiglia, graziosa co' conoscenti e con tutti; non facile a concedere il suo affetto, di cui ella medesima, anche ne la sua modestia, comprendeva il valore, era sdegnosa di volgari amicizie e di sentimenti fiacchi, e, intimamente sola ed appassionata, trovava ne la religione un sollievo; senz'esser punto bigotta, aveva slanci mistici sinceri, cercava ne l'idea de l'infinito e de l'eterno la quiete de l'animo e giungeva così a scordare i suoi dispiaceri col trascurarli e col tenere sempre alto lo spirito.[12]
Certo Ferdinanda ne l'intimo suo dovette combattere dolorose lotte e aver momenti di desolata stanchezza dinanzi a le miserie ed a le ingiustizie del mondo, così diverso dal suo cuore e da' suoi sogni; come una flessibile pianta al soffio del vento si china umilmente, ma ne resta sfrondata, ella piegavasi a le sventure, ma sentiva morire in sè stessa ogni gioia, ogni cara illusione; pur senza consolarsi sapeva rilevar il cuore da l'abattimento per rivolgersi più che devotamente, amorosamente a Dio, baciando la mano che la percuoteva, sentendo con dolcezza sopra di sè la protezione di un padre vigile e amoroso, cui ella chiedeva sommessa un ristoro a' suoi mali, ristoro che attendeva paziente, dicendo a sè stessa come dirà più tardi al suo grande nipote: «È da vile il non saper soffrire.» Così acquistava la pace e una certa indifferenza per le proprie pene, che era tutt'altro che freddezza.
Religiosa fu certo quanto la cognata sua Adelaide Antici Leopardi, ma quale diversità tra la fede rigida, opprimente di questa e la fede tutta d'amore e di carità di quella! Per Adelaide la religione fu spesso un terrore e un tormento, per Ferdinanda sempre un conforto; quella pregava piangendo anche in quei momenti che avrebbero dovuto esser più lieti per lei; questa ritrovava un sorriso ne la preghiera, anche quando il suo cuore era più oppresso; per la prima la fede era un mistero di tenebre, per la seconda un mistero di luce.
La tristezza di Ferdinanda dipendeva certo in buona parte da un'indole per natura disposta a la malinconia e da una finezza di sentire che doveva ad ogni momento esser ferita da le due realtà de l'esistenza. Ella era una vera Leopardi, uno di quegli esseri che pensano troppo ed amano troppo in un mondo dove non soltanto poco si pensa e poco si ama, ma ancora poco si apprezzano il pensiero e l'affetto, creature che di rado trovano fra gli uomini chi le somigli, e vivono perciò quasi estranee fra i loro simili, infelici perchè non possono nè mutare le cose, nè mutare sè stesse, vedendosi negate anche le gioie che godono i volgari, perchè a loro il sogno scolora la realtà. Come, a quanto dicono, Ferdinanda somigliava a Giacomo Leopardi ne le fattezze, negli occhi, nel sorriso, così gli somigliava ne la grande e funesta sensitività. Ma oltre a ciò non fu certo arrisa da la fortuna la sua modesta vita. Non pare che pel marito ella provasse grande trasporto d'affetto, benchè avesse per lui ogni premura e fosse degna di lode come moglie al pari che come donna. Nelle poco liete vicende de la sua nuova famiglia vennero a confortarla i figliuoli; di tre fanno menzione le sue lettere: Nanna, Peppe (quel Giuseppe, che fu illustre archeologo ed intimissimo di Giacomo Leopardi, il quale nel prediligere il figliuolo ricordava forse le tenere premure e la santa amicizia de la madre) e Camillo, divenuto poi benedettino ne la badia di San Pietro in Perugia. D'un altro figlio di lei, Anton Giacomo, fa cenno Monaldo ne le sue memorie: il povero bambino, travagliato da una lunga malattia che l'aveva fatto sottoporre a una cura penosissima, moriva a diciotto mesi il 21 marzo 1803, lasciando afflittissima la madre, che lo aveva assistito con indefessa premura, non staccandosi mai da lui, nè pure per concedersi qualche minuto di riposo, dormendo anzi, o meglio vegliando, ne lo stesso letto col piccolo ammalato. Anche morto, volle tenerlo fin che potè fra le proprie braccia e vestirlo ella stessa.
Monaldo ricorda ancora la malattia orribile di un altro figliuolo di Ferdinanda, che nel 1801 a due anni stava per esserle tolto e che contro ogni speranza improvvisamente risanò, crede il conte, per un miracolo de la Madonna.
Di tutti i figli Ferdinanda fu ugualmente tenera: nel giugno del 1821, sentendo che certi assassini infestavano i dintorni del collegio in cui aveva posto in educazione il suo Camillo, andò in fretta a riprenderlo, benchè probabilmente egli non corresse alcun pericolo.
* * *
Affezionatissima a Monaldo e a la famiglia di lui, essendo nel '19 a Recanati, intuì la grandezza di Giacomo non ancora compresa da nessuno, sentì nel suo cuore la bontà e gli affanni di quel Grande e l'amò con la soavità e l'effusione di tenerezza che nella propria casa egli non aveva conosciuta, nè conobbe mai. Il timido giovanetto che, tranne coi fratelli, parlava pochissimo e quasi per forza, le aperse l'animo suo e la chiamò più che zia, amica. In lui, chiuso in sè talmente da lasciar a pena trasparire un raggio de la sua luce intellettuale, ella apprezzò le maniere correttissime, la dignità di un dolore che doveva attrarre simpaticamente lei così amica de la malinconia e così pietosa; avvicinatasi al nipote sospinta da un affettuoso interesse, riuscì a farlo parlare, ne ammirò i pensieri ed i sentimenti; e finch'ella rimase a Recanati, godette di tenerselo quanto più poteva vicino e d'interrogarlo, sofferse di vederlo penare. Ella non osava ancora dir nulla, ma in cuor suo bramava di consolarlo e di guidarlo con la sua mano affettuosa di donna nel mondo da lui sospirato e in cui egli avrebbe potuto trovare le distrazioni necessarie al suo spirito, troppo assorto in sè stesso e negli studi. Sapendo di poter poco, nulla osava offrirgli che il suo affetto, ma questo caldo, espansivo, tenero, tutto devozione: e quanta gioia per lei nel veder rasserenarsi la fronte del giovanetto, nel vederlo sorridere a' suoi scherzi! Ella pensava già di intromettersi presso Monaldo in favore di Giacomo, pur non avendo la certezza di far cosa gradita a questo, le mancava il coraggio d'iniziare i suoi tentativi. Tornata a Roma, dopo una dimora a Recanati, gli scrive da prima quasi con una certa timidezza, poi sempre con più aperta effusione. Le loro due prime lettere partono contemporaneamente, senza che l'uno sappia de l'altra: il giovinetto ha tanto bisogno di sentirsi amato e la gentile signora gli ha fatto per la prima intravedere le materne dolcezze!... Egli le chiede con abbandono il conforto de le sue parole: ella sarà una de le poche persone cui egli potrà aprire il suo cuore: ed ella risponde lungamente, teneramente, il suo Giacomo troverà il cuor de la zia non tanto dissimile dal proprio e gli dipinge apertamente sè stessa, lo rimprovera con dolcezza per la sua malinconia, lo esorta a non lasciarsi andare a una sensitività senza freno, che lo renderebbe infelicissimo, a uscir di casa, e quando sa che quest'ultimo consiglio è stato ascoltato gli scrive: «In certo modo nella mia solitudine godevo di farvi compagnia, venendo con voi ed accompagnandovi fuori di casa, come se personalmente fossi con voi»; discute con lui di filosofia, quantunque con modestia confessi e si dolga di non aver bastante ingegno per rispondere adeguatamente a le riflessioni di lui; e tuttavia si prova a persuaderlo che la vita non è necessariamente sventura, che l'uomo non è creato per soffrire.... poi ride de la propria gravità: «Giacomo mio, io rido con me stessa, perchè mi pongo a trattare di certa materia che non è da me; ma voi mi siete tanto a cuore che per non sentirvi infelice, divengo filosofo, teologo e tuttociò che a questo scopo può bisognare»; (lettera 2 febbraio 1820) ed egli risponde che le espressioni de la tenerezza di lei, gli parrebbero quasi esagerate, se non conoscesse il cuore da cui partono.
Ferdinanda si duole e si compiace insieme di queste parole; protesta che non sa essere se non sincera, non che talora non debba ella stessa piegarsi a fare qualche complimento; se le convenienze lo esigono, lo fa, ma così di mal grado e con tanta parsimonia che teme sempre di far scorgere quanto questo l'annoi. Invece con le persone che ama e stima non dura alcuna fatica ad essere espansiva: «I miei sentimenti escono dal cuore, vanno alla penna, alla carta, come un vaso d'acqua posto in pendenza versa ciò che contiene entro sè stesso.» (Lettera 8 aprile 1820.) Il suo interesse pel nipote si fa sempre più vivo, ella si strugge di toglierlo da le sue tristezze, vorrebbe giovargli a costo di qualunque sacrificio proprio, si studia intanto di consolarlo, e lo prega, lo scongiura di vincere per amor di lei la sua malinconia, assicurandolo ch'egli ha in sè tutto ciò che può conciliare la stima e l'affetto, benchè egli, affranto dal suo dolore, creda l'opposto. Vuole che si distragga: «Nella natura troverete delle delizie che non troverete mai nel silenzio di una camera,» gli dice e lo esorta a uscire in campagna; chiamandolo col dolce nome di figlio suo gl'impone di non avvilirsi, di non rendersi la vita un tormento; e sempre gli accenna il Cielo come il miglior conforto di chi soffre. Ma ella non tarda ad accorgersi che una consolazione di parole non basta al nipote, e, ardendo d'affetto e di compassione, ella, pur tanto ritrosa ad impicciarsi dei fatti altrui, ella che doveva ben conoscere il carattere autoritario di Monaldo, prega il fratello di mandarle Giacomo a Roma per qualche tempo. Il conte, ostinatissimo in fondo, ma cedevole a l'apparenza, non nega, anzi pare disposto a dare un consenso, che certo non era punto nelle sue intenzioni, se ci vollero ancora due anni per piegarlo a lasciar uscire di Recanati il figliuolo. E Ferdinanda pertinace nel suo zelo non si stanca d'insistere, senza dirne però nulla al nipote pel timore che le alternative di speranza e di dubbio debban troppo tormentare quell'anima agitata e sensitiva; però quando sa che gli son date speranze d'ottenere un impiego a Bologna, gli rivela il suo desiderio e i suoi tentativi: ella vorrebbe che in casa sua egli acquistasse abitudini di società e facesse la conoscenza di persone autorevoli con l'aiuto de le quali egli potrebbe poi trovare un impiego a Roma. Perori egli stesso la sua causa presso il padre, questi non è disamorato, anzi è degno d'affetto, e la sua freddezza apparente dipende tutta dal dispiacere di vedersi escluso da la confidenza dei figli. La donna gentile insiste teneramente perchè quel ghiaccio si fonda, perchè Giacomo parli al padre a cuore aperto: s'egli potrà andare a Roma troverà in lei una madre affettuosa che non lascierà nulla d'intentato per compiacerlo.
Ma mentre Ferdinanda è tutta lieta di questa speranza, un'inaspettata, gravissima sventura viene a colpirla: il 30 novembre 1820 muore la contessa Virginia Mosca-Leopardi, sua madre. Ferdinanda non era punto preparata a questo dolore; solo otto giorni innanzi ella aveva scritto a la contessa, rallegrandosi di sentirla star meglio e compiacendosi de la poca gravità de gl'incomodi che l'affliggevano, facendole coraggio, pregandola d'ascoltar la messa in casa e ad ora tarda, perchè il Signore gradisce il buon cuore e non vuol che si faccia più di quel che le proprie forze permettono. Ferdinanda che quasi in ogni lettera raccomandava premurosamente la madre al nipote, sfoga con lui il suo cordoglio: sofferse tanto a la funesta notizia che credette di dover seguire ne la tomba la sua perduta; la mente non poteva distrarsi dal doloroso ricordo, il cuore non sapeva aver altro desiderio che quello de la diletta defunta, e, pur cercando ne la fede e ne la famiglia la forza per rassegnarsi a quella sciagura, non riusciva a trovarla; le sue intime pene furon tali in realtà che la condussero anzi tempo al sepolcro. Ella medesima, che tante volte aveva scongiurato Giacomo di vincere la tristezza, ora gli scriveva che il proprio dolore, in cui le pareva forse di sentir viva ancora la sua mamma, le riusciva carissimo e che cercava di nasconderlo agli sguardi di tutti, perchè non si tentasse di toglierglielo; unico conforto per lei era quello di non averne nessuno.
La compagnia del fratello Vito e della famiglia di lui, rimasti a Roma per qualche tempo, le diede distrazione, se non sollievo; partiti loro, avrebbe voluto ella pure tornar a Recanati, ma sentiva di non poter reggere ai cari e penosissimi ricordi che là ogni cosa le avrebbe ridestato nell'animo.
Ma il suo era uno di quei cuori che dimenticano le proprie ferite per curare le altrui; e anche ne la dolorosa oppressione del suo spirito, ella trova parole materne per Giacomo e vuol adoperarsi a farlo uscire di Recanati, poichè questo ormai è il supremo desiderio di lui. Pel nipote fa quello che non avrebbe mai fatto per sè stessa, chiede un'udienza al cardinale Segretario di Stato a fine di raccomandargli il grande e infelicissimo giovane, cui ella vorrebbe venisse concesso il posto vacante di professore di latino a la Biblioteca Vaticana. Non si stanca di cercar persone che insistano a favore di lui; le dicono che il Mai potrebbe molto ed ella prega amici e conoscenti che lo dispongano in favore del nipote. Questi le diviene sempre più caro, perchè sempre più ella comprende quanto le somigli nella delicata, profonda sensitività: «Gli animi sensibili si conoscono, s'intendono, si amano.» (Lettera 21 marzo 1821.) Pure la gentile Ferdinanda si duole di questa sensitività, perchè comprende che è causa di intimi strazi, da cui la vita è amareggiata per sempre; consiglia il suo Giacomo a rendersi il cuore più forte, più fermo; forse allora potrà essere meno infelice. «Ma se non l'ottenete.... Ebbene riposate nei cuore vostro, che sarà sempre migliore di quello degli altri; chè rare volte si combinano de' cuori umani sensibili e onesti.»
Le sue premure per la cattedra non riuscirono a nulla, perchè quel posto era già promesso ad altri; così Ferdinanda non ebbe la tanto desiderata gioia d'aversi Giacomo vicino.
Le ultime lettere di lei rivelano una grande stanchezza, un languore invincibile, ma fino l'ultima è ardente d'affetto pur ne le malinconiche parole che si riferiscono ai parenti di Giacomo, i quali si erano mostrati offesi da l'insistenza di lei, che voleva ad ogni costo togliere il nipote a la micidiale tristezza in cui si consumava a Recanati. A questo proposito Teresa Teia Leopardi scrive ne le sue Note biografiche: «La sua tenerezza per Giacomo le fece oltrepassare i limiti di una prudente intervenzione tra lui ed i suoi genitori. Ne so abbastanza su quelle intime scaramucce.» Queste scaramucce accrescevano l'amarezza de la marchesa Melchiorri, che lentamente si avvicinava al sepolcro, rassegnata ai voleri del Cielo, ma col cuore oppresso da mille pene: Monaldo non le rispondeva più, ed ella scriveva al nipote, e furon le ultime parole che gli rivolse: «Mille cose.... a chi poi?... A chi si ricorda di me in casa vostra; vogliamo dire, caro Giacomo, che tu parlerai sempre solo a te stesso di me! Basta. Saluti a tutti.» (Lettera 29 maggio 1822.) Così, ne la sua mortale spossatezza, Ferdinanda si scuoteva per raccogliere le proprie forze nei suoi gentili affetti, e non potendo forse scrivere a lungo, diceva a Giacomo di pensar egli stesso le espressioni de l'amore di lei assicurandolo ch'ella vi consentiva per quanto grandi fossero.
In quell'estate, andando a Nocera pei bagni, da cui sperava poter ritrarre qualche giovamento a la malferma salute, vi moriva senza avere avuto la gioia di riabbracciare il nipote, ch'ella aveva amato come una madre vera; e, ironia de la sorte, nel novembre di quello stesso anno 1822, Giacomo otteneva finalmente di recarsi a Roma con lo zio Antici. Ella, la buona anima gentile, non era più là per accoglierlo e fargli festa, ma dal cielo forse sorrideva al grande spirito di lui che ella, prima fra i parenti, aveva saputo comprendere.[13]