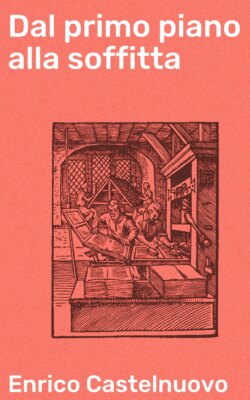Читать книгу Dal primo piano alla soffitta - Enrico Castelnuovo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеIndice
La regata doveva cominciare alle cinque pomeridiane, ma fin dalle quattro il piano nobile del palazzo formicolava di dame e di cavalieri, e il conte Zaccaria col pomposo genero a fianco conduceva in giro per l’appartamento tre o quattro austriaci d’alto affare, duri, impettiti, coperti di decorazioni. Era un bel palazzo davvero quello ch’egli mostrava a’ suoi ospiti, uno di quegli edifizi maestosi e leggiadri ad un tempo di cui gli architetti moderni hanno perduto il segreto. Stile del classicismo avviato alla decadenza, lo dicono le Guide, e ne attribuiscono la costruzione al Sansovino o a uno dei suoi discepoli. Cinquant’anni fa, esso era anche uno dei pochi palazzi veneziani che nell’interno serbassero il carattere primitivo. Dalle travi dello spazioso androne pendevano due grandi fanali che avevano già appartenuto a due galere della Repubblica; il soffitto della lunga sala era adorno di elegantissimi stucchi che incorniciavano degli affreschi non privi di merito; sopra gli usci che nella sala stessa s’aprivano a destra e a sinistra c’erano dei ritratti di famiglia, quali col corno ducale in testa, quali in armatura, quali con la zimarra senatoriale, quali col vestito paonazzo a larghe maniche dei procuratori di San Marco. Altri quadri coprivano le pareti, e fra i molti ce n’erano alcuni realmente pregevoli, un Tintoretto, un Palma giovane, un Paris Bordone. Il salotto di ricevimento, i cui muri erano coperti d’arazzi di Francia, aveva un caminetto di marmo scolpito dal Vittoria, un’antica lumiera di Murano e due bei candelabri di bronzo, che riproducevano in assai minori proporzioni i due famosi della Cappella del Rosario a’ SS. Giovanni e Paolo. Pesanti cortine di damasco rosso, un po’ sfilacciate e sgualcite, moderavano la luce ch’entrava dall’ampie finestre, e la medesima stoffa rivestiva i seggioloni dagli alti schienali intagliati ch’erano disposti in giro simmetricamente e davano alla stanza un aspetto grave e solenne, come se dovesse a ogni momento adunarvisi il Consiglio dei Dieci. Nel salottino attiguo si ammiravano alcuni quadretti del Canaletto e del Longhi e due pastelli di Rosalba Carriera. E qua e là, nell’altre parti del palazzo, erano pure oggetti artistici di pregio, senza contare le argenterie, le maioliche, le porcellane. Si diceva, per esempio, che la collezione di vecchio Sassonia ch’era stata acquistata dal nobil’uomo Cristoforo Bollati durante la sua ambasciata a Vienna fosse la più bella che c’era in Venezia.
Mentre che il conte Zaccaria faceva da cicerone agl’illustri forestieri e il marchese genero gli serviva da interprete, gli altri invitati si pigiavano nel salotto degli arazzi intorno alla languida contessa Chiaretta, o, prudentemente, prendevano il loro posto sul poggiuolo o davanti a qualche finestra per goder meglio dello spettacolo.
Chi ha un po’ l’abitudine della società sa benissimo che in ogni ricevimento, in ogni festa c’è un manipolo di persone alle quali nessuno bada e che i servi stessi dimenticano volontieri nell’andar in giro coi rinfreschi. Sono i parenti poveri, i vecchi conoscenti di famiglia, i maestri dei bimbi, tutta gente a cui s’è detto a bocca stretta:—Se venite ci farete un piacere—lasciando sottintendere un’altra frase—Se non venite, ce ne farete due.
In questa condizione umiliante si trovavano quel giorno il conte Luca e la contessa Zanze Rialdi, cugini dei padroni, relegati insieme con la loro figliuola Fortunata a una finestra di fianco che dava sul rio e dalla quale il Canal Grande si vedeva solo in iscorcio. Nè la finestra era esclusivamente per i Rialdi, chè anzi essi dovevano dividerla con Don Luigi, precettore del contino Leonardo, e con un’altra signora soprannominata la contessa Ficcanaso per la rara abilità con cui essa riusciva a insinuarsi dappertutto e a saper tutti i pettegolezzi della città.
La contessa Zanze e la contessa Ficcanaso si facevano mille moine, ma in fondo non si potevano soffrire. E quel giorno poi a trovarsi appaiato nella stessa mortificazione provavano una stizza grandissima.—Che vogliano levarsi dai piedi la Ficcanaso—pensava la contessa Zanze—questo si capisce, ma un trattamento simile a me, che sono della famiglia!—E l’altra diceva in cuor suo:—Facciano quante asinerie vogliono a una parente povera; chè già quella è una vera mignatta, ma usino i dovuti riguardi a una persona del mio grado.
Malgrado del disprezzo reciproco, è probabile però che le due contesse si sarebbero sfogate a sparlar dei padroni di casa se la presenza di don Luigi non le avesse tenute in riga. E sì che don Luigi della roba sullo stomaco ne aveva anche lui, e aveva una voglia di dirne quattro! Per San Filippo Neri! Un sacerdote par suo, un letterato, il precettore del padroncino, il cappellano della famiglia, cacciarlo in un angolo come se fosse una spazzatura, come se si vergognassero di lui! E si vantavano d’esser gente devota alla Chiesa! Queste cose don Luigi le aveva sulla punta della lingua, ma non le diceva per paura degli altri, e specialmente di quelle femmine chiacchierone. Così, per darsela ad intendere a vicenda, il prete e le due signore andavano a gara nel levare a cielo la bellezza degli addobbi, il buon gusto dei ristauri e lo sfarzo con cui si faceva tutto in casa Bollati, e solo di tratto in tratto si permettevano qualche osservazione a carico dell’una o dell’altra fra le dame raccolte nel geniale ritrovo. Erano allusioni velate, erano suggestioni piene di carità evangelica, erano timidi dubbi seguìti dall’onesta frase: Non bisogna credere alle cattiverie del mondo;—erano lamentazioni generiche sul pervertimento dei costumi e sulle gravi conseguenze della vanità.
Nè il conte Luca, nè Fortunata prendevano parte a siffatte mormorazioni. Il conte Luca non aveva fiele, e per lui, a metterlo in disparte, gli facevano un piacere fiorito, chè alla società egli non si era mai potuto avvezzare, e della Regata non gliene importava un’acca, e sarebbe rimasto ben volentieri a casa sua, davanti alla scacchiera, l’unica passione della sua vita, a studiarvi un problema intorno al quale ammattivano da più giorni gli avventori del caffè alla Vittoria. In quanto a Fortunata, ch’era una ragazzina timida e sbiadita di dodici anni e mezzo, non le veniva neppure in capo di lagnarsi del posto che le avevano assegnato. Di dove era, allungando un po’ il collo, ella vedeva benissimo il Canal Grande, vedeva perfino le signore che si facevano fresco sul poggiuolo d’un palazzo prospettante il palazzo Bollati.
Sotto la sua finestra poi, all’imboccatura del rio, c’era un grosso battello che serviva a sbarrare il passaggio (come s’usa nei giorni di regata), ed era pieno di gente allegra, uomini, donne, fanciulli che ingannavano il tempo mangiando semi di popone e disputando romorosamente intorno all’esito probabile della gara. C’erano due partiti. Gli uni tenevano per Tita Oliva, gli altri, meno numerosi, per quel Nane Sandretti detto Bisatto ch’entrava in regata per la prima volta. Tita, come sappiamo, era il gondoliere di casa Bollati, e quando lo si nominava, tutti gli occhi si alzavano verso la finestra a cui era affacciata la ragazza Rialdi.
Il cuore di Fortunata batteva anch’esso per Tita, ch’era sempre gentile con lei e che la chiamava padroncina. Nel venir a palazzo essa lo aveva incontrato per istrada già vestito da regatante, con la sua fascia rossa intorno alla vita, l’aveva incontrato insieme con tre o quattro altri compari, ed egli aveva salutato rispettosamente lei, il conte Luca e la contessa Chiaretta, e aveva detto:—Adesso si va col gondolino ai Giardini, e speriamo bene.
Come la Fortunata gli augurava il trionfo! Come si sentiva inclinata verso quelli che parteggiavano per lui, come l’indispettivano i fautori di quel Nane Bisatto che aveva la petulanza di venir a lottare coi provetti!
Un fremito di voci umane, un rumore crescente di applausi annunziò l’avvicinarsi delle gondole di Corte, le quali, precedute e seguìte dalle bissone, facevano il giro del Canal Grande prima che i gondolini della regata si mettessero in moto. Il corteggio passò e ripassò come un lampo davanti al palazzo Bollati, dove le signore sventolavano i fazzoletti e gli uomini gridavano con quanto fiato avevano in corpo: Viva l’Imperatore, viva l’Imperatrice! È utile rammentare a questo proposito che, quantunque anche in quel tempo vi fossero in Venezia uomini gagliardi e generosi pronti a versare il loro sangue per l’indipendenza della patria, e non mancassero gli affigliati alla Giovine Italia, la grande maggioranza della popolazione accettava rassegnata il dominio austriaco e applaudiva i Sovrani col solito entusiasmo della folla per tutto ciò che brilla ed abbaglia.
—Viva, viva!—strillava Fortunata con la sua vocina. E continuava, rossa dall’emozione:—Ah, ecco l’Uscocca, ecco l’Uscocca.... Mamma, babbo, presto, guardate Leonardo.... Come sta bene!
In ginocchio sulla prora della sua svelta ed elegante bissona, sotto un baldacchino tutto veli e frangie inargentate, il contino Bollati animava i rematori col gesto e con la voce, e pareva un antenato di sè medesimo alla battaglia di Lepanto.
—Ah!—seguitava la fanciulla in preda a un nuovo parossismo d’ammirazione.—E quella è la lancia del collegio di marina... ci dev’esser Gasparo lì dentro... sì, sì... eccolo là.... Babbo, mamma... non lo vedete?... È lui che governa il timone....
—Sì, sì, cara—rispondevano i genitori—non spingerti tanto fuori dal davanzale.
Gasparo era il fratello maggiore di Fortunata, allievo dell’Accademia di marina, e prossimo a uscirne cadetto.
La fulgida visione disparve, e di lì a poco s’intese il cannone che annunziava la partenza dei regatanti dalla punta dei Giardini pubblici. Un lungo mormorio corse attraverso la folla accalcata sulle due rive del Canalazzo; poi si fece uno di quei silenzi solenni in cui si sente palpitare il cuore d’un popolo. Oggi scaduta dalla sua importanza, la regata era fino a trent’anni fa lo spettacolo favorito dei Veneziani. A ogni modo, essa era ed è sempre lo spettacolo popolare per eccellenza. La lotta dei gladiatori in Roma antica, la corsa dei tori in Ispagna trovano forse una maggior partecipazione in tutte le classi sociali, ma nessuna festa scuote più vivamente le fibre della moltitudine. Quanto tempo prima se ne discorre nei traghetti, per le osterie, nelle case, nei trivii, quanto tempo dopo si continua a parlarne! E il giorno della prova, mezza Venezia si spopola per riversarsi sull’altra metà. La gente s’insacca nelle barche, nelle peate, nei battelli d’ogni forma e misura, fa ressa sulle fondamenta, paga volentieri qualche soldo per assicurarsi una seggiola o un posto sopra qualche panca, o s’arrampica sugli sporti delle fabbriche, sull’inferriate delle case, sui piedestalli dei candelabri, o s’addensa dietro le spallette del ponte di Rialto, la cui mole maestosa e severa sembra acquistare il moto e la vita a quell’ondeggiamento di teste. E in quel giorno più che mai il popolo è superbo della sua Venezia, e s’inebbria in quel tripudio di colori e di luce onde ogni cosa s’anima e si trasfigura, dal freddo marmo dei palazzi gotici, arabi, lombardeschi, barocchi, alle carni pastose e alle fulve o brune chiome delle donne e delle fanciulle.
Ma ecco nuovamente venir di lontano un rumore che somiglia al muggito del mare, ecco una viva ansietà dipingersi nei volti, ecco tutti gli sguardi tendere a un punto.
—Son vicini...
—Son qui...
—Chi è il primo?
—Non si capisce.... C’è il sole che confonde la vista.
Il conte Zaccaria, gonfio e pettoruto pel bel successo della sua Uscocca, aveva annunziato come cosa sicura a’ suoi ospiti che il primo sarebbe stato il gondolino rosso N. 6 a poppa del quale vogava il suo Tita Oliva. Ma, ohimè, il gondolino N. 6 non era che il secondo, e anche questo secondo posto gli era fieramente contrastato dal gondolino viola N. 4; l’uno e l’altro poi erano preceduti d’un buon tratto dal gondolino celeste N. 8, su cui si trovava il formidabile Nane Bisatto. I gondolini 5 e 7 si disputavano il quarto premio, gli altri, ormai disperati di riuscire, venivano dietro lentamente a grande distanza.
—Non è deciso nulla—disse il conte Zaccaria facendo di tutto per nascondere il proprio dispetto.—Riderà bene chi riderà ultimo.
Infatti i gondolini dovevano ancora giungere al punto estremo del Canal Grande, a Santa Chiara, poi girare intorno a un palo che qui chiamano il paletto, e rifare una gran parte del cammino fin presso l’imboccatura del rio Foscari, ove sorge la cosidetta Macchina, ch’è una elegante baracca di legno improvvisata sull’acqua e segna la meta ultima della corsa. In tal maniera, da tutti i palazzi che stanno tra il rio Foscari e Santa Chiara, i regatanti si vedono due volte, cioè all’andata e al ritorno. E realmente il ritorno può serbare non piccole sorprese, e tale che chi era primo diventa secondo, e tal altro che pareva ormai fuori d’ogni speranza accenna a conquistarsi valorosamente la sua bandiera. Ma questa volta gl’intenditori dicevano chiaro e tondo che a Nane Bisatto il primo premio non lo portava via neppure il Padre Eterno, giacchè c’era troppa distanza tra lui e il gondolino di Tita Oliva, ed era già molto se quest’ultimo poteva mantenersi il secondo e non esser sorpassato dal gondolino N. 4, quello dove c’era Menico Fichetti da Pellestrina, un giovine piccolo e sottile, ma che aveva nervi d’acciaio.
Questi discorsi si tenevano anche nel barcone ch’era fermo all’imboccatura del rio sotto il palazzo, e Fortunata che aveva preso tanto a cuore la causa di Tita, si metteva nei panni di lui e aveva una gran voglia di piangere.
La contessa Zanze, la contessa Ficcanaso e don Luigi erano in disposizione d’animo affatto diverse, e, poichè il fiasco del barcajolo veniva a ricader sui padroni, ne provavano una segreta esultanza, che non esprimevano apertamente, ma che lasciavano trapelare. Don Luigi faceva delle riflessioni filosofiche sulla caducità delle cose umane, sullo sperpero del danaro pubblico e privato in feste e in bagordi e sul poco giudizio che c’era a distrarre i ragazzi dagli studi per farli andare sulle bissone.... Con quella voglia che avevano di studiare! Le due contesse assentivano appieno alle savie parole del sacerdote, tanto più che il servo aveva presentato loro il vassoio dei dolci quando tutti s’erano già preso il buono e il meglio, e ciò le aveva esacerbate fuor di misura.
Ma il dialogo fu troncato dal riapparire dei regatanti. Ora, la finestra sul rio guardava precisamente verso la parte dalla quale i gondolini tornavano, e Fortunata vide ben presto che il viola continuava ad essere il primo e aveva aumentato anzichè diminuito l’intervallo che lo separava dagli altri. Il valore di Nane Bisatto aveva finito ormai col trascinare i più restii, e, con una volubilità che afflisse e irritò Fortunata, parecchi tra i fautori del suo protetto si unirono anch’essi a quelli che applaudivano l’eroe della giornata. Ma quel che è peggio, il gondolino rosso non era più nemmeno il secondo, non era nemmeno il terzo; era il quarto, quello a cui era destinato l’ultimo, premio, la bandiera gialla e il relativo porcellino, quasi un’onta per Tita, avvezzo ai primi trionfi. Povero Tita! Egli non osava alzar la testa, vogava per l’onor delle armi, ma avrebbe preferito esser sott’acqua lui e il suo gondolino, piuttosto che sentire tutti quegli sguardi fissi sopra di sè, piuttosto che passar davanti al palazzo dove c’erano i padroni e tanti ospiti d’alto affare. Tita non si ricordava in quel momento di Fortunata, oppure ell’era la sola che, pensando alla sua umiliazione, aveva gli occhi pieni di lagrime. I padroni invece erano irritatissimi, dicevano che Tita non era più buono a nulla, e che aveva compromesso il decoro della casa, e che meritava d’essere strapazzato senza misericordia.
Questo incidente fece sì che in palazzo Bollati si gustasse meno l’ultima parte, pur così bella, dello spettacolo, quando cioè tutte le barche prima raccolte, ristrette ai due lati del Canal grande, pigliano il largo e formano un suolo galleggiante che copre e nasconde la superficie dell’acqua. È per solito l’ora del tramonto, e gli ultimi raggi del sole scintillano sui ferri bruniti delle gondole, sfolgorano con bagliori d’incendio sui vetri delle finestre, danno risalto alle dorature e alle stoffe colorate delle bissone, alle livree dei gondolieri, agli abbigliamenti delle signore, alle vesti chiassose delle popolane. Ed è un suono di musiche allegre, un vociare confuso, uno strepito di remi che si urtano, di ferri che cozzano, di carene che scricchiolano. Indi cala lento lento il crepuscolo, la folla si disperde, il rumore a poco a poco svanisce, e il Canalazzo ritorna nell’usato silenzio.
Frattanto, giù nell’entratura di Cà Bollati, Tita sedeva accasciato sopra una panca, e non sapeva risolversi a salir dalle loro Eccellenze dopo lo smacco subìto. Parecchi amici e compari gli facevano corona e si sforzavano di calmar la sua agitazione e di persuaderlo a presentarsi ai padroni con la faccia franca, chè già non l’avrebbero mica mangiato vivo seppure una volta la fortuna gli era stata contraria. In quel gruppo di confortatori c’erano anche alcune donnette, una sua sorella tra l’altre, bel tipo di veneziana da Cannareggio, con certi occhi neri e lucenti come due carboni e con una parlantina inesauribile.
—Oh, corpo de diana—ella diceva al fratello—vorrei anche vedere che ti trattassero con mala grazia. Io risponderei: Lustrissimi, credono che a vogare in regata sia lo stesso che a starsene lunghi distesi con la pancia in giù sui cuscini d’una bissona?... Eh, non ho peli sulla lingua io....
Tita s’impazientiva.—I rimproveri dei padroni sono il meno... È l’amor proprio.
—To’, non la può mica andar sempre bene... Una volta corre il cane e l’altra il lepre... È stato così dacchè mondo è mondo.
—Siora Cate ha ragione—soggiungeva un vecchio gastaldo d’un traghetto vicino, persona assai autorevole—non c’è ragione di tribolarsi... E lascialo dire a chi se ne intende... Bisatto non è degno d’allacciarti le scarpe... E se ha vinto oggi, a rivederci domani.
—È stato quel colpo di vento alla Punta della Salute—ripigliò un altro.—C’ero io, c’ero. Bisatto l’ha sentito meno perchè il suo gondolino si trovava più a destra.
Ma Tita non voleva esser consolato e andava in escandescenze, soprattutto quando la sua umiliazione gli era rammentata dai guaiti del porcellino che giaceva in un angolo, più morto che vivo.
—Povera bestia!—esclamò la Cate, chinandosi sull’infelice animale in atteggiamento di suora di carità.—Come se ne avesse colpa!... È tutto ammaccato... Che ragione c’era di pigliarlo a calci? Che se poi crepa di bile, non è più buono da mangiare.
—È vero—notò gravemente un nuovo personaggio comparso in quel punto. Era il signor Oreste, il cuoco, in abito da signore, col metternicche in testa, una collana d’oro al collo e uno spillone di diamanti sulla camicia.—È vero—egli riprese dopo una pausa. E inventandosi apposta un proverbio per l’occasione continuò:—Bestia ben trattata buona in pignatta.... E questa qui non ha bisogno d’altre disgrazie.... Conviene ingrassarla per una settimana, e poi si potrà farne uno stufatino con la salsa piccante....
—Ma che stufatino!... Ma che salsa piccante!—interruppe la Cate.—Meglio arrosto.
—Scusi, siora Cate, è troppo piccolo.
—Alla malora il porco e i suoi protettori—urlò Tita in una recrudescenza di furore.—Ch’io possa morire d’un accidente se di quel porco lì ne assaggio un boccone.... L’avevo detto al mio compagno che se lo tenesse tutto per lui.
Ma la sorella, ch’era una giovane savia e positiva, protestò contro quest’idea bislacca.—Neanche per sogno.... Quello ch’è giustizia.... Ciascuno la sua parte.
—Belle parti che si faranno—disse il signor Oreste con piglio sprezzante, accennando alla piccolezza dell’animale.
—O che non potrebbe attendere alle sue casseruole, sior piavolo?—rimbeccò la Cate, che non poteva soffrire il cuoco, il quale un giorno aveva voluto mettere a troppo caro prezzo un piatto di polpette ch’egli le aveva regalate.
—Ehi, ehi, la mia tosa, che fumi vi montano alla testa?
—Zitto—sussurrò qualcheduno—che c’è sior Bortolo.
Infatti, l’agente generale discendeva dalla scaletta del mezzà in compagnia d’un signore dai baffi grigi che faceva il sensale di mutui e godeva di una mediocre riputazione.
—Siamo intesi, caro Bellani... Combinando l’affare l’un per cento a me....
In quel punto la porta della scala di servizio si aprì con violenza, e un cameriere in livrea gridò tutto trafelato.—Che qualcheduno vada subito in farmacia a cercare un medico.... Dal dottor Zuliari andrò io... È venuto un deliquio a Sua Eccellenza Leonardo.