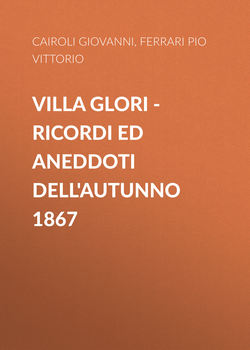Читать книгу Villa Glori – Ricordi ed aneddoti dell'autunno 1867 - Ferrari Pio Vittorio - Страница 7
V.
Sempre in casa Giovanelli
ОглавлениеIl vicolo dei Quattro Cantoni era però un posto tutt'altro che sicuro per noi, perchè guardato dalla polizia. Infatti allo stesso pianerottolo dove noi abitavamo, anzi di fronte alla nostra porta, dimorava un precettato o, come oggi direbbesi, un ammonito. La notte, all'avemaria, doveva trovarsi in casa ed i gendarmi venivano ogni tanto a verificare.
Bisogna credere che il Comitato ignorasse affatto questa circostanza, perchè altrimenti non avrebbe in alcun modo scusa per averci posti così in bocca al lupo. Noi stessi l'ignorammo per più giorni. Il Giovanelli non ce ne disse nulla ed anzi era fiero di poterci presentare quell'accanito. Ci fece scoprire la cosa un altro fatto che ora narrerò.
Al piano terra della nostra casa abitava un tale di cui non ricordo nome e condizione, ma che dal vestito che indossava, pantaloni larghi alla francese ed una grande papalina rossa in testa, era dai vicini denominato il Turco.
Come precisamente la pensasse costui non si sapeva; però dovea di certo essere uomo gioviale, perchè una bella sera gli venne il ticchio di voler dare una festa da ballo. Non saprei ricordare quali fossero gli invitati; bensì ricordo che l'orchestra era costituita da un'armonica e dalla chitarra di Pietruccio come accompagnamento.
Quando il Turco venne a fare li patti con Pietruccio, ci si mise di mezzo il Giovanelli e sembrandogli che una tal festa potesse tornar pericolosa per noi, tentò di dissuaderlo. Fu come buttar olio sul fuoco. Il Turco fu irremovibile non solo, ma anzi dichiarò che il motivo per cui dava la festa era nè più nè meno perchè… eravamo alla vigilia di grandi avvenimenti.
La festa ebbe luogo e per tutta quella notte non potemmo dormire. A parte lo strepito ed il baccano indiavolato che facean ballando con salti interpolati ad urli sì da sembrare una vera ridda infernale, noi si stava in grandi angustie per timore che quello strepito attirasse la polizia e che essa venisse, come difatti venne, a dare una capatina al secondo piano dall'amico precettato che ci abitava di fronte. Infatti, poco oltre la mezzanotte, si udirono dei passi sulle scale e si sentì pure lo strisciar d'una sciabola contro la nostra porta. Noi balzammo tutti di letto e ci buttammo nella camera delle donne, che erano scese alla festa. Afferrate le lenzuola, cominciammo febbrilmente ad annodarle fra loro per calare da una finestra e in pari tempo al Giovanelli si diede consegna, se bussassero, d'aprire il più tardi possibile, fingendo d'essere addormentato e di doversi vestire. Intanto chi radunava i vestiti, chi ricomponeva i letti, altri nascondeva biancheria, altri caricava una rivoltella.
Fortunatamente non ne fu nulla. Cinque minuti dopo il Giovanelli ci avvisò che i gendarmi ridiscendevano le scale, com'eran venuti e noi respirammo.
Di cotali scene ne accadevano spessissime fra i reclusi di quei giorni. In casa di certa madama Petrarca, ove la polizia andò a fare una perquisizione, alcuni amici che vi si trovavano, riuscirono a fuggire da una finestra, dimenticando nella stanza tutti i cappelli.
L'on. Cucchi, capo della cospirazione d'allora, credo che di simili episodi potrebbe narrarne un volume e riuscirebbe certo interessantissimo.
I giorni scorrevano così fra una emozione ed una risata. I compagni e gli amici che ci venivano a visitare, aumentavano di giorno in giorno. I futuri rivoluzionari e i capisquadra facean capo a noi per sapere notizie, e noi ne sapevamo assai meno di loro. Si inquietavano tutti per questa incertezza, per questi ritardi, e noi si cercava di tenerli buoni con bicchierate e con sigari. Questo sistema però, oltre ch'essere pericoloso con simil gente, la quale facilmente trasmoda e trasmodando chiacchiera6, aveva finito anche col diventare rovinoso per le nostre finanze. Ogni giorno si facevano i conti di cassa; ma se il mangiare fra noi in comune poteva essere economia, non lo erano di certo il raddoppio di spesa portato dalla famiglia dell'ospite nostro e la gazzarra in permanenza a beneficio degli amici e dei patriotti nostri visitatori.
S'aggiunga che la speranza di prossimi movimenti si dileguava ogni giorno più e che le discussioni sulla popolazione più o meno preparata, sulle armi pronte facevansi ognor più vive.
Un giorno Augusto, quasi a riprova che di armi ce n'era in abbondanza, ci raccontava come egli spessissimo passava il Tevere a Ripetta su d'una barca, nella quale a prua stavano nascosti quattro fucili due sciabole e tre pistole. E ci narrava la cosa con tale serietà che sembrava ne volesse inferire che in ogni barca del Tevere vi fossero armi e che se l'armi c'erano perfin nelle barche, immaginarsi nelle case!
Ma invece pur troppo la bisogna camminava ben altrimenti; e fu appunto in quei giorni che il povero Enrico, trovandosi in seno al Comitato, presenti il Cucchi e gli altri capi e discutendosi delle armi disponibili, si sentì dire che c'era in pronto qualche centinaio di picche!
– Che diamine! esclamò egli esasperato, volete prendere Roma a suon di picche? perchè non la prenderemo allora colle vanghe o colle zappe? E fu da quell'istante che nel Cairoli surse l'idea d'importare le armi dal di fuori mediante apposita spedizione, che fu appunto la nostra.
A questa dolorosa realtà, che cioè in Roma non c'era nulla e che le armi furono poi portate più tardi, ma pur troppo non arrivarono in tempo, non posso trattenermi dal contrapporre le notizie che in proposito fornisce la Civiltà Cattolica nel suo lepido scritto intitolato I crociati di S. Pietro (anno 1867, Vol. 6, 7, 8, 9, serie VII): «D'armi, traendone ragguaglio anche solo da quelle che vennero a mani del Governo Pontificio, si aveva il sufficiente: pistole, rivoltelle, specialmente della fabbrica di Brescia e ad uso della cavalleria (!), boccacci da masnadieri, rompicapi da cannibali, lame, coltelli a serramanico, stiletti, accette in gran numero e copia altresì di ordegni da scassinar porte. Di bombe orsiniane si possedevano veri monti: solo quelle destinate all'assalto del casino militare a detta d'un sicario erano trecentosessantaquattro.
«L'arma prescelta per la pugna notturna era una scure in asta a due fendenti con in capo un pernio e un dente a molla onde infiggervi una lunga lama di pugnale. Ne furono rinvenute presso a un migliaio (forse eran queste le famose picche)».
Più sotto soggiunge che tali armi si fabbricavano in Orvieto e ricordarsi anche il nome dell'infame artefice. E più sotto ancora: «il principal deposito di 600 scuri e 750 pugnali si rinvenne in via San Giovanni de' fiorentini, ove credesi approdassero opportunamente pel Tevere. Oltre a ciò sull'ultimo il Cucchi ottenne dal governo italiano un bell'ottocento fucili militari con baionetta, che dalla Spezia partirono sopra una tartana, ecc. ecc.»
Questo scritto mi fa sovvenire d'un progetto ventilatosi in quei dì tra i capi dell'insurrezione e poscia scartato.
Nel palazzo Wedekind in Piazza Colonna, ove ora ha sede l'Associazione della Stampa e un tempo c'erano gli uffici della Posta, avea allora stanza il Casino militare frequentato, specialmente la sera, dall'alta ufficialità dell'esercito pontificio. S'era progettato di tentare un colpo di mano su quel posto, impadronirsi d'un tratto dei capi del presidio, rizzare simultaneamente le barricate gettando lo scompiglio nella truppa che, priva o decimata de' suoi capi, male avrebbe potuto reprimere la rivolta.
Non ricordo il motivo per cui fu abbandonato un tal progetto. Probabilmente sarà stata la mancanza di mezzi e più specialmente delle armi e delle trecentosessantaquattro bombe sognate dalla Civiltà Cattolica e dal suo sicario. Certo che se lo si fosse tentato, non poteva riuscire che ad una inutile carneficina.
Il numero dei cospiratori in città andava intanto ogni giorno aumentando, ma pur troppo continuavano a difettare pur anco i mezzi.
Un giorno l'amico Cella, il valoroso e gentile eroe del Caffaro, venne a trovarci e ci portò un altro suo amico e prode compagno d'armi della gloriosa schiera dei Mille. Era certo Erter di Venezia, che aveva avuto il suo battesimo di fuoco a Palermo lanciandosi all'assalto d'un pezzo d'artiglieria che molestava i nostri.
Si trovava in Roma da parecchi giorni ed era rimasto senza quattrini. Ricorse all'amico Cella e questi, trovandosi in condizioni poco dissimili, lo condusse a noi perchè lo invitassimo a desinare. Fu ricevuto a braccia aperte e così i nostri luculliani desinari furono onorati della presenza d'un duodecimo commensale.
Questo nuovo amico suonava pur esso la chitarra e cantava; non era però all'altezza di Pietruccio.
Ci si intratteneva pure assai volentieri colle due figlie del Giovanelli, due buone ragazze (ora saranno matrone!) e tanto simpatiche. Si chiamavano Ghitina e Ginevra.
La Ghitina, la sposa, ricordo che aveva un suo topolino bianco, cui prodigava molte cure ed affetto. Quella bestiolina alla sera specialmente formava il nostro spasso. Era domestica oltremodo, correva a prendere il cibo in mano e saliva dalle braccia sul collo e sulla testa della sua padroncina.
Un giorno essa lo mise in camera sotto un cuscinetto ch'era su d'una sedia. Il topolino s'addormentò per davvero e la Chitina dimenticò d'avercelo collocato. Un'ora dopo, distratta e senza avvedersene, si mise a sedere su quel cuscino. Povera Ghitina! chi può ridire il suo dolore quando lo rinvenne soffocato? i suoi occhioni ridenti si sciolsero in grosse lagrime. L'aveva proprio ucciso lei, e con quale arma!
Le distrette finanziarie crescendo ad ogni istante, fu stabilito di comune accordo che qualcuno di noi si recasse dal Cucchi a rappresentargli i nostri bisogni. Fu mandato infatti uno dei nostri assieme ad alcuno degli amici dell'Hôtel di Roma, che trovavansi in condizioni ancor peggiori delle nostre, avendo all'albergo un conto arretrato di parecchi giorni da saldare.
Stava in quel momento il Cucchi discutendo con parecchi amici. Udito il motivo della visita dei nostri, domandò qual somma occorrerebbe loro per il tempo ancor probabile di permanenza in Roma e per saldare il debito di tutti cotesti (come chiamarli altrimenti?) spiantati. Gli fu risposto che occorrevano per lo meno mille e cinquecento lire.
Il Cucchi arretrò sbigottito, ed uno dei presenti uscì in questa esclamazione:
– Mille e cinquecento lire! ma non sapete che se avessimo una tal somma compreremmo tante armi?
Questa risposta fu per noi una rivelazione.
Io che nella nostra compagnia avrei dovuto essere il più ardente, giusta l'opinione dell'Andreuzzi, se prima ero sfiduciato, a quest'uscita rimasi addirittura avvilito. Come, esclamai fra me, non si hanno nemmeno mille e cinquecento lire disponibili e si pretende di fare una rivoluzione? una rivoluzione per la quale occorrono dei milioni e non delle migliaia di lire?..
Invano l'Andreuzzi tentava persuadermi. Non ne volevo sapere. D'altro canto si parlava giorno per giorno di Menotti Garibaldi che si avanzava ed era già entrato nel confine pontificio; le sue bande ingrossavano ed era imminente un fatto d'arme. Essendo discordi i pareri, fu deciso che ognuno riprendesse la sua libertà d'azione. Vincoli non ne avevamo. Eravamo partiti ad un unico scopo: la rivendicazione di Roma.
A me ed al compagno mio parve che questa, coi mezzi che s'avevano alla mano, fosse addirittura un'ubbia. D'altro canto in campagna già i nostri fratelli marciavano; era imminente il momento di menare un po' le mani, e senz'altro decidemmo la nostra partenza.
Infatti la sera di quello stesso giorno prendemmo il diretto per Terni.
Gli altri amici rimasero in Roma; non ricordo di quali mezzi siano stati soccorsi o se sieno riusciti ad averne da casa. Essi furono il nucleo degli assalitori di Porta San Paolo e si trovarono poscia con gli altri al loro posto a Mentana. Alcuni di loro vi rimasero anzi prigionieri.
All'atto del partire da Roma la polizia ritirava i passaporti dei forestieri per restituirli poi a Passo Corese. Già accennai che il mio compagno Muratti aveva il passaporto di un suo amico, il conte Giovanni Colloredo di Udine. Quando fummo a Corese, un commissario fece la chiama per la consegna dei passaporti; arrivato al nome di Colloredo, non gli venne risposto da alcuno, perchè Muratti in quell'istante stava occupato a rassettare il suo bagaglio e nella distrazione del momento aveva dimenticato il suo nuovo casato.
– Colloredo! – chiamò di nuovo più ad alta voce il commissario, mentre io schiacciavo il piede e davo del gomito all'amico per richiamarlo:
– Conte Giovanni Colloredo! – chiamò per la terza volta ed a chiara voce il commissario.
– Eccolo! – rispose tosto rinfrancato il Muratti scrollando la testa con lieve sorriso sardonico che pareva dicesse: Chiami le persone coi loro dovuti titoli ed allora risponderanno.
Il commissario capì il latino, si fe' rosso un pochino, levò il berretto ossequioso e consegnandogli il recapito mormorò:
– Scusi tanto!
Così partiamo trionfanti.
6
Una sera venne fatta dal Comitato certa distribuzione di denaro. Era giorno di festa, e i quattrini ben si può arguire come furono adoperati. Tanto bastò perchè a tarda ora la città fosse percorsa da numerose pattuglie a cavallo!