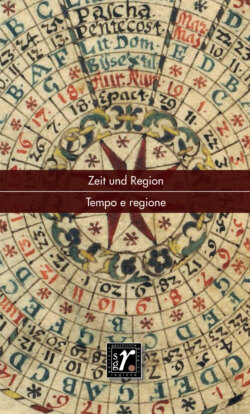Читать книгу Geschichte und Region/Storia e regione 29/2 (2020) - Группа авторов - Страница 8
Beneficium, precaria e paradossi antropologici
ОглавлениеIl tema del beneficium è stato a lungo concepito all’interno del discorso sul feudalesimo, al centro negli ultimi decenni di importanti rivisitazioni sfociate nell’acceso dibattito suscitato dalla pubblicazione, nel 1994, di Fiefs and Vassals di Susan Reynolds.10 Tale opera in un certo senso costituisce una sorta di spartiacque, conducendo a una periodizzazione relativa allo stesso dibattito storiografico con un prima e un dopo Reynolds.11 Il principale obiettivo polemico della storica inglese era il feudalesimo nella sua accezione storico-giuridica così come era stato elaborato in particolare dallo storico belga François Louis Ganshof e ritenuto dalla studiosa il più pericoloso poiché si presentava apparentemente come il più oggettivo. Il feudalesimo ganshofiano, infatti, avrebbe fornito una sorta di lente protettiva, degli occhiali da sole attraverso i quali si sarebbero potute osservare le stranezze e le varietà delle creature medievali.12 Tali occhiali avrebbero consentito agli storici di vedere uniformata una realtà che tuttavia uniforme non era, e dunque per tale motivo la studiosa propose di abbandonare i modelli generali come il concetto di feudalesimo estraneo a suo dire alla realtà indagata ed elaborato solo successivamente. In tale prospettiva gli stessi termini vassallo e vassallaggio avrebbero agito come dei buchi neri concettuali capaci di risucchiare ogni interpretazione storica che si fosse imbattuta in loro.13 L’impeto demolitorio di Susan Reynolds non ha tuttavia prodotto un modello alternativo che riuscisse a emergere dalle macerie del precedente edificio costruito a suo tempo da Ganshof, ma ha avuto il merito di infrangere o quanto meno incrinare molti schemi mentali consolidati. Fiefs and Vassals, come già accennato, ha portato infatti a un intenso dibattito tra gli studiosi, riaccendendo il loro interesse nei confronti dei Libri feudorum e verso la comparsa nel secolo XII di un diritto feudale in forma scritta, e ha proposto al tempo stesso prospettive di studio nuove sulle forme di proprietà e di possesso nell’alto medioevo.
Se il dibattito successivo alla pubblicazione dell’opera si è concentrato prevalentemente sul ruolo giocato dai Libri feudorum nell’elaborazione del feudalesimo, meno risalto hanno avuto tuttavia le pur importanti riflessioni della studiosa in merito al beneficium e le critiche da lei rivolte alla tradizionale lettura di tale particolare concessione come forma di compensazione militare. La concessione beneficiaria, infatti, vista per lungo tempo come asse portante del rapporto vassallatico-beneficiario, a seguito della radicale critica mossa da Reynolds al concetto stesso di feudalesimo e alla proposta di una diversa scansione temporale del fenomeno ha subito una sorta di messa al bando nelle indagini storiche sull’alto medioevo, specie per quanto riguarda la storiografia italiana. In Italia, dove immediato era stato l’interesse per il modello di feudalesimo proposto dallo storico belga senza per questo comportare una sua accettazione automatica, diversi studiosi si erano d’altra parte occupati anche del beneficium offrendo importanti contributi, pur rimanendo sostanzialmente legati a un’interpretazione dello strumento beneficiario in chiave storicogiuridica.14 Di grande rilievo sono in particolare le considerazioni avanzate da Piero Brancoli Busdraghi che, sebbene adottasse nella sua indagine una prospettiva retroattiva prendendo le mosse dal cosiddetto Edictum de beneficiis emanato da Corrado II nel 1037, pose in evidenza il prevalente carattere orale della concessione beneficiaria e la sua applicazione in ambiti molto diversi e non limitati unicamente a quello militare.15 Quest’ultima osservazione, tuttavia, non sembra essere stata recepita dalla storiografia che ha continuato a leggere nel beneficio sostanzialmente uno stipendio per le prestazioni militari.16
Negli ultimi decenni, d’altra parte, gli studiosi italiani si sono concentrati prevalentemente sulle dinamiche successive al Mille, con particolare riferimento alla signoria rurale, tralasciando dunque ampiamente l’alto medioevo.17 Nel corso dei secoli altomedievali, tuttavia, l’uso del beneficium è relativamente ben attestato anche nel regno italico e si configura come uno strumento che solitamente si muove nella sfera dell’oralità e che solo raramente viene consacrato dalla parola scritta; ciò rende dunque particolarmente preziose le fonti che ne parlano sia che rievochino precedenti concessioni in beneficio sia che facciano riferimento a concessioni accompagnate dalla redazione della fonte stessa. Il beneficium nella sua accezione giuridica compare, del resto, già nella tarda antichità all’interno del Codex Theodosianus, la raccolta di leggi imperiali a partire dal regno di Costantino I voluta dall’imperatore Teodosio II. Il termine, tuttavia, non presentava un significato univoco, venendo impiegato per indicare gli atti dell’autorità pubblica, specie di quella imperiale, che costituivano un vantaggio per un singolo individuo o per un gruppo. Così beneficia potevano essere le concessioni di terre che l’imperatore faceva ai militari che avevano il compito di sorvegliare le frontiere, i limitanei, ma beneficium poteva indicare anche il condono delle pene, la concessione di qualche privilegio o l’applicazione mitigata di una legge. Al beneficium si faceva ricorso anche per il salario e la remunerazione attraverso un pagamento pro beneficio, ma poteva riferirsi anche al prestito di denaro o allo scambio di beni fondiari. In età giustinianea il termine venne poi ad assumere un valore semantico equivalente a quello di ius, indicando prevalentemente i vantaggi di cui godeva chi si trovava in una situazione giuridica particolare.18 Vi era dunque un substrato giuridico significativo sul quale si sarebbero poi innestate le concessioni beneficiarie altomedievali che avrebbero avuto nel regno italico ampia diffusione soprattutto dopo la conquista franca del 774, pur emergendo sporadicamente, come si vedrà, anche in età longobarda. Nella sua riflessione sulle concessioni beneficiarie altomedievali Reynolds ha inoltre avuto il merito di evidenziare in particolare il ruolo svolto dalle precariae ecclesiastiche, assegnazioni a breve termine ampiamente impiegate a partire dal secolo VI, specialmente dai grandi enti ecclesiastici quali monasteri e sedi episcopali, per gestire indirettamente le immense proprietà fondiarie ottenute nel corso del tempo attraverso le donazioni pro anima effettuate dai laici. Il vincolo che si creava con le preghiere impediva a tali enti di procedere con la vendita o l’alienazione delle proprietà, che tuttavia potevano essere scambiate con beni analoghi o potevano essere assegnate per brevi periodi tramite concessioni come la precaria. Diretta conseguenza di ciò, secondo Reynolds, sarebbe il fatto che i beneficia altomedievali, e in seguito i feudi, non avrebbero avuto un’origine militare, come spesso si è invece ritenuto, ma ecclesiastica e pertanto non avrebbero avuto alcun nesso esclusivo con i vassalli.
L’acceso dibattito suscitato dalla pubblicazione di Fiefs and Vassals ha dunque favorito l’emergere di alcune proposte per una rilettura del beneficium che non fosse più soggetta unicamente all’ottica vassallatico-beneficiaria. Sulla scia di Reynolds, infatti, si è espressa negli ultimi anni in particolare la storica tedesca Brigitte Kasten la quale ha approfondito l’ipotesi secondo cui all’origine del beneficium vi sarebbe stata la concessione di precaria, a cui facevano ricorso i signori fondiari altomedievali nell’assegnazione di grandi proprietà terriere a un usufruttuario o a un possessore.19 Della precaria parlava ad esempio Isidoro di Siviglia nel quinto volume della sua opera, dedicato alle leggi e alla storia, dove classificava il precarium nel diritto delle obbligazioni e lo identificava con l’autorizzazione che il creditore concedeva al debitore che rivolgeva la richiesta, sotto forma di preghiera (preces), di rimanere sulla terra concessa e usufruire delle rendite.20 Si trattava di una forma contrattuale duttile, sviluppata nella tarda antichità, che aveva un carattere vitalizio e che consentiva la creazione di legami sociali ed economici in contesti tra loro molto diversi. Uno degli ambiti prediletti per l’uso di tale contratto era quello ecclesiastico che secondo Kasten giocò un ruolo fondamentale nella riflessione sulla precaria, favorendo la connessione con il concetto di beneficium. Nella Gallia del secolo V, infatti, Salviano di Marsiglia usò il termine precarium in senso religioso descrivendo gli esseri umani come precarii possessores dei doni che Dio concede loro.21 Gli uomini, dunque, figurano come degli usufruttuari a termine dei beni che la divinità elargisce, ma il vero proprietario rimane Dio. Ecco che la concessione si configura come un’opera di bene, un beneficium a favore dell’umanità peccatrice. Il concetto, tuttavia, non venne usato solo nell’ambito della teologia morale per essere impiegato anche nell’organizzazione delle stesse istituzioni ecclesiastiche, soprattutto per ovviare alle problematiche connesse alla proprietà. Fu probabilmente Prospero Tirone d’Aquitania a sostenere per primo, sempre nel secolo V, la necessità di donare i propri beni alla Chiesa e a documentare la donazione con un atto ufficiale per quei chierici che avessero voluto vivere attingendo risorse dal patrimonio ecclesiastico.22 Solo a quel punto i donatori avrebbero potuto ricevere, sotto forma di usufrutto vitalizio, i loro beni che sarebbero stati concessi dunque in beneficium. Posizioni simili vennero assunte, verso la metà del secolo VIII, anche da Crodegango di Metz. Nella sua Regula Canonicorum, redatta per i canonici della sua cattedrale, il vescovo sosteneva infatti la necessità di assegnare in usufrutto ai chierici non benestanti uno stipendium, indicato come beneficium, che sarebbe stato ricavato dal patrimonio ecclesiastico e da lui ritenuto strettamente connesso alla precaria. Così il chierico che fosse entrato a far parte della comunità della cattedrale avrebbe dovuto donare la sua proprietà alla sede episcopale per riceverla poi dal vescovo in usufrutto vitalizio sotto forma di precaria.23 Una concessione che avrebbe impedito al chierico di alienare i beni concessi evitando così di compromettere il patrimonio vescovile. Nel corso del secolo VIII si sarebbe quindi avviato un processo di sovrapposizione tra precaria e beneficium parallelamente a una sempre più precisa definizione delle forme di possesso lecite per gli ecclesiastici. Con i Carolingi si sarebbe poi verificata un’espansione della precaria anche tra i laici e tale forma di concessione si sarebbe trovata a convivere, divenendone in alcuni casi modello, con altre assegnazioni temporanee che i sovrani carolingi e i grandi del regno compivano a vantaggio dei loro seguiti di fideles, tra cui troviamo anche i vassalli ma non in maniera esclusiva.
Negli ultimi anni, tuttavia, il beneficio è stato indagato anche alla luce dei risultati offerti dalle ricerche antropologiche sullo scambio di doni. Paul Fouracre in particolare, riflettendo sugli usi del termine beneficium, ha osservato che fin dall’età tardo antica all’interno di una vasta gamma di significati vi era quello di una forma particolare di concessione che risulta legata a quanto studiato dagli antropologi a partire dalla pubblicazione del Saggio sul dono di Marcel Mauss.24 La concessione beneficiaria, infatti, sembra rappresentare bene la dinamica dell’obbligatorietà del contro-dono in un sistema di gift exchange, adattandosi nello specifico a una forma di dono paradossale indagata dall’antropologa statunitense Annette Weiner.25 Nel suo lavoro dedicato ai possessi inalienabili la studiosa ha ben mostrato come, nel contesto di scambio di doni interno alle comunità del Pacifico da lei indagate, vi siano alcuni beni che devono necessariamente fare ritorno a colui che li ha ceduti generando una dinamica paradossale, di carattere universale, riassunta nella formula keeping-while-giving. Tali beni presentano, infatti, una natura ambigua in quanto si pongono al tempo stesso come simboli di stabilità e cambiamento, di uguaglianza e gerarchia, e si caratterizzano per l’impossibilità di essere ceduti. Dal momento che, tuttavia, la loro durata nel tempo supera quella dei loro proprietari, essi devono essere necessariamente trasferiti all’interno del gruppo in modo tale da garantirne la preservazione. Alla base del paradosso vi sarebbe quindi la necessità di assicurare la permanenza in un mondo che è sempre percepito come sottoposto a perdita e decadenza, pertanto la messa in circolo di beni sui quali il detentore originario continua a mantenere il controllo produce l’illusione del mantenimento dello status quo.26 Fouracre, nel suo studio sull’uso del beneficium in area franca, ha posto dunque in evidenza come, nell’assegnazione e nella ricezione dei benefici, i beni ceduti non vengano alienati in via di principio e come tale favore non intacchi la virtù del concedente. La concessione, infatti, pone in risalto il prestigio e la proprietà di quest’ultimo che ne rimane il vero detentore e il capitale non subisce alcuna diminuzione dal momento che la concessione stessa si presenta come un atto virtuoso elevandolo culturalmente.27
Alla luce di tali nuovi approcci procederò dunque nella seconda parte di questo lavoro con l’analisi di alcuni documenti, in parte attinti da corpora documentari di importanti monasteri, che consentono l’osservazione dei vari usi del beneficium nel regno italico di tradizione longobarda. Tali usi non sono confinati unicamente alla sfera vassallatica, ma al tempo stesso non sono nemmeno necessariamente legati alla conquista franca del regno longobardo in quanto, come già si è accennato e come si vedrà dal primo caso proposto, l’istituto del beneficium, già presente nella tradizione giuridica romana, emerge sporadicamente anche in età longobarda. Beneficium, d’altra parte, è un termine che assume varie sfumature a seconda del contesto di impiego, ma la sfumatura originaria di favore non verrà mai meno affiancandosi in alcuni casi alla specifica forma di concessione. Lo studio del beneficio, tuttavia, ha posto il problema di abbandonare una scansione temporale per periodi nettamente distinti, pertanto in tale sede seguirò un andamento cronologico a partire dall’inizio del secolo VIII per affacciarmi al secolo X prendendo come estremo l’anno 924 quando venne assassinato l’imperatore Berengario I, ultimo erede di Carlo Magno, sia pur non in linea diretta, che cinse entrambe le corone d’Italia e dell’Impero. Il primo termine è dettato dalla stessa documentazione in quanto è a partire dal secolo VIII che le fonti scritte iniziano a farsi consistenti dopo la grave penuria che caratterizza i due secoli precedenti. Il secondo, invece, è suggerito da un evento politico come la morte di un sovrano che, sebbene tradizionalmente sia stato visto come uno dei tanti deboli re “nazionali” che sarebbero emersi dalla frammentazione dell’Impero carolingio, di fatto fu la figura dominante nella politica del regno dopo la scomparsa del cugino Carlo III nel gennaio 888. Anche la scelta del 924 come estremo cronologico è certo un atto di interpretazione ma funzionale a concentrare l’indagine, per un tema come quello del beneficium, su un arco temporale definito che consenta di evidenziare al tempo stesso sia come alcune tracce di tale forma di concessione emergano anche prima della conquista franca, sia come il mondo carolingio, in cui l’istituto beneficiario ebbe ampia diffusione, per molti aspetti non terminò bruscamente dal momento che alcuni suoi elementi si protrassero nei decenni successivi all’888 trasformandosi gradualmente nel corso del secolo X.
Tra beneficio concesso e beneficio conteso nelle fonti del regnum Italiae Nell’ottobre 724, al tempo di re Liutprando, nella chiesa di S. Pietro a Lucca il prete Romualdo, trasferitosi in Tuscia e proveniente dall’Italia settentrionale, fece vergare al notaio Sicoino un atto di donazione in favore del monastero dei SS. Pietro, Martino e Quirico nel luogo detto Capannule28, a Castellione nel territorio lucchese.29 Qui si era insediato, con il consenso del vescovo Talesperiano di Lucca, per risiedere con la moglie, la pretessa Ratperga. Nell’atto si ricorda che il prete aveva acquistato vari terreni nel territorio di Pisa e di Lucca e in quell’occasione aveva deciso di donarli pro anima al monastero potendo risiedervi assieme alla moglie, esentati da ogni forma di tassazione, in cambio del servizio religioso.30 Nel caso in cui il prete fosse morto prima della moglie, quest’ultima avrebbe potuto continuare a vivere in quel luogo tranquillamente e senza alcuna tassazione, dedicandosi al servizio di Dio. Dopo la morte di entrambi tanto la casa in cui avevano scelto di vivere quanto la struttura costruita all’esterno e detta ospitale [sic], sarebbero divenuti a tutti gli effetti parte integrante del patrimonio monastico.31 Vi è tuttavia un secondo atto, vergato forse nello stesso giorno del documento di donazione, indicato come cartula beneficiis e redatta sempre dal notaio Sicoino nella stessa chiesa di S. Pietro a Lucca.32 È il vescovo qui a comparire in prima persona ricordando come il prete Romualdo fosse giunto quello stesso anno con la moglie a Capannule nel monastero e vi avesse costruito una struttura adibita a ospitale acquistando anche un vigneto. Romualdo chiese dunque al vescovo di poter vivere in quel luogo prestando servizio alla comunità monastica e Talesperiano acconsentì esentandolo dalla tassazione che avrebbe dovuto corrispondere al prete della pieve locale di S. Maria. In cambio Romualdo, oltre a prestare l’officium monastirialis [sic] nella chiesa dei SS. Pietro, Martino e Quirico, per le festività dei tre titolari della chiesa avrebbe anche dovuto contribuire all’illuminazione della cattedrale di S. Martino.33 Risalta dunque la diversità dei due atti. Il primo è un documento che registra la donazione di beni privati a un piccolo monastero nel territorio posto sotto la giurisdizione dell’episcopio di Lucca, il secondo è invece un contratto tra il vescovo e il prete Romualdo che viene indicato come cartula beneficiis. In quest’ultimo si prevede sostanzialmente che il prete potesse risiedere nel luogo in cui si era stabilito prestando in cambio il servizio sacerdotale presso il monastero al quale aveva donato i suoi beni. Si trattava dunque di una concessione dell’usufrutto vitalizio di beni che erano stati in precedenza donati al luogo sacro e che alla morte del prete e di sua moglie sarebbero entrati a far parte definitivamente del patrimonio cenobitico. La dinamica risulta quindi pienamente inserita nella logica paradossale del keeping-while-giving indagata da Annette Weiner ma in una declinazione particolare che prevede la restituzione al primitivo proprietario dell’usufrutto dei beni donati, ormai trasformati in beni inalienabili, sui quali il nuovo detentore non intende perdere il controllo. Si tratta di una dinamica che emergerà pienamente in età carolingia ma che traspare già a quest’altezza cronologica, in piena età longobarda, indicata esplicitamente come concessione beneficiaria.34
Se il beneficio non pare dunque una totale novità importata dai Franchi con la conquista del regno longobardo nell’estate del 774, è tuttavia in età carolingia che esso vede un’ampia diffusione in vari ambiti, tra cui vi è certo anche quello militare, sebbene non in maniera esclusiva, e che emerge in particolare in alcune aree del regno negli ultimi decenni del secolo VIII. A questo proposito vi è un diploma di Carlo Magno che mostra l’uso del beneficio in un’area calda del regnum Langobardorum, teatro di una rivolta nel 776 a due anni dalla conquista di Pavia, e che costituisce l’unico caso all’interno del corpus diplomatico del sovrano per un destinatario del regnum da cui emerge chiaramente il riferimento a tale particolare concessione. Il 21 dicembre 811, dunque, il sovrano donò alla sede patriarcale di Aquileia alcuni beni che erano stati confiscati diversi anni prima ai fratelli Rotgaudo e Felice, che avevano partecipato alla rivolta friulana promossa dal duca Rotgaudo in un estremo tentativo di resistenza alla dominazione franca dopo la caduta di Desiderio.35 La donazione riguardava nello specifico un domocoltile costituito da un terreno arabile, vigne, prati, pascoli e selve, assieme a una porzione dello stesso podere situata nel porto fluviale sul Natisone. Il diploma, tuttavia, ci informa che vi era anche un terzo fratello, di nome Lodolfo, il quale a differenza dei suoi fratelli non aveva perseverato nell’infedeltà e dunque la sua porzione di eredità non era stata toccata dalla confisca. Solo una parte dei beni confiscati veniva comunque assegnata alla Chiesa aquileiese, in quanto nel diploma si specifica che dei restanti beni l’imperatore avrebbe deciso successivamente.36 Si ricorda inoltre che i beni di Rotgaudo e Felice, uccisi nella repressione della rivolta erano stati assegnati come beneficium regio a Landola, un fidelis del sovrano. In seguito, dopo la morte di Landola, quegli stessi erano passati in un primo tempo al figlio Benno e successivamente a un certo Bono sempre in beneficio.37
Il diploma consente dunque di osservare da vicino come nel passaggio dalla dominazione longobarda a quella franca il beneficium venne usato per assegnare terre confiscate ai ribelli poste in un’area che si era mostrata particolarmente ostile alla nuova dominazione e nella quale si era reso necessario ricorrere a uomini di fiducia per amministrarle. Il diploma, tuttavia, fu redatto dopo più di trent’anni dal fallimento della rivolta quando i tempi dovevano apparire ormai maturi per un nuovo uso di quei beni, divenuti parte del fisco regio, che fino a quel momento erano stati concessi come beni inalienabili. Per questo, infatti, negli anni che separano la confisca dalla donazione alla sede patriarcale lo strumento cui il sovrano fece ricorso per concedere quei beni era stato il beneficium che consentiva l’assegnazione di beni sui quali non intendeva perdere il controllo; si metteva dunque in atto una forma di concessione da cui nuovamente emerge con evidenza il paradosso di keeping-while-giving. Nel dicembre 811, invece, a più di trent’anni dalla rivolta, Carlo Magno dispose per una nuova destinazione di quei beni e procedette quindi con una donazione vera e propria, alienandoli in via definitiva in favore del patriarcato aquileiese.
Nello stesso periodo, d’altro canto, l’uso del beneficium traspare anche dalla documentazione di carattere privato. Esso, tuttavia, non risulta impiegato in maniera uniforme in tutto il territorio del regno ma si concentra in aree specifiche come, ad esempio, la Sabina dove si trovava una delle più prestigiose abbazie dell’epoca: S. Maria di Farfa. Si trattava di una regione caratterizzata da una particolare situazione politica, dal momento che il territorio fu diviso nel secolo VII tra il ducato longobardo di Spoleto e la Sabina romana o suburbicaria. Proprio tra questi due ambiti si inserì il monastero di Farfa, fondato all’alba del secolo VIII in piena età longobarda, la cui ricca documentazione mostra bene come in quell’area il passaggio dalla dominazione longobarda a quella carolingia non comportò grandi stravolgimenti. La vita nel monastero, infatti, continuò senza interruzioni e le donazioni delle élite e dei sovrani proseguirono anche dopo la vittoria di Carlo Magno su Desiderio.38 Il considerevole corpus documentario farfense, giunto fino a noi grazie all’opera di copia di Gregorio da Catino, mostra in particolare come, tuttavia, a partire dall’inizio del secolo IX in alcuni atti si parli esplicitamente di assegnazioni beneficiarie. A titolo esemplificativo vi è il caso di un certo Massiolo, figlio del fu Calvulo, che il 18 luglio 808 a Rieti chiese all’abate Benedetto di Farfa per concessionem beneficii, per sé e per i suoi figli, l’usufrutto di alcuni beni che aveva donato all’abbazia, a sua volta ricevuti in dono e confermati tramite atto scritto da un tale Rodorico di S. Stefano, a quella data ormai defunto.39 I beni ricevuti in beneficio non avrebbero dovuto essere alienati in alcun modo e in cambio Massiolo avrebbe dovuto versare annualmente all’abbazia una pensione di tre denari in occasione della messa in onore della titolare del monastero, il 15 agosto. Esattamente cinque anni dopo, il 18 luglio 813, è una donna a ricevere in beneficio quanto aveva donato all’abbazia pro remedio animae otto giorni prima.40 In quell’occasione, dunque, l’ancilla Dei Helina chiedeva all’abate Benedetto che i beni donati le venissero riassegnati sub beneficiali ordine in usufrutto vitalizio41, in cambio del pagamento di una pensione di tre soldi d’argento o dell’equivalente in tessuti da versare annualmente all’abbazia sempre il 15 agosto.42 Helina non si limitava comunque a chiedere in beneficio unicamente quanto aveva precedentemente donato, ottenendo infatti anche alcune terre monastiche con i coloni e le relative famiglie, mentre nel documento veniva posta una clausola secondo cui la donna non avrebbe potuto alienare in alcun modo quanto le veniva assegnato.43 Si trattava di un atto indicato nella sottoscrizione della donna come precaria e dunque tale caso consente di osservare quanto rilevato da Brigitte Kasten in merito alla stretta connessione tra il beneficium e tale tipologia contrattuale che avrebbe fornito un modello per la concessione di beni inalienabili. È possibile tuttavia osservare come in quell’area, alcuni anni prima della conquista franca del regnum Italiae, la stessa donna fosse stata protagonista di altri due atti registrati da Gregorio da Catino nel Regesto Farfense. Nel maggio 770 Helina aveva infatti donato al monastero le sue proprietà in Sabina mentre l’anno seguente ad essere oggetto della donazione erano stati i beni che erano appartenuti in passato alle sue sorelle Taciperga e Liutperga, al tempo dei re longobardi Desiderio e Adelchi, del duca Teodicio di Spoleto e del gastaldo di Rieti, nonché nipote della donna, Ilderico.44 In entrambi i documenti Helina riservava per sé e per la madre Teudiperga l’usufrutto vitalizio dei beni donati senza tuttavia indicarlo come un’assegnazione sub beneficiali ordine; la struttura del documento è d’altra parte molto simile ma si può osservare come nell’area, a quell’altezza cronologica, non fosse ancora diffuso il formulario riscontrabile alcuni decenni dopo per quella tipologia di concessione.
Più ridotta rispetto a Farfa, ma con alcuni casi significativi, è la documentazione di un altro importante monastero quale S. Ambrogio di Milano, fondato in età carolingia a distanza di circa dieci anni dalla conquista di Pavia da parte di Carlo Magno e divenuto in breve tempo uno dei principali enti monastici del regno d’Italia e dell’Impero franco.45 Tra i documenti da cui emerge un qualche uso dello strumento beneficiario vi è il caso di Crescenzio da Delebio che nel dicembre 837 stipulò un contratto con il monastero di S. Ambrogio per ricevere in beneficio la curtis di Dubino in Valtellina.46 Quest’ultima era stata in precedenza tenuta in livello dallo stesso Crescenzio che in quell’occasione si impegnava ad amministrarla per cinque anni in qualità di scarius (un “ufficiale minore” con compiti gestionali), consegnando ogni anno all’abbazia vari prodotti come fatto fino ad allora mentre era livellario; quel giorno, tuttavia, si stabilì che avrebbe potuto tenere per sé il grano e il vino prodotti.47 Se si fosse mostrato negligente nella gestione della curtis recandole danno o diminuendo il censo dovuto avrebbe risarcito il monastero attingendo dalle proprie sostanze per il doppio del valore, e il monastero avrebbe potuto confiscargli i beni alla stregua dei vari masarii finché il danno non sarebbe stato ripagato.48 Si può notare, tuttavia, come di fatto non sia l’intera curtis ad essere concessa a Crescenzio in beneficio, e che pare invece continui ad essere tenuta in livello, ma alcune rendite. In ogni caso l’assegnazione beneficiaria non fa di Crescenzio un vassallo dell’abate, piuttosto, come ha rilevato anche Andrea Castagnetti, pare si tratti di un beneficio di servizio mostrando dunque l’uso di tale strumento per retribuire le mansioni più varie, come quelle offerte da uno scario, e che nulla hanno a che vedere con il mondo militare.49
Un altro caso relativo sempre a S. Ambrogio, e che sembra richiamare il primo documento analizzato in tale sede, risale al 5 dicembre 863 quando il prete Angilberto da Cannobio ricevette in beneficio i beni precedentemente donati.50 Angilberto aveva infatti donato pro anima, quando era ancora chierico, alcuni beni che facevano parte del suo patrimonio privato.51 In quell’occasione gli veniva dunque concesso il vitto al pari dei monaci che vivevano nella cella di Campione, nelle terre che un tempo appartenevano al gruppo parentale di Totone e che erano poi entrate nel patrimonio della basilica ambrosiana con il lascito testamentario del 77752, o quello della curtis di Cannobio, posta sulle rive del Lago Maggiore. In cambio Angilberto avrebbe officiato la liturgia riscuotendo in benefitio nomine per il resto della sua vita le rendite dei beni da lui donati a S. Ambrogio per potersi garantire vestiario e calzature.53 Nel caso avesse mancato ai compiti che gli spettavano in qualità di sacerdote il contratto sarebbe stato annullato e i beni di cui godeva l’usufrutto sarebbero tornati al monastero; se al contrario fossero stati l’abate o i suoi successori a contravvenire all’accordo il prete avrebbe ottenuto come risarcimento una somma di duecento soldi. Da un atto stilato il mese successivo, apprendiamo che la località scelta da Angilberto fu Cannobio. Qui, infatti, l’abate Pietro II venne immesso nel possesso e investito per columna dei beni donati dal prete che sottoscrisse il documento di investitura.54 Il caso, dunque, richiama da vicino quello di Lucca risalente a più di un secolo prima nel quale, come si è visto, veniva consentito a un altro prete e a sua moglie di vivere per il resto della loro vita presso un monastero dell’episcopio lucchese: in cambio, dopo aver donato i suoi beni al cenobio, il presbitero era tenuto a prestare il servizio sacerdotale. La situazione, d’altro canto, è in parte simile anche a quella di Crescenzio, che avrebbe dovuto gestire i beni monastici come bonus actor et scarius. Anche Angilberto, infatti, era tenuto ad agire come bonus sacerdos per fruire delle rendite prodotte dai beni assegnatigli in usufrutto vitalizio e che rimanevano sotto il controllo del detentore originario, il monastero di S. Ambrogio. Di nuovo è dunque possibile osservare le dinamiche paradossali del keeping-while-giving veicolate dalla concessione in beneficio, ma declinate in una modalità particolare pari a quella emersa dal caso lucchese e molto simile ai due esempi farfensi. Angilberto, primitivo detentore dei beni oggetto della concessione beneficiaria, aveva infatti rinunciato ai suoi diritti di proprietà e li aveva trasferiti a un nuovo detentore. Quest’ultimo poteva dunque assegnare quei beni, divenuti inalienabili, come una sorta di stipendio per i servizi svolti dal prete.
Altre aree del regno invece, pur dominate da importanti enti monastici come S. Silvestro di Nonantola, non restituiscono un quadro così significativo come quello emerso dalla documentazione di S. Maria di Farfa o di S. Ambrogio.55 Così per il caso nonantolano è possibile osservare l’uso del beneficio unicamente grazie a una fonte esterna all’abbazia: una lettera di papa Giovanni VIII in cui si annunciava la scomunica del vescovo di Verona.56 Si tratta di una fonte particolarmente interessante dal momento che ci pone di fronte non all’assegnazione in beneficio di alcuni beni monastici ma del monastero stesso e del relativo patrimonio. La lettera venne redatta in un contesto particolare assieme a due altre missive indirizzate nella primavera dell’877 a vari destinatari per rendere nota l’avvenuta scomunica del vescovo Adalardo di Verona.57 Dal documento in questione, indirizzato all’imperatore Carlo il Calvo, apprendiamo che il monastero di Nonantola era stato concesso in beneficium al presule veronese58, un fatto senza precedenti e per il quale il pontefice riteneva offesa non solo la sua autorità ma la stessa dignità imperiale.59 Adalardo, tuttavia, si era insediato sulla cattedra veronese probabilmente tra la fine dell’875 e l’inizio dell’anno successivo e aveva sostenuto l’incoronazione imperiale di Carlo il Calvo assieme al conte Walfredo di Verona nel febbraio 876, quando compare tra i vescovi presenti alla sinodo pavese durante la quale il sovrano venne elevato al soglio imperiale.60 È altamente probabile, quindi, che l’assegnazione in beneficio di uno dei principali monasteri del regno fosse avvenuta per volontà del sovrano in segno di gratitudine per il supporto che Adalardo aveva mostrato. Non pare un caso, infatti, che il riferimento alla concessione beneficiaria sia contenuto unicamente nella lettera indirizzata all’imperatore, l’unico che aveva l’autorità per agire in quel modo. Tale concessione aveva tuttavia suscitato uno scandalo che aveva portato alla scomunica del presule affinché potesse ravvedersi e correggere la propria condotta, ed è in tale frangente che venne inviata, tra le altre, la lettera in questione.61 Dell’abate Teodorico di Nonantola non è dato sapere alcunché in questa fase ma è probabile che rimase nel monastero sebbene delegittimato nelle sue attività politiche e patrimoniali. Era Adalardo che svolgeva ora le funzioni di abate di Nonantola ma tale situazione aveva alimentato il malcontento dei monaci che avevano visto violato il loro diritto alla libera elezione dell’abate e probabilmente furono loro a rivolgersi al pontefice affinché ponesse fine a tutto ciò. Le lettere di scomunica, indirizzate oltre che all’imperatore anche ai vescovi delle tre sedi metropolitiche di Aquileia, Milano e Ravenna e al clero veronese, avevano quindi carattere pubblico ed erano rivolte al contesto sociale di cui Adalardo era parte. Le missive, infatti, sortirono gli effetti previsti e il presule rinunciò dunque al monastero riappacificandosi con il papa che ritirò la scomunica, mentre l’abate Teodorico venne reintegrato alla guida della comunità nonantolana.
Un ultimo caso ci porta a Pavia agli inizi del secolo X e riguarda un conflitto sorto attorno ad alcuni beni monastici tenuti in beneficio. Nell’aprile 915 si svolse un placito presieduto dal messo imperiale Odelrico nel viridarium del palazzo regio, accanto alla laubia dove re Berengario I teneva il placito generale.62 Si trattava dell’ultimo atto di una controversia che si protraeva da anni tra Teodelassio, abate di S. Colombano di Bobbio, e il marchese Radaldo63, scaturita dall’intrusione che quest’ultimo aveva effettuato con i suoi uomini nella curtis monastica denominata Barbada.64 L’abate, infatti, sosteneva che le case e le famiglie della corte erano tenute contra legem da Radaldo poiché spettavano al monastero. Spiegò dunque ai giudici come Radaldo e il suo avvocato Gotefredo avessero risposto alle lamentele sostenendo che quanto affermato corrispondeva a verità ma i beni contestati non erano detenuti in violazione della legge, dal momento che per lungo tempo la curtis era stata assegnata in beneficio.65 Radaldo si era dunque accordato con l’abate per presentarsi in sede di placito e porre fine alla contesa, attraverso un atto ufficiale, esponendo la documentazione relativa. Il marchese e il suo avvocato tuttavia, nonostante una lunga ricerca, non riuscirono a trovare alcuna prova documentaria o testimone che potesse dimostrare il diritto a mantenere quei possessi, gestiti fino a quel momento a titolo beneficiario ex regia potestate66, e furono dunque costretti a restituirli al monastero di S. Colombano. È evidente che la diatriba era stata risolta prima di presentarsi al placito e in quell’occasione il raggiungimento di un accordo venne semplicemente confermato con un atto scritto che tutelasse il monastero. Tale caso, quindi, consente di osservare come il marchese non fosse in possesso di alcun documento che comprovasse l’assegnazione del beneficio regio, che doveva essere avvenuta oralmente al tempo degli imperatori Guido e Lamberto di Spoleto nell’ultimo decennio del secolo IX. Solo nella primavera del 915, tuttavia, il cenobio riuscì a entrare nuovamente in possesso di quei beni rivolgendosi al tribunale regio di Berengario I. Il particolare secondo cui la curtis era solita essere assegnata come beneficio regio sembra inoltre suggerire un’origine fiscale di quei beni, concessi a Radaldo dai rivali storici di Berengario con i quali il marchese aveva rapporti parentali. È probabile, d’altro canto, che le lamentele da parte dei monaci fossero cominciate subito ma solo dopo molti anni, in una fase in cui Berengario I era ormai rimasto l’unico sovrano a dominare la scena politica del regno e si stava preparando all’incoronazione imperiale, riuscirono a riottenerla con un atto ufficiale a fronte dell’impossibilità evidente da parte di Radaldo di difendere in giudizio le sue ragioni in merito al beneficio conteso.