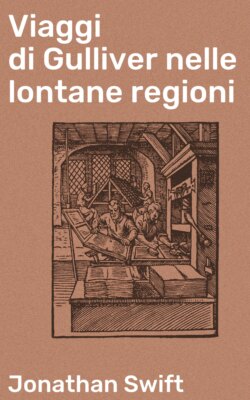Читать книгу Viaggi di Gulliver nelle lontane regioni - Jonathan Swift - Страница 13
CAPITOLO I.
ОглавлениеL'autore dà qualche notizia di sè medesimo e della sua famiglia. — Prime cagioni che lo invogliarono di viaggiare il mondo. — Naufragio e vita salvata a nuoto. Tocca sano e salvo la spiaggia a Lilliput; fatto prigioniero, è condotto attorno per quel paese.
Mio padre era un picciolo possidente della contea di Nottingham; fui il terzo de' suoi cinque figli. Mi pose, ch'io avea quattordici anni, nel collegio Emmanuele di Cambridge, ove rimasi tre anni, applicandomi seriamente ai miei studi; ma il peso di mantenermi, benchè m'avesse fatto un ben magro assegnamento, essendogli tuttavia greve, atteso lo scarso suo patrimonio, fui costretto entrare qual novizio di chirurgia sotto il magistero del signor Giacomo Bates, esimio professore di quest'arte in Londra; presso il quale rimasi quattro anni. In questo intervallo, mio padre mi spediva a quando a quando qualche po' di danaro ch'io spesi nell'imparare la nautica e diverse parti delle scienze matematiche, utili grandemente a chi vuole imprendere navigazioni, giacchè ho sempre creduto che, una volta o l'altra, sarei chiamato dal mio destino su questa carriera. Licenziatomi dal signor Bates, tornai a trovare mio padre; e coll'assistenza di lui, del mio zio Giovanni e d'alcuni altri parenti, misi insieme quaranta lire sterline oltre alla promessa di altre trenta ogn'anno per mantenermi a Leida. In questa università mi dedicai per due anni e sette mesi alla fisica, ben comprendendo come tale scienza mi sarebbe stata di grande sussidio nel far lunghi viaggi.
Appena tornato da Leida, il mio buon maestro signor Bates mi raccomandò perchè fossi ammesso in qualità di chirurgo nel vascello La Rondine, comandato dal capitano Abramo Pannel, con cui rimasi tre anni e mezzo, facendo seco un viaggio o due nel Levante ed in altre parti. Tornato addietro, risolvei stabilirmi in Londra, al che mi confortò il detto maestro mio, signor Bates, procurandomi con le sue raccomandazioni più d'una clientela. Preso un appartamento in una piccola casa posta in Jewry Vecchia, mi pesò il celibato, onde mi sposai con mistriss Maria Burton, seconda figlia del signor Edmondo, calzettaio, conosciuto con tal cognome in contrada Newgate, e ne conseguii una dote di quattrocento sterlini.
Sfortunatamente venne a morire due anni appresso il mio buon maestro Bates: onde, avendo io pochi amici, le clientele principiarono a mancarmi; tanto più che la mia coscienza ci avrebbe patito se per amor di guadagno avessi voluto darmi alle male ciarlatanesche pratiche d'alcuni miei colleghi. Consigliatomi pertanto con mia moglie e qualche mio conoscente, presi la determinazione di mettermi nuovamente al mare. Chirurgo successivamente in due vascelli, feci per sei anni diversi viaggi in tal qualità alle Indie orientali ed occidentali, dond'ebbe qualche miglioramento la mia condizione. A bordo impiegava le mie ore di libertà nel leggere i migliori autori antichi e moderni (chè andai sempre proveduto d'una suppellettile abbondante di libri); su le spiagge, nello studiare le usanze e l'indole dei diversi popoli, e nell'impararne le lingue in che riuscivo con grande facilità, siccome dotato di una tenace memoria.
L'ultimo di questi viaggi per altro non fu gran che fortunato, onde credei d'averne abbastanza di mare, e feci proposito di rimanermene a casa con mia moglie e la mia famiglia. Venuto via da Jewry Vecchia andai a stare di casa in contrada Fetter, poi al Wapping, sperando trovar faccende fra que' marinai; ma nemmeno lì ci vidi il mio conto. Dopo essere rimasto tre anni nella speranza che le cose prendessero miglior piega, dovei buttarmi all'acqua di nuovo, ed accettai un'offerta fattami del capitano Guglielmo Prichard, comandante dell'Antilopa, che era in procinto di fare un viaggio all'Oceano australe. Salpammo da Bristol ai 4 di maggio del 1699, ed avemmo su le prime un viaggio assai prospero.
Non ci sarebbe forse il prezzo dell'opera se io incomodassi il mio leggitore, raccontandogli i particolari delle nostre avventure su quei mari: basti l'informarlo che nel nostro tragetto di li all'Indie orientali una violenta burrasca ci trasportò a maestro (nord-owest) della terra Van-Diemen, ad una latitudine, come apparve dalle nostre osservazioni, di 30 gradi, minuti 2 ad ostro. Dodici di noi erano morti per effetto delle immoderate fatiche e del cattivo nutrimento; si trovavano tutt'altro che in buona condizione i sopravvissuti. Ai 5 novembre, che è il principio della state in que' climi, era sì nebbiosa la giornata che i piloti s'avvidero di uno scoglio sol quando il vascello ne fu lontano di un mezzo tratto di gomona, ed il vento era sì gagliardo che ne spinse irremissibilmente a rompere contro di esso. Sei della brigata, ed io ne fui uno, lanciata la scialuppa nel mare, fecero con essa una giravolta onde liberarsi e dallo scoglio e dal bastimento andatovi addosso. Remigammo per circa tre leghe, secondo i miei computi, finchè già mezzo morti dalle fatiche e dai disagi sofferti nel bastimento, non fummo più buoni di durarla in questo lavoro. Ci abbandonammo pertanto alla discrezione dell'onde, nè passò mezz'ora che la scialuppa fu volta di sotto in su da un subitaneo buffo di vento settentrionale.
Che cosa divenisse de' miei compagni della scialuppa, o di quelli che poterono aggrapparsi allo scoglio, non ve lo so dire; ma dovetti crederli tutti periti. Quanto a me, mi diedi a nuotare verso dove mi dirigeva la fortuna, e lasciandomi spignere dal vento e dalla marea, spesse volte mi sono lasciato andare le gambe all'ingiù, ma senza trovare mai fondo. Sol quando fui quasi spedito, nè ero più abile ad aiutarmi da me in alcun modo, sentii che il mio piede toccava la terra; e da quel momento la burrasca aveva cominciato a calmarsi tanto ch'io era padrone di tenercelo senza lasciarmi trasportare dai marosi. Il declivo della spiaggia era sì tenue che dovei camminare circa un miglio prima di raggiugnerla, e quando ci fui, saranno state, secondo le mie congetture, le otto all'incirca della sera.
Andai innanzi quasi un mezzo miglio senza scoprire alcun vestigio di abitanti o di case; o certo, se v'erano, non me ne accôrsi, tanto la prostrazione assoluta del mio corpo m'avea ridotto a tristo partito. Alla stanchezza ed al caldo della stagione aggiugnete che io aveva in corpo quasi un boccale e mezzo d'acquavite, bevuta nel bastimento all'atto del licenziarmene, e crederete che tutte queste combinate circostanze mi resero molto proclive al sonno. Mi coricai dunque su l'erba che era cortissima, pur fitta e soffice assai, ove diedi la più profonda dormita ch'io mi ricordi avere mai fatta in mia vita, e che ha ad essere durata circa nove ore, perchè quando mi svegliai, cominciava appunto a vedersi il giorno.
Feci per alzarmi, ma non fui capace di movermi, perchè, essendomi occorso d'addormentarmi supino, mi trovai tutt'a due le braccia e le gambe attaccate con forti legami al terreno; ed alla mia capellatura assai lunga e folta era stato praticato lo stesso servigio. Sentii nel tempo stesso che alcune sottili funicelle mi legavano tutto il corpo dalle ascelle fino alle cosce. Io non potea guardar altro che all'insù, ed il sole cominciava a scottare e la sua luce ad incomodarmi gli occhi. Io udivo un confuso bisbiglio d'intorno a me; ma nella postura in cui giacevo non mi era dato vedere altra cosa che il firmamento.
Di lì a poco sentii alcun che di vivo moversi su la mia gamba sinistra, e che avanzandosi gentilmente sul mio petto mi montò quasi sul mento. Chinando gli occhi all'ingiù quanto potei con la mia testa, fatta immobile dalle legature, vidi che quel vivente era una creaturina umana, non alta sei dita, con proporzionato arco e con proporzionate frecce nelle mani ed il suo turcassino dietro le spalle. In questo mezzo sentii circa un'altra quarantina d'esseri della medesima specie (tali almeno li congetturai) che venivano dietro al primo.
Vi lascio immaginare se rimasi attonito. Misi un sì forte grido che tutti si diedero spaventati alla fuga; anzi alcuni di loro (questo poi l'ho saputo dopo) si fecero male nel saltar giù dai miei fianchi per far più presto. Ciò non ostante tornarono quasi subito, e un di loro arrischiatosi al punto di fisare e squadrare i miei lineamenti, sollevò gli occhi e le mani in atto di ammirazione, e sclamò con voce strillante ma distinta: Hekina degul! esclamazione che gli altri ripeterono a coro parecchie volte, senza che certamente io capissi allora che cosa si volessero dire.
Rimasi tutto questo tempo, ed il leggitore me lo crederà facilmente, in uno stato di grande agitazione; finalmente a furia di sforzi per mettermi in libertà, ebbi la fortuna di rompere le cordicelle che mi strignevano attorno la vita e di staccare dal suolo le caviglie che tenevano legato il mio braccio sinistro. Allora, portandomi alla faccia questo braccio, potei capire la meccanica di cui si erano valsi per legarmi a quel modo, e nel medesimo tempo con una violenta strappata, che mi produsse tutt'altro che gusto, arrivai ad allentare i legamenti che attaccavano i miei capelli al terreno, ciò che mi diede abilità quanta bastava per dare alla mia testa una voltata di circa due dita. Ma quelle creature tornarono a fuggire dal mio corpo prima che potessi acchiapparne una sola.
In questa, udii un nuovo grido stridulo oltre ogni dire, dietro cui uno di que' campioni profferì ad alta voce queste parole: Tolgo phonac, ed in un subito sentii volar su di me la scarica d'un centinaio di frecce che cadute su la mia mano sinistra la forarono come altrettanti aghi da cucire. Poi, senza darmi tregua, scoccarono all'aria una folata di dardi, come facciamo noi colle bombe in Europa, alcuni de' quali caddero, suppongo, sul mio corpo, ancorchè io non li sentissi grazie ai miei panni: ed altri su la mia faccia che mi copersi con la mano destra. Cessata questa pioggia d'armi da lancio, misi un gemito di dolore, poi voleva far gli ultimi sforzi per isciogliermi, ma que' signorini non me ne diedero il tempo, chè mi mandarono addosso una rugiada di quelle galanterie, copiosa più della prima, anzi alcuni si arrischiarono a tribolarmi i fianchi con le loro aste; ma per buona sorte li riparava la mia casacca di cuoio di bufalo, onde non riuscirono a trafiggerli. Credei quindi che il più saggio partito per me fosse lo starmene quieto per allora; e divisai starci fino alla notte, durante la quale, avendo la mano destra già in libertà, non mi sarebbe stato difficile far libero il resto della mia persona; chè poi, in piedi una volta, io mi giudicava un competitore bastantemente gagliardo per un intero de' loro eserciti, se pure ciascun soldato era dello stesso calibro di quello che venne a trovarmi la prima volta. Ma il destino dispose altrimenti di me.
Poichè quella popolazione si fu accorta che io mi era messo quieto, non mi vennero scaricate addosso altre frecce; ma dallo strepito che io udiva, capii che cresceva sempre di numero, e ad una distanza di circa quattro braccia, rimpetto al mio orecchio destro, udii per una buon'ora continua un picchiamento come di gente intenta ad una fabbrica. Arrivato, sin quanto me lo permettevano le caviglie conficcate in terra e le mie legature, a voltare il capo da quella banda, vidi un palco alto all'incirca un piede e mezzo da terra, capace di contenere quattro di quegli abitanti, con due o tre scale a mano per salirvi; dalla quale tribuna un di loro, che all'aspetto pareva un personaggio di distinzione, mi tenne un lungo discorso di cui non intesi una sillaba.
Avrei dovuto premettere che quel personaggio principale, prima di cominciare la sua concione, gridò forte per tre volte: Langro dehul san (e queste parole e le precedenti mi furono in appresso ripetute e spiegate). Non appena furono profferite, ebbi presso di me una cinquantina di quei nativi, che tagliò la cordicella da cui era reso immobile il lato sinistro del mio capo, ond'ebbi la libertà di voltarlo a destra e di contemplare la persona ed i gesti dell'oratore. Parvemi fosse di mezza età e più alto dei tre altri; un de' quali era un paggio del corteggio, un po' più lungo del mio dito di mezzo, collocato fra due che gli servivano di braccieri. Egli adempì tutte le incombenze di un oratore, perchè mi parve notare nella sua aringa molti periodi di minaccia, ma molt'altri ancora di promesse, di compassione e persino di cortesia.
Risposi in pochi cenni, ma d'una guisa la più sommessa, sollevando la mia mano sinistra ed entrambi gli occhi al sole, come chiamandolo in testimonio della mia sincerità. Ma c'era un'altra cosa: io mi sentiva morto di fame, che non avevo preso un morsello di cibo fin da più ore prima di abbandonare il bastimento, e questo bisogno della natura era sì imperioso, che non potei starmi dal far conoscere il mio mal essere (anche a costo di mancare alle strette regole dell'etichetta), col cacciarmi sovente le dita in bocca per dar a capire la mia necessità di mangiare. L'hurgo (così viene colà denominato un gran personaggio, come seppi da poi) mi comprese ottimamente. Sceso dalla sua tribuna, ordinò s'appoggiassero ai miei fianchi diverse scale, su cui salì un centinaio circa di que' nativi, i quali presero la via della mia bocca, carichi di canestri pieni di vivande, che il re aveva fatte preparare e mandar qui alla prima notizia del mio arrivo su quella spiaggia. Notai che erano composte di carni d'animali diversi, ma al palato non potei distinguerne le specie. Vi erano spalle, piedi e lombi come quelli di castrato, cucinati a perfezione, ma più piccioli di un'ala di lodola. Io ne mangiava due o tre in un boccone, e ad una volta con essi tre pagnotte, grosse ciascuna come una palla di moschetto. Mi rinovarono questa provista il più presto che poterono, dando mille segni di stupore e sbalordimento all'enormità della mia mole e del mio appetito.
Indicai allora per cenni un altro bisogno: quello di bere. A proporzione di quello ch'io aveva mangiato, capirono che una piccola quantità di vino non mi sarebbe bastata; ed essendo creature di molto ingegno, fecero con gran destrezza salir su' miei fianchi una delle più ampie botti, e, ruzzolatala verso la mia mano, ne tirarono fuori la cannella. Ne bevei tutto il liquido in una sorsata, perchè la botte non arrivava a contenere un mezzo boccale di vino, della natura del mezzo borgogna, ma più delizioso d'assai. Fecero arrivarmi una seconda botte che mi tracannai nella stessa maniera, poi feci segni per nuovo vino, ma non ne avevano lì altro da darmi. Terminate che ebbi queste meraviglie, misero grida e salti di gioia sopra il mio corpo, ripetendo più volte quelle parole della prima volta: Hekinah degul! Allora mi fecero segno di gettar giù le due botti, raccomandando per prima cosa ai passeggeri di tirarsi da banda e gridando forte: Borach mevolah; poi quando videro le botti in aria, fu un grido universale: Hekinah degul!
Confesso che mentre costoro passeggiavano così in lungo ed in largo sopra il mio corpo, mi era venuta più d'una volta la tentazione di agguantarne con la mia mano sinistra una quarantina o una cinquantina dei primi che mi fossero venuti a tiro e batterli contro al terreno. Ma la ricordanza di quanto io aveva sofferto, nè forse era il peggio che avessero potuto farmi in quella mia posizione, e la parola d'onore che aveano ricevuto da me, perchè io riguardava per tale la rassegnazione data loro a divedere, mi scacciarono dalla testa un tale estro. Poi mi consideravo anche legato dai vincoli dell'ospitalità verso un popolo che m'avea trattato con tanta spesa e magnificenza. Ciò non ostante non potevo in mio cuore desistere dallo stupirmi dell'intrepidezza di quegli esseri in bassorilievo, che salivano e si diportavano sul mio corpo, mentre io aveva una mano libera, senza tremare alla vista d'una sì sterminata creatura com'io doveva ad essi parere.
Dopo qualche tempo, e quando videro ch'io non faceva più alcuna domanda di cibo, mi comparve innanzi un personaggio d'alto conto inviato da sua maestà imperiale. Sua eccellenza, dopo essere salita su la parte sottile della mia gamba destra, venne su fino alla mia faccia, e tratte fuori le sue credenziali, munite del regio suggello, che mi piantò rasente gli occhi, parlò all'incirca dieci minuti, senza manifestare alcuna sorta di sdegno, per altro con un certo fare risoluto, spesse volte accennandomi un punto in distanza, che seppi più tardi essere la metropoli del regno, lontana di lì un mezzo miglio a un dipresso, ove, dietro beneplacito manifestato da sua maestà nel consiglio de' suoi ministri, io doveva essere condotto. Gli risposi poche cose, ma che non istavano in tuono con la proposta; poichè gli feci un segno con la mia mano sciolta che portai su la legata (tenendola ben alta dalla testa di sua eccellenza per paura di buttar giù lui o il suo corteggio), indi mi toccai con la stessa mano il capo ed il corpo per fargli capire il mio desiderio di essere libero.
Parve in fatti che m'intendesse, perchè crollò la testa in atto di dire che non andava bene il mio conto, indi diede alla propria mano tale atteggiamento donde compresi che volea condurmi di lì in istato di prigioniero. Pur fece altri segni, bisogna rendergli questa giustizia, per significarmi che avrei avuto da mangiare e da bere pel mio bisogno, e che sarei stato trattato eccellentemente. Qui pure mi tornò la voglia di provarmi ad infrangere i miei ceppi, ma sentii di nuovo il dolore della mia faccia e delle mie mani piene in parte di pustole, grazie al complimento degli spilli che vi erano stati scoccati, e alcuni de' quali ci rimanevano tuttavia conficcati, ed osservai ad un tempo che il numero de' miei nemici andava crescendo. I miei cenni pertanto furono intesi ad accertarli che mi sarei acconciato in tutto e per tutto ai loro voleri. Dietro tal mia promessa l'hurgo ed il suo seguito partirono da me con civiltà ed ottima grazia.
Immediatamente dopo, udii un generale grido e ripetutamente esclamate queste parole: Peplom selan; poi mi sentii al fianco sinistro una gran folla di gente, la quale allentò i miei legamenti tanto che fui in istato di voltarmi sul destro e dispormi ad una operazione che la mia vescica piena rendea d'inevitabile necessità: al qual bisogno soddisfeci compiutamente a grande stupore di quella popolazione che, dal primo mio atto, avendo congetturato benissimo che cosa fossi per fare, si aperse immediatamente in due ale a destra e a sinistra per non rimanere sommersa dal torrente che con tanta violenza e strepito sgorgò dal mio corpo.
Ma io dovea dire come prima di questo incidente, m'avessero spalmate le mani e la faccia con certo unguento piacevole all'odorato, che in pochi minuti mi fece passare tutto il dolore derivato dalle loro frecce. Queste circostanze, unite al ristoro portatomi dai nudrimenti e dalle bevande che mi recarono, il tutto d'una sostanza assai nutritiva, mi disposero al sonno. Dormii circa otto ore, come ne venni assicurato da poi, nè c'era di che stupirne, perchè i medici mandatimi per ordine dell'imperatore, aveano versata una dose di sonnifero nelle botti del vino che io aveva bevuto.
Sembra che fin dall'istante del mio primo addormentamento su la spiaggia, gli abitanti di que' dintorni, accortisi del prodigioso gigante dormente, ne avessero spedita per espresso la notizia all'imperatore, e che questi in pien consiglio mettesse subito il decreto perchè fossi legato nella maniera che vi ho descritta; la qual fazione seguì nella notte stessa mentre io era immerso nel sonno; sembra pure che nel medesimo tempo ordinasse l'apparecchio delle vettovaglie inviatemi e la fabbricazione di una macchina da trasporto per condurmi alla metropoli.
Una tal decisione può forse apparire arrischiata e pericolosa al massimo grado, e credo che nessun sovrano dell'Europa, in uguale occasione, la prenderebbe ad esempio. Pure a mio avviso fu una decisione circospetta e generosa oltre ogni dire. Mettete un poco che quegli abitanti si fossero provati, mentre io dormiva, ad ammazzarmi con quelle loro frecce, con quelle loro lancie. Mi sarei certamente svegliato alla prima sensazione di dolore, e questo avrebbe incitata la mia rabbia e le mie forze al segno di rompere, a costo di far male a me stesso, que' legamenti che mi teneano; e sciolto che fossi stato, quegli omettini inabili a resistermi non avrebbero potuto aspettarsi misericordia da me.
È a sapersi che quel popolo era potente nelle matematiche, ed avea raggiunta una grande perfezione nelle meccaniche, mercè le disposizioni e gl'incoraggiamenti di quel monarca, famoso proteggitore delle scienze e dell'arti. Ha questi al suo comando parecchie macchine su le ruote pel traslocamento d'alberi e d'altri grandi pesi. Spesse volte fa fabbricare le sue navi da guerra, alcune delle quali hanno sin nove piedi di lunghezza, nelle foreste stesse ove abbonda il legname da costruzione, e tali navi, poste su le macchine dianzi accennate, fanno viaggi di trecento, di quattrocento braccia per giugnere al mare. Cinquecento carpentieri ed ingegneri pertanto furono messi in opera per allestire uno de' maggiori carri che avessero. Il corpo di questo carro, alto quattro dita da terra, avea sette piedi di lunghezza e quattro di larghezza, e si movea sopra ventidue ruote. Quel grido Peplom selan che udii prima d'addormentarmi la seconda volta, contrassegnava l'arrivo di questo carro, posto all'ordine, a quanto sembra, in quattro ore di tempo dopo il mio arrivo. La macchina fu portata parallela al mio corpo giacente. Ma la difficoltà principale consistea nel sollevarmi da terra e mettermi steso su questo carro. Vennero alzati a tal uopo ottanta pilastri, alti un piede ciascuno, e gagliardissime funi, della grossezza dello spago degli uffizi di spedizione, furono attaccate con uncini a larghe fasce, di cui gli operai subalterni aveano cinto il mio collo, le mie mani, la mia vita e le mie gambe. Novecento tra i più vigorosi facchini, addetti al dicastero del genio, furono scelti per tirarmi su mediante un apparato di girelle poste all'estremità d'ogni colonna, di modo che in men di tre ore fui levato da terra, portato e disteso e legato stretto sul carro. Tutte queste cose mi vennero raccontate, perchè mentre si faceano, io era immerso nel più profondo sonno per una conseguenza de' narcotici infusi entro il mio vino. Mille e cinquecento de' più grossi cavalli dell'imperatore, ciascuno alto quattro dita e mezzo, vennero adoperati per condurmi alla volta della metropoli che, come ho detto, era lontana di lì un mezzo miglio.
Quattro ore circa dopo esserci messi in viaggio, mi svegliai per un caso il più ridicolo. Essendo avvenuto che il carro si fermasse un istante per raggiustare alcun che di andato fuor d'ordine in quella compostissima costruzione, due giovani nativi, mossi dalla curiosità di vedere che figura io facessi addormentato, s'arrampicarono tanto che arrivarono ad entrare nel carro; poi, avvicinatisi pian piano alla mia faccia, l'un d'essi, un uficiale della guardia imperiale, introdusse nella mia narice sinistra un buon tratto della sua picca, che facendomi il solletico in quella parte come se fosse stata una paglia, mi promosse un violento starnuto; il che gl'indusse a battersela alla presta per paura di essere veduti. Sol tre settimane dopo, seppi il motivo di questo subitaneo mio svegliamento. Marciammo lentamente tutto il restante di quella giornata, e fermatici la notte, rimasero sino a giorno schierate ai lati del mio carro cinquecento guardie, la metà munite di torce a vento, l'altra metà di archi e di frecce per esser pronte a scaricarle su me se avessi tentato disciogliermi. Nella successiva mattina, al levar del sole ci rimettemmo in cammino, ed era all'incirca il mezzogiorno quando ci trovammo ad una distanza di duecento braccia dalla città. L'imperatore e tutta la sua corte ne vennero incontro, ma i suoi grandi uficiali non vollero comportare in verun modo ch'egli s'avventurasse a salir sul mio corpo.
Laddove si fermò il carro sorgeva un antico tempio, giudicato il più vasto che vi fosse nell'intera monarchia. Contaminato, alcuni anni addietro, da un esecrabile omicidio, il religioso zelo di que' popoli lo ebbe per profano da quell'istante, onde non servì più che ai bisogni del comune, e tutti i sacri arredi e suppellettili del medesimo vennero trasportati altrove. Entro questo edifizio fu deciso che sarei alloggiato. La porta maggiore che guardava a settentrione, era alta a un dipresso quattro piedi e larga quasi due, onde, benchè un po' a stento, io poteva far passare per essa il mio corpo. A ciascun lato della porta era una finestra non più alta di sei dita da terra. In quella di sinistra il fabbro ferraio di sua maestà fermò novant'una catene, simili a quelle che vediamo ai dì nostri (nel 1726) pendere dagli orologi delle signore in Europa, e quasi altrettanto larghe, le quali catene venivano a cignere la mia gamba sinistra, e ve le fermavano trentasei chiavistelli. Rimpetto a questo tempio, all'altro lato della grande strada maestra, e ad una distanza di venti piedi sorgeva una torre di cinque piedi almeno d'altezza. In questa salì l'imperatore coi primari personaggi della sua corte, per avere il comodo di ben osservarmi; così mi fu detto, perchè io non potei allora avere la fortuna di vedere questi alti personaggi. Fu fatto un computo da cui risultò che cento mila abitanti all'incirca della metropoli ne erano usciti, tutti spinti dalla medesima curiosità; e, a malgrado degli sforzi delle mie guardie, credo non saranno stati meno di diecimila quelli che per più riprese salirono sul mio corpo col mezzo di scale. Fu presta per altro ad uscire una grida che proibiva il far ciò sotto pena di morte. Poichè gli esperti ebbero giudicato cosa impossibile che mi sciogliessi dalle nuove catene, vennero tagliate tutte le cordicelle che mi legavano prima; onde mi trovai in piedi, dominato da un mal umore, di cui non ho mai provato l'eguale in mia vita. Ma non vi so descrivere lo strepito e lo stupore di quella popolazione al vedermi saltare in piedi e camminare; e dico camminare, perchè le catene che legavano la mia gamba sinistra erano lunghe circa due braccia, e mi davano la libertà di girare innanzi addietro, stando sempre nondimeno in quella periferia; mi procuravano un altro vantaggio, che essendo cioè infitte alle pareti quattro dita al di dentro della porta, mi permettevano il ficcarmici entro e giacervi con tutta la lunghezza del mio corpo.