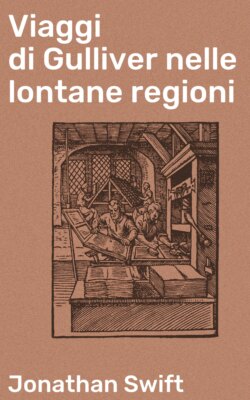Читать книгу Viaggi di Gulliver nelle lontane regioni - Jonathan Swift - Страница 9
ОглавлениеMantua, væ! miseræ nimium vicina Cremonæ!
ad una signora che col suo manto gettò in terra un violino di Cremona.
Più grottesco è il giuoco di parole con cui confortò un uomo attempato che aveva perduto i suoi occhiali, ma un Italiano non ne comprende la forza se non sa o non si ricorda che in inglese spectacles vuol dire occhiali. Il verso consolatorio fu questo:
Nocte pluit tota, redeunt spectacula mane.[13]
La sua superiorità in un genere di spirito più reale è confermata da parecchi aneddoti. Un personaggio ragguardevole, di condotta non troppo regolare, aveva per impresa gentilizia le parole: Eques haud male notus. Swift la comentò in questo modo: Sì ben noto che se ne fidano poco. Aveva una passione tutta sua d'improvvisare proverbi. Un giorno, in compagnia d'altri suoi conoscenti, passeggiava lungo il giardino d'un suo amico, e vedendo che il padrone del giardino non pensava ad offrirgli un frutto, disse: — La mia povera madre m'insegnava questo proverbio:
Quando a tiro hai la pesca
Di corla non t'incresca.
Always pull a peach
When it is in your reach.
Detto ciò, diede ai compagni il buon esempio di spiccarsi le pesche da sè.
Un'altra volta, egli ed un amico passeggiando a cavallo, il compagno cadde col suo cavallo, senza per altro farsi male, entro un pantano; Swift esclama:
Più è il fango, men disagio
Soffri nel tuo naufragio.
The more dirt,
The less hurt.
L'uomo caduto si levò quasi contento della sua caduta, perchè amava anch'egli i proverbi, e si maravigliava di non aver mai udito questo, che in realtà il decano aveva improvvisato opportunamente in quel momento. Swift si dilettava ancora di comporre adagi rimati; il suo giornale a Stella prova come a tutte le menome occasioni avesse pronta la rima.
Fu sollecito oltre ogni dire dell'esterna mondezza, sollecitudine che portò sino allo scrupolo; amava grandemente gli esercizi della persona, massime il camminare a piedi. I moderni nostri camminatori riderebbero della scommessa ch'egli fece di andare a piedi a Chester, facendo dieci miglia per giorno (un viaggio di circa dugento miglia); non è men vero che, a quanto si crede, Swift faceva troppo esercizio, e che la sua salute ne soffriva. Era assai buon cavallerizzo, cavalcava molto, e s'intendea di cavalli; scelse questo nobile animale per farne l'emblema del merito morale sotto il nome di houyhnhnm. Swift sollecitava le persone alle quali era affezionato, singolarmente Stella e Vanessa, a far molto esercizio; a queste ne faceva pressochè un dovere. Non vi è quasi una sola delle sue lettere, nella quale non finisca parlando dell'esercizio del corpo come di cosa essenziale alla propria salute, che rendevano sì incerta la sordità e gli svenimenti cui andava soggetto. Il suo fisico soffriva d'un'affezione scrofolosa, che precipitò forse il disordinamento della sua mente, benchè ne sia stato immediata cagione un dilatamento di serosità al cervello, come rimase comprovato nella sezione del suo cadavere.
La beneficenza del decano si manifestava con atti superiori d'assai alla carità ordinaria. Portava sempre con sè una certa somma ripartita in diverse qualità di monete per distribuirle proporzionatamente a coloro che gli sembrassero meritevoli di soccorso; chè il suo grande scopo era quello di aiutare i veri bisognosi senza esporsi possibilmente al rischio di essere ingannato dalla infingardaggine. Scrisse parecchi trattati su questi argomenti.
Veniva ricevuto per ogni dove con contrassegni del più profondo rispetto, e solea dire che avrebbe bisognato istituire una colletta per mantenerlo di cappelli, perchè i suoi erano frusti in un attimo a furia di restituire i saluti che gli venivano fatti. Una volta fece una prova assai gaia della fede che il pubblico prestava ad ogni suo detto. Si era unita una grande folla attorno al suo decanato per vedere un'eclissi. Swift, importunato dallo strepito, fece dire a quella gente che per ordine del decano di San Patrizio l'eclissi veniva differita. Un tale annunzio straordinario fu accolto sul serio, e la calca immantinente si dissipò.
Considerato Swift quale scrittore, il suo carattere presenta tre notabili particolarità. La prima (qualità che lo distingue, e che ben di rado è stata accordata, almeno dai suoi contemporanei, ad un autore), è l'originalità. Il medesimo Johnson confessa non esservi stato forse un solo autore che abbia sì poco accattato dagli altri, siccome Swift, e che per conseguenza abbia altrettanti diritti ad essere considerato originale. Non era infatti stata pubblicata verun'opera che potesse servir di modello a Swift, e le poche idee da lui tolte ad altri son divenute sue per l'impronta che loro ha dato.
La seconda particolarità che abbiamo già fatta notare, si è l'assoluta indifferenza per la rinomanza letteraria. Swift si valea della sua penna come un volgare artigiano degli stromenti del proprio mestiere senza dar loro una grande importanza. Swift potea bene sentir ansia sul successo dei suoi ragionamenti, irritarsi delle contradizioni, prendersela contra gli avversari che facevano guerra ai suoi principii, e volevano impedirgli di raggiungere la meta cui aspirava, ma in ogni occasione mostrò pel buon successo dei propri scritti una indifferenza che presentava tutti i caratteri della sincerità. La non curanza con cui li lanciava nel mondo, il velo d'anonimo che cercava sempre di conservare, l'abbandono dei guadagni che potevano derivargliene, dimostrano com'egli disdegnasse il mestiere d'autore di professione.
La terza singolarità dalla quale andava contraddistinto il carattere letterario di Swift si è che, eccetto la storia, non si è mai provato in veruno stile di componimento, senza riuscirci. Ognuno comprende ch'io non intendo ora parlare d'alcuni saggi pindarici o de' suoi versi latini, cose di troppo lieve importanza, perchè se ne tenga qui un conto. Certamente si può dar la taccia di frivola o di assai volgare alla maniera onde talvolta ha messo in opera il suo talento: pure i suoi versi anglo-latini, i suoi enigmi, le sue descrizioni poco dilicate, le sue violenti satire politiche sono nel loro genere perfette altrettanto quanto lo comporta il soggetto, e lasciano l'unico rincrescimento di non vedere un sì bel genio impiegato nel trattare argomenti più nobili.
Nella finzione egli possedeva in supremo grado l'arte della verisimiglianza, o come lo abbiamo osservato nei Viaggi di Gulliver, l'arte di pignere e sostenere un carattere fittizio in tutti i luoghi ed in tutte le circostanze. Una gran parte di questo secreto consiste nell'esattezza dei piccioli fatti staccati che formano siccome il prologo o, per così esprimerci, la sinfonia di una storia raccontata da un testimonio oculare. Tali sono le cose che direbbesi non interessar vivamente altri fuor del narratore. Son queste la palla d'archibuso che fischia all'orecchio del soldato, e fa più impressione in lui di tutta l'artiglieria che di poi non ha cessato di tuonare durante l'intera battaglia. Ma per uno spettatore posto in distanza tutte quelle prime minuzie vanno perdute nel corso generale degli avvenimenti. Ci voleva tutto il discernimento di Swift o di De Foe, autore del Robinson Crusoè e delle Memorie d'un soldato di cavalleria, per afferrare i minuti incidenti atti a fare impressione su lo spettatore che la levatura del suo ingegno e della sua educazione non hanno assuefatto a comprendere le cose sotto un aspetto di generalità. L'ingegnoso autore della Storia della finzione, il signor Dunlop, mi ha preceduto nel paralello ch'io mi era prefisso d'istituire tra il romanzo di Gulliver e quello di Robinson Crusoè. Mi gioverò delle sue espressioni che rendono le mie proprie idee.
Dopo avere dispiegata la sua proposizione dimostrando come Robinson Crusoè renda verisimile il suo racconto d'una tempesta, «quei minuti particolari (egli dice) ne portano a credere tutto il resto della narrazione. Niuno s'immagina che il narratore avesse fatto menzione di simili bagattelle se non fossero state vere. Queste medesime bagattelle sono da notarsi nei Viaggi di Gulliver; ne guidano in parte a credere i racconti meno probabili.»
Niuno ha mai revocato in dubbio il genio di De Foe, ma non era gran fatto estesa la sfera delle sue cognizioni: donde procede che la sua immaginazione non ha potuto creare al di là d'uno o due eroi delle sue finzioni: un marinaio ordinario come Robinson Crusoè, un soldato grossolano come il suo soldato di cavalleria, alcuni cialtroni di bassa condizione come alcuni altri personaggi fittizi, ecco le sole parti che l'estensione delle sue cognizioni gli permetteva di far comparire su la scena. Egli si è precisamente trovato nel caso dello stregone indiano, la cui virtù magica non va più oltre dell'aiutarlo a trasformarsi in due o tre animali. Swift è il dervis persiano che ha la potestà di far passare la sua anima nel corpo ove le piace trasmigrare, di vedere cogli occhi del nuovo corpo, d'adoperarne gli organi, d'impadronirsi perfino dell'intelletto che lo animava. Lemuel Gulliver, l'astrologo Isacco Bickerstaff, il Francese che scrive il nuovo viaggio a Parigi, mistress Harris, Maria la cuciniera, l'Uomo che con l'intenzione di sollevare i poveri, divisa di mangiare i loro figli, il violento politico Whig che fa rimostranze su le insegne di Dublino, son personaggi disparati fra loro altrettanto quanto appariscono esserlo col decano di San Patrizio. Ciascuno serba il proprio carattere, ciascuno si move nella sua propria sfera, sempre colpito da quelle circostanze che la sua posizione sociale o la sua maniera di vedere gli hanno rese più interessanti come individuo.
La proposizione che ho stabilita su l'arte di dare verisimiglianza ad un racconto immaginario, trova il suo corollario nel principio medesimo. Giova che minute circostanze facciano impressione su lo spirito del narratore ed usurpino una certa parte del suo racconto, e giova ad un tempo che circostanze più importanti di propria natura conciliino solo in parte la sua attenzione, o in altri termini, così in un racconto, come in un quadro, vi è una lontananza ed un primo piano; e la scala visuale degli oggetti decresce a proporzione del loro allontanarsi da chi li racconta. Nè in ciò è men notabile l'arte di Swift; Gulliver racconta d'una maniera più vaga le cose giunte per voce d'altri al suo orecchio che non quelle di cui vuol far credere d'essere stato testimonio egli stesso. Non trovate qui come negli altri viaggi ai paesi d'utopia, un quadro esatto del governo e delle leggi di quelle contrade, ma le nozioni generali che un viaggiatore curioso cerca procacciarsi nell'intervallo di alcuni mesi del suo soggiorno fra gli stranieri. In somma il narratore è il centro, il grande organo della storia; non racconta fatti che le circostanze non gli abbiano permesso di osservare, ma non ne omette veruno, le cui circostanze connettendosi a dirittura con lui lo rendano importante ai suoi occhi.
Le principali opere in prosa di Swift sono le Fole (Tales of a tub), il Viaggio di Gulliver, le Lettere del Pannaiuolo; le migliori in versi sono il Club della legione, Cadeno e Vanessa, poema, la Rapsodia su la poesia. Alcune di queste traggono in molta parte il loro vezzo dalle circostanze che le inspirarono all'autore e dalla natura dei tempi in cui vennero pubblicate. Fra le molte e notabili produzioni di questo autore che Voltaire chiama il Rabelais dell'Inghilterra, il Gulliver è l'opera meglio destinata a vivere presso la posterità. È per altro giustizia il dire che un'opera di tanta levatura basta di per sè sola a stabilire una rinomanza.