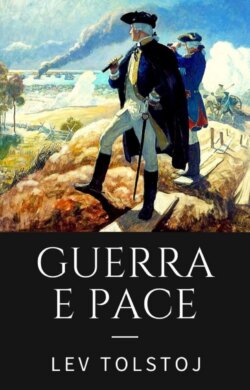Читать книгу Guerra e pace. Ediz. integrale - Lev Tolstoj, Lev Tolstoj - Страница 34
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеIl reggimento ussari di Paulograd era accampato a due miglia da Braunau. Lo squadrone, cui era addetto Nicola Rostow col grado di alfiere, occupava il villaggio tedesco di Salzeneck. L’alloggio migliore era stato destinato al capo squadrone, capitano Denisow, conosciuto in tutta la divisione col nome di Vasca Denisow. Insieme con lui alloggiava Rostow, fin da quando avea raggiunto in Polonia il reggimento.
L’8 di Ottobre, quel giorno stesso in cui il quartier generale era sottosopra per la sconfitta di Mack, lo squadrone seguitava tranquillamente nella sua vita di campo. Denisow, che tutta la notte avea perduto alle carte, non era ancora rientrato a casa, quando già Rostow di buon mattino tornava a cavallo dalla distribuzione dei foraggi. Arrivato a piè della scala, stazzonò sul collo il cavallo, gettò indietro con atto svelto una gamba, stette un po’ in bilico col piede nella staffa, come se a malincuore si staccasse dall’animale, e finalmente balzò in terra e chiamò il piantone.
— A te, Bondarenco, fa il piacere, – disse gettando le redini ad un ussaro che accorreva. – Fallo passeggiare, – soggiunse con quella aperta, fraterna confidenza che è propria dei bravi giovani quando si sentono felici.
— Pronto, vostra signoria! – rispose il piccolo russo, scotendo tutto lieto la testa.
— E bada veh, adagino!
Un altro ussaro si precipitò verso il cavallo, ma Bondarenco s’avea già avvolto le redini al polso. L’alfiere, si vedeva, era prodigo di mance, e tornava conto di servirlo. Rostow stazzonò di nuovo il cavallo sul collo e sulla groppa e si fermò sulla scala.
— Bell’animale! è un amore! – disse fra sè. Poi, sorridendo sempre, sollevò con la sinistra la sciabola, e montò in fretta le scale facendo suonar gli sproni. Il Tedesco, proprietario della casa, in camiciola e berretto, con in mano una forcina per rimuovere il letame, fece capolino dalla stalla delle vacche, e in vedere il giovane, sorrise bonariamente e ripetè due volte: «Buon giorno! buon giorno!»
— Di già al lavoro, eh? – disse Rostow, sempre allegro e confidente. – Evviva gli Austriaci! evviva i Russi! Urrà all’imperatore Alessandro!
Erano le esclamazioni favorite del Tedesco, il quale, uscito dalla vaccheria, agitò in aria il berretto e gridò a gola spiegata:
— Evviva tutto il mondo!
— Evviva! – gli fece eco Rostow imitandone il gesto. Benchè non ci fosse motivo di giubilo nè pel Tedesco che ripuliva la stalla nè per Rostow che tornava dai foraggi, i due uomini si guardavano con affetto fraterno, si scambiavano sorrisi e saluti, manifestavano in tutti i modi la gioia dell’animo. Dopo di che, l’uno rientrò nella stalla, l’altro in camera sua.
— Che n’è del padrone? – domandò Rostow a Lavruscka.
Era questi l’attendente di Denisow, un birbone matricolato noto all’intero reggimento.
— Da ieri sera è fuori. Deve aver perduto. Quando vince, torna presto a casa, e pare che sia suo tutto il mondo; se non viene fino a giorno, vuol dire che l’han pelato, e allora è fuori della grazia di Dio. Posso servire il caffè?
— Sì, sì, portamelo.
Di lì a dieci minuti, Lavruscka tornò col caffè.
— Viene! – disse. – Adesso sì, che son guai!
Rostow guardò dalla finestra, e vide venir Denisow. Era questi un omicciattolo, rosso in viso, dagli occhi lucidi, dai capelli e dai baffi neri ed irsuti. Aveva la casacca di pelo sbottonata, il berretto sulla nuca, i larghi calzoni cascanti. Accigliato, a capo basso, si avvicinava alla scala.
— Lavruscka! – gridò appena entrato, biascicando la lettera r. – Su, animale, toglimi questa roba di dosso!
— Gli è quel che faccio, – rispose l’attendente.
— Ah! sei già in piedi, Rostow!
— Da un pezzo. Sono già andato pel fieno e ho anche visto la Matilde.
— Bravo! Ed io, figlio d’un cane, m’han conciato per le feste... Che disdetta! che disdetta! Appena andato via tu, non ne azzeccai più una. Ehi, qua il tè!
Arricciava la fronte, torceva la bocca, mettendo in mostra i denti piccoli e forti, si cacciava le dita nella selva fitta dei capelli, si fregava il viso e la fronte.
— Il diavolo mi trascinò dal sorcio (era il nomignolo d’un ufficiale). Non una carta, figurati, quel che si dice una!... Ogni posta semplice me la porta ai sette cieli... Ad ogni colpo, mi appioppa un pàroli!
Afferrò la pipa accesa, che l’attendente gli porgeva, ne sprizzò il fuoco da tutte le parti, la scaraventò a terra, rompendola in cento minuzzoli. Poi, calmatosi di botto, volse su Rostow i neri occhi luccicanti.
— Almeno ci fossero delle donne! Signor no! Non si può far altro che bere... E quand’è che si potrà menar le mani? Ohe! chi è di là? che altra diavoleria?
Di là della porta, si udì un rumor di grosse scarpe, accompagnato da un tintinnio di sproni e da una tosse rispettosa.
— Il maresciallo d’alloggio! – disse Lavruscka.
Denisow si rabbuiò da capo.
— Brutt’affare!... Rostow, fa il piacere, conta un po’ quanto avanza in questa borsa (e gliela gettava), e poi riponila sotto il guanciale.
Ciò detto, andò dal maresciallo ch’era di fuori. Rostow vuotò la borsa, e prese a far tanti mucchietti di monete d’oro, contando diligentemente.
— Ah! Telianin! Ben venuto! Lo sai? Mi hanno spennato ieri sera, – suonò dall’altra camera la voce di Denisow.
— Da chi? da Bicow forse, dal sorcio?... Lo sapevo io, – rispose una vocina stridente, e subito dopo entrò in camera il luogotenente Telianin, ufficiale dello stesso squadrone.
Rostow cacciò la borsa sotto il guanciale e prese la piccola mano umidiccia che l’ufficiale gli porgeva. Telianin, prima che la campagna incominciasse, era stato escluso, per una cosa o per l’altra, dal reggimento della Guardia. Serbava ora una buona condotta; nessuno però lo amava, e Rostow in ispecie non riusciva a vincere nè a nascondergli un senso di sconfinata antipatia.
— Ebbene, giovane cavalleggiero, come vi serve il mio Corvetto? – domandò Telianin (Corvetto era il cavallo che avea venduto a Rostow). Il luogotenente non guardava mai in viso alla persona cui parlava; volgeva qua e là di continuo gli occhi irrequieti. – Stamane, vi ho visto fare una trottatina.
— Ma... non c’è male, un discreto cavallo, – rispose Rostow, benchè la bestia, pagata da lui 700 rubli, non ne valesse nemmeno la metà. – Ha preso un po’ a zoppicare sulla sinistra anteriore.
— Niente, niente... Si sarà spaccata l’unghia. V’insegnerò io una saldatura eccellente.
— Mi farete finezza.
— Non è mica un segreto... E quanto all’animale, mi ringrazierete.
— Vado a dare ordine che lo portino fuori, – disse Rostow, tanto per liberarsi da Telianin, e si allontanò.
Denisow, accoccolato sulla soglia dell’anticamera, con la pipa fra i denti, discorreva col maresciallo d’alloggio. Vedendo Rostow, corrugò la fronte, e additando col pollice di sopra la spalla verso la camera dove Telianin era rimasto, fece una eloquente smorfia di fastidio.
— Non mi garba punto quel giovanotto, – disse senza curarsi della presenza del maresciallo.
Rostow scrollò le spalle, come per dire: «E a me neppure; ma che farci?» Poi, dati gli ordini opportuni, tornò da Telianin, e lo trovò, come già lo avea lasciato, indolentemente seduto e fregandosi le mani bianche e minuscole.
«Se ne danno pur troppo di questi tipi ributtanti!» pensò Rostow, entrando.
— Sicchè, avete fatto tirar fuori l’animale?
— Sì.
— Andiamo dunque. Io son passato di qua, sol per domandare a Denisow se avea ricevuto l’ordine del giorno di ieri. L’avete ricevuto, Denisow?
— Non ancora. E voi dove andate?
— Voglio far vedere a questo giovanotto come si ferra un cavallo.
Discesa la scala, entrarono nella scuderia. Il luogotenente mostrò come s’avesse a fare la famosa saldatura dell’unghia, e se n'andò pei fatti suoi.
Tornato in camera, Rostow trovò sulla tavola una bottiglia d’acquavite e delle salsicce. Denisow, curvo sopra un foglio, facea stridere la penna scrivendo in furia. Alzò gli occhi, e guardò torvo all’amico.
— Scrivo a lei. – disse, appoggiandosi coi gomiti sulla tavola, contento di potere esporre col vivo della voce tutto ciò che si disponeva a scrivere. – Tu lo vedi, amico mio. Finchè non si ama, si dorme, noialtri figli della polvere... Ma appena ti spunta dentro l’amore, eccoti divenuto un nume, eccoti puro come al primo giorno della creazione... Che altro c è? Mandalo al diavolo! non ho tempo! – gridò di botto a Lavruscka che gli si accostava senza cerimonie.
— Ma chi volete che sia? Voi stesso l’avete ordinato. È il maresciallo che è venuto pei danari.
Denisow stava per gridar dell’altro, ma si contenne.
— Che seccatura! – brontolò poi. — Quanto ci avanza nella borsa, Rostow?
— Sette rubli nuovi, e tre di vecchio conio.
— Brutto affare! Orsù, che mi fai costì impalato? Vada via il maresciallo, e tutti lesti!
— Dà retta, Denisow, – disse Rostow arrossendo, – se vuoi, te li presto io...
— Non mi piace pigliare a prestito dagli amici.
— Se non accetti, sai, me l’avrò a male. Io ne ho dei danari.
— Ma no, ti ripeto, no!
E Denisow andò versò il letto, per prender la borsa di sotto al guanciale.
— Dove l’hai messa, Rostow?
— Sotto al primo guanciale.
— Ma qui non c’è nulla...
I due guanciali volarono, uno dopo l’altro per terra. La borsa non c’era.
— Oh questa sì ch’è bella!
— Aspetta, l’avrai fatta cadere...
Rostow raccattò e scosse i due guanciali. Tirò giù la coperta e scosse anche questa. Niente borsa.
— O che mi sia scordato?... Ma no, no... M’è venuto perfino in mente che tu ti mettessi un tesoro sotto la testa, ed ho ficcato ben dentro la borsa preziosa. Dove sarà mai? – si volse Rostow all’attendente.
— Io non son nemmeno entrato. Dove la metteste, là dev’essere.
— Ma non c’è.
— Una distrazione, si capisce. Avete creduto di metterla e ve ne siete scordato. Frugatevi nelle tasche.
— Ma che tasche! Se non avessi avuto quell’idea del tesoro... E poi ricordo benissimo di averla messa.
Lavruscka buttò all’aria lenzuola e materassi, guardò sotto il letto, sotto la tavola, per tutti gli angoli e i ripostigli, e rimase poi ritto in mezzo alla camera. Denisow in silenzio ne avea seguito tutti i movimenti, e quando lo vide smettere e allargar le braccia in segno di non aver trovato, si volse a Rostow.
— Rostow, tu non sei mica un ragazzo...
Rostow, sentendo fisso su di sè lo sguardo di Denisow, alzò gli occhi e nel punto stesso gli abbassò. Tutto il sangue agglomerato più in giù della gola gli affluì alle guance e nelle pupille. Una strana oppressura gl’impediva di trarre il fiato.
— E in camera poi, – osservò Lavruscka, – non ci siete stato che voi e il luogotenente. In qualche parte la borsa dev’essere.
— E tu, fantoccio del diavolo, muoviti, cerca! – gridò Denisow, facendosi paonazzo e scagliandosi minaccioso sull’attendente. – Venga fuori la borsa, o saranno legnate! Legnate a tutti!
Rostow, gettata un’occhiata a Denisow, si abbottonò la giubba, si affibbiò la sciabola e prese il berretto.
— Fuori la borsa, ti dico! – urlò Denisow, scotendo per le spalle l’attendente e urtandolo contro la parete.
— Lascialo stare, Denisow; io so chi ha preso la borsa, – disse Rostow, avviandosi alla porta e senza alzare gli occhi.
— Eh via, sciocchezze! – e le vene del collo e della fronte gli si gonfiavano come corde. – Io ti dico, io, che sei pazzo... Io non tollero certe cose... La borsa è qui. Gli strapperò la pelle a questo furfante, e la borsa verrà alla luce.
— Io so chi l’ha presa, – ripetette Rostow con voce tremante, e fece ancora un passo per uscire.
— Ed io ti dico, che non te n’andrai, no, – gridò Denisow, facendo atto di trattenerlo. Ma Rostow si divincolò con furia, e lo guardò fiso negli occhi con tanta ira, quanta ne avrebbe volta al maggior suo nemico.
— Capisci tu quel che dici? – e gli tremava la voce. – Fuori di me, nessun altro è stato in questa camera. Vuol dire dunque, che se altri non l’ha presa, allora...
Non potè compir la frase e si allontanò correndo.
— Ah, che il diavolo vi pigli, te e tutti quanti! – furono le ultime parole che gli giunsero.
Rostow si diresse all’alloggio di Telianin.
— Il padrone è fuori, – rispose l’attendente. – È andato allo stato maggiore. Ma che forse qualche cosa è successa? – soggiunse, notando il viso sconvolto del visitatore.
— No, niente.
— Per poco non l’avete trovato. Proprio adesso è uscito.
Lo stato maggiore si trovava a tre verste da Salzeneck. Rostow, senza tornare a casa, balzò in sella e mosse a quella volta. Nel villaggio, che lo stato maggiore occupava, sorgeva un’osteria, frequentata dagli ufficiali. Rostow vi si recò. Sull’ingresso, vide il cavallo di Telianin.
Nella seconda camera, il luogotenente se ne stava seduto davanti a un piatto di salsicce e una bottiglia di vino.
— Ah, eccovi qui anche voi, giovanotto! – disse sorridendo e alzando le ciglia.
— Sì, – rispose Rostow fra i denti, e prese posto alla tavola accanto.
C’erano anche nella camera due Tedeschi e un ufficiale russo. Tutti tacevano, non s’udiva che il rumor dei coltelli sui piatti e il masticar del luogotenente. Terminata la colazione, Telianin cavò di tasca una borsa allungata, ne fece scorrere l’anello con le piccole dita ricurve, ne prese una moneta d’oro e la gettò al tavoleggiante.
— Sbrigatevi, prego, – disse.
La moneta era nuova. Rostow si alzò e si accostò a Telianin.
— Vogliate mostrarmi cotesta borsa, – disse con voce sommessa, udibile appena.
Telianin, sempre con gli occhi vaganti e le ciglia alzate, gliela porse.
— Sì, una graziosa borsetta... Sì... sì, – disse, facendosi pallido. – Guardatela, giovanotto, guardatela pure.
Rostow la prese, la osservò, diè uno sguardo al contenuto, e poi si volse a Telianin. Il luogotenente, come al solito, guardava intorno di qua e di là, e di botto parve invaso da un accesso di buon umore.
— Quando saremo a Vienna, avrò modo di vuotarla... Qui, in questi miserabili paesucoli, non c’è come spendere un soldo... Orsù, date qua, giovanotto, vado via.
Rostow taceva.
— Sicchè, anche voi volete far colazione?... Si mangia benino qui... Via, rendetemi la borsa...
E stesa la mano, la prese, se la cacciò nella tasca dei calzoni, mentre alzava indifferente le ciglia e leggermente apriva la bocca, come per dire che quella lì era roba sua, che il mettersela in tasca era la cosa più naturale di questo mondo, e che a nessuno dovea dar conto dei fatti suoi.
— Ebbene, giovanotto? – disse poi, traendo un sospiro.
I loro occhi s’incontrarono, e parve che una scintilla ne partisse.
— Venite qua, – disse Rostow, pigliandolo pel braccio, e quasi trascinandolo verso la finestra. – Cotesti danari son di Denisow... e voi li avete presi, – gli bisbigliò all’orecchio.
— Che?... che?... Come vi permettete voi?...
Le parole tronche suonarono come un grido disperato, come una domanda di perdono. Erano nè più nè meno che una confessione. Rostow n’ebbe un senso di sollievo, e nel punto stesso fu preso da una profonda pietà per il disgraziato. Ma bisognava pur troppo compire l’opera incominciata.
— Chi sa che penserà questa gente qui, – balbettò Telianin, prendendo il berretto e avviandosi verso l’altra camera vuota. – Bisogna che vi spieghi...
— Non serve. So tutto oramai, – rispose Rostow.
— Ma io...
Pallido, smarrito, gli tremavano tutti i muscoli del viso; gli occhi erravano sempre, ma non osavano alzarsi; una specie di rantolo gli stringeva la gola.
— Conte!... ve ne scongiuro, non mi rovinate... Pigliate... Eccovi questi maledetti danari, – e li gettava sulla tavola. – Pensate che ho una madre, un povero padre vecchio...
Rostow raccolse le monete, evitando di guardare a Telianin, e fece atto di uscire, senza articolare una sillaba. Si fermò nondimeno sulla soglia e tornò sui suoi passi.
— Dio mio! – disse con le lagrime agli occhi, – come mai v’è bastato l’animo...?
— Conte, ve ne prego! – balbettò Telianin, avvicinandosi.
— Non mi toccate! – esclamò Rostow, tirandosi indietro; – e se proprio ne avete bisogno, ecco, prendete.
E gettatagli la borsa, uscì concitato dall’osteria.