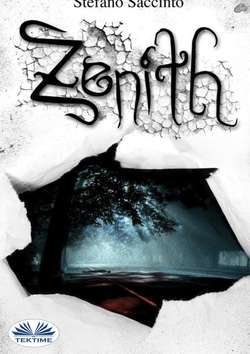Читать книгу Zenith - Saccinto Saccinto - Страница 5
Capitolo 1
ОглавлениеIl cielo era iniziato a venire giù dalla mattina presto di una giornata dei primi di luglio. Una raffica di grosse gocce di pioggia che sembrava un semplice temporale estivo aveva continuato a battere per tutto il tempo Colleterno, un avvallamento di case e altri edifici, per lo più abbandonati, disteso tra sette colli come Roma. Un posto quasi del tutto disabitato. Si diceva che gli avessero dato quel nome per via del vecchio cimitero delimitato da un basso e irregolare muro di tufi che circondava l'intera vetta della collina più alta, relegata per sempre nel silenzio e nella solitudine della morte.
Le strade di Colleterno erano state invase da fiumi d’acqua che si rigiravano contro gli spigoli dei marciapiedi, lo scroscio insistente di centinaia di fontane echeggiava lungo i canali e si amplificava nelle vie fino a insinuarsi nella testa come un insopportabile sottofondo mentale. Il freddo e il buio erano scesi con la rapidità di un'inaspettata invasione organizzata da forze soprannaturali. Al di là del volume impressionante di acqua, le auto, i pali della luce, i muri, le ringhiere dei balconi e gli angoli dei palazzi erano diventati deformi, ammorbiditi dall'umidità, quasi malleabili.
Avevo passato il pomeriggio con la fronte poggiata al vetro della portafinestra appannato regolarmente dal respiro, in piedi, nascosto in silenzio dietro una tenda come un'ombra immobile attratta dal richiamo di qualcosa di invisibile, a guardare il cielo di luglio piovere sulle terrazze delle case e colare giù per le ruvide facciate, rivestendo le strade, gli alberi e tutto quanto di un velo di piombo liquefatto che rifletteva oscurità. La città si era come diluita in una dimensione senza luce.
La paura di qualcosa di indefinito mi aveva tenuto in piedi contro il vetro per tutto quel tempo. Poi, quando la pioggia aveva smesso di colpo, mi ero risvegliato da quello strano, lunghissimo torpore. Avevo sfossato dall'armadio qualche indumento invernale e avevo scavalcato con un bacio le urla di mia madre che non voleva che uscissi. Avevo tirato lo scooter fuori dal garage e mi ero messo in strada. Avevo disceso il viale di casa lentamente, paralizzato dal freddo dell'aria e dall'oscurità che avvolgeva ogni cosa, col mento dentro il collo della felpa, le maniche fin sopra le dita e il collo incassato nelle spalle.
La casa dei miei nonni era al termine di un labirinto di stradine che portavano in un vicolo cieco e male illuminato alla periferia di Colleterno. All'esterno era un cubo sormontato dalla ringhiera del terrazzo, dalla facciata da rifare e con un solo finestrino grande quanto un libro, in corrispondenza del bagno. All'interno era un'unica stanza a pianterreno comprensiva di cucina, camera da letto e soggiorno, senza finestre. Le pareti screpolate si riunivano in una buia volta che il grande lampadario laccato in oro, dai portalampadine a forma di candele dentro bolle di vetro sottile, quasi non arrivava a illuminare. La pavimentazione era fatta da ruvide mattonelle opache a macchie frastagliate gialle e nere, divise da fughe larghe dentro le quali si formava una caratteristica forma di sporcizia umida e nera.
In sequenza ravvicinata c’erano una stufa a legno per cucinare, il tavolo e il letto. Ai piedi del letto c'era una cassapanca simile alla bara che Django si trascina per tutto un film e di fronte un armadio di legno scuro. Sul fianco dell'armadio qualcuno aveva avuto l'idea di appendere una stampa di Dalì con un manichino in posa drammatica pieno di cassetti. In un angolo irraggiungibile della stanza, sopra il materasso, dalla parte in cui il letto affiancava il muro, c’era una piccola mensola. Un cero, che mia madre continuava a sostituire e tenere acceso, illuminava i volti in bianco e nero di quattro giovani in foto, morti tempo prima. I loro occhi, accesi dal riflesso della fiamma, sembravano muoversi per la stanza. Non sapevo né chi fossero e né perché qualcuno avesse deciso di mantenerli vivi sul piccolo altare, sapevo solo che ogni volta che avevo trovato il coraggio di avvicinarmi a guardarli, da qualche parte nella mia mente una porta si era aperta e aveva cigolato su un corridoio oscuro e io avevo lasciato perdere le foto e mi ero costretto a ignorarle finché la porta nella mia mente non si era chiusa di nuovo.
L'odore di vecchio aveva ormai impregnato qualsiasi cosa all'interno della casa e ogni volta che ci andavo, mia madre riusciva a capirlo soltanto annusandomi i vestiti. L'avrebbe capito anche quella volta, ma i miei nonni erano andati via da un pezzo, avevo una copia delle chiavi e io e i miei amici non avevamo un altro posto dove andare a vedere la semifinale.
Quando i clacson delle moto suonarono dietro la porta di entrata, schiacciai l'ennesima sigaretta nel portacenere e andai ad aprire con una mano sugli occhi per proteggermi dai fari. Alzai la testa. Un rivolo di acqua e ruggine serpeggiava nello spessore della plastica trasparente mentre le ultime gocce si staccavano dalla tettoia sopra la porta. Uno strano silenzio interiore, come un leggero abbassamento di pressione, mi fece salire un conato di vomito. Il sottofondo mentale era scomparso.
«Hai preso le birre?» Claudio si sfregò le mani fra loro, dopo aver parcheggiato la moto.
«Non ho preso niente» tornai dentro, lasciando la porta aperta.
«Male. Partita senza birre è come fumetti senza nuvolette».
«Allora accontentati di guardare le figure».
«Hai visto che giornata?» disse Paolo «Da quest'anno è ufficiale che l'inverno comincia il quattro luglio».
Tornai alla mia sedia davanti al tavolo di fronte alla specchiera.
«Sono da soli sedici anni su questa Terra, ma una cosa del genere non l'avevo mai vista» disse ancora Paolo.
«Come sta la nostra televisione? Ha sempre quel problema dell'audio che prende e non prende?» chiese Claudio. Poi lanciò il giubbotto da qualche parte sul letto.
«Non lo so. Guardavo il telegiornale ma non stavo ascoltando».
«Senza birre e senz'audio. Pensavo che scherzassi quando dicevi che avrei dovuto accontentarmi delle figure».
Si avvicinò alla televisione, dopo aver raccolto il telecomando dal tavolo.
«Questa stufa non si può accendere, vero?».
Girai la testa indietro verso Domenico. Richiuse la porta alle sue spalle.
«Vero».
«Basterebbe un po' di legna».
«Tecnicamente siamo ancora in estate. In estate non si fa deposito di legna. E fuori è un po' difficile trovarne di asciutta» disse Paolo.
«Ma, cazzo, fa freddo. Quel tavolo per esempio non ci serve. Non abbiamo neanche le birre da poggiare. Che ne dici, eh?».
Domenico si avvicinò lentamente al mio orecchio.
«Che ne dici?» sentii il calore del suo fiato.
Mi girai. Non credevo che stesse parlando con me. Tornai a guardare la televisione.
La morte, la morte.
Che strano pensiero.
«Keep silence. Sta per iniziare» disse qualcuno.
La fine.
L'audio fortunatamente c'era.
* * *
Restammo fuori dalla porta a gelare e a fumare l’ultima sigaretta della serata. Cercavamo di muoverci il più possibile sulle gambe e sprecavamo commenti su quanto la Croazia avesse meritato di vincere contro la Francia. In realtà le avevamo commissionato la vendetta per l’eliminazione dell’Italia, ma le cose non erano andate bene.
Dopo aver lanciato via il mio mozzicone, sollevai la sella per prendere il casco dal bauletto. Poi la lasciai ricadere, battendomi una coscia con la mano.
«La corrente».
Cercai il mazzo di chiavi nella tasca. Scartai la rana di gommapiuma e una a una tutte le chiavi fino a trovare quella giusta.
«Fa’ presto. Stiamo crepando» disse Claudio. Cercò di incassare contemporaneamente nuca e gola dentro il collo rialzato della maglia. Paolo fece più o meno la stessa cosa, seduto sulla moto dietro di lui.
«Andatevene a dormire. Chiudo e vi raggiungo nel mondo dei sogni».
«Mi sa che ti abbandono anch'io. Domani mattina presto parto per il campeggio. Roba di un mese. Speriamo di combinare qualcosa con qualcuna, questo è l’ultimo anno» disse Domenico mentre spingeva i talloni a terra per tirare indietro lo scooter.
Misero in moto. Andarono via.
La chiave scattò nella serratura, piegai su e giù la maniglia per sbloccarla. Scavalcai il gradino di ingresso e agitai una mano nel buio per scostare la tenda davanti al contatore. Staccai la corrente. Uscii fuori tirandomi dietro la porta, ruotai la chiave ma si bloccò a metà giro nella serratura. Riprovai un paio di volte, prima di fermarmi a guardarmi attorno.
Alle mie spalle, Colleterno finiva nella distesa di terra arida delle fornaci abbandonate dove lavatrici rotte, anacronistici scaldabagni, divani dalla stoffa lacerata e vecchie vasche da bagno dal fondo nero creavano uno scenario surreale emergendo tra i cactus dei fichi d'India che risalivano, a est, uno dei fianchi della collina del cimitero. Nelle notti di luna piena da lì si riuscivano a vedere persino le lapidi, ma era ancora più inquietante quando su grandi ammassi di nuvole si stagliavano soltanto i suoi contorni indicati dai camini delle due fornaci che puntavano verso il cielo come indici di gigantesche mani squadrate.
Strinsi le dita attorno alla chiave e piantai la suola dello scarpone contro il legno per sfilarla. L'accendino mi cadde dalla tasca e finì in una pozzanghera sotto il marciapiede. Mi piegai per prenderlo, bestemmiai e lo agitai per far venire fuori l’acqua. La ringhiera del terrazzo vibrò, come se ci fosse finito contro qualcosa. Un 'ombra sembrò muoversi sulla mia testa. La alzai di scatto verso il terrazzo e restai immobile a sentire i battiti del cuore accelerare all'improvviso.
Gli abissi del cielo si affacciavano, silenziosi, dalla ringhiera arrugginita, appesantiti da gigantesche masse livide che si spostavano lente come pachidermi. Nonostante non piovesse più da due ore, il carico di nuvole non si era ancora dissolto. Afferrai la chiave, tirai più forte che potevo, facendo tremare i vetri della porta finché non mi ritrovai il mazzo di chiavi nella mano. Lo rimisi in una tasca dei jeans, saltai sullo scooter, affondai il mento nel collo della felpa, misi in moto e mi avviai.
Svoltai nella prima stradina senza accelerare per riprendere la calma. I rami di un fico, simili a dita palmate, si alzavano da dietro un muro che finiva accanto a un sentiero di terra che costeggiava un vecchio casale dall'entrata senza porta. Sotto quell'albero c'era un aratro arrugginito che aveva fatto da postazione e campo base a molte avventure dei pomeriggi di quando ero bambino, ma non avevo mai pensato alla densità del buio che poteva radunarsi sotto le sue fronde di notte. Mi tenni a distanza persino dalla sua ombra.
La pavimentazione in pietra del viale principale si intravide oltre il passaggio tra due vecchie case. Mi fermai al centro della strada. Avevo la fronte e la nuca ghiacciate, le nocche intorpidite e doloranti per il freddo. Girai la testa verso il buio da cui provenivo. Il ginocchio della gamba su cui mi reggevo iniziò a tremare inspiegabilmente. Lo guardai per un attimo per farlo smettere.
Superai lo stretto passaggio con la bocca spalancata e lo sguardo sollevato per sorvegliare le finestre delle due vecchie abitazioni una di fronte all'altra come le sfingi guardiane della Storia infinita. Non si mosse nulla. Mi affacciai nel viale deserto. I muri delle case, i pali dei lampioni, i bidoni dell'immondizia e le saracinesche chiuse dei garage, perfino le pietre su cui giravano, lente, le ruote della mia moto, ogni cosa sembrava viva e addormentata. Nel silenzio crudo di quella notte sembrava di sentire i respiri che si sovrapponevano scompostamente uno all’altro. La mente debole e liquida ruotava intorno nella testa come l'acqua nello scarico del cesso. L’invisibile membrana della realtà si era rotta creando un passaggio che aveva permesso a qualcosa di spaventoso di riversarsi per le strade.
Seguii il lungo viale illuminato a distanza da qualunque cosa. Imboccai senza pensarci una scorciatoia che si snodava in una rete di stradine all'incrocio tra abitazioni malridotte, gran parte delle quali erano state sgomberate anni prima perché inagibili. Di un tetto a tegole era rimasto un costato di legno coperto da lamiere ondulate annerite. Tende di cellophane oscillavano come improvvise apparizioni nel vuoto delle finestre che si affacciavano sulla strada. Vecchi oggetti abbandonati creavano uno spettrale arredamento di ombre sulle pareti interne delle stanze, visibili da grossi squarci nei muri esterni. Le strade del quartiere disabitato si incrociavano deserte e silenziose come gli sterrati delle città fantasma di vecchi film western. Le attraversai andando a passo d'uomo con la moto a centro strada, cercando di non farmi impressionare troppo dagli strani cigolii e fruscii che venivano dal buio delle case.
Soltanto quando arrivai dall'altra parte del quartiere disabitato mi resi conto della strada che stavo percorrendo. La salita del vecchio monastero che portava alla curva delle nicchie e al ponticello di legno. Gli scricchiolii del ponte, la scarsa illuminazione, la vetta del cimitero che appariva con le migliaia di luci arancioni dal fitto tra i platani non erano una bella esperienza da vivere. Ma la cosa peggiore erano le nicchie. Erano disposte sul lungo muro di fianco all'entrata del monastero. Al loro interno stavano in piedi, immobili, nelle tuniche ormai logore, i corpi imbalsamati di alcuni dei monaci che avevano abitato un tempo il monastero. Erano nove, affiancati come statue col volto oscurato dall'ombra dei cappucci calati per nascondere le loro teste morte.
Andai avanti per un breve tratto di salita, superai un vicolo cieco sulla destra e costeggiai il cancello verde del monastero quasi fino all'angolo della strada. Mi fermai. La bocca dello svincolo in fondo alla salita, quello che portava alla curva delle nicchie, emanava un buio talmente denso da sembrare una specie di luce nera. Restai sovrappensiero a guardare il maiale adesivo mezzo staccato che strizzava l’occhio dallo sportello del bauletto sotto il manubrio. Quando eravamo piccoli scavalcavamo il cancello che circondava il monastero, salendo da un dislivello lungo il muro perimetrale, vicino a una cabina grigia della rete elettrica. A volte facevamo delle vere e proprie sfide di coraggio, giocavamo a chi riusciva a superare il cortile interno a croce e ad avvicinarsi di più ai corpi imbalsamati, prima di correre via dalla paura. Il monastero superava di parecchio persino il vecchio cimitero, per i giochi macabri.
Un giorno, uno dei miei compagni non venne a scuola. Il pomeriggio prima, in uno di quei giochi stupidi, aveva perso l'equilibrio mentre scavalcava e la punta di un'asta del cancello gli aveva infilzato una gamba. Era rimasto appeso con l'asta incastrata tra le ossa della gamba per diverso tempo prima che riuscissero a tirarlo giù. Da allora nessun bambino aveva più tentato di scavalcare il cancello verde. Avevamo trovato un'altra strada, più veloce e meno pericolosa, attraverso un canale di scolo sommerso dall'erba alta nel campo dietro il monastero, ma l'immagine di quel bambino appeso per una gamba era ormai diventata nelle nostre menti il segno che i monaci volevano restarsene per conto loro e che non amavano essere disturbati da nessun essere vivente.
Non volevo disturbarli neanche quella notte. Inclinai la moto per tornare indietro, dal quartiere disabitato al viale principale, e accelerai, ma frenai immediatamente. Le tapparelle di una finestra chiusa sul muro del vicolo cieco vibrarono mosse da un vento leggero, sotto la luce che andava e veniva da un lunga luce orizzontale al neon. C'era qualcosa, non era per fare lo stupido, che si era mosso oltre la finestra del vicolo cieco. Una presenza, niente di umano o di animale. La stessa presenza che avevo sentito sbattere contro la ringhiera del terrazzo. La presenza di qualcosa di non vivo.
Ti spalmerai la faccia a terra.
Di nuovo quella stupida voce. Spensi la moto. La sola idea che facesse tutto quel rumore mi aveva terrorizzato di colpo. Mi passai il dorso di una mano sulle labbra, continuavo a inumidirle con la lingua senza rendermene conto. Restai a decidere cosa fare senza muovermi, quasi senza respirare. Il terrore prese a salire insieme al ritmo del battito del cuore, sentivo improvvisamente caldo. Continuavo a credere impossibile quello che stava accadendo.
Il buio emerse allora dal vicolo cieco. Non era il buio normale, quello che si può immaginare di una stradina senza illuminazione in una notte senza luna. Era un buio denso, un'entità che non apparteneva alla realtà, un'oscurità che inghiottiva lentamente tutto ciò che raggiungeva. E dentro il buio, una strana figura di forma umanoide strisciava sul pavimento allungando un braccio nero sul terreno per spingersi in avanti, come se avesse sulle spalle il peso intero di tutto quel buio e fosse lui a trascinarselo dietro, lento, ma inarrestabile.
Era abbastanza. Ingoiai l'idea di attraversare lo strada che affiancava le nicchie. Spinsi i talloni a terra e tirai la moto dal manubrio per rimetterla in salita. La riaccesi e partii. Mi piegai in avanti per compensare la pendenza, svoltai nella strada che girava a elle intorno al monastero. L'aria gelida mi bruciava il viso mentre le ruote divoravano l'asfalto. Il cuore prese a colpire a ripetizione il petto come se volesse disintegrare la coltre di gelo che lo ricopriva. Il muro del monastero e il taglio del marciapiedi, lucidati dall'acqua, correvano ai bordi della mia visuale trasformati in scie eteree ingoiate dalla notte.
Una realtà imprecisa emergeva strato dopo strato dal buio e aggiungeva una piccola porzione di spazio per volta alla sequenza di vicoli già attraversati, prolungandosi senza fine. Era come se la distanza che mi separava dalla via per tornare a casa si allungasse sempre di più sotto il calore e la pressione degli pneumatici, dilatandosi fino all’inverosimile. Mi sembrò di aver corso per tutta la vita su quella moto dentro vicoli e stradine che si ripetevano all’infinito in una notte eterna, come in un gioco di scatole cinesi, senza arrivare mai alla fine.
Seguii l’angolo in cui si piegava la strada quasi senza rallentare. Inclinai talmente tanto la coda della moto che il taglio della gomma slittò sull’asfalto viscido. Riuscii a mettere una gamba a terra mentre lo scooter schizzava via verso il ciglio della strada alla mia destra. Lo seguii per un istante con la mano ancora stretta al manubrio, poi lo lasciai andare. Ruotò a terra su un fianco, leggero come una trottola, nello stridio acuto delle carene incise, finendo contro la staccionata che delimitava la strada. Andai a recuperarlo, mi rimisi in sella e accelerai talmente in fretta che la ruota slittò ancora, senza attrito. La gomma riprese contatto, spinse in avanti la moto di colpo, la ruota anteriore si sollevò per un attimo. In fondo al buio, al di là del ponticello di legno, vibravano le luci dell'ultima svolta per casa.
Mandai giù una sorsata di saliva quando, sui gradini oltre il muro sormontato dall’inferriata verde, l’ombra della prima figura incappucciata si sollevò come se fosse viva, proiettata dal faro della moto nella parte alta della nicchia. Strisciai il mento sulla spalla per girarmi indietro, all'altezza del cancello d’ingresso del monastero, poco prima di raggiungere il ponte di legno.
Dietro di me il mondo non esisteva più. Non era semplicemente immerso nell’oscurità, era definitivamente scomparso in un unico volume nero compatto che aveva assorbito ogni cosa. Le due linee appena visibili che definivano la strada, l’angolo alto in fondo al grande edificio del monastero, persino il cancello verde che dall’ultima svolta aveva preso a correre di asta in asta sul muro perimetrale, tutto si interrompeva senza un perché a metà strada. Da quel momento non riuscii più a disincantarmi dal buio e a tornare a guardare la strada davanti a me. La curvatura dell’asfalto diventava sempre più convessa, più liscia e viscida, la ruota posteriore girava troppo velocemente e slittava da una parte e dall'altra perdendo aderenza.
Le mani erano impietrite dal freddo, le labbra squarciate, la fronte dolorante, mentre dagli occhi lacrime ghiacciate si diramavano lungo il viso. Le ossa e i muscoli si indebolirono di colpo, iniziai a tremare senza controllo, per il freddo, per la paura. Mi resi conto del dolore sotto le unghie soltanto quando sentii che stringevano talmente tanto le manopole da scorticarle. Un'incalzante sequenza di passi in corsa batteva nelle pozzanghere ai bordi del buio che avanzava.
Chiusi gli occhi. Per un attimo le pupille si persero da qualche parte sotto le palpebre. L'asfalto si fece inconsistente sotto la ruota di avanti. Il manubrio diventò leggero come se stessi guidando su una lunga lastra di ghiaccio, iniziò a oscillare in maniera spaventosa, mi sbilanciai, la moto diede una svolta a destra e un netto contraccolpo a sinistra.
La ruota di avanti scivolò via, la moto scomparve sotto di me, la vidi riapparire qualche metro più avanti saltando e ruotando verso il ponte. Da qualche parte, nell'occhio sinistro, un lampo rosso esplose, trasformandosi in un muro d'asfalto. La faccia, la guancia, l’orecchio e la tempia bruciarono sulla strada. Fu come sbattere contro la superficie del tempo che si distorse irrimediabilmente nel paradosso immediato che nulla fosse mai accaduto.
Vidi la moto saltare sui dislivelli delle assi di legno del ponte, prima di scomparire nel buio. Il ponte si interrompeva a metà su un salto di almeno venti metri giù dalla collina, un albero di cui restavano solo le radici mezze divelte si era staccato dal fianco di terra ed era caduto sulla vecchia struttura di legno, sfondandola. La moto era stata ingoiata dal bosco sotto il ponte. Rotolai sui dislivelli delle assi fin dove il ponte si interrompeva, poi sentii il vuoto sotto di me e caddi in un'ondata di aria gelida che mi investiva la faccia gridandomi nelle orecchie un lamento spaventoso.
Rimbalzai sul terreno argilloso decine di metri più sotto, rotolai tra gli alberi come una bambola di pezza. Mi fermai con un braccio incastrato sotto la pancia, disteso a terra, sotto le fronde di un platano, con un occhio aperto e l'altro sprofondato nel fango. Non sentivo più freddo né rumori né alcun dolore. C’era solo l'odore della terra e delle foglie bagnate che saliva nelle narici. Davanti a quell'unico occhio si formarono lentamente delle immagini.
Lei mi veniva incontro in un pomeriggio di sole con un riflesso lucido intorno all’ombelico sotto la camicia azzurra. I suoi fianchi ruotavano tra le mie mani mentre si girava di spalle, la sua pelle diffondeva un profumo che soltanto io potevo sentire. Strisciavo le dita lungo una cucitura dei suoi jeans mentre mi sedevo a terra. Si voltava a guardarmi dall’alto, poi cercava posto nello spazio tra le mie gambe. Scostavo da una parte i suoi capelli, mi avvicinavo al suo collo. Lei inclinava la testa da un lato e si stringeva tutta, appena le mie labbra la sfioravano. La sua mano teneva la mia tra la sua guancia e la spalla. Poi la baciava piano.
Una lacrima calda scese dall’angolo dell’occhio aperto.
Le pareti cadevano a pezzi per l’umidità e scuri squarci di intonaco tumefatto si aprivano nell’alta volta sopra la mia testa. La luce dei lampi fotografava di tanto in tanto la stanza. La mia immagine appariva per un attimo nella grande specchiera di fronte. Ero seduto a una sedia di legno cigolante con gli scarponi poggiati sul tavolo, avevo una maglia nera pesante e un paio di jeans, aspettavo l'arrivo dei miei amici per la semifinale. Da un portacenere si innalzava il fumo di una sigaretta spenta alla meglio. Al telegiornale passava un servizio su un terremoto che aveva distrutto un’intera città da qualche parte in culo alla Russia. Il freddo era penetrato anche all’interno della casa, ce l'avevo nelle ossa, il freddo di una strana giornata di luglio che aveva spezzato quell’estate così lineare. Il vetro di una credenza rifletteva dallo schermo della televisione l'immagine di una scimmia in giacca e cravatta con un cappello da giullare sulla testa. I vecchi mobili, gonfi di anni trascorsi a resistere all’umidità, nascondevano in parte le marce pareti. La mia pelle sarebbe rimasta per sempre impregnata dall'odore di vecchio e di chiuso della casa dei nonni. Mia madre, il giorno dopo, avrebbe scoperto per l'ultima volta che ci ero stato, quando avrebbe annusato il mio cadavere.
Splendida fine.