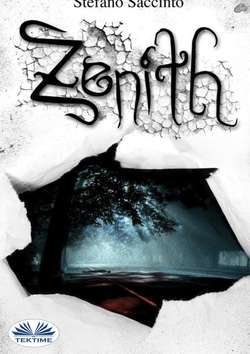Читать книгу Zenith - Saccinto Saccinto - Страница 7
Capitolo 3
ОглавлениеLa prima anima non aveva le sembianze di un’anima. Era un ragazzo lungo e magro con le spalle a spigoli. Portava una giacca e un paio di pantaloni grigio chiaro, una camicia bianca aperta sul collo e scarpe nere. Avanzava tra l'erba alta e rada con le ginocchia sollevate. Gli occhi castani dalle ciglia lunghe mi guardavano sopra un naso con la punta schiacciata sul volto rettangolare. La strana lucentezza della pelle la faceva sembrare vagamente plastificata.
«Pensavo che non avrei trovato nessuno qui. Sono venti minuti che cammino» disse. Fece altri due ampi passi e si fermò, allungò una mano «Ambrose Denitti. Designer di interni. Interni di lusso».
Il polso della camicia venne fuori dalla manica della giacca. Trattenne il fianco della stessa con l'altra mano.
«Che razza di situazione» dissi. Mi alzai da terra, dalla sterpaglia dove me n'ero stato seduto fino ad allora. Strinsi la mano davanti a me.
«Sico» dissi.
La fronte dell'anima si corrugò. Tirai un'ultima boccata dalla terza o quarta sigaretta da quando ero arrivato, prima di schiacciarla sotto la punta dello scarpone. Le spalle appuntite traslarono di lato per farmi spazio. Mi allungai verso il sentiero.
«Ho l'auto che si è fermata sulla statale. Non so che cosa le sia preso, non mi ha mai dato problemi. Per quello che l’ho pagata, c’è da non crederci. A dire il vero devo essere uscito un po' fuori strada» fece frusciare la giacca, allungando un braccio all'indietro mentre mi camminava accanto «Ho provato a contattare il soccorso stradale, ma non c'è campo» controllò il display di un grosso cellulare, ticchettandoci sopra con due dita «Non è che mi faresti provare con il tuo?» mi puntò con l’antenna del telefono.
Scossi la testa e alzai le spalle.
L’aria intorno a noi era cambiata, un vento leggero si era alzato, mentre nel cielo le nuvole si assottigliavano piano.
«Posso pagarti la telefonata» disse l’anima, allargando le braccia.
Mi fermai, mi girai verso di lui «Non ho un telefono» dissi.
«Va bene, va bene. Facciamo così: vieni con me fino alla macchina e resta almeno a controllarla mentre io cerco aiuto».
Feci ancora no con la testa.
«Senti, sei l'unico che può aiutarmi. Non vedo nessun altro qui,» fece un giro completo su se stesso «ho un Porsche Boxster grigio metallizzato con tettuccio apribile automatico e interni in pelle rossa immatricolato sei mesi fa, fermo fuori strada a non so quanti chilometri. Che dici, vogliamo lasciarlo lì incustodito per molto?».
Ripresi a camminare, il ragazzo mi seguì. Scavalcammo l'erba alta ai bordi del sentiero per avvicinarci alle due braccia di rampicanti. Gli ultimi steli di gramigna gli finirono dentro i pantaloni, scostò la gamba con rabbia e assestò un calcio a un cespuglio rinsecchito, sradicandolo. Bestemmiò qualcosa tra sé e sé.
«Domani sono pieno di appuntamenti, devo chiudere due contratti importanti. Non posso stare qui a perdere tempo con te, ma mi serve il tuo aiuto» si fermò.
Una mano lanciò il telefono all’altra, scivolò sotto la stoffa della giacca e cavò un portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni. Lo aprì con il pollice. Tirò fuori con l’indice e il medio un pezzo da cinquanta e lo sventolò verso di me. Il riflesso bianco spalmato sulla punta piatta del naso lo faceva sembrare ridicolo.
«Prendili, dài». Credeva di essere ancora vivo.
La morte è un concetto relativo. Basta solo andarci oltre.
«Ti è mai capitato» dissi «di pensare a qualcosa che non abbia a che fare con la tua vita?».
«Che cosa vuoi dire?».
«Che dovresti pensare di rinunciare ai tuoi appuntamenti».
«Dici che andrà via tutta la notte per tirare fuori la macchina?» gettò il pollice alle sue spalle. La banconota scivolò di nuovo nell’apertura di pelle. La mano scomparve dietro il suo culo.
«Dico che adesso è tardi per pensare a queste cose».
«Dici?».
«Dico che sei morto».
«Morto? Che cosa vuoi dire con morto?».
«Tutto quel buio l’hai visto? L’erba che comincia di punto in bianco nel vuoto? Questa strana luce turchese, queste due braccia enormi che vengono fuori dal terreno?» poggiai una mano sul braccio più vicino, appena raggiunto «Ti sembra la vita, questa? Ti sembra la realtà?».
Si allontanò di qualche passo, si puntò addosso le dita di entrambe le mani.
«E io? Ti sembro uno che è morto? Non lo vedi che sto in piedi? Sono solo uscito fuori strada. Certo, devo aver tamponato qualcosa, adesso non ricordo. Ma poi ho camminato fino a qui» quasi urlò.
I due pugni giganti, con le foglie prese da un leggero fremito, iniziarono a schiudersi sopra di noi. Ci spostammo più indietro. Le ragazze si sollevarono, Ambrose si ritrasse alla loro vista. La ragazza vestita di bianco gli accennò un invito ad avvicinarsi. Il suo viso continuava a mutare. Adesso sembrava quello di una adolescente e anche il suo corpo non era più quello di una donna, le braccia e le gambe si erano fatte più esili e i seni neri, che erano stati sodi, adesso erano appena accennati.
«Che cosa ci fanno nude? Chi sono?» Ambrose si rivolse a me.
Alzai le spalle.
«Ambrose» iniziò la voce della ragazza vestita di nero «Hai ventisei anni. Li hai attraversati tutti senza un solo piccolo dolore e senza un solo piccolo affetto. Non hai mai conosciuto sacrifici o rinunce. Ti sei ritrovato a ventitré anni a capo dell’azienda di tuo padre, senza un percorso di studi, senza alcun merito, ma per diritto di discendenza. Nei giorni della sua morte, non provavi niente. Soltanto la voglia irrefrenabile di prendere possesso dei tuoi nuovi beni per vivere una vita dinamica, in continuo movimento e in continua mutazione. Hai iniziato a cambiare auto e donne come un bambino che fa presto a dimenticare un gioco vecchio per uno nuovo. La tua vita è stata una corsa continua lontano dalla verità che ti sembrava così noiosa e statica. Una vita di continue bugie. Dette a chi? Dette a te stesso. Che ne pensi, hai avuto una morte abbastanza dinamica?».
«Io non sono morto» scattò di nuovo il ragazzo «Mi si è fermata l’auto. Ho avuto un piccolo incidente mentre rientravo. Ho sbattuto contro qualcosa, ma non è stato niente di grave. Vi sto parlando, sono davanti ai vostri occhi. Non sono morto» tentò di convincerci agitando il cellulare.
«Mente a se stesso, come ha sempre fatto, tanto da aver confuso la verità con le sue bugie. Non è in grado di ricordare. E oramai non c'è più tempo. La sua auto corre a grande velocità lungo una strada di campagna. Un sorpasso azzardato nei pressi di un dosso spezzerà la sua vita questa sera. Dovrai evitare l’impatto» la ragazza dal vestito bianco si rivolse a me.
«O lasciare che la morte faccia il suo corso» aggiunse l'altra, con lo sguardo fisso sul volto di Ambrose.
«Tieni a mente che alla sua sono legate tutte le altre vite. A partire dalla tua».
Le dita delle mani da cui ci parlavano iniziarono a richiudersi. Le due ragazze si sedettero senza smettere di guardarci.
«Aspettate» Ambrose riprese ad agitarsi nel completo grigio «Voi non lo sapete, non potete saperne niente, della mia vita e di quello che mi è successo. Voglio sapere chi vi ha detto quelle cose su mio padre, voglio sapere chi siete».
«Siamo spiriti della morte» un sussurro filtrò attraverso il sorriso che sezionò il viso della ragazza dalla pelle bianca «Lei è la Dolce Illusione. Io sono la Pura Verità».
I pugni si serrarono definitivamente, Ambrose si girò verso di me, indicandoli con la punta del telefono tesa alla fine del braccio alle sue spalle.
«Ma lo senti come parlano, lo senti cosa dicono? Sono completamente pazze. E tu credi alle loro cazzate?».
«Io non credo a niente» mi avviai verso il buio.
«Aspetta» la mano di Ambrose mi afferrò una spalla. Mi girai. «Dove stai andando?» chiese.
«Non lo so».
«Benissimo, vuol dire che verrò con te» fece per infilarsi il telefono in tasca. Come uno sciabolare di enormi lamiere, le pareti nere volteggiarono nell’aria del buio immenso davanti ai nostri occhi, al di là del prato turchese, per ricomporre il corridoio oscuro. La mano di Ambrose scivolò giù dalla mia spalla.
«Sei sicuro?» gli chiesi. «Non direi». «Perfetto». Ripresi la via. Questa volta la prima anima se ne restò ferma ad aspettare.
* * *
Le nuvole avevano ripreso ad ammassarsi nel cielo sopra la statale srotolata dai contorni vaghi di una città lontana come un lungo tappeto d’asfalto steso in un saliscendi infinito verso la notte. Camminavo affianco al guardrail con gli occhi puntati a terra e calciavo una pietra per farla rotolare in salita. Continuavo a strofinarmi le mani per il freddo.
Non avevo mai avuto un'allucinazione così realistica. In realtà non avevo mai avuto alcuna allucinazione, neppure quando da piccolo lo schienale della sella della bici di un mio amico si era infilato nel manubrio della mia bici mentre impennava e tornando a terra mi aveva catapultato all'indietro facendomi svenire. Non lo so quanto ero stato vicino alla morte quella volta, ma ricordo soltanto un buio leggero e un silenzio di pace. Niente porci giganti o cose del genere. Niente colline tetre, niente anime da salvare per tornare alla vita.
Dietro un vecchio cancello arancione, una lampadina lasciata accesa illuminava i tavoli quadrati e le panche di legno accatastati nel cortile di una balera. Tristi triangoli colorati ondeggiavano nell’aria su un filo sospeso da una parte all’altra del cortile. Il buio si insinuava nei cunicoli contorti tra gli ulivi tutto intorno. Ogni tanto qualcosa si muoveva in mezzo all'erba della campagna. Lanciavo un'occhiata di sfuggita e andavo avanti. Una civetta si alzò in volo dalla chioma di un albero vicino, le grandi ali scure si distesero contro il cielo rossastro, facendomi finire al centro della strada. Mi chiedevo che fine aveva fatto il mondo. Colleterno, Domenico, Claudio, Paolo, i miei unici amici. I miei genitori. Mi chiedevo di Lei.
Mi chiedevo quanto fossero lontani e cosa stesse facendo ognuno di loro. Stavano dormendo di sicuro. Forse vagando attraverso i loro sogni, avrebbero potuto incrociare i miei e intravedermi, avremmo potuto incontrarci ancora. Oppure tutto iniziava davvero a finire e non avrei mai più visto nessuno di loro. Non si sopravvive a una cosa come quella che mi era capitata. Questo non era nient'altro che l'ultimo sogno di un uomo già morto, un film per un solo spettatore, un sogno vivido come un'altra forma di realtà viva dall'altra parte della notte. Mi sentivo perso in una solitudine definitiva, come quando avevo ascoltato per la prima volta quella tristissima canzone degli Smashing Pumpkins, For Martha, di un disco che Claudio aveva comprato da poco. Un incredibile senso di abbandono mi gelò per un attimo e mi fece salire le lacrime agli occhi. Ingoiai, mi strinsi a me, continuai a strisciare gli scarponi sull'asfalto.
Raggiunsi l’unico dosso visibile nel raggio di alcuni chilometri, subito dopo una stazione di servizio, e mi voltai indietro a guardare. Non c’erano fari in avvicinamento, tutto sembrava tranquillo. Mi appoggiai al guardrail col fondo dei jeans, ci sedetti sopra, poi presi a colpirlo a ritmo con i talloni. Tirai fuori tabacco, filtri e cartine. Nella leggera foschia che iniziava a sollevarsi dal terreno, mi venne in mente una storia che Domenico ci raccontava spesso. Diceva che era accaduta veramente, ma aveva tutte le caratteristiche di una leggenda metropolitana.
Una notte suo zio rientrava da un lungo viaggio in macchina con la famiglia. A un centinaio di chilometri da Torino trovarono un banco di nebbia fitta che li costrinse a una fila interminabile che andò avanti a passo d'uomo per più di un'ora. Lo zio guidava con la fronte attaccata al parabrezza, il volante schiacciato al petto e i tergicristalli che andavano al massimo per spingere via l'umidità che non smetteva di formarsi. I bambini erano terrorizzati, la moglie continuava a ripetergli di stare attento. La nebbia si infittiva come non avevano mai visto. Qualcuno davanti alla fila decise che non si poteva più proseguire, azionò le quattro frecce e si fermò a bordo strada. La fila si bloccò del tutto.
Dopo molto tempo, quando la nebbia iniziò a diradarsi, le macchine ripartirono una a una. Ripartì anche lui. Si rimise con il petto sul volante, azionò la freccia per superare e si lasciò distanziare dalla macchina che lo precedeva per avere la visibilità della corsia di sorpasso. L'aria diventava sempre più tersa, i nervi dello zio iniziarono a distendersi. Ma mentre accelerava per spostarsi di corsia, il busto di una donna apparve dalla strada, si alzò a sedere dall'asfalto e finì contro il paraurti.
Lo zio lanciò un urlo, sentì il tonfo del torace della donna che rimbalzava contro l'auto e quello della testa che si spappolava sull'asfalto. Inchiodò e scese per andare a vedere che cosa era successo, sicuro di aver avuto una specie di visione. Invece aveva visto bene. Una donna era davvero stesa lì a terra col cervello che tappezzava l'asfalto. Era una prostituta che era rimasta sul ciglio della strada per tutto il tempo in cui le auto si erano fermate per la nebbia. Aveva aspettato che ci fosse maggiore visibilità per poter passare e quando la nebbia aveva cominciato a dissolversi, si era incamminata, nello stesso momento in cui le auto erano ripartite. Le prime erano riuscite a schivarla, ma quella davanti allo zio di Domenico l'aveva investita senza ucciderla. A finirla era stato lui.
Accesi la sigaretta. L’intermittenza di due fari in lontananza segnalò l’arrivo di un’auto che saliva e scendeva lentamente una serie di cunette che precedevano il rettilineo prima del dosso. Aumentò la velocità quando si immise sul piano regolare e si tenne sulla linea centrale della strada finché non diventò continua.
Una seconda auto rischiarò la statale con i coni di luce dei fari che cambiavano angolazione per i continui colpi d’assestamento dati al volante dal guidatore. Percorse il tratto di cunette sobbalzando senza controllo e, in meno di niente, si mise in coda all’altra vettura. Il muso liftato di un’auto da corsa dava scatti nevrotici verso il centro strada per superare, senza riuscire a trovare lo spazio.
Saltai giù dal guardrail e raggiunsi il centro della strada, nel punto più alto del dosso. Mentre andavo, nella nebbia che saliva, guardai giù dall'altra parte. L’asfalto scendeva inclinandosi in una curva a neanche un centinaio di metri. Una debole luce si proiettò sulle frecce bianche dei cartelli neri in sequenza. Era tardi, ormai, per dare retta al dubbio che avessi scelto il posto peggiore per evitare l’impatto. L’auto di Ambrose si ricavò lo spazio a colpi di gas, l’altra si fece da parte. Dietro di me, il riflesso dei fari si intensificava sulla superficie bianca e nera dei cartelli. Il rumore che vibrava sul guardrail non era quello di un’auto.
Restai immobile a tirare dalla sigaretta e spingere fuori il fumo che si arrotolava nell’aria densa. La Porsche andava troppo forte. Avrei fatto la fine della prostituta del racconto di Domenico. Quando il paraurti di un enorme autotreno emerse dalla curva oltre il dosso, raggiunsi il bordo della strada più vicino, scavalcai il guardrail e mi allontanai di qualche metro. Poi mi girai.
Uno stridere di gomme squarciò l’aria, sormontato dalle urla dei clacson delle due auto e dal frastuono di quello dell’autotreno che sbandò in modo spaventoso per deviare. La cabina oscillò in cima alla salita, fuori dalla carreggiata, poi verso la strada, il rimorchio si sbilanciò in contrasto alla sterzata. Sembrava una bestia di dimensioni mastodontiche che inciampa e vacilla prima di crollare abbattuta.
La Porsche finì dritta contro l’angolo anteriore sinistro del muso dell’autotreno. L’onda d’urto che si propagò fece tremare l’aria, il tetto di chiome di alberi oltre la strada e le luci della stazione di servizio. Un unico mostro di ferraglia, vetro e gomma si spinse verso l’alto per la violenza, una serie a catena di scintillii investì l'ignara notte d’estate e una pioggia arcuata di detriti esplose, rimbalzando a decine di metri di distanza. Poi, trascinato dal contraccolpo del rimorchio, l’autotreno si inclinò sul fianco e si schiantò al terreno, strisciò per qualche metro e sbalzò a grande distanza quello che restava della Porsche. L’altra auto schizzò incolume sull’asfalto e inchiodò prima della curva oltre il dosso.
Aspettai che tutto si fermasse prima di attraversare la nube di terra sospesa nella foschia e innalzata dal telone del rimorchio. Mi misi sulla strada, cercai l’auto di Ambrose. La gente era venuta fuori dalla stazione di servizio, a piedi, si era fermata a vedere. Alcuni si passavano le mani sulla testa, altri cercavano di spiegare a quelli che avevano accanto, qualcuno correva avanti e indietro per capire cosa fare. Vedevo le loro ombre muoversi attraverso il filtro bianco della nebbia. Dall’altra parte, nell’auto in discesa illuminata a intermittenza dalle quattro frecce, una figura se ne stava seduta con il volto nelle mani, mentre qualcuno veniva fuori, guardava la strada e attraversava di corsa. La sua voce mi raggiunse prima di lui.
«Mi ha superato sul dosso. Ho detto “Questo è pazzo!”, non credevo che…» il ragazzo si schiantò i pugni sulle cosce «Avrei dovuto rallentare, avrei dovuto lasciarlo passare» iniziò a disperarsi piegandosi in due con una mano sugli occhi.
Andai a prenderlo per un braccio, lo trascinai verso la cabina dell’autotreno. Ci affacciammo a guardare. L’uomo al suo interno se ne stava col tronco tenuto al sedile dalla cintura di sicurezza, la testa riversa da un lato e un rivolo di sangue che si allungava dalla stempiatura tra i capelli verso il basso.
L’hai fatto secco, bella prova.
Dopo qualche secondo iniziò a muoversi e si liberò dalla cintura. Si toccò la ferita e cercò di capire cosa fosse successo, mettendosi in piedi oltre il parabrezza come dietro una teca di vetro attraversata dalle crepe che si diramavano.
«Tiriamolo fuori» dissi.
Feci cenno all’uomo di allontanarsi, mi ficcai la sigaretta tra i denti, piantai la suola della scarpa su una crepa e la mossi piano avanti e indietro, allontanando subito la gamba. Il vetro venne giù un pezzo alla volta. Il ragazzo accanto a me allungò una mano. L’uomo la prese, scavalcò quel che restava del parabrezza ed ebbe un mancamento. Lo trasportammo vicino all’auto del ragazzo, stendendolo oltre il ciglio della strada, al riparo, sotto il guardrail. La ragazza che se n’era stata per tutto il tempo all’interno della macchina scese velocemente.
«È vivo?» chiese.
«È vivo, sì, è vivo» rispose il ragazzo. La strinse e le baciò una guancia quando lei iniziò a piangere.
«Dobbiamo estrarre l’altro uomo» si rivolse poi a me.
La ragazza si chinò sul corpo del ferito. Il suo modo di osservarlo, mentre ravviava i capelli dietro il piccolo orecchio, la delicatezza e la spontaneità con cui la sua mano scivolava tra le mani dell’uomo, stringendone una, mi fece provare qualcosa di strano. Nonostante fossero due sconosciuti, per lei adesso quell'uomo era la cosa più importante al mondo. Avrei voluto sentirmi così anch’io, una sola volta, per qualcuno. Avrei voluto essere l’uomo ferito sul ciglio della strada e che Lei fosse la ragazza piegata su di me. Indietreggiai di qualche passo, poi mi voltai risalendo verso il dosso e mi incamminai in discesa. Lanciai via la sigaretta.
Mi fermai davanti a quella che fino a poco prima era stata una Porsche Boxster grigio metallizzato. Gli uomini della stazione di servizio venivano in fretta verso di noi, ma si fermarono di colpo quando il fuoco divampò intorno alla carrozzeria. Per quello che era stata pagata.
«Gli estintori» urlò qualcuno e corsero tutti indietro.
Cercai il corpo con lo sguardo, sembrava che fosse stato inghiottito dal mostro di lamiere. Poi vidi qualcosa. Un occhio, disumanamente spalancato, rivolto nella mia direzione. Intorno a quell’occhio ricostruii i contorni del viso deformato con le labbra aperte all’inverosimile. L’altra metà del volto era completamente schiacciata sul cruscotto spinto contro i sedili anteriori in pelle rossa. Aggrottai le sopracciglia e tesi un orecchio. Il sottofondo irreale di I wanna be adored, una vecchia canzone degli Stone Roses, veniva fuori dallo stereo che funzionava ancora.
Una pozza di sangue si ampliava a pochi centimetri dalle mie scarpe, come se stesse cercando di raggiungermi. Le gocce, lunghe e fluide, fuoriuscivano dalla base dello sportello chiuso. Immersi un piede nel sangue, camminai nel cono visivo di quell’unico occhio. Mi chiesi se quella che osservavo, al di là del terrore che mostrava, fosse o meno un’espressione interrogativa nel crepitio della plastica che bolliva.
Il riflesso sulla punta piatta del naso di Ambrose si allargò, il bagliore aumentò in un attimo. Scoppiai a ridere senza riuscire a trattenermi. Poi alzai le braccia per coprirmi il volto. Se l’occhio di Ambrose aveva ancora la capacità di vedere, la mia immagine che rideva fu l’ultima cosa che restò impressa nella sua retina. Nell’arco di un solo secondo, una nuova vampata devastò la notte, mischiando sangue, abiti e lamiere, fumo e vite spezzate e avvolgendomi in un vortice di dolore abbagliante che rase al suolo tutto quello che c’era intorno. Mi contorsi per un tempo infinito in quel dolore indescrivibile.