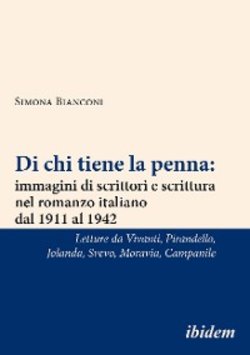Читать книгу Di chi tiene la penna: immagini di scrittori e scrittura nel romanzo italiano dal 1911 al 1942 - Simona Bianconi - Страница 4
Introduzione
ОглавлениеMettere al mondo un figlio, scrivere un libro, piantare un albero?
Chi scrive un libro genera vita. Chi scrive di un autore e della sua scrittura arricchisce l'esperienza, grazie all'introduzione di un nuovo testo dall'accoglienza indiscussa. Corrobora la creazione chiamando in causa un proprio pari, con tutta la responsabilità che ne comporta l'inquadramento in un tessuto narrativo e in un sistema di personaggi; con la consapevolezza del suo destino di interazione con il lettore e della talvolta rischiosa acquisizione di una sostanziale indipendenza rispetto al testo principale. Il lettore può, in alcuni casi, arrivare a pensare alla vicenda del libro in se stessa, estrapolandola dalla trama in cui è compresa.
Questa condizione di privilegio è dovuta al fatto che lo scrittore è detentore di un potere magico nella comunicazione. È colui che va oltre le parole. Che lascia traccia definitiva di sé. Come sostiene Claude-Edmonde Magny nella sua Lettera sul potere di scrivere indirizzata al giovane Jorge Semprún esule a Parigi, del febbraio 1943, “Scrivere è un'azione grave, e che non lascia indenne chi la pratica”[1]. Ciò è vero anche per lo scrittore inventato, che si appresta all'opera letteraria ponendo in gioco tutto se stesso. Inversamente, se si parla di prosa, il genere in cui si cimentano, anche se non esclusivamente, tutti gli autori delle fiction letterarie qui presentate, sempre con Magny, essa “non può fare a meno di portare con sé una greve massa di esperienza umana: le occorre essere radicata nell'umano, minacciata altrimenti di non essere affatto”[2]. Con le parole di Mario Perniola, “Mentre la poesia tende a separare nettamente la vita dalla letteratura, ad escludere completamente l'esperienza della ricerca dall'opera, il romanzo[3] tende a connetterli (sic) […] erede del principio dell'espressione dell'io”[4]. E, ancora sulle due prospettive della poesia e della narrativa, “Mentre il narratore tende a concepire la propria attività come una continuità di opere, ciascuna delle quali è in rapporto con la precedente e la seguente, il poeta considera ogni opera come un'entità a sé stante”[5]. Ecco dunque enucleato il legame inscindibile tra l'autore e la sua scrittura.
Nella lettera di Magny si individuano due requisiti fondamentali per la buona letteratura, qui utili in quanto strumenti interpretativi del carattere del personaggio autore: lo scrittore autentico non scivola troppo facilmente nell'imitazione e la sua opera ne è espressione[6]; “la letteratura è possibile solo al termine di una prima ascesi e come risultato di questo esercizio grazie al quale l'individuo trasforma e assimila ricordi dolorosi, mentre si va costruendo una personalità”[7].
Tali presupposti si estendono senza difficoltà al protagonista scrittore, la cui natura “artificiale” non impedisce di individuarne la forza attraverso l'interazione tra la storia psicologica e la scrittura.
In ultimo, poche delucidazioni su un approccio all'opera primaria che vuole mantenersi entro l'ambito del racconto.
Nonostante il fascino immediato esercitato dall'invenzione di un ambiente e di un processo creativo e la sempre facile tentazione dell'esegesi autobiografica che gli si connette, non si devono automaticamente cercare, in ciò che è frutto di pura costruzione, riflessi dell'immagine dell'autore di primo grado. Ne conseguirebbe una lettura di breve respiro, con al termine una serie di annotazioni nella logica binaria, fine a se stessa là dove non dettata da scopi specifici. È perciò fondamentale, nell'interpretazione, partire dalla rete dei personaggi e dalle modalità narrative della loro esistenza, dal momento che è questo “sistema” testuale ad offrire le maggiori risorse nella lettura.
Naturalmente la lettura dei testi va circoscritta.
Ambito dello studio è il romanzo, in virtù della sua accessibilità il genere letterario per eccellenza nel ventesimo secolo, quello attraverso il quale ha luogo più frequentemente il processo di comunicazione scrittore-lettore[8]. E quello in cui, come facilmente si intuisce, le immagini dell'autore e della sua scrittura risultano più nitide. Nell'esame ho escluso le biografie, come le autobiografie in senso stretto – nonostante le difficoltà della delimitazione del genere – né, come già osservato, mi soffermo sul livello di autobiografismo presente. Un dato è innegabile: la stessa introduzione del personaggio scrittore come cardine della storia, a prescindere dagli sviluppi del tema, conferisce al romanzo un tratto autobiografico a priori.
Nello stringersi del cerchio, la scelta è poi ricaduta su alcuni testi italiani, con eventuali riferimenti ad opere precedenti, nello spazio cronologico tra il 1911 e il 1942; non esaminati in prospettiva storico-letteraria né specificamente alla luce delle caratteristiche tipologiche. Sullo sfondo della diffusione dell'istruzione tra la popolazione, dell'affermazione della letteratura di massa e dell'esplosione del romanzo, al centro dell'indagine è il motivo della scrittura vista nelle dinamiche della sua genesi e pratica; e dei suoi effetti, a partire da un'epoca segnata dall'aumento esponenziale del pubblico dei lettori – e delle lettrici.
Suggestivo è il caso dell'equa ripartizione dei sei protagonisti autori dei due sessi, con tre donne per i romanzi del periodo 1911-1916. Con la produzione di tutti i personaggi contrassegnata dalla predominanza della prosa. E comprensibilmente: la narrativa si connette alla ricerca individuale e dunque è atta a riprodurre i movimenti della coscienza dello scrittore[9]; per converso, la scelta del genere è parte integrante della definizione del personaggio stesso.