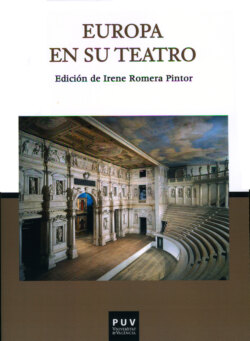Читать книгу Europa en su teatro - AA.VV - Страница 13
La favola pastorale nei convegni del
«Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale»
ОглавлениеIrina Freixeiro Ayo
Universidade de Santiago de Compostela
Questa recensione ha lo scopo di presentare le diverse relazioni lette ai convegni di studi Origini del dramma pastorale in Europa (Viterbo, 31 maggio – 3 giugno 1984) e Sviluppi della Drammaturgia Pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento (Roma 23 – 26 maggio 1991) organizzati dal «Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale» diretto da Federico Doglio.1
Nel primo dei suddetti convegnile diverse relazioni pubblicate potrebbero essere divise in due grandi sezioni: da una parte, la maggioranza dei testi, gli interventi che girano intorno all’opera di Angelo Poliziano, La fabula di Orfeo; dall’altra quelli che trattano temi di carattere più generico e contestuale all’interno dello studio del dramma pastorale nell’Umanesimo italiano. Ad ogni modo le lezioni che formerebbero questa seconda sezione prendono anche l’opera del Poliziano come punto di riferimento per esemplificare diversi aspetti, per cui si può affermare che l’Orfeo funge da nesso tra le due sezioni.
Inizierò citando le letture di carattere più contestuale, dato che con queste si apre il volume degli atti del primo convegno. Alberto Tenenti «Figurazione bucolica e realtà sociali (1350-1550 c.)» riflette sulla totale idealizzazione del mondo pastorale, un mondo in cui gli elementi realistici si riducono al minimo, per mostrare così la rottura tra la figurazione bucolica, la realtà storica e le ambientazioni obiettive. Lo studio «Tra mito dell’amore e ritorno all’età dell’oro. Considerazioni sulla cultura del tardo Quattrocento» di Cesare Vasoli giustifica la tematica dell’amore pastorale minacciato dal carattere distruttivo del tempo e della morte partendo dall’analisi della concezione dell’amore proposta da Marsilio Ficino. Ne «Il vagheggiamento della natura e dell’amore alle origini del dramma pastorale» di Aulo Greco si cercano le prime tracce della pastorale nella letteratura italiana, identificandole nei versi delle egloghe di Francesco Petrarca. Marzia Pieri offre in «Dalla lirica alla festa: il caso dell’egloga nella Napoli aragonese» uno studio della pastorale nell’ambito napoletano mentre ilMeridione italiano era ancora sotto il dominio spagnolo; situazione che spiega, tra l’altro, la forte presenza della tematica politica nelle fabule, inesistente nelle opere di questo genere nel resto della penisola. Franca Angelini in «Su alcune ‘rozze’ pastorali» studia la produzione dei nominati pre-Rozzi, rilevante per la sperimentazione all’interno del genere, dato che, senza allontanarsi dal testo letterario, assegna un ruolo di massima rilevanza alla funzione dell’attore e alla capacità d’improvvisazione. Giovanna Romei studia in «Leone de’ Sommi e la pastorale: teoria, testo e scena» la creazione del testo teatrale nato dalla rappresentazione —comune specialmente nell’ambito ferrarese— attraverso gli scritti di Leone de’Sommi, che propone un’esperienza teatrale nel senso contrario. Per concludere questa sezione troviamo lo studio «La comedia pastoril en España» di Francisco López Estrada, che riflette sulla situazione del teatro nel Siglo de Oro rispetto allo sviluppo del dramma pastorale. Questi assume come punto di riferimento Il pastor fido di Guarini (dato che il resto delle opere pastorali italiane non ebbero una grande ripercussione in Spagna) per concludere che il dramma pastorale spagnolo non segue il modello del Guarini giacché le esigenze dei gusti iberici avevano motivato un adattamento delle regole osservate ne Il pastor fido.
La seconda sezione delle relazioni, così come ho accennato in precedenza, ruota intorno a diversi aspetti de La fabula di Orfeo. Potremmo iniziare con l’analisi generale elaborata da Giuseppe Rocca nel saggio «Lettura della Fabula di Orfeo in cui identifica alcuni aspetti per applicarne un’analisi retorica utilizzando la Rota Vergilii. Ne «La fabula satirica e l’Orfeo del Poliziano» di Antonia Tissoni Benvenuti si offre invece un’analisi dell’opera dal punto di vista del genere e si giustifica la categorizzazione di questa all’interno della fabula satirica. Nino Borsellino, in «Orfeo e Pan. Sul simbolismo della pastorale», studia i simboli intorno alle due figure e il rapporto tra questi personaggi nell’opera del Poliziano e nelle opere di Virgilio e di Ovidio. Elena Povoledo studia ne «L’Orfeo di Poliziano tra cultura e realtà teatrale», in modo molto visuale, i luoghi di recita nella città di Firenze per conoscere in questo modo l’esperienza teatrale del giovane Poliziano e i requisiti che potrebbe aver implicato la rappresentazione dell’Orfeo. Nino Pirrotta avanza alcune ipotesi sulla musica che potrebbe aver accompagnato la fabula di Poliziano. In «Problemi musicali di una rappresentazione dell’Orfeo di Poliziano» analizza le ridotte referenze musicali all’interno del testo letterario, dato che non si conserva alcun documento che possa testimoniare lo sviluppo musicale nel corso della recita. Riprendendo di nuovo lo studio del simbolismo, Mia Cocco riflette in «Poesia e Morte nell’Orfeo del Poliziano» sul rapporto tra morte e poesia per affermare infine la supremazia di quest’ultima come l’unica capace di sopravvivere non solo alla Fortuna, ma anche al tempo e alla morte. Emilio Bigi si allontana un po’ dall’Orfeo e analizza un piccolo dramma in «‘Semplicità’ pastorale e ‘grazia’ cortigiana nel Tirsi», dove studia lo stile semplice ed elegante dell’opera Tirsi, costruita sulla base delle ottave del Poliziano e con ricchissime reminiscenze della letteratura pastorale precedente. Il Tirsi infatti, insieme all’Orfeo, si allontana dalle opere del suo tempo per il suo carattere e per la sua struttura originale. Troviamo infine «La ricezione del tema di Orfeo nella drammaturgia classica francese» di Enea Balmas, nel quale, così come succedeva negli studi di tematica spagnola, si mostra come l’opera di Polizano ottenga un successo piuttosto ridotto nella Francia dell’epoca.
A conclusione del libro si riscontrano due raccolte bibliografiche: una bibliografia che riguarda i testi italiani in rapporto con la pastorale, elaborata da Stefano Mazzoni, e una seconda bibliografia, questa volta straniera, sullo stesso tema, elaborata da Letizia Sorrentino.
Anche nel volume degli atti del secondo dei convegni si potrebbero stabilire due nuclei tenendo conto degli argomenti delle diverse relazioni. I saggi della prima sezione presentano come tema centrale le caratteristiche delle rappresentazioni teatrali, mentre lasciano invece in un secondo piano l’analisi critica del testo letterario. La seconda sezione presenta argomenti più eterogenei, dall’analisi di opere minori al confronto fra dramma pastorale e commedia dell’arte.
Se La fabula di Orfeo del Poliziano era l’opera di riferimento nel primo volume, nel secondo questo ruolo viene rivestito da due opere differenti: le più rappresentative del genere pastorale all’interno della letteratura italiana, vale a dire, L’Aminta di Torquato Tasso e Il pastor fido di Gian Battista Guarini.
Apparterrebbe al primo gruppo lo studio «Immagini e forme dello spazio scenico nella pastorale ferrarese» di Adriano Cavicchi. Qui l’autore ci offre un breve riassunto dei documenti relativi ai dettagli e alle peculiarità delle rappresentazioni nella corte ferrarese, ponendo grande attenzione allo sviluppo di questo genere dopo la morte di Alfonso ii. Francesco Luisi, nelle «Note sul contributo musicale alla drammaturgia pastorale avanti il melodramma», oltre a definire il melodramma come «la realizzazione musicale definitiva di una pastorale», compie un percorso dal Poliziano fino all’Aminta di Tasso, la quale sarebbe il riferimento principale per la drammaturgia musicale. Franco Croce scrive «La teatralità dell’Aminta», relazione in cui sottolinea l’uso della narrazione nell’opera del Tasso: cioè, l’uso della scena come sfondo dove si discutono gli avvenimenti, sempre in comparazione con la teatralità dell’opera di Guarini. Irene Mamczarz studia ne «I teatri provvisori di ‘verzura’ in Italia e in Francia» i luoghi di rappresentazione e la loro evoluzione in Francia e nell’Italia settentrionale come i palazzi, i teatri, le piazze e, soprattutto nel Seicento, i giardini. Sottolinea tre luoghi fondamentali per le rappresentazioni del Cinque-Seicento: il teatro di Niccolò Sebregondi, i teatri di «verzura» di Giuseppe Vigarani nel parco di Versailles e i teatri verdi di Giuseppe, Ferdinando e Ales-sandro Bibiena. Chiude questa sezione la relazione di Paola Guerrini «L’Aminta e l’iconografia di ‘paesaggio’ nella drammaturgia pastorale», in cui si offre un percorso interartistico intorno all’opera di Tasso, dalle immagini e xilografie che accompagnavano le prime edizioni fino agli adattamenti al cinema dei primi anni del Novecento.
Come detto sopra, la seconda sezione presenta saggi più eterogenei che non hanno un nesso comune, a eccezione dei già menzionati capolavori pastorali dell’epoca come punto di riferimento per i diversi argomenti. Umberto Albini presenta nel suo «Il dramma satiresco greco» uno studio tra la concezione positiva dei satiri nella classicità e la visione negativa che si attribuisce a queste figure nell’Umanesimo. Riccardo Bruscagli nel testo «Ancora sulle pastorali ferraresi del Cinquecento: la parte del Lollio» riflette sull’opera Aretusa di Lollio, una riproposta del genere pastorale che si situa tra la pubblicazione de Il sacrificio e dell’Aminta. Marziano Guglielminetti studia in «Un teatro del piacere o dell’onore?» le novità che offre il nuovo dramma pastorale del Cinque-Seicento, che si basa, soprattutto per le novità tecniche e formali, ancora sullo sfondo rustico proprio di questo genere. Il «Significato della Pastorale di Angelo Beolco detto Ruzante» di Giovanni Calendoli si dedica allo studio dello stile della pastorale sviluppato da questo autore: gli avvenimenti si svolgono in una campagna non così gradevole come quella della tradizione pastorale. Questa visione però, non rimane statica, in realtà relizza un’evoluzione durante l’opera stessa fino ad identificare un mondo più idillico e di finzione, specchio riflettente dei sogni impossibili del personaggio del Ruzante. Franco Vazzoler ne «Le pastorali dei Comici dell’Arte: la Mirtilla di Isabella Andreini» commenta l’opera scritta appunto dalla Andreini, oltre che autrice, attrice nella compagnia dei Gelosi. Questa, usando come punto di partenza l’Aminta del Tasso, adatta l’opera ai requisiti della compagnia cui apparteneva. Questo implica, tra l’altro, un numero maggiore di personaggi e di intrecci così come una caratterizzazione speciale di alcuni ruoli adatti alle competenze degli attori con cui lavorava. Per ciò che concerne la commedia dell’arte, è interessante il saggio di Giovanna Romei «La Commedia dell’Arte e la favola pastorale», in cui studia l’adattamento dei drammi pastorali fatto dagli attori di commedia. Studia, tra altre opere, appunto la Mirtilla, citata e analizzata anche da Franco Vazzoler.
All’interno di questa seconda sezione ci sono inoltre tre relazioni che esamina il dramma pastorale fuori della penisola italiana: Lois Potter nel «Pastoral drama in England and its political implications» risalta la produzione teatrale inglese che accoglie tratti del dramma pastorale italiano. È il caso di autori come Sidney, Spencer e soprattutto di William Shakespeare e John Fletcher (del quale, tra l’altro, risulta essere la traduzione de Il pastor fido in lingua inglese). Per quanto riguarda la Spagna, José Javier Rodríguez Rodríguez ne «La imitación de Il Pastor fido en la Comedia de Diana y Silvestro» riprende un’opera quasi dimenticata che imita, oppure traduce nel caso di alcuni frammenti, l’opera del Guarini. Infine Daniela Dalla Valle stabilisce un rapporto tra il mondo pastorale italiano e quello francese da un punto di vista strutturale, tematico e diacronico nel suo saggio «Il Tasso, il Guarini e la Pastorale drammatica francese».
Così come nel primo volume, il libro si chiude con due interventi bibliografici: una bibliografia italiana e francese, elaborata da Alessandra Maretti, e un’ultima bibliografia che riguarda la letteratura pastorale fuori dall’Italia raccolta da Maurizio Rebaudengo.
Nel primo volume le relazioni non solo concordano nel ruolo fondamentale dell’opera del Poliziano per lo sviluppo della favola pastorale, ma offrono anche uno studio completo e dettagliato del genere. La varietà tematica dei diversi interventi nell’insieme effettua un’analisi completa dell’Orfeo senza lasciare nessun campo inesplorato. Il resto dei saggi, svincolati da questa sorta di nesso connettore all’interno della raccolta, offrono una ricca informazione contestuale, che potrebbe anche applicarsi allo studio dell’opera del Poliziano, sottolineano l’importanza del ricupero dei classici, e studiano le caratteristiche del mondo pastorale idealizzato e lo sviluppo di questo genere, tanto in Italia quanto in altri paesi europei.
Il secondo volume invece, si centra nello studio delle rappresentazioni, anche se per raggiungere conclusioni pertinenti è fondamentale lo studio del testo letterario. Al posto dell’Orfeo si situa Il pastor fido di Guarini e in modo particolare, l’Aminta di Tasso. Inoltre, possiamo affermare che questa sia la raccolta che più abbraccia le affermazioni europee del dramma pastorale, analizzato nelle varianti inglesi, francesi e spagnole. Gli effetti visuali della messinscena e l’interarticità vengono anche amplificati e formano difatti l’oggetto di studio più rilevante di quest’ultima raccolta.
In conclusione, entrambe le opere ci mostrano una panoramica completa e dettagliata in quasi tutti gli aspetti del dramma pastorale dal primo Quattrocento fino al primo Seicento. Benché ognuna si focalizzi su temi molto specifici, attraverso le diverse relazioni, si viene a creare un contenuto compatto che ci permette di estrapolare un quadro più che completo del dramma pastorale nella letteratura italiana.
1. Origini del dramma pastorale in Europa, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing, 1985; Sviluppi della drammaturgia pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing, 1992.