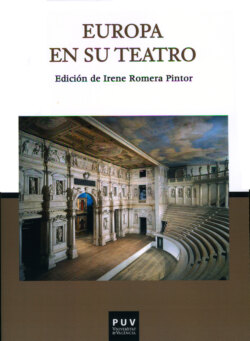Читать книгу Europa en su teatro - AA.VV - Страница 14
Origine e primi anni di attività del «Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale»
ОглавлениеQuirino Galli
Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale
Un «Centro Studi» può nascere e durare nel tempo soltanto se fondato su basi scientifiche e se a sostenerlo vi sono chiare e ferme prospettive. Il tema centrale dell’attività scientifica e didattica di Federico Doglio fra gli anni ′65 e ′75 verteva sul ruolo del Teatro Pubblico in Italia e il rapporto che questo doveva avere nei confronti della tradizione nazionale. 1
Nell’anno accademico 1969-1970 un fascicolo, Il Repertorio classico italiano, si aggiungeva alle dispense.2 Negli anni successivi ancora come tema di ricerca, di studio e di insegnamento: Vittorio Alfieri e Alessandro Manzoni.3 Dunque la riscoperta di un patrimonio culturale attraverso il teatro è uno dei percorsi che la riflessione storica può intraprendere. Ed è in questo insieme di osservazioni scientifiche, che sono alla base della creazione di un «Centro Studi» proprio su quell’arco di storia che viene meno frequentato dagli operatori teatrali, che nasce l’esigenza di intervenire.
Tuttavia, è pur vero che le grandi visioni hanno bisogno di fatti contingenti per prendere forma. Nell’anno accademico 1972-1973 il titolo del mio seminario, presso la cattedra di Storia del teatro e dello spettacolo dell’Università di Roma, docente Federico Doglio, era Il teatro d’avanguardia; accadde che gli studenti mi chiesero di trasformare quel seminario in un laboratorio. Dopo aver-ne parlato con Doglio, accettai la richiesta degli studenti e proposi loro di fare oggetto del laboratorio l’Ecerinis di Albertino Mussato; ritenevo, infatti, che si trattasse di un testo che, alternando dialoghi a monologhi, a passi epico-narrativi, bene si prestava a dare materia a una esperienza teatrale. Inoltre, l’Ecerinis era pur sempre la testimonianza del rinascere del sacro fuoco della tragedia.
L’esito di quel Laboratorio, che aveva rispettato i canoni di un teatro sperimentale, non fu solo lo spettacolo di fine d’anno, ma fu la sua acquisizione da parte dell’UNESCO; e il gruppo di studenti con il loro professore andò per l’Italia, proponendo ai più diversi pubblici quel testo con lunghi passi in latino che ai più semplici abitanti di piccoli paesi sembrò una bella musica.
L’Ecerinis giunse anche a Viterbo (città nella quale io risiedo) e per tre sere i sessanta spettatori, tanti dovevano essere, in quell’ambiente che una volta, forse, era stata la cappella del monastero dove soggiornò per più anni Vittoria Colonna, parteciparono alla rappresentazione di un testo che i più di loro non conoscevano. Il fatto ebbe una certa risonanza, per cui, qualche mese dopo, nella primavera del 1974, mi fu proposto di intervenire nelle celebrazioni per il Settimo Centenario della morte di San Bonaventura da Bagnoregio con qualcosa di teatrale, e pensai alla messinscena di qualcosa che ci riportasse al cli-ma culturale del Medioevo. Ancora una volta d’accordo con Federico Doglio, accettai e proposi la rappresentazione delle Laudi perugine, da allestirsi nella Sala del Conclave del Palazzo dei Papi. Le idee guida della messinscena furono pressoché le stesse impiegate per l’Ecerinis; per cui, per tre sere, nel mese di ottobre, centoventi spettatori posti sul perimetro di un grande rettangolo assistettero ad un rito. Ma il fatto rilevante ai fini della nascita del «Centro Studi» fu che nel corso di quei tre giorni si svolse un pubblico dibattito tra studiosi di diverse discipline, come F. Doglio, I. Baldelli, P. Brezzi, sui contenuti culturali dei testi recitati e cantati, un dibattito a cui assistette un buon pubblico e soprattutto alcuni esponenti della politica locale. Qualche settimana dopo, la RAI chiese a un Ente locale di Viterbo di allestire la messiscena di una Lauda della Natività; richiesta che l’Ente girò a me e che io accettai, impiegando le stesse componenti, ma tralasciando ogni riferimento a un «rito», pensando, invece, ad uno spettacolo predisposto per una visione frontale come è quella di una telecamera. La cosa importante che ne seguì fu la richiesta da parte di due Enti locali (Amministrazione Provinciale e Ente Provinciale per il Turismo) di un pubblico incontro con Doglio per determinare possibili iniziative culturali; e fu in questa occasione che Doglio propose la creazione di un «Centro di Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale». Seguirono a breve le risposte positive dei due Enti pubblici interessati, gli accordi con Doglio e le più immediate iniziative per pubblicizzare il progetto. E nel giugno del 1975, mentre all’interno del grande cortile del Palazzo Albornoz, fatto costruire nel XIV secolo per ospitare il cardinale Egidio Albornoz, colui che riportò a Roma da Avignone la sede papale, si rappresentava La festa goliardica, con testi tratti dalla Commedia elegiaca, Federico Doglio annunciava la creazione del «Centro» e presentava sia gli studiosi che avrebbero fatto parte del Comitato scientifico,4 sia il tema del Primo Incontro.
Aprendo i lavori del primo Convegno, F. Doglio tra l’altro affermava:
L’ormai secolare distacco che si lamenta fra gli studiosi di teatro e gli uomini di teatro italiani, è la causa principale della debolezza della nostra tradizione teatrale, una tradizione che, dai Drammi Liturgici ai testi di Pirandello, conta innumerevoli capolavori ma non possiede un luogo, una sede autorevole per metterli in scena con quella dignità e quella continuità che appunto consentono in altri paesi, il radicarsi e il realizzarsi di una vera vita di rapporto col pubblico, quindi, di un’autentica cultura.5
Se la Scuola non contempla nei suoi Ordinamenti la conoscenza della Storia del teatro, osservava Doglio, i Teatri Stabili vengono meno ad un impegno istitutivo. E più oltre affermava:
In questo contesto ci troviamo, quindi, ad operare controcorrente, ed è una condizione stimolante per chi crede che il teatro sia, non già un trattenimento evasivo per la borghesia benestante delle città, ma un evento interpersonale di alto contenuto educativo, soprattutto nella nostra epoca, l’epoca dei mass-media tanto spesso alienanti e massificanti. Recuperare il significato dell’evento, che si realizza fra persone, unitesi per riflettere sui grandi temi dell’esistenza umana, quindi per compiere insieme un’esperienza di vita morale, civile, estetica, per conseguire comunque un acquisto interiore, questo ci sembra essere il compito assegnato al teatro drammatico nel nostro tempo.6
Al Primo Convegno, 1976, il cui tema era Dimensioni drammatiche della liturgia medioevale, parteciparono studiosi provenienti da Italia, Belgio, Francia, Germania, Svezia. Si trattava di un tema che, opportunamente scelto, dichiarava la prospettiva storica come fondamento scientifico del percorso da intraprendere e poneva nel Dramma liturgico, che muovendo dall’Italia longobarda si diffondeva nell’Europa centrale, la rinascita del Teatro.7
Ciò che dette una reale concretezza alle indubbie prospettive scientifiche fu la «verifica scenica» prodotta dalla rappresentazione. In quel caso fu Momenti liturgici del triduo sacro: Reconciliatio paenitentium; De solemni actione liturgica postmeridiana in Passione et morte Domini; Adoratio crucis secundum «Regularis Concordia»; Planctus Mariae et aliorum in die Parasceven; Depositio; Ad vigiliam Paschalem; Visitatio Sepulchri. Il rito fu celebrato dai Padri benedettini di Sant’Anselmo di Roma; ed ebbe per il pubblico il significato della partecipazione a una cerimonia religiosa, più che l’assistere a una rappresentazione.8 I testi furono raccolti in un fascicolo e distribuiti agli spettatori, fu un’operazione di reale significato culturale, che si è ripetuta per tutti i Convegni e che, dunque, ha favorito la conoscenza di opere più che rare.
Il luogo delle celebrazioni, distribuite nei giorni del Convegno, fu la Chiesa di San Sisto, una chiesa edificata in epoca romanica, distrutta da un bombardamento aereo durante la Seconda guerra mondiale e ricostruita così com’era. La scelta di questo luogo fu molto interessante, perché significò una stretta connessione con il tessuto sociale e culturale di riferimento, ovvero quello del pieno Medioevo. Infatti, per il Secondo Convegno, 1977, Il contributo dei Giullari alla drammaturgia delle origini, il luogo prescelto per la rappresentazione fu piazza San Lorenzo, antistante il Duomo e il Palazzo papale.
La piazza come luogo della rievocazione dell’arte giullaresca fu tutt’altro che pretestuosa; essa rappresentava, sul piano storico, la definitiva rinascita della città che rompeva l’egemonia di una cultura appannaggio esclusivo della Chiesa, del Monastero e del Convento. Per cui:
Tentando di circuire dall’esterno il mondo complesso e variegato, che —con una parola sola che sottende tante cose—, chiamiamo il mondo dei giullari, si finisce forse, a tratti, col trovarselo più accosto, dinnanzi. Non sarà lo stesso per il mondo degli scolari che popola a Bologna o a Parigi, agli inizi del Duecento, le nuove istituzioni universitarie?9
Al Convegno parteciparono studiosi provenienti prevalentemente dall’Italia, ma anche dagli USA e dalla Francia.
Lo spettacolo, dal titolo Detto del gatto lupesco, era costruito con l’interpretazione di più testi: di Castra Fiorentino, di Ruggieri Apugliese e di altri rimasti anonimi.10
Un’altra piazza di Viterbo, quella di San Pellegrino, fu teatralizzata per lo spettacolo del III Convegno, 1978; una piazza che conserva ancora intatti tre dei suoi lati com’erano nel XIII secolo, mentre il quarto è costituito da una chiesa risalente all’XI secolo e che è stata oggetto di restauri nel XVIII secolo e dopo la seconda guerra mondiale. Lo spettacolo era De uxore cerdonis, un testo, appartenente al genere della Commedia elegiaca, forse di un certo Jacobus di Benevento, collocabile nel tardo medioevo, nel quale la narrazione evocava la figura del personaggio caratterizzato in un tipo psicologico, come è proprio di queste composizioni.11
Titolo del Convegno era L’eredità classica nel medioevo: il linguaggio comico e vi parteciparono studiosi provenienti dall’Italia, dalla Francia, dall’Inghilterra e dagli USA. A quale genere letterario sia da ricondurre la Commedia elegiaca, quali rapporti essa abbia con la commedia latina e quello che di questa i letterati del XII e XIII secolo ne sapessero, furono gli argomenti delle relazioni. Altrettanto argomentato fu il dibattito riguardante l’essenza formale del testo, approdando a diverse soluzioni: il testo è composto da distici elegiaci che accostano la narrazione al dialogo, o è una narrazione che trova maggior forza nel dialogo, o è una forma espressiva che ha una sua corrispondenza nel mondo culturale dell’epoca.12
Alle questioni connesse alla rinascita del genere comico dovevano seguire quelle connesse alla rinascita del genere tragico. Pertanto, tema del IV Convegno, 1979, al quale parteciparono studiosi provenienti dall’Italia, dalla Svizzera, dalla Germania e dagli Usa, fu: La rinascita della Tragedia nell’Italia dell’Umanesimo. Dalle varie relazioni emerge che tra gli intellettuali del Medioevo sono condivise le idee che il verso della composizione della tragedia debba essere solenne, i protagonisti nobili, gli accadimenti luttuosi e il finale infausto, ma con una possibile utilità sul piano etico. È evidente che per i tragediografi del ′300 e del ′400 il modello fu Seneca; ma lo sviluppo della composizione procedeva alternando passi esplicitamente teatrali, ovvero attraverso il personaggio, a passi semplicemente narrativi. Si trattava di testi che guardavano al presente, o all’immediatamente passato, scritti per rivendicare quelle libertà che tiranni e sovrani autoritari tentavano di sopprimere.13
Il testo rappresentato per quel Convegno fu Ecerinis di Albertino Mussato, non in una piazza, dove al culmine di una scalinata, l’attore avrebbe letto il testo secondo quanto è tramandato, ma un Chiostro: quello della Chiesa di Santa Maria del Paradiso, risalente al XIII secolo, splendido esempio dell’incontro fra Romanico e Gotico. Lo spazio scenico era suddiviso in due ambiti: quello attorno al pozzo sopraelevato di alcuni gradini, attorno al quale si svolgevano i dialoghi, e quello di un ampio palco addossato a un lato del chiostro, dal quale un attore narrava agli astanti ciò che stava accadendo, ovvero le crudeltà e gli assassinii di cui si ammantava Ezzelino III.14
Altrettanto suggestiva fu la rappresentazione delle Laudi per il V Convegno, 1980. Ebbe inizio all’interno del Duomo e poi, usciti da questo, attori e spettatori, secondo un andamento processionale, attraversarono quella piazza nella quale due anni prima si erano esibiti i giullari, ed entrarono negli ambienti sottostanti del Palazzo dei Papi, dove ridettero vita alle antiche laudi di Assisi.15
Aprendo questo Convegno Federico Doglio ribadiva quel motivo che aveva ispirato le tematiche dei quattro precedenti Incontri, ovvero:
(…) esplorare i multiformi modi espressivi, i linguaggi e le forme della drammaturgia medioevale, procedendo con ordine, secondo lo sviluppo cronologico degli eventi culturali ed artistici.
Per cui:
Questo metodo di lavoro ha consentito di raccogliere gli studi degli specialisti in una serie di «atti», che costituiscono ormai un’indispensabile collana consultabile da chi si occupa di teatro medioevale, una serie di saggi su temi che da almeno cinquant’anni erano assenti o in penombra nella cultura italiana.16
Una collana alla quale devono essere aggiunte le documentazioni filmate degli eventi spettacolari. Si tratta della iniziale costituzione di un patrimonio culturale che potrebbe aiutare a colmare la distanza tra studio del teatro delle origini e teatro militante; come potrebbe essere un insieme di materiali utili ad accostare i giovani alla cultura teatrale.
Gli argomenti proposti dai relatori, che provenivano dall’Italia, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Inghilterra, toccarono temi diversi tra loro che riflettevano la varietà delle sollecitazioni morali e spirituali presenti in quei movimenti dei quali protagonisti erano gli Ordini minori e i ceti popolari. Furono i movimenti dei Disciplinati, dei Flagellanti, che in processione, orando e cantando, attraversavano le città, chiedendo ai potenti di ricordarsi dell’umiltà di Cristo; e che poi, costituendosi in Confraternite, vennero ad essere controllati dal vescovo.17
Di fatto più discipline concorsero alla trattazione dell’argomento proposto dal tema del Convegno: dalla storia della letteratura, alla storia delle arti figurative, alla storia della musica, alla storia delle comunità locali.
Il Convegno del 1981 proponeva come argomento Rappresentazioni arcaiche della tradizione popolare. I relatori provenivano dall’Italia, dalla Francia, dalla Germania e dagli USA. Si trattava di un ampliamento e approfondimento degli argomenti trattati nel precedente Incontro, ma che nello stesso tempo poneva al centro delle varie indagini il concetto di «popolare», richiamando la possibile antitesi tra popolare/colta e quella più storicizzata tra subalterna/dominante; per cui con popolare si potrebbe intendere soltanto la forma più semplice del-la cultura, lasciando aperto il dibattito sul rapporto tra la cultura popolare e la storia, ovvero una inevitabile delimitazione dei significati della stessa cultura popolare.18 In effetti, è problematico individuare l’origine di fatti culturali definibili come popolari. Infatti, si può dire che la cultura popolare durante il Medioevo ha avuto fasi diverse, che ha precedenti in epoca latina e prolungamenti in quella moderna; oppure: si può collocare l’origine di quei fatti nella tradizione culturale romanza, pur avendo la sua origine nel mondo latino. Per cui la continuità di una tradizione non esiste in termini di linearità, ma piuttosto di discontinuità e conservazione, ovvero tradizione, e radicamento nel presente e se ne può concludere che «alla continuità delle forme si oppone la discontinuità dei contenuti».19
Furono queste le linee teoriche che guidarono lo svolgimento dei lavori del Convegno, che risultò particolarmente articolato attraverso la varietà delle relazioni e per i divergenti punti di vista sul piano teorico. Anche la parte dedicata alla verifica attraverso lo spettacolo, ripartita in più eventi, fu di particolare interesse. Infatti, quegli eventi spettacolari rappresentavano realtà culturali diverse e, seppure estrapolate dal loro contesto socio-culturale, erano risolte in una oggettività affascinante.
Le rappresentazioni furono: Il Bal do Sabre (Gruppo folcloristico di Bagnasco, Cuneo) eseguita in Piazza San Carluccio, delimitata da edifici di origine medioevale e rinascimentale; Sega la vecchia (Gruppo teatrale di Ramazzano, Perugia) eseguita all’interno del Palazzo degli Alessandri, posto su un lato di Piazza San Pellegrino, dove gia era stata messa in scena La commedia elegiaca; Il Maggio fiorito (Gruppo folcloristico di Pieve di Compito, Lucca), nel Parco cittadino di Pratogiardino, realizzato a ridosso della medioevale cinta muraria; La mascherata macabra (Gruppo le maschere di Dossena, Bergamo) nel Cortile di San Carluccio, un vecchio convento risalente al XVI secolo.
Gli spettacoli conviviali dall’antichità classica alle corti italiane del ′400 fu il tema del VII Convegno, 1982. E Federico Doglio, aprendo i lavori, affermava:
Questo settimo anno tentiamo, per la prima volta, non l’esplorazione di un momento della storia dello spettacolo, bensì l’analisi di un fenomeno esteso nel tempo, tentiamo, con i contributi di studiosi di ricca e varia competenza, una ricerca interdisciplinare, una lettura diacronica di un «genere» multiforme e complesso come quello degli intrattenimenti allestiti durante i banchetti, pubblici e privati, nel corso di più di un millennio di storia delle principali civiltà mediterranee.
Reperti archeologici, documenti storici, testi letterari e fonti iconografiche ci informano della reale entità, consistenza e persistenza di un fenomeno che gli antropologi culturali, gli etnologi, gli storici delle religioni, ci insegnano essere stato sempre collegato con eventi rituali che caratterizzavano i fatti fondamentali della vita sociale.20
Le relazioni ebbero il merito di riportare all’attenzione di un pubblico moderno paesaggi culturali e artistici circoscritti agli specialisti, come il mondo conviviale dei Greci21, degli Etruschi, dei Romani22 e dei Latini dell’Alto medioevo23; per cui il maggior numero delle relazioni fu dedicato a temi riguardanti: la musica24, la danza e l’acrobazia25, perché momenti di intrattenimento, non soltanto all’interno delle Corti, ma qualche volta anche per un più variato pubblico.
Lo spettacolo fu la messinscena di Cena Cypriani, un testo attribuito a San Cipriano, una attribuzione che non ha alcun fondamento storico. Storicamente certo è il rifacimento che ne fece Rabano Mauro di Magonza nell’855, come è certo che fu rappresentato nell’875 a Roma, forse per l’incoronazione di Carlo il Calvo.
A Viterbo fu allestito all’interno della Rocca Albornoz; fu un’esperienza di rara novità per gli spettatori e prova di una grande inventiva per il gruppo degli interpreti, dagli attori ai costumisti. Scriveva il regista:
Ci troviamo chiaramente davanti al divertimento e al delirio verbale di uno spirito allegro che attingendo a piene mani dal Vecchio e dal Nuovo Testamento si diverte a tracciare in assoluta libertà un canovaccio, una traccia verbale per una messinscena tutta da inventare per quei registi che si accingessero alla eventuale realizzazione.26
La rappresentazione, di fatto, consisteva nell’ingresso e nel passaggio in scena di personaggi tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento, riconoscibili sia per la battuta con la quale si presentavano, cinquecentocinquanta citazioni dai Testi Sacri, sia per un segno appartenente alla loro immagine. Nessun dialogo, nessun monologo e, pertanto, nessuna fabula. Riproporre quel testo a più di mille anni di distanza fu un’operazione di grande rilevanza culturale.
Nel 1983 Il «Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale» fu designato dalla Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval per organizzare il Quarto colloquio. Si trattò di una designazione che era il riconoscimento in campo internazionale del valore scientifico che il «Centro» aveva a fondamento della sua attività: organizzazione dei Convegni, pubblicazione degli At-ti, allestimento degli spettacoli e documentazione filmica di questi. Attività che si completava con gli incontri che il «Centro» organizzava con i docenti delle scuole medie di Secondo grado di Viterbo, poi di Roma, incontri nei quali, proprio attraverso i filmati, venivano presentati documenti che proponevano un patrimonio culturale posto ai margini dei programmi scolastici.
Il Quarto colloquio della Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval, per la quantità e qualità delle relazioni fu, nell’ambito degli studi sul teatro medievale, un evento di vaste proporzioni, il cui tema non poteva essere circoscritto a uno specifico argomento, ma doveva spaziare in più campi. E così poteva essere schematizzato:
Gli argomenti specifici, prescelti e segnalati dall’assemblea dei parte
cipanti al precedente Colloquio, erano:
1) quello assai vasto e generico dei «misteri»;
2) quello circoscritto ed esemplificativo del «processo di Paradiso e processo d’inferno e loro realizzazione scenica»;
3) infine quello operativo della «tecnologia della messa in scena».27
Ai partecipanti fu offerta, fuori degli orari del Convegno, la possibilità di visionare i documenti filmati delle rapresentazioni allestite per i precedenti incontri, ma anche la messinscena di un nuovo testo, Dittico di Erode. Laudi drammatiche perugine del 1300, realizzata nel Chiostro della Chiesa di Santa Maria del Paradiso.
Nel presentare la loro interpretazione del testo, gli attori con il loro regista avvertirono l’esigenza di puntualizzare il senso della loro operazione nei confronti di un testo del passato. E il regista scriveva:
È per questo che, nonostante ogni sforzo di filologia, noi non possiamo (e non vogliamo) arrivare al vero storico: ci basta il probabile, il verisimile, l’ipotetico, ed è per questo che non possiamo presentare un testo senza contaminarlo con le nostre interpretazioni e con la nostra invadente coscienza di uomini venuti dopo.28
Lo spettacolo era composto da due laudi, che, di fatto, nel XIV secolo si recitavano in giorni diversi nell’arco dell’anno.
Il luogo nel quale fu allestita la rappresentazione era quello nel quale quattro anni prima era stata proposta l’Ecerinis. Ma questa scelta non fu determinata dalla mancanza di altre ipotesi, perché la città di Viterbo, tra Chiostri e Chiese, offre tanti altri ambienti all’interno dei quali le suggestioni del passato sono tangibili, ma fu dovuta a convenienze dell’immediato. Il Chiostro di Santa Maria del Paradiso, in realtà, da sessanta anni in qua ha perso il suo isolamento e, ora, è circondato da nuovi edifici; ed è, forse, questa realtà urbanistica che suggerisce a chi entra nel Chiostro la sensazione di lasciarsi alle spalle palazzi e traffico e di trovarsi in una dimensione lontana nel tempo. Di fatto il tessuto urbano della città lascia ancora percepire, anche se immersi nel cemento, quelli che dovevano essere i poli della società medioevale e rinascimentale: l’ambito urbano del potere religioso e l’ambito urbano del potere politico interni alle mura, con i conventi e monasteri dentro e fuori di queste.29 Ciò che di essi è stato smarrito nell’assetto urbanistico moderno è una lettura paratattica della città come riflesso della società, per cui le piazze, le chiese, i chiostri attualmente esprimono una loro decisa soggettività e possono generare quella trasfigurazione del reale che può accogliere la rivivificazione di frammenti di cultura a loro coevi.
Nel 1984 tema del Convegno fu Origini del dramma pastorale in Europa, tema che ancora affascina per la sua apparente distanza dal reale; e gli studiosi, prevalentemente italiani, oltre a un francese e a uno spagnolo, non mancarono di far riferimenti a questioni di ordine metodologico. Per tanto: quanto c’è di reale della vita dei pastori nella letteratura del tempo? Quale relazione sussiste tra la figurazione poetica e la realtà storica del XV secolo, oppure tra figurazione pastorale e ricreazione scenica? Furono questi i temi che disegnarono la trama dello svolgimento del Convegno e che può essere riassunta nella seguente affermazione:
Non si tratta insomma di semplice gusto della finzione e dell’artificio, ma di sfruttamento interessato di un fertile canovaccio e di accoglienti fondali che si prestano ad ospitare ed inquadrare il lamento lirico come lo sfogo autobiografico, la celebrazione encomiastica come lo sviluppo teatrale. 30
In effetti, se tra la società cittadina e la comunità extraurbana non v’era relazione e se per secoli il pastore e il contadino erano stati oggetto di vivace scherno, da dove veniva tanta poesia? Proveniva dall’idealizzazione del mondo:
Per questo, la bellezza del nostro mondo, la ricchezza di una natura sempre prodiga di vita, la meraviglia dell’immane macchina dell’universo, la semplice perfezione delle cose create debbono essere, prima di tutto e soprattutto, insegnamento e, segno di una perfezione che infinitamente le trascende e che, tuttavia, sembra esprimersi proprio nell’incantata limpidezza di una campagna vaga e silenziosa, tra le selve ombrose e le verdi erbe così care alla poesia pastorale.31
Lo spettacolo prescelto fu La fabula di Orfeo tratto da Stanze di Angelo Poliziano. L’impegnativa messinscena riscosse molto successo, per la convergenza di diverse sensibilità artistiche, affiancata dal rigore della ricerca storica e filologica. Scriveva il regista:
La scelta per il mondo della favola, al di là delle mode del tempo, non rappresenta per lui (Poliziano) una fuga dal reale, ma la dimensione in cui il suo sentimento umanistico trova l’espressione più efficace. È la parola, spesso accompagnata da una fantasiosa ed immaginifica aggettivazione, ad indicare perentoriamente l’ambito interpretativo, che diviene composizione di atmosfere, ora idilliche, e contemplative, ora amorose, ora carnascialesche.32
La scenografia, più che una soggettiva interpretazione, fu il risultato di scrupolose ricerche di progetti di allestimenti teatrali dell’epoca: dai disegni di Leonardo per quanto riguarda il testo, alla pratica rinascimentale per quanto riguarda la sua realizzazione.
Scriveva lo storico della musica:
Se invece, come noi crediamo, la Favola d’Orfeo si ricollegò, perfezionandola, ad una fastosa tradizione di spettacoli celebrativi, spesso conviviali, il dialogo, molto più conciso di quello delle rappresentazioni, dovette essere tutto parlato e cantati soltanto i pezzi lirici. Musiche strumentali possono avere accompagnato momenti di azione puramente fisica, spesso spettacolare, senza parole. Su queste basi abbiamo impostato il compito arduamente problematico della ricostruzione.33
Luogo dell’allestimento fu l’ampio Parco di Villa Lante, distante quattro chilometri da Viterbo, edificata nella seconda metà del ′500.
Il tema del Convegno del 1985 fu Ceti sociali ed ambienti urbani nel teatro religioso europeo del ′300 e del ′400. L’evoluzione dell’assetto urbanistico, come una delle manifestazioni più evidenti di una evoluzione più generale porta con sé anche l’evoluzione delle manifestazioni dello spirito. Manifestazioni che si esprimono attraverso i codici della ritualità. Le espressioni collettive delle devozioni coinvolsero strati della società urbana sempre più ampi e l’area stessa del tessuto cittadino fu trasformata in luogo destinato alla rappresentazione d’argomento religioso. Dunque, da un lato la presenza sempre più determinante delle Confraternite,34 dall’altro l’ideazione di apparati scenici sempre più pretenziosi e prossimi alle esigenze di uno spettacolo, concorsero alla nascita della Sacra rappresentazione.35 E quanto mai efficace divenne sul piano culturale ed educativo il parallelo nel processo creativo fra la rappresentazione scenica e l’immagine pittorica degli affreschi agiografici.36 Furono questi i temi intorno ai quali argomentarono i vari relatori, che quell’anno provenivano dall’Italia e dalla Spagna.
L’opera scenica proposta per quel Convegno fu Il miracolo di Bolsena, appartenente a un Laudario di Orvieto, risalente ai primi decenni del ′300. Il luogo del-la rappresentazione fu il Sagrato della Chiesa di San Martino, piccolo centro a 6 chilometri da Viterbo, una abbazia cistercense risalente al XIII secolo, ma con vistosi rifacimenti di epoca barocca. Tra le possibili soluzioni scenografiche fu presa quella di una divisione del fronte scenico in quadri, che A. D’Ancona chiamava «capannucce», occultati da un proprio sipario che si apriva quando l’episodio prendeva vita nella narrazione.37Si trattava di una soluzione che evidenziava il carattere epico-narrativo del racconto scenico, ma che prefigurava già l’ideazione dei «luoghi deputati» della Sacra rappresentazione; una soluzione a fronte della quale sta l’ipotesi di una scena che, attraverso l’immagine di una montagna con una grotta alla base per la natività e il culmine per la crocefissione, prospetta l’insieme di simboli che sono a fondamento della cultura figurativa del Medioevo.38Dunque, la verifica scenica era, al pari di tutte le relazioni scientifiche, non solo lo spettacolo utile a suggestionare lo spettatore moderno, ma l’affermazione di una tesi e la definizione di un percorso conoscitivo e ri-creativo di un fatto culturale appartenente al passato.39
Quel Convegno fu l’ultimo che il «Centro Studi» organizzò a Viterbo. Le divergenze e le incomprensioni fra gli Amministratori locali e la Direzione scientifica furono insanabili e il «Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale», purtroppo per Viterbo, trovò sede altrove.
1977: Il «Teatro di Ventura» con la regia di Ferruccio Merisi rappresenta sul sagrato del Duomo di Viterbo il «Detto del Gatto Lupesco».
1978: La Compagnia del Politecnico diretta da Giandomenico Curi rappresenta la comedia elegiaca «De Uxore Cerdonis» nella Piazza San Pellegrino nel Quartiere Medievale.
1980: La Compagnia «Il Baraccone» diretta da Luigi Tani rappresenta nella cripta del Palazzo Papale di Viterbo «Guarda bene Disciplinato» (Laudi Umbre delle Confraternite).
1985: La Compagnia «Il Baraccone» diretta da Luigi Tani rappresenta sul sagrato della Chiesa di San Martino al Cimino «Il Miracolo di Bolsena».
1. DOGLIO, F., Il teatro pubblico in Italia. Lezioni di «Storia del teatro e dello spettacolo». Appunti e documenti, Roma, Bulzoni, 1969.
2. DOGLIO, F., Il repertorio classico italiano rappresentato dai nostri stabili, Roma, Bulzoni, 1970.
3. DOGLIO, F., La fortuna scenica del teatro alfieriano, Roma, vol. i, anno accademico 1970-71; vol. ii, anno accademico 1971-72. Alessandro Manzoni. Scritti e appunti sul teatro, Roma, Elia, 1973.
4. I componenti del Comitato scientifico erano, oltre a Federico Doglio: Ignazio Baldelli, Eugenio Battisti, Nino Borsellino, Paolo Brezzi, Orazio Costa, Aulo Greco, Scevola Mariotti, Giorgio Petrocchi, Nino Pirrotta.
5. DOGLIO, F., «Apertura dei lavori», en Dimensioni drammatiche della liturgia medioevale, Roma, Bulzoni, 1977, p. 12.
6. DOGLIO, F., «Apertura dei lavori», en Dimensioni drammatiche…, ed. cit., p. 13.
7. Cfr. LIPPARDT, W., «Il tropo drammatico. Problemi inerenti alla sua origine, alla sua esecuzione e diffusione», en Dimensioni drammatiche…, ed. cit., pp. 17-31.
8. La regia fu curata da Orazio Costa, ma, in effetti, si trattò di una supervisione artistica, perché gli attori, ovvero coloro che eseguivano il rito, celebravano una cerimonia.
9. Cfr. ALESSIO, F., «Cultura, Artes e istituzioni dal xii al XIII secolo», en Il contributo dei Giullari alla drammaturgia italiana delle origini, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 15-25 (cit. p. 25).
10. La regia fu di Ferruccio Merisi.
11. La regia fu di Giandomenico Curi.
12. Cfr. BERTINI, F., «La commedia latina del XII sec.», en L’eredità classica nel medioevo: il linguaggio comico, Viterbo, Agnesotti Editore, 1979, pp. 63-80.
13. STäUBLE, A., «L’idea della tragedia nell’umanesimo», en La rinascita della Tragedia nell’Italia dell’Umanesimo, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing, 1980, pp. 47-70.
14. La regia fu di Rino Galli.
15. La regia fu di Luigi Tani.
16. DOGLIO, F., «Introduzione», en Le Laudi drammatiche umbre delle origini, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing, 1981, p. 23.
17. Cfr. BREZZI, P., «La religiosità popolare tardoducentesca nel quadro della società italiana coeva», en Le Laudi drammatiche…, ed. cit., pp. 29-45.
18. Cfr. MANSELLI, R., «Storicità e astoricità della cultura popolare», en Rappresentazioni arcaiche della tradizione popolare, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing Editrice, 1982, pp. 25-42.
19. Cfr. BRONZINI, G. B., «Origini e continuità della drammatica popolare del Medioevo. La dimensione allegorica e carnevalesca», en Rappresentazioni arcaiche…, ed. cit., pp. 43-79.
20. DOGLIO, F., «Introduzione», en Gli spettacoli conviviali dall’antichità classica alle corti italiane del ′400, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Agnesotti Editore, 1983, pp. 13-17 (cit. p. 14).
21. Cfr. ROSSI, L. E., «Il simposio greco arcaico e classico come spettacolo a se stesso», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 41-50.
22. Cfr. TORELLI, M., «Gli spettacoli conviviali di età classica (Documenti archeologici su possibili fatti genetici e sviluppi)», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 51-64.
23. Cfr. CORBATO, C., «Symposium e teatro: dati e problemi», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 65-90.
24. Cfr. BONARIA, M., «La musica dal mondo latino antico al medioevo», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 119-148; salMen, W., «Musica conviviale nell’alto e nel tardo medioevo», pp. 183-202 (traduzione dal tedesco).
25. Cfr. BUSCH-SALMEN, G., «Balletti e numeri di equilibrismo dinanzi alla mensa medioevale», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 209-218 (traduzione dal tedesco); gallo, F. A., «La danza negli spettacoli conviviali del secondo Quattrocento», en Gli spettacoli conviviali…, ed. cit., pp. 261-268.
26. Cfr. MOLè, F., «Note di regia», en Cena Cypriani, fascicolo contenente il testo della rappresentazione, p. 3.
27. GASCA QUEIRAZZA, G., (Presentazione), en Atti del iv Colloquio della Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval (Viterbo 10-15 luglio 1983), ed. de M. Chiabò, F. Doglio y M. Maimone, Viterbo, Union Printing Editrice, 1984, pp. 5-7 (cit. p. 6).
28. Cfr. ROCCA, G., en Dittico di Erode, fascicolo contenente il testo della rappresentazione, pp. 5-6.
29. Sulla relazione tra i due poli del potere cittadino, cfr. Duby, G., L’arte e la società medievale, Bari, Laterza, 1977.
30. Cfr. TENENTI, A., «Figurazione bucolica e realtà sociali», en Origini del dramma pastorale in Europa, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing Editrice, 1985, pp 17-28 (cit. p. 20).
31. Cfr. VASOLI, C., «Tra mito dell’amore e ritorno all’età dell’oro. Considerazioni sulla cultura del tardo Quattrocento», en Origini del dramma pastorale…, ed. cit., pp. 29-40 (cit. pp. 32-33).
32. Cfr. TANI, L., «Nota di regia», en La fabula di Orfeo, fascicolo contenente il testo della rappresentazione, p. 27.
33. Cfr. PIRROTTA, N., «Nota alle musiche», en La fabula…, ed. cit., p. 30.
34. Cfr. RUSCONI, R., «La religione dei cittadini: Riti, Credenze, Devozioni», en Ceti sociali ed ambienti urbani nel teatro religioso europeo del ′300 e del ′400, ed. de M. Chiabò y F. Doglio, Viterbo, Union Printing Editrice, 1986, pp. 17-40.
35. Cfr. PACCIANI, R., «La città come palcoscenico: Luoghi e proiezioni urbane della sacra rappresentazione nella città italiana fra trecento e quattrocento», en Ceti sociali…, ed. cit., pp. 59-82.
36. Cfr. FRUGONI, C., «Realtà, trasposizione scenica, teatro pietrificato nella vita cittadina medioevale», en Ceti sociali…, ed. cit., pp. 83-91.
37. La regia fu di Luigi Tani.
38. Cfr. GALANTE GARRONE, V., L’apparato scenico del dramma sacro in Italia, Torino, Bona, 1935.
39. Nel 1956 si tenne ad Arras un convegno sul tema La mise en scène des oeuvres du passé. Dalle relazioni esposte dagli studiosi e dagli operatori di teatro furono argomentate diverse questioni relative al complesso problema della messa in scena di un teatro che, per contenuti e modalità espressive, appartiene a sistemi culturali in sé conclusi, ma che può essere incisivo nel mondo contemporaneo. Ciò che è di fondamentale importanza, di fronte alla complessità del problema, è la possibilità di poter disporre di raccolte che, accanto al testo drammaturgico, documentano la realizzazione scenica così come essa si è adeguata nel corso del tempo; sono tali raccolte che consentono il contatto con realtà culturali diverse e lo studio delle medesime (v. A. Veinstein). La messa in scena di un’opera del passato, qualunque sia l’atteggiamento culturale che la sostiene, è inevitabilmente un processo di attualizzazione nel quale il testo dell’autore, come dato culturale, si vivifica attraverso l’attore e il regista, in quanto interpreti; sono questi che danno vita al testo così come si può dar vita a un quadro, rinvenendo in questo: epoca, luogo, senso e significato dei simboli; come nella pittura medioevale, che, al pari del teatro religioso, aveva la capacità di coinvolgere il pubblico, proponendo i valori connotativi della società (v. J. Laude). Di fatto, l’interpretazione può essere operata anche come una traduzione del testo e delle sue modalità espressive che appaga le esigenze della contemporaneità in virtù di un’analisi critica dei contenuti, ma può anche essere la ri-creazione, basata sui risultati delle indagini filologiche, di una esperienza che appartiene, con la sua identità, alla storia della società; una ri-creazione che pretende da parte del regista amore e rispetto del testo e del contesto in cui questo venne ideato. E se ciò che poteva coinvolgere un pubblico medioevale può lasciare indifferente un pubblico moderno, il lavoro dell’interprete deve tendere a riproporre quello che è eterno nelle opere del passato (v. R. Clermont). Per questa prospettiva un significato essenziale è quello che può derivare dalla reciproca integrazione dell’ambiente architettonico con la dinamica dello spettacolo (v. R. Allio). Cfr. La mise en scène des œuvres du passé: entretiens d’Arras, 15-18 Juin 1956, ed. de J. Jacquot y a. Veinstein, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1957. In particolare, cfr: Veinstein, A., «Documentation et création», pp. 91-109; lauDe, J., «L’histoire, la peinture et la mise en scène d’événements passés», pp. 129-160; ClerMont, R., «La mise en scène du théâtre médiéval», pp. 223-231; allio, R., «Les scènes de plein air», pp. 279-282.