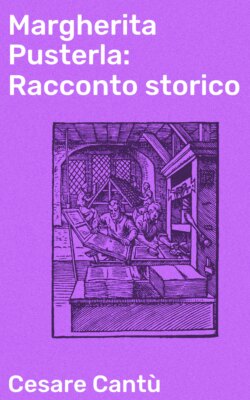Читать книгу Margherita Pusterla: Racconto storico - Cesare Cantù - Страница 12
LA CONVERSIONE.
ОглавлениеCon questo martello passò Buonvicino la giornata: invano procurò divagarsi in altre cure, in differenti pensieri. La notte non chiedetemi se velasse le pupille; nè il dì seguente fu più tranquillo, o l'altro, o l'altro. Aspettava una risposta, e la risposta non sapea venire; temeva, sperava; e quel rimanere sospeso gli venne alfine così tormentoso, che, per togliersene fuori, pareagli avrebbe sofferto meno di mal animo la certezza del peggio. Alcuna volta per uscire dalla perplessità, proponeva di recarsi a lei; pareva deliberatissimo, indi mutava pensiero; tornava a risolvere, movevasi, usciva, s'avviava per quel quartiere, giungeva a quella via mozza,—un'occhiata alla porta, un sospiro, e passava.
Dopo tanti pentimenti e ripentimenti pure trovò il coraggio di entrare. Come gli tremavano le ginocchia, come gli bollivano le tempia nel breve tragitto dalla via all'ingresso! il rimbombare del ponte levatojo sotto i suoi passi pareagli una voce di sconsiglio, di minaccia; salendo lo scalone, dovette appigliarsi alla sbarra, perchè gli si annaspavano gli occhi; vi era entrato sempre con tanto cuore, con sì serena baldanza!—Ch'io non sia più uomo?» disse fra sè; e col muto rimprovero rinvigorita la volontà, accostossi all'anticamera, ed ai famigli chiese della Margherita. A lui non tenevasi mai la porta: onde, rispostogli che la dama stava nel salotto, mentre un paggio correva ad annunziarlo, un altro ve lo introduceva.
Era un salotto capace, coll'altissima soffitta di travi maestrevolmente intagliate e dorate; le pareti coperte di corami a rilievi di colori e oro; un tappeto orientale era steso sul pavimento; un fino cortinaggio di damasco cremisino ondeggiava sopra gli usci, e innanzi alle spaziose finestre, fra' cui telaj arabescati, e i piccoli vetri rotondi penetrava la luce temperata. Sul vasto focolare lentamente ardeva un ceppo intero, diffondendo un tepore ancora gradevole in quella prima stagione. Macchinosi armadj di noce ed eleganti stipi di ebano intarsiato ad avorio, e messi ad argento e madreperla, erano addossati alle pareti: qui e qua alcuni tavolini, e qualche gran seggiola a bracciuoli ed orecchioni, somiglianti a quelli che oggi la comodità o l'imitazione ritorna di moda.
In una di queste sedeva la Margherita, in abito di semplice eleganza; e poco da lei discosto, muta e indifferente come una decorazione, sovra umile sgabello lavorava una damigella. Margherita pareva allor allora avesse deposto sul predellino il tombolo, sul quale coi piombini stava tessendo trine, occupazione prediletta delle sue pari, ed erasi recato in mano un libriccino di pergamena, riccamente rilegato, con borchie d'oro, cesellate finamente.
Senza levar gli occhi da questo,—Benvenuto!» esclamò con accento melodioso, e con un molle chinar di capo, allorchè il paggio, alzando l'usciale, ripetè il nome del cavaliero che introduceva. L'agitazione propria non permise a Buonvicino di notare se nel suono della voce di lei, qualche tremito annunciasse l'interno commovimento: ma, per legare discorso,—Qual è, madonna, (le chiese) il libro che ha la fortuna di occupare la vostra attenzione?»
—È (rispose ella) il dono più caro di che mio padre mi presentasse quando venni sposa. Caro padre! negli anni di sua senile quiete, occupava d'ogni dì qualche ora a scriverne una pagina; coll'accuratezza che voi vedete, miniò egli stesso e indorò queste lettere capitali; sono di sua mano questi ghirigori del frontispizio: ma il meglio, oh il meglio son le cose che vi ha vergate, col titolo di Consigli a mia figlia. E me lo consegnò coll'ultimo bacio, allorchè mi congedò dalla sua casa a questa. Pensate s'io mel tenga prezioso! Anzi, poichè la ventura vi guidò in buon punto, parrei troppo ardita se, avendo voi ozio, vi pregassi a farmene un poco di lettura?»
Un desiderio della Margherita era sempre il suo: quanto più questo, che lo toglieva da una situazione tanto penosa e impacciata? Accostato adunque uno scannello, tosto si fu seduto poco lontano da lei. Margherita riprese le sue trine, la damigella continuava a cucire, e Buonvicino, con avido movimento pigliato il libro, seguitando là appunto ove la dama mostrava d'averne sospesa la lettura, a voce alta incominciò:
—Ma sia pure, figliuola mia, che la passione ti tolga di mente quel Dio che chiamasti testimonio de' giuramenti fatti allo sposo: non badare nulla agli uomini, i quali, senza udire le discolpe, ti condanneranno all'inappellabile tribunale dell'opinione: deva pure il tuo consorte ignorare per sempre i torti tuoi—qual sarai tu con te stessa? Consumato appena il fallo, addio serenità; cento timori ti assalgono; a cento menzogne ti trovi costretta; e un passo dato in sinistro a mille altri ti conduce. Tante ore passavi col marito in quella mite gioja senza ebbrezza, che solo in grembo alla virtù si ritrova; con lui dividendo, alleggerivi le tribolazioni, retaggio dell'uomo nell'esiglio. Ora egli dee venirti odioso, egli continuo rimprovero del tuo peccato, egli la cui vista ti rinfaccia un giuramento, onde libera ti legasti seco, e che poi sleale hai violato. Se d'altro t'incolpa, se ti bistratta, vorresti giustificarti, ma la coscienza ti grida che meriti ben di peggio. Se ti accarezza—oh qual cosa di più straziante che le fidenti carezze d'un oltraggiato? I suoi affettuosi abbandoni lacerano l'anima tua ben peggio che i corrucci, che l'oltraggio, anzi, più che un pugnale. La notte, nel letto testimonio di sereni riposi, quieto, sicuro egli ti dorme a lato:—dorme quieto, sicuro a lato di colei che l'offese, che lo detesta come ostacolo alle fantastiche sue felicità. Ma il placido dormire non è più per te; egli è là per rimproverarti tacendo. Nelle penose ore della lunga veglia, t'ingegni stornare il pensiero sulle cure della vita, sui passatempi; cerchi bearlo in quell'oggetto che chiami il tuo bene, e ch'è causa d'ogni tuo male; ma in ciò pure che dubbj, che delirj! Degli affetti suoi chi ti assicura? Te n'ha egli neppur dato prove quante il marito?—Mi amerà, tu dici, perchè l'amo io.—Oh, non t'amava il tuo sposo? e lo tradisti. Bene; e se l'amico tuo ti trascuri e ti disprezzi, cosa gli dirai tu? rimproverarlo d'infedeltà, rinfacciargli i giuramenti? Ma il bene stesso che gli vuoi non è un'infedeltà, uno spergiuro? Allora abbandonata da esso, ove ricorrerai? allo sposo ingannato? ai figliuoli posti in dimenticanza? alla pace domestica demeritata?
_Tali sono le tue veglie. E quando pure il sonno dà tregua alla fatica dei pensieri, che sogni! che visioni! Tu ne balzi atterrita, e fissi gli occhi sullo sposo. Oh! forse, tra il dormire, ti uscì dal labbro una parola che tradisse il tuo segreto; lo guardi spaventata, egli guarda te carezzevole, e ti domanda: Che hai?—Oh l'animo tuo in quel punto!_
Ed ecco intorno i pargoletti, cari, vezzosi, dolcissima cura, abbellimento e delizia della vita. Tu li carezzi, li carezza il padre; li bacia, li palleggia, ne guida i primi passi: insegna alle labbra infantili a ripetere il suo nome, il tuo, con essi viene a ricrearsi dalle sollecitudini dei negozj; all'innocenza loro cerca il balsamo quando il nausearono la prepotenza, l'orgoglio, la doppiezza degli uomini. E ti dice: Diletta mia, quanto è soave questa età; quanta affezione ci lega al nostro sangue! Miserabile! perchè impallidisci?
Poi coll'immaginazione egli previene il lampo, quando, gia' vecchio, si vedrà ringiovanire in quegli esseri amati, e guidato a mano da loro, ritesserà la tela della vita: Essi saranno buoni, è vero, diletta mia? buoni come la loro madre; e consolazione nostra come essa fu sempre la mia.
Che? tu chini la fronte? arrossisci? premi al seno il più piccino, non per impeto d'affetto, ma per celare il turbamento del viso? Suvvia, sta ferma: che temi? Dio non v'è, o non cura, o perdonerà per un sospiro che gli darai quando il mondo ti avrà abbandonata. Gli uomini non ne sanno nulla: nulla mai ne saprà il tuo consorte… Oh ma che importa? Lo sa la coscienza tua: te lo rinfaccia con voce insistente che non puoi soffocare, cui non sai rispondere: essa ti mostra davanti una strada di menzogne e di raggiri, per cui sei costretta a scendere più rapida, quanto più inoltri nel declivio: vorresti fermarti e non puoi… Guai, guai se ti porta fin là, dove neppure ti giunga la voce della coscienza.
A ciò, figlia mia, a ciò vuol ridarti colui che tenta rapirti all'amore del tuo sposo.—E costui, ti ama?
Grosse stille di sudore gocciavano dalla fronte impallidita di Buonvicino mentre leggeva: il cuore gli si serrava: sentivasi mancare: più e più fioca gli diveniva la voce; qui alfine del tutto gli mancò. Depose il libro, o piuttosto se lo lasciò cascare di mano: rimase cogli occhi a terra confitti, nè per alquanti minuti potò riavere la parola. Margherita seguitava ad aggruppare i fili, muovere i piombini, trapiantare gli spilli del suo lavoro, studiando mostrarsi tranquilla: ma chi v'avesse posto mente, dallo scompiglio dell'opera avrebbe argomentato allo scompiglio dell'interno. Neppure a Buonvicino poterono rimanere inosservate alcune lagrime che, per quanto ella si ingegnasse di rattenere, le caddero dagli occhi sul lavoro.—Qual merito avrebbe la virtù, se le sue vittorie non costassero nulla?
Dopo un intervallo di silenzio, egli si alzò; e facendosi forza quanto poteva maggiore per rendere salda la voce,—Margherita (esclamò) questa lezione non sarà perduta: quanto mi basterà la vita, ve ne avrò obbligazione».
La dama levò sopra di lui uno sguardo di quell'ineffabile compassione, che forse prova un angelo quando osserva l'uomo, alla sua tutela commesso, inciampare nella colpa, da cui prevede che frappoco risorgerà, bello del pentimento. Poi, non appena Buonvicino fu uscito, non appena intese l'imposta rabbattersi sull'osservata orma di lui, concesse libero sfogo all'affanno, sin allora penosamente compresso: si alzò, corse alla culla ove dormiva il suo Venturino, lo baciò, lo ribaciò, e sulla tenera faccia del vezzoso infante lasciò sgorgare un torrente di lagrime; ultimo tributo che pagava alle memorie della gioventù, a quei primi affetti che aveva lusingati perchè innocenti. Una madre, nei pericoli del cuore, a qual asilo più sicuro può riparare, che all'innocenza de' suoi bambini? E il bambino aprì gli occhi, quegli occhi di fanciullo, in cui il cielo pare riflettersi in tutta la serena limpidezza; fissò, conobbe la madre, e gettandole al collo le tenere braccia, esclamò:—Mamma, cara mamma!»
Quella parola come sonava in quel momento preziosa, illibata, santa alla Margherita! Tutta ne godette la voluttà; in quella trovò di nuovo la calma, la sorridente tranquillità d'un cuore che, il momento dopo la procella, esulta d'esserne uscito illeso.
Buonvicino andossene come fuori di sè: non distinse la scala, i servi, la porta, la via; errò lungo tempo come il caso lo portava, senza vedere, senza udire. Era, non so se l'abbiamo accennato, il giovedì santo, giorno di universale compunzione, quando, siccome oggi ancora molti, così tutti in quel tempo solevano girare alla visita dei sepolcri, in cui si cela il Sacramento, per commemorazione di quel glorioso, ove stette riposta la salma dell'Uom Dio, nel dì che fu consumata la rigenerazione del genere umano. Torme d'uomini, di donne, di fanciulli, poveri, cenciosi e mezzo ignudi, contadini in zoccoli e giubbone di stamina, cavalieri in ricco abito dimesso, senza piume, senza le armi, empivano le strade, quali solitarj, quali a coppia, in fila o a disordinate torme seguitando una croce, da cui, tolto il divino peso, cascava un sindone a festone. I più camminavano scalzi, molti non d'altro coperti che d'un sacco; alcuno ripeteva ad alta voce il rosario, e un disaccordo di voci piagnolose gli rispondeva: altri intonavano lo Stabat Mater e i salmi del re penitente: o mormorando in tono compunto il Miserere, ad ogni verso si percotevano le spalle con flagelli di corde aggruppate: alcuno, quasi ciò fosse poco, ravvolto sino al capo in ruvido traliccio e cosperso di cenere, si avviava lento con dietro due o tre famigli e confratelli, che tratto tratto gli scagliavano sul dorso staffilate a tutta forza. Ed ecco comparivano numerose confraternite di maschi e donne imbacuccati, schiere di frati e di monache non legate alla clausura: e tutti nude le piante, le mani giunte, gli occhi a terra, scoronciando, cantando, singhiozzando.
In tal modo passavano da una all'altra delle sette basiliche principali, di cui le più rimanevano allora fuori del recinto della mura; e giunti in ciascuna, fra le adorazioni che vi prestavano, e le memorie del maggior mistero di amore e di espiazione, raddoppiavano le preci, il canto, il piangere, il gemere, il picchiar dei petti, il flagellarsi.
Da ciascuna parrocchia poi venivano alla visita lunghe processioni; in tutte era un uomo vestito da Cristo, con un pesante crocione sulla spalla: e intorno a lui donne che figuravano la Vergine, la Maddalena, santi d'ogni età, d'ogni nazione, innalzando gemiti di pietà: nel mentre altri, vestiti alla foggia che i molti pellegrini avevano veduto usarsi in Palestina, dovevano figurare i Giudei, Pilato, Erode, Longino, il Cireneo; e ciascuno rappresentava secondo il suo personaggio, e proferiva strane parole, interrotte dai gridi, dai singhiozzi degli spettatori, da un frastuono di raganelle e di mazze percosse per le muraglie e contro le porte, onde i fanciulli in frotta manifestavano l'incomposta loro devozione.
Un saltambanco cieco, montato sur un tavolotto, con una tal quale flebile e monotona cantilena ripeteva una composizione, rozza se poteva essere, e che oggi desterebbe sorriso e disprezzo[6], allora moveva lacrime di devota compassione. L'intenta plebe si affrettava di gettar un quattrino nel bossolo del povero cieco: ad alcuni di quei robusti uomini, educati o cresciuti per la guerra, che non avevano mai compatito ai travagli veri e presenti dei loro simili, ora udendo rammentare le volontarie pene dell'Innocente, s'imbambolavano gli occhi: e taluno, battendo la scabra destra sull'elsa della spada, esclamava:—Oh che non éramo là noi a liberarlo!»
Frati intanto, o palmieri coperti del sarrocchetto, profittavano di quell'ardore, di quel commovimento per dipingere gli orrori onde avevano veduta oppressa la Terrasanta dai Musulmani, e incoravano chi avesse fede a voler redimerla col ferro, o almeno coll'oro sollevarla.
In mezzo a questo brulichìo di popolo, a questa bizzarra mescolanza di cose le più serie con burlesche, carattere dei mezzi tempi; fra lo spettacolo grandioso di una gente intera che si condolea dei patimenti di tredici secoli fa, come fossero di jeri, passava Buonvicino, ora lasciandosi dalla calca trasportare, ora fendendola a ritroso, ma coll'occhio a terra, quasi temesse incontrar un accusatore in ogni volto che fissasse: assorto ne' suoi pensieri così, che uno, al mirarlo, potea crederlo più di tutti compreso dalla pietà universale. Era in quella vece un travaglio fiero, insistente, di fantasie, di sgomenti, che gli si stringevano attorno come la folla ond'era circondato. Ma dalla folla si sviluppò alla fine, e cacciossi fuori della città. Il sole piegava al tramonto; un vento impetuoso, come suole di quella stagione, fischiava tra i rami delle piante, ove appena cominciava a rifluire il succhio vitale, ed agitava le erbette rinnovate al raggio del sole, che, dopo il torpore invernale, le fomentava traverso un aere, la cui limpidezza non era offuscata ancora dalle crasse esalazioni dei prati marci.
Quivi trovata alfine la solitudine, tanto desiderata agli animi commossi, abbandonavasi Buonvicino ai suoi sentimenti,—sentimenti opposti di amore, di dispetto, di gioje, di tribolazioni, di speranze, di ripetio. Sedeva, girava, meditava: or rivolgeva gli sguardi sopra la città, sulle torri ove ammutolivano i sacri bronzi; sugli spaldi ove le ronde passeggiando, a intervalli gridavano e si rispondevano, Visconti, Sant'Ambrogio. Questo grido ritraendolo a pensare ai mali della sua patria, lo svagava un istante da' suoi proprj:—ma i mali della patria non erano gran parte, anzi la maggior parte de' suoi? Riandava i tempi della passata libertà, paragonandoli ai troppo diversi che ora gli pesavano sopra, ed ai peggiori che vedeva avvicinarsi; ricorreva le balde speranze giovanili, quando si figurava libero in libera patria, e giovare col braccio e col consiglio i suoi cittadini, salire ai primi onori, meritar lode e gloria nel pubblico:—in privato poi… E qui tornava alla Margherita, a lei ancora fanciulla, ancora un bocciuolo di rosa che da lui aspettava l'alito vivificatore: un cuore innocente, che ad una sua parola poteva sorgere al pieno sentimento di una intemerata felicità.—Ah! tutto era disparso; disparsa la pubblica speranza, disparsa la domestica contentezza.—Ella, almeno, ella sia felice, e goda anche la porzione di bene che a me fu negata.—Felice?… bene?… Ed io, sciagurato, io osai d'insidiarne la purezza? io aspirai a turbare per sempre la tranquillità di lei, d'un amico?»
Fra questi e somiglianti pensieri, Buonvicino si accostò alla postierla di Algiso, come chiamavano quel ch'è oggi il ponte di San Marco; ed entrato, si trovò di fianco alla chiesa degli Umiliati di Brera. Nel giorno e nell'ora che Buonvicino vi capitò, pochi devoti, quelli solo cui l'età o le occupazioni impedivano di visitare cogli altri le sette chiese, traevano qui ad offrire la solinga loro preghiera a Colui, che tutte e da per tutto le ascolta.
L'ordine degli Umiliati era nato in Milano, circa tre secoli prima, da alcuni laici congregatisi a far vita devota in case comuni, ove le donne non erano dagli uomini appartate. San Bernardo, quando viaggiava persuadendo l'Europa a precipitare sopra l'Asia per impedire che la mezzaluna prevalesse alla croce, Maometto a Cristo, la civiltà alle barbarie, dettò qui agli Umiliati le regole, per cui alcuni vennero unti sacerdoti, segregati i due sessi; onde rimase formato il secondo Ordine, di cui erano questi, che sovra un prædium, e vulgarmente breda o brera, avevano fabbricato il convento che conservò l'antico nome. Il terzo Ordine riconosceva per istitutore il beato Giovanni da Meda, che nella casa di Rondineto, oggi collegio Gallio a Como, fondò i preti Umiliati. Tanto crebbe l'Ordine, che nel solo Milanese possedeva ducenventi case (case e canoniche chiamavano i loro conventi), e in ciò si distingueva dagli antichi di san Benedetto e dai recenti di san Domenico e san Francesco, perchè dedito per istituto all'operosità manufattrice. La seta in quei tempi era cosa rara, e una libra pagavasi fino a 180 lire: nè Milano pare ne abbia posseduto manifatture prima del 1314, quando molti Lucchesi, avendo perduta la patria per la tirannide di Castruccio, si sparsero per l'Italia portandovi quell'arte che già tra loro fioriva. Vivissimo all'incontro era in queste parti il traffico e il lavorìo della lana, e gli Umiliati ne facevano la parte maggiore. Nel 1305, questi di Brera appunto avevano inviato alcuni dei loro a piantare manifatture sino nella Sicilia: per Venezia spedivano a tutta Europa gran quantità di panni, e guadagnavano immense ricchezze, con cui compravano immensi poderi, soccorrevano i bisognosi, e potevano persino, nelle debite proporzioni, prevenir quello che fece la Compagnia delle Indie in Inghilterra col servire di somme il patrio Comune, Enrico VII imperatore ed altri sovrani.
Gran credito perciò godeva quest'Ordine; e sovente ai membri di esso affidavasi pubbliche incombenze, singolarmente di riscuotere le gabelle, percepire i dazj all'entrata della città, trasportare peculj, conservare pegni. Ma essendo d'ogni istituzione umana il corrompersi, tralignarono anche gli Umiliati: le ricchezze bene acquistate furono convertite male: all'operosità subentrarono l'ozio e i vizj che ne conseguono: immensi tenimenti erano goduti in commenda da pochi prevosti che sfoggiavano in lusso di tavola e di trattamenti: tanto che gli scandali che ne nascevano indussero san Carlo Borromeo a domandarne l'abolizione nel 1570, destinando gran parte dei loro beni a favore d'un Ordine allora nascente, i Gesuiti.
Questi pure, passato il loro tempo, vennero dal papa disfatti, e il grandioso palazzo ch'essi avevano fabbricato a Brera, fu destinato all'istruzione, all'astronomia, alle belle arti, di cui oggi sono colà le scuole e i modelli.
Così ad un podere successe una manifattura, a questa l'educazione, infine il culto del bello: sicchè quel palazzo può in alcun modo segnare l'andamento della società.
A quel posto però, nei giorni di Buonvicino, sorgeva un monastero disadorno secondo i tempi, e una vasta chiesa di stile gotico, lavorata di fuori a marmi scaccati bianco e nero. Sui due campi laterali si vedea da una banda il beato Rocco, pio pellegrino di Mompellieri, morto poc'anni prima, dopo essere vissuto in continuo servizio degli appestati, perlocchè veniva riverito e invocato come tutore contro i contagi che allora di frequente ripullulavano; dall'altra un san Cristoforo, persona gigante, con un Gesù bambino a cavalluccio; effigie che poneasi sulle facciate e lungo le vie, perchè credeano che, al solo mirarla, desse la buona andata, e preservasse dalla morte improvvisa.
Nel mezzo si apriva una portella, cui faceano stipite certi fasci di colonnine ritorte a spira, con attorno fiori, rabeschi, uccelli; e che sorreggevano un arco acuto, di sopra il quale sormontava un terrazzino, sostenuto da due colonne dì porfido, le quali, invece di base, impostavano sopra due grifoni in atto di spiegare le ali. Quel terrazzino era il pulpito, da cui nei giorni festivi, i frati predicavano alla folla concorsa in sul sagrato, all'ombra di un olmo centenario.
V'ha dei momenti, quando l'animo nostro è disposto, quasi direi necessitato a meditare su tutto ciò che si affaccia ai sensi: le cose medesime, che cento volte si erano vedute con indifferenza, toccano e colpiscono.
Quante fiate Buonvicino era passato innanzi a quel piazzuolo, a quell'olmo, a quella chiesa senza più che inchinarsi, come si usa ai luoghi benedetti! Ora vi si fermò; tenne gli occhi sopra una porta che, di fianco alla chiesa, introduceva al convento, e vi lesse scritto: In loco isto dabo pacem.
La pace? non era quella ch'egli avea perduta? che andava rintracciando? un momento di calma non era la più ambita delle dolcezze fra le sue burrasche? Perchè non entrare laddove era promessa?
Ed entrò.
I conventi, in qualunque concetto voglia aversene la santità e la vita contemplativa, erano un ricovero, a cui volentieri rifuggiva l'uomo sbattuto dagli affanni; il loro silenzio, la devota quiete, quel distacco dagli affari mondani, li faceva somigliare ad isole fra il turbolento mare della società: e il cuore bersagliato dalla fortuna (onesta parola, onde si velano la slealtà, l'ingratitudine, l'incongruenza degli uomini) vi cercava, e spesso anche vi trovava il balsamo della dimenticanza.
Fra i duri casi di mia vita, non m'usciranno mai dalla mente otto giorni, che volli vivere in un monastero. La situazione di quello, sotto incomparabile temperie di cielo, ricreato dalla vista di un'ubertosa amenità campestre e montana, contribuirono senza dubbio a rendermi la tranquillità ch'io era venuto a domandarvi. Ma sotto quei portici taciturni, in quelle fughe di corridoj, non popolati che da persone, in ogni apparenza diverse da quelle che siamo avvezzi scontrare pel mondo, sempre mi tornava al pensiero Dante Alighieri, quando, errabondo al par di me, lasciata anch'egli ogni cosa più caramente diletta, anch'egli indispettito colla patria e coi compagni di sua sventura, là per la diocesi di Luni si assise in un chiostro a meditare. Dove un frate, vistolo rimanere così a lungo osservando, gli si appressò chiedendogli:—Che volete, che cercate, buon omo?»—Egli rispose:—Pace».
E per desiderio di pace Buonvicino si condusse sotto l'atrio, ove la tettoja proteggeva i muricciuoli, disposti ai pitocchi che numerosi, principalmente nella carestia d'allora, venivano per le zuppe ivi distribuite ogni mezzodì. Sulle pareti d'allato vedeasi la storia, vera o leggendaria della istituzione degli Umiliati: e chi oggi in quel palazzo ammira i capolavori degli artisti antichi e le mediocrità dei moderni, a fatica saprebbe figurarsi la rozzezza, onde allora v'erano pitturate a guazzo certe immagini lunghe, smilze, in punta di piedi, senza movenze nè scorci, senza ombre nè fondo nè terreno.
L'indovinare che cosa significassero non sarebbe stata facile impresa, se non fossero venuti in soccorso caratteri e versi non meno grossolani. A manritta dunque si mostrava un diroccamento di case, di mura, di chiese, e la scritta Mediolano indicava doversi intendere le rovine di questa città, allorchè rimase desolata per opera dell'imperatore Federico Barbarossa e de' suoi confederati, pur troppo italiani. Sul dinanzi, alcuni in abito dimesso, parte in ginocchio, tutti colle mani giunte, avevano a significare i cavalieri milanesi che, secondo la tradizione, fecero voto, se mai la patria si rassettasse dalla schiavitù, di congregarsi a vita di penitenza e di santità. Ciò dichiarava la sottoposta iscrizione in questi che, almeno nell'intenzione dell'autore, erano versi:
Come diruto Mediolano
De Barbarossa cum la mano
Li militi se botano a Maria
Ke laudata sia.
Erano dalla banda sinistra figurate delle case, quali finite, quali ancora in costruzione per indicare Milano, se distrutto dalle dissensioni, or rifabbricato dall'affratellamento dei Lombardi: e una dozzina fra signori e dame, non distinti che dal prolungarsi a queste la guarnacca bianca fino sul tallone, mentre agli altri dava appena al ginocchio, recandosi a braccio e in collo dei fardelli, cioè i loro averi, si dirizzavano ad una chiesa, sovra la quale, fra certe nuvole che avresti scambiato per balle di bambagia, appariva la Madonna, e la scritta diceva:
Questi enno li militi humiliati
Quali in epsa civitati
Solvono li boti sinceri.
Dicete un ave o passeggieri.
La rusticità dei versi e del dipinto non offendeva Buonvicino, a poco di meglio abituato; poichè, sebbene fossero già vissuti Dante e Giotto, ristoratori della poesia e della pittura; sebbene i canti di quello fossero letti pubblicamente e commentati in Lombardia, e Giotto fosse venuto qui a dipingere in Corte di Azone Visconti, non per questo il gusto era diffuso; e non era l'infimo degli scolari di Andrino da Edesia pavese quel che aveva eseguito il grossolano dipinto.
Bensì la storia quivi rappresentata rispondeva bene allo stato interno del nostro Lando, talchè vi stette alquanto fiso in muta contemplazione. Angiolgabriello da Concorezzo portinajo, allorchè lo vide accostarsi alla soglia, si trasse da banda, dicendogli:—Iddio vi benedica»; ed esso entrato, si trovò in un cavedio erboso, nel cui mezzo un pozzo, presso al quale verdeggiava un agnocasto, arboscello che nei chiostri mai non lasciavasi mancare, credendo giovasse a mantenere illibata la castità. Tutt'intorno girava un portico in volta, sostenuto da pilastrelli di cotto, sotto al quale altre immagini, del merito delle prime, istoriavano la vita operosa d'alcuni santi, come san Paolo che tesseva fiscelle, san Giuseppe intento alla pialla, i Padri dell'eremo che faceano carità insieme trecciando foglie di palma.
Del resto ogni cosa quieta. Passeri a migliaia stormivano su per le tettoje, mentre qualche rondine primaticcia aliava esplorando e meditando il nido sotto quelle volte, ove mai non le era stato turbato: i numerosi telaj, che si vedevano disposti negli spaziosi cameroni, riposavano in quel dì, sacro al meditare: tratto tratto appariva alcun frate in tunica di lana bianca: sovr'essa un'onestà, pur bianca, cinto i lombi d'una coreggia, cogli zoccoli in piede e coll'aria di grande mestizia, conveniente al solenne lutto di quel giorno. Erano avvezzi a vedere estranei vagare per le loro case: non ne facevano meraviglia, non domandavano, non temevano: la religione proteggeva le ricchezze ivi raccolte, e rendea sacre le persone, che la divozione o la sventura vi conducesse. Onde passavano da lato a Buonvicino, esclamavano Pax vobis, e seguitavano la loro via.
Tutto questo insieme facea su Buonvicino l'effetto di un placido zefiro sopra un lago mareggiante. Vagò osservando, riflettendo, e il suo passo, dapprima frettoloso e incomposto, veniva lasciando la furia, e dando indizio della calma che a poco a poco le subentrava. Udivasi fra ciò un accordo di voci, ma fioco, lontano come uscisse di sotterra, intonare una lugubre melodia; dietro al cui suono Buonvicino arrivò nella chiesa. Era affatto oscura acciocchè meglio ajutasse il raccoglimento: nessuna lampada, nessun cero luceva sullo spogliato altare: un bisbiglio di preghiere, fatto da devoti che non si vedeano, ricordava gli angelici spiriti che, nel giorno medesimo, furono intesi gemere invisibili nel tempio di Gerusalemme quando moriva il loro Fattore. Nella confessione o, come diciamo noi Lombardi, nello scuruolo, i frati ripetevano a muta le lamentazioni di Geremia, e il racconto così semplice e così appassionato della morte di Cristo.
Tentone si inoltrò Buonvicino, e appressatosi ad una delle sedici colonne che in tre navate dividevano il tempio, trovata alcuna cosa, le si inginocchiò davanti, e tastando si accorse esser un avello, con sopra effigiato colui che in esso riposava. Era di fatto il sepolcro di Bertramo, primo gran maestro generale degli Umiliati, che aveva loro dettate le costituzioni, e si era addormentato in Dio nel 1257.
Sopra quell'urna appoggiato il capo, Buonvicino pianse, dirottamente pianse. Una devota compunzione tutto l'aveva preso: il pensiero di un Dio, di una fine che tutti aspetta, di un Giusto, soffrente per le colpe altrui, di un dolore universale, era sottentrato al sentimento delle personali affezioni, all'idea dei danni antichi, del recente errore, della patria, di Margherita, di quanto il mondo l'aveva fatto godere e soffrire. Quel godere del mondo (egli pensava) a che riesce se non a scontenti e noje? Qui invece all'austerità della quaresima, al lutto di questi giorni, succederà il tripudio, l'alleluja: l'altro domani, scontrandosi per le vie, l'un l'altro saluterà esclamando: È risorto!—salubri penitenze che si risolvono in una santa esultazione!
Ciò meditando, Buonvicino si sentì toccar il cuore, e fermò la risoluzione di togliersi dal tramestio mondano, e rendersi tutto a Dio. La sera non uscì dal convento; chiese d'esser annoverato tra i fratelli, e l'ottenne; in breve fu vestito e professato. Persona di tal credito fu tenuta un prezioso acquisto per la congregazione: la fama se ne diffuse tosto, genza che destasse gran meraviglia, perchè non erano rari somiglianti casi. I buoni ne benedissero il Signore; Buonvicino più fu diletto dai suoi amici, più rispettato dai padroni; i malevoli stessi, ora ch'egli più non dava ombra, ne confessavano i meriti e le virtù.
Egli, assaporando quella pace di Dio che oltrepassa ogni intendimento, per alcun tempo attese alle cure comuni del nuovo suo stato; risolto poi di ordinarsi prete, sì per esercizio di pazienza, sì per acquistare una cognizione, buona a tutti, indispensabile a un sacerdote, prese ad esemplare la Sacra Bibbia. Oh allora, che pascolo trovò all'intelligenza e al cuore! Oltre la rivelazione delle superne verità, quanto conforto ne trasse a' suoi casi, quante consolazioni! quanto impulso al bene! Nei canti dei profeti sentiva continuo l'amor di patria, ond'esso aveva caldo il petto; la sventura v'è ogni tratto ricreata di speranze; l'ingiustizia che signoreggia, o manifesta, o colla maschera del diritto, trova colà un continuo appello ad altri giorni, ad altro giudice; concordia, amore, eguaglianza, giustizia, animano da capo a fondo quel libro, nel cui studio frà Buonvicino, accorgendosi quanto gli uomini ne deviassero operando a fini personali anzichè al bene comune, dividendosi in oziosi che godono e faticanti che stentano, in ribaldi che ingannano e sopraffanno, e leali che beneficano e soffrono, non che prendere odio per gli uni, disprezzo per gli altri, gli abbracciava tutti in generosa benevolenza, e nell'intento di amicarli, di concordarne gli sforzi a quella che è prima condizione di ogni sociale progresso: la moralità.
Molto durò, discosto da ogni pratica di gente; cominciò poi ad uscire predicando, e allora gran fama si levò, non tanto della sua bravura, come della grande sua bontà. Diffondevasi tra il popolo, massime della campagna; giacchè pel popolo, diceva egli, pei poveri specialmente, ha parlato Cristo, fra vulgari scelse i seguaci suoi, le primizie della Chiesa. Ne istruiva dunque l'ignoranza sulla eguale origine degli uomini, sulla comune destinazione; mostrava donde veniamo; dove si va; i più semplici doveri, le più schiette virtù di padri, di figli, di sposi, di operaj, erano perpetuo suo tema; ingenuo e fin vulgare nel dir suo, sminuzzando il pane della parola secondo la capacità; facendosi, come Eliseo, piccolino per ravvivare le piccole membra.
Passava quindi in concetto di santo, poichè, sebbene non fosse andato pellegrino al Monte Gargàno, a Roma, in Terrasanta, sebbene non facesse di quei miracoli, di cui smoderata era allora la frequenza, operava il miracolo più insigne, quello di rendere buoni gli uomini colla voce e coll'esempio. E poichè allora pur troppo fra quelle razze ineducate succedevano frequenti battibugli di contumelie e peggio, tutto egli davasi nel ricomporre la concordia, e mirabili effetti otteneva di conversioni.
Molti potrei raccontarne, se non udissi alcuno de' miei lettori domandarmi se questa sia una leggenda di santi. Dirò dunque soltanto come una volta (questo accadde in Varese mentre egli trovavasi colà nella Cavedra, casa del suo Ordine) uno dei Bossi ed uno degli Azzati, primarj borghesi, erano venuti a parole, dalle parole ai fatti, e dietro loro una turba parteggiante minacciava un sanguinoso scompiglio.—Bisogna chiamare fra Buonvicino», suggerì alcun prudente. Così fanno; egli accorre, procura mitigare gl'irritati, rammentando le promesse e le minacce di Cristo che ci vuole umili al pari di sè; ma il Bossi, che era dei due il più tracotante e bizzarro, cieco nella collera, volse il furore contro il frate, e bestemmiando Dio, le chieriche, le cose più riverite, cominciò a picchiarlo.
Picchiare un religioso era tenuto tale sacrilegio, che gli astanti parte si ritrassero come atterriti, parte si accingevano a volerne vendetta.
E frà Buonvicino, su quel primo momento, sentendo più l'impulso delle antiche abitudini, che non la legge d'abnegazione, che erasi da sè medesimo imposta, afferrato l'assalitore, l'ebbe sbattuto a terra, e alzava il pugno contro di esso; ma l'ira diede luogo subitamente; rientrò in sè; mise un sospiro, quasi dolente che l'antico uomo ad ora ad ora ricomparisse; sollevato il temerario, se gl'inginocchiò davanti, e incrociando le braccia sul petto, con umiltà tanto più sincera quanto che era generosa, gli disse: «Perdonatemi! non sapevo quel che facessi».
L'atto pio commosse il prepotente, il quale cadde egli medesimo ai piedi dell'offeso, chiedendo a gran voce perdono, misericordia; e tornato a coscienza, diventò esempio di quelle cristiane virtù, di cui la somma è la carità.
Nè meno famoso venne frà Buonvicino a Milano. In quei tempi che tutto andava per collera e fazioni nella Chiesa, nel foro, nelle scuole, nei conventi, nel campo, i contendenti si ingegnavano di trarre il frate dalla loro. Nel più vivo erano le questioni teologiche, se la luce apparsa sul Taborre fosse creata od increata: se il pane che mangiavano e la tunica che vestivano Cristo e i suoi fosse loro proprietà o di uso soltanto; se gli angeli e i santi godessero della beatifica visione della divinità, ovvero stessero sotto l'altare di Dio, cioè sotto la protezione e consolazione dell'umanità di Cristo, fino al dì del giudizio. Ma qual volta alcuno volesse metter Buonvicino sul ragionarne, e risolvere tra il dottor Angelico, il dottor Sottile, e il dottor Singolare, esso rispondeva che il nostro non è il Dio delle contese, che vuolsi studiare nella religione per rendere un ossequio ragionato, non per introdurre la superbia dell'umana sapienza nelle cose che il savio venera tacendo.
Che ne avvenne?
Sulle prime, tutte le parti egualmente il disapprovarono, e chi il chiamò pusillanime cristiano, chi troppo cieco credente. Egli non rispose, continuò, e, come accade sempre, tutte le parti egualmente finirono per rispettarlo. Piuttosto avendo conosciuto i vizj della città, penetrato nelle sale dei grandi come nelle officine del fabbro, e sotto la trabacca del soldato, sapeva dove occorressero i rimedj: alla libertà del paese, guasta non tanto dalla prepotenza de' dominatori, quanto dalla corruttela dei dominati, trovava ottimo ristoro predicare il Vangelo, scuola della libertà vera, vera opposizione e alla tirannia dei capi e alla sfrenatezza dei soggetti; vera soluzione del più importante problema sociale, quello di render soddisfatti coloro che non posseggono, assicurando il riposo di quei che posseggono. Per tal modo riusciva caro ai sofferenti che sollevava con superne consolazioni, e riverito dai potenti, i quali, nell'uomo probo, non ligio ai superbi loro capricci, sono costretti a venerare l'imperio della nobile virtù.
Margherita, già non crederete che egli la dimenticasse; più non si dimentica quando si è amato così. Nè della donna sua temeva egli lo spregio: non ne aveva egli veduto le lagrime in quel terribile momento? La ricordava sempre come la persona più cara che avesse lasciata in un mondo da cui si era diviso. Per lungo tempo ne schivò affatto la vista; la prima volta che osò domandarne conto a Francesco Pusterla, che, come altri amici, veniva tratto tratto a salutarlo, quel nome, quasi avesse dovuto bruciargli le labbra, tornò più fiate a morirgli in gola: pur finalmente lo pronunziò con un rossore, con un tremito convulso di tutta la persona.
Al fine la materia restò domata dallo spirito, e quando Franciscòlo gli parlava della sua domestica felicità, sentivasi inondato, non più da invidia, ma da tutta pura compiacenza. Nelle orazioni sue, la persona prima e più caldamente raccomandata, era la Margherita, senza che per questo il pensiero disviasse dal Creatore alla creatura: anzi, una dolce speranza il lusingava, che le espiazioni sue, le sue preghiere dovessero acquistare alla Margherita una serie di felicità.
Non doveva essere esaudito, perchè la felicità vera non è germoglio di queste glebe terrestri.
Allorchè si sentì sicuro di sè, tornò una volta a casa della signora Pusterla; ripassò con altro cuore su quel ponte, sotto quegli atrj, su per quelle scale: entrò nel memore salotto; e vi trovò la Margherita che fanciulleggiava col suo Venturino.
Qual momento fu quello pei due amanti! Ma l'una e l'altro vi si presentavano col vigore acquistato in lunga risoluzione virtuosa.
Frà Buonvicino ragionò di Dio, della fralezza dell'uomo; toccò del passato come una rimembranza cara e dolorosa; chiese perdono; si staccò dalla cintola un rosario di grani di cedro a faccette, su ciascuna delle quali era intarsiata una stella di madreperla, e con pendente una croce, allo stesso modo lavorata. Era paziente fatica del suo ritiro, e consegnandola a Margherita,—Tenetela per mia memoria. Possa questa un giorno venirvi di consolazione! e nel recitarne le orazioni, pregate Dio per un peccatore».
Queste parole, quell'atto non furono senza lacrime dell'uno e dell'altra. Margherita si strinse al seno e premette alle labbra quel dono, che assumeva un carattere sacro innanzi all'intelletto, nel mentre al cuore lasciava indovinare quante volte frà Buonvicino dovette pensare a lei nel lungo tempo duratovi intorno.
Quel rosario, quella croce, doveano mischiarsi, deh come! nelle avventure di quella infelice!