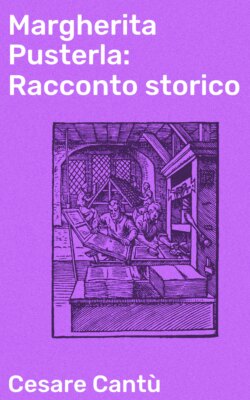Читать книгу Margherita Pusterla: Racconto storico - Cesare Cantù - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L'AMORE.
ОглавлениеBuonvicino dei Landi, famiglia principalissima di Piacenza, da giovinetto era stato posto in Bologna agli studj, cui con fervore si dirizzava la gioventù della risorta Italia, trovando in essi un'altra via per salire colà, ove dapprima si giungeva solo colle armi e colla prodezza della persona. Tali studj si riduceano, è vero, a pedantesche regole di grammatica e di retorica, alla filosofia dei commentatori d'Aristotele, e alla cognizione delle Decretali; ma l'amor delle belle lettere e la ricerca dei classici latini ravvivata poteano, qualora trovassero terreno da ciò, far negli animi germogliare affetti e sensi generosi. Così accadde di Buonvicino, il quale appunto, su quei primi anni, pascendosi nei detti e nei fatti gloriosi degli antichi, sollevava l'animo sopra le minute gare del suo tempo. E sebbene ne traesse idee, lontane affatto dalla nuova civiltà, di quelle idee che pur troppo nocquero al felice ordinamento delle repubbliche italiane, però quel nome di patria, perpetuo tema degli scrittori romani, aveva infervorato la fantasia del garzone, il quale non ambiva se non di crescere cogli anni, per potere o nelle magistrature servir il suo paese, o difenderlo in campo.
Infelice! Gli anni vennero, ma con essi la sventura e i desolati disinganni, che così spesso tormentano le anime generose.
Piacenza sua patria era caduta in podestà di Matteo Visconti, poi di Galeazzo. Questo qua, meno astuto e più corrotto del padre, credeasi lecito ogni suo talento nelle città dominate; e per tacere altre soperchierie onde aggravò la servitù dei Piacentini, tentò disonorare Bianchina, moglie di Opizino Lando detto Versuzio, fratello del nostro Buonvicino. Mal per lui: giacchè nella donna trovò virtù, trovò vendetta nel marito: il quale, fatta un'intelligenza con alcuni fidati, abolì nella sua città il dominio dei Visconti, e la consegnò al cardinal Poggetto, legato del papa.
Buonvicino, su quell'età in cui si vagheggiano i sentimenti più che non si calcolino le circostanze, pieno delle idee del patriottismo antico, modificato dalle nuove che faceano guardare come straniero l'abitatore d'ogni altra città, e servitù l'essere signoreggiati dal vicino, appena ebbe fumo di quella pratica, accorse con buon numero di suoi condiscepoli, ed arrivò a Piacenza in tempo, come di giovar col valore, così di mostrare generosità. Perocchè, il giorno che scoppiò la rivolta, trovavasi in quella città Beatrice moglie del signor Galeazzo, col figlioletto Azone, alla salvezza del quale unicamente intesa, la madre lo fece trafugare, rimanendo essa in palazzo per non dar sentore della fuga, ed affrontando lo sdegno e la brutalità d'un popolo sollevato, purchè ne andasse salvo il bambino. Come la cosa fu nota a Buonvicino, rispettando e venerando gli affetti di una madre, non che impedire le fosse fatta violenza di sorta, egli medesimo la scortò sino ai limiti del distretto piacentino, quivi consegnandola sicura alle guardie del marito.
Accadea questo fatto nel 1322, e da quell'ora si rimetteva in Piacenza il governo a popolo, giacchè il dominio papale potevasi riguardare come una libertà, sì perchè i pontefici, sedendo allora in Avignone, non esercitavano da così lontano che una autorità di protezione, sì perchè erano stati fautori del franco stato, se non altro per isvigorire i Ghibellini, tendenti a scemare le franchigie lombarde a pro dell'Impero.
Negli otto anni successivi, Buonvicino maturò fra le generose cure d'una libera patria, coll'altezza di sentimenti che ispira il togliersi alla vita privata per vivere la pubblica, il curare meno le domestiche cose che le comuni; educazione che tanto contribuì a migliorare l'Italia durante le sue repubbliche.
Andava in quel mezzo ognora più in basso la fortuna dei Visconti, guerreggiati da Lodovico il Bavaro imperatore, il quale era sostenuto dai molti nemici che si erano procacciati, e da Versuzio Lando che non mai desistette dal combattere contro di essi; tanto che Galeazzo, Luchino, Giovanni e Azone finirono coll'essere chiusi nelle orribili prigioni di Monza, dette i Forni, ove stentarono dal 5 luglio del 1327 fino al 25 marzo del seguente.
Ma quando Galeazzo morì, e con lui cessò il mal animo eccitato nei popoli e nei principi, piegarono a meglio le cose dei Visconti: Azone, miglior del padre, gridato signore di Milano il 14 marzo 1330, pensò a ricuperare le città che aveva perdute, come di fatto riuscì con Bergamo, Vercelli, Vigevano, Pavia, Cremona, Brescia, Lodi, Crema, Como, Borgo San Donnino, Treviglio e Pizzighettone. Anche sovra Piacenza fissava cupidi gli occhi, ma il conseguirla non era così agevole impresa; poichè, tenendo essa la sua libertà a nome del papa, non avrebbe potuto il Visconti insidiarla senza venire in rotta con questo. Cominciò dunque la sorda guerra de' politici tranelli, fece un capo grosso per non so che violazioni e rappresaglie dei Piacentini contra i sudditi suoi: minacciò, fu duopo mandare dei messi e degli ostaggi a Milano, fra i quali Buonvicino. Morto era il fratello Versuzio; morti i più vicini parenti; morti i più cari amici nelle guerre passate; aveva potuto vedere come all'atto gli affari riescano diversissimi da ciò che l'immaginazione figurava; vie più gli si disabbellirono le splendide fantasie di gioventù allorquando, venuto alla Corte milanese, conobbe con quanti viluppi e lacciuoli e coperte vie e secondi fini vi si guidassero i pubblici interessi; scaltrimenti che un'anima schietta neppure indovina, ma che i prudenti del mondo dicevano e dicono necessarj per reggere e prosperare gli Stati. Sulle prime egli si indispettì, s'infuriò anche; ma col lungo vederne, contrasse quella sentita melanconia che nasce dalla chiara cognizione di un fine, unita coll'impossibilità di raggiungerlo.
Del resto, in questa sua qualità media fra di ostaggio e di ambasciatore, ed anche per memoria del segnalato servigio reso alla signora Beatrice, Buonvicino era stato accolto e trattato con ogni onoranza; e sì egli, sì i compagni suoi, allogati presso le prime famiglie di Milano, colla speranza che l'ospitalità legasse le amicizie, e queste col tempo surrogassero ai rancori municipali quella che chiamavano universale benevolenza, e volea dire tolleranza del giogo comune. Buonvicino era stato appoggiato alla famiglia di Uberto Visconti, il quale abitava tra la via di San Clemente e una fornace di vetri posta in quella delle Tanaglie, dove poi venne allargata la piazza Fontana, e dove l'osteria del Biscione rammenta ancora gli antichi possessori.
Uberto Visconti, padre della Margherita da cui s'intitola il nostro racconto, sebbene, come fratello di Matteo Magno, fosse molto riguardato nella città, non partecipava però al comando, o che l'integro animo rifuggisse dal mescolarsi nei sozzi avvolgimenti della politica onde i suoi tendevano a conservare o crescere la signoria; ovvero che questi ad arte tenessero lontano un uomo, il quale si poco conoscevasi del mondo, che avrebbe preteso di gettare la parola di giustizia, fino a traverso ai passi dell'ambizione. Aggiungi che i Visconti, siccome ghibellini, cioè fautori dei diritti imperiali, erano sinistramente veduti dai papi, che coi Guelfi sostenevano i diritti della Chiesa e del popolo; e poichè le passioni politiche facilmente si avviluppavano cogli affari religiosi, accadeva non di rado che i Ghibellini professassero errori in fatto di fede, e i pontefici colpissero di pene spirituali i loro temporali nemici; e il popolo riguardasse come eretici anche coloro che contrariavano le mire terrene dei papi.
Quindi non poche anime timorate si faceano coscienza di seguitare la bandiera del Biscione: ed Uberto non favoriva i parenti suoi che repugnante, e quel tanto solo che pareva esigere il suo decoro e la fede di cavaliero. Però in una mischia avvenuta in Milano quando, nel 1302 i Torriani fecero un estremo sforzo per rientrarvi, Uberto era stato abbattuto da sella, e lì tra la folla e sotto ai piedi dei cavalli, si era per alcuni minuti vista la morte ad un pelo. Onde avea promesso alla Madonna di smettere le armi, impugnate per causa non giusta; ed avea creduto effetto di quel voto la generosità, colla quale un capo de' nemici, Guido della Torre, gli aveva dato mano a sorgere, tornar a cavallo e camparsi, dicendogli:—Non sia mai vero ch'io di cittadini pari tuoi privi la patria mia, che fortunata se molti ne contasse».
Allora Uberto si tolse dal parteggiare pei Visconti, tanto che questi disgustati lo confinarono ad Asti, poi richiamato, gli conferirono di quegli onori che possono contentare l'amor proprio senza crescere l'ingerenza; come l'andare podestà in questo o quel Comune, accompagnare a Roma l'imperatore, sostenere ambascerie di complimento.
I Visconti invece vennero in aperta rottura col papa; talmente che il cardinal legato, spiegato il vessillo delle sante chiavi sopra il solajo del suo palazzo in Asti, predicò che qualunque uomo o donna lo seguitasse per distruggere Matteo e i suoi, rimarrebbe assolto (dicono le rozze cronache) dalla pena d'ogni trascorso; scomunicò il Visconti fino alla quarta generazione, perchè eretico e reo di venticinque misfatti, fra i quali d'aver esercitata giurisdizione sui beni e le persone ecclesiastiche, impedito ai suoi di armarsi per le crociate, repressa la santa inquisizione, e procurato di campare dal fuoco l'eretica Mainfreda.
Il trovarsi involto in questa scomunica tanto più spiaceva a Uberto quanto più egli venerava l'autorità papale, e non tralasciò fatica per calmare gli animi, per riconciliare i Milanesi alla Chiesa: anzi pare doversi alle sue persuasioni se Matteo si diede a vita devota e a visitare chiese, finchè in Duomo, convocato il clero ed il popolo, recitò tutto il credo, protestando quella essere la propria sua fede. Il papa non giudicò sincero quel pentimento e quell'abjura, onde non ritirò l'anatema; Matteo morì con questo; e Uberto, più non volendo intendere di pubbliche cure, visse da privato, sebbene splendidamente, ora in Milano, ora sulle ridenti spiaggie del Lago Maggiore, dove ampj possedimenti teneva a Invorio inferiore, a Oleggio e altrove nel Vergante, là sulla sponda occidentale intorno a Lesa. Quivi confortavasi tutto nelle cure casalinghe, e poichè i suoi tre figli Vittore, Ottorino e Giovanni, di spiriti guerreschi, poco tempo rimanevano con lui, spendeva tutta l'attenzione sua a educare l'unica figliuola Margherita, con modi ben diversi da quelli che sogliono quei molti, cui supremo intento sembra formar savie fanciulle e donne cattive.
Disingannato del mondo in vecchia età, ben accordavasi con chi nella fresca se ne trovava disgustato, com'era Buonvicino. Si legò dunque un'intima amicizia tra il vecchio e questo giovane, il quale, non avendo più padre, come tale riguardava Uberto, come fratelli i figli di esso, e come sorella la Margherita. I discorsi dell'uomo pratico anticipavano a Buonvicino l'esperienza del mondo: sui pochi libri che allora correvano, egli esercitava gli involontarj riposi: scriveva anche qualche verso, come rozzamente allora e qui si poteva; per città brillava nelle gualdane e negli esercizj di corpo: mai non mancava di intervenire, come a scuola di filosofia sociale, ai pubblici dibattimenti; nelle brigate piaceva singolarmente per un far gentile, non iscompagnato mai da maschia franchezza: anche quelli che sedevano al governo lo riverivano, perchè sapeva accoppiare la soggezione, che la forza e la vittoria pretendono, colla dignità della sventura non meritata.
Un sì gentile e peregrino cavaliero non vi farà meraviglia se ottenne ricambio d'amore dalla Margherita. Poteva egli contare i trent'anni, mentre essa arrivava ai quindici appena, onde le gentilezze che Buonvicino usava all'ospite sua, nel cuore di lei, mal conscio di sè stesso e inesperto dell'amore, destavano un senso di pudica compiacenza. Ma questa inclinazione, come suole, restò gran tempo un segreto per tutti, e sino pei due amanti. Giammai non le aveva egli detto, Vi amo; parola che suol venire dopo che già l'eloquente linguaggio dell'affetto in cento altri modi l'espresse. Ella poi nè tampoco sapeva di amarlo, almeno non lo confessava, anzi nol chiedeva pure a sè stessa. Se non che al comparire di lui il cuore le batteva forte forte: quand'egli partiva rimanea sconsolata, come le mancasse alcuna cosa di necessario, di suo; egli non le aveva indicato che tornerebbe, nè quando, eppure essa lo attendeva: se tardasse era come sulle spine; al rivederlo provava una compiacenza interiore, una pienezza di vita, come (almeno pareva a lei), come al veder suo padre, le sue amiche, un'alba di maggio, una vigna in settembre. Avrebbe voluto piacergli, parergli bella; parergli buona e brava: quasi senza avvedersene, allorchè lo aspettava, adornavasi con più attenta cura: una parola ch'egli le dirigesse sentivasi ravvivare; ambiva ch'egli voltasse gli occhi sopra di lei, ma non appena la fissasse, ella abbassava i suoi arrossendo; nel rispondere alle domande, alle cortesie di lui, balbettava, si confondeva; sbagliava le note quando d'accordo toccavano il liuto; poi si pentiva, si vergognava, si rimproverava, accusava sè stessa come di una fanciullaggine; proponevasi di fare altrimenti, e tornava a far lo stesso. Le ajuole del suo giardino avevano un fiore preferito, un preferito albero il boschetto: il fiore della margaritina, ch'egli aveva mostrato prediligere; la pianta sotto cui, un giorno che ne piangeva la lontananza, egli le era comparso davanti improvviso.
Così, desiderarlo, rivederlo, fantasticare, staccarsene, desiderarlo di nuovo, formavano la storia della sua vita; vita povera di casi, ricca di sentimenti, e tutta dominata da quel non so che di misterioso, che tanta dolcezza sparge e tante pene sul prino amore, che ci fa sudare e rabbrividire, gemere e cantare, piangere e ridere senza aver di che: temere e sperare nè sapere qual cosa: cento volte in un giorno chiamarci beati, e cento crederci le più misere creature;—quel bene, quel male, che non si conosce al vero se non quando o crebbe fino al colmo della contentezza, o restò fulminato dalla sventura.
Non così incerti ondeggiavano gli affetti in Buonvicino, il quale, sebbene fresco ancora di cuore e virtuoso, avea però sperimentato del mondo la sua parte, ed esaminato abbastanza questa vita, che è una commedia per chi osserva, una tragedia per chi sente.
Nessuna seduzione più facile di quella che non si teme: nessun tempo in cui l'anima sia dischiusa tanto all'affetto, come nei travagli. Era il caso di Buonvicino, sentì d'innamorarsi della Margherita, e non se ne guardò: conobbe di non essere a lei discaro, e se ne compiacque: lieto d'aver sì bene collocato il cuor suo, pago di una dolce corrispondenza. Sovente, dopo le tempeste della pubblica vita, dopo avere, coll'occhio melanconico e penetrante di chi studiò gli uomini, ed alla prima scorge ove tendano le loro azioni, visto l'affaccendarsi delle egoistiche passioni, egli tornava a riconciliarsi coll'umanità nella contemplazione di un'anima schietta, in cui far il bene era istinto, non calcolo: cercava tranquillità nel costante sereno che dominava intorno ad essa; somigliante alla pace che gli angeli diffondono sovra le anime, di cui sono destinati ad alleggerire i patimenti.
Ma questa placida innocenza di lei lo ratteneva dal palesarle l'affetto suo, al tempo stesso che glielo rendeva più vivace. Possedere quell'ingenua fanciulla che, tra le cure dell'ottimo dei padri, veniva educandosi alla virtù ed al sapere, ben avvisava egli come sarebbe la felicità de' suoi giorni; ma potrebbe egli render lei altrettanto fortunata? Pendevano in bilancia i destini della casa e della patria di lui: poteva succedere che, in libera terra, avesse egli a vivere primo cittadino, colla potenza di un nome onorato e di un carattere più onorato ancora, guidando i compatriotti suoi al bene e alla decorosa quiete. Ma questo avvenire lusinghiero stava all'arbitrio di principi, in cui raro era il disinteresse. E se gli fossero mancati di parola? se fossero prevalse le brighe, l'ambizione? Egli poteva trovarsi, non che ridotto all'oscurità, ma balzato lontano, o precipitato fra quei pericoli avventurosi, ove, simile a chi naufraga in alto mare, un'anima leale desidera trovarsi sola, per sentirsi maggiore coraggio di lottare con fermezza, e minore cordoglio qualora il dovere o la generosità le impongono di soccombere. In tal caso quand'egli avesse alimentata la nascente fiamma della Margherita rivelandole la sua, ecco formata un'altra vittima: ecco procurato a sè il rimorso d'avere turbato in quella giovane anima la calma, il riso di quella primavera dell'età, che scorre, ahi troppo veloce e irreparabile! per dar luogo alle cure, alle faccende, alle amarezze, al disinganno, all'inutile repetìo per tutto il resto della vita.
Ciò lo indusse a tacere sempre l'amor suo, a dissimularlo almeno nelle parole, per quanto gliene costasse al cuore. Ma l'amore come si può nascondere? Contro al proposito, egli si lasciava trascorrere talora a qualche immeditata parola, ad una delicata prevenzione, ad uno di quei niente che rivelano alle fanciulle l'uomo, il cui sospiro può dischiuderne l'innocenza al pieno fiore della vita.
I temuti e previsti rivolgimenti a danno di Piacenza non tardarono. Azone, per quanto gli facesse gola l'acquisto di quella città, per quanto credesse una ragione del riaverla l'essere stata altre volte posseduta da suo padre, non s'arrischiava però di assalirla direttamente per non venir in guerra col pontefice, sotto la cui protezione erasi que la riparata Cortesie e promesse largheggiava dunque a Buonvicino: ma intanto adoperava, come si dice, a trar dalla buca il granchio colla zampa altrui. Francesco Scotto ambiva di possedere Piacenza, già dominata dalla sua famiglia, ed opprimendo gli emuli Landesi e cacciandone i Papalini, assodarvi la sua padronanza. Se l'intese a tal uopo coi Fontana, coi Fulgosi, con altre famiglie di colà, che occupati i castelli, proclamarono signore lo Scotto, cassata ogni supremazia papale, sbandeggiati per sempre e spossessati d'ogni aver loro i fautori dei Landi e nominatamente Buonvicino.
Si consolava questi nella sciagura tenendo per certo che Azone, secondo quel che prometteva e mostrava, dovesse prendere le armi contro al nuovo tiranno e rimetter libera Piacenza al papa ed a' suoi cittadini. Ma Azone giocava di due mani: sott'acqua aveva egli stesso dato ajuto allo Scotto nell'impadronirsi della patria non già per amore a questo, ma per poternelo poi spogliare senza correre in guaj colla Corte pontificia. Di fatto armò: tutti i fuorusciti presero parte alla spedizione; Buonvicino fu dei primi e meglio valenti; e col coraggio solito in chi muove a ricuperare la patria, ebbero presto levata Piacenza allo Scotto. Ma quando aspettavasi che il Visconti ne gridasse la libertà, egli ordinò che le due opposte fazioni deponessero le armi; indi, come buon conquisto, aggiunse Piacenza alle sue possessioni.
Quanto se ne trovassero scornati i Piacentini, e Buonvicino sopra gli altri, voglio lasciarlo pensare a voi. Quest'ultimo, tenuto povero e guardato attentamente a Milano, si trovò dunque perduta la patria, offuscato il lustro della famiglia, falliti i sogni della giovinezza, nè più rimanergli se non l'eredità, che unica sopravanzava a troppi signori in Italia, un braccio valoroso. Ma poichè egli non era disposto a venderlo al migliore offerente, doveva ricoverarsi nella propria virtù, cercare la compiacenza da cui, anche tra le miserie è accompagnato e consolato chi soccombe per la causa della giustizia.
Persuaso allora alla condizione sua presente più non convenisse l'accoppiarsi ad una fanciulla di casa tanto principale, e che, appunto perchè la conosceva e l'amava, pareagli degna del più sublime stato; fors'anche per non sembrare disertore de' suoi fratelli di sventura quando si fosse imparentato alla famiglia del tiranno, cominciò a dilungarsi dal vedere la Margherita, poi se ne distolse interamente; e chiuso dentro a sè l'affetto che le portava, giunse a persuadersi d'averla in tutto cancellata dal suo cuore.
Aveva egli conosciuto alla Corte di Azone il cavaliere Franciscòlo Pusterla, che, allora in grande stato presso il principe, nè del favore abusava a danno altrui, nè se ne prevaleva a proprio vantaggio; onesto, generoso, ricordevole delle virtù italiane, e volonteroso del bene de' suoi concittadini. Vero è che, per una certa debolezza di naturale che altri scambia per forza, per una irrequieta smania di fare, di comparire, di sentire la vita, non si trovava saldo quanto bastasse per resistere al fascino degli onori od all'autorità del potere; anche quando conosceva riprovevoli i passi del principe non osava dirlo, tanto meno poi mostrarne dispetto od opposizione: troppo compiacendosi di poter primeggiare in Corte e nella città,—senza accorgersi che uno può figurare vie più coll'apparir meno colà dove la turba si accalca.
Parve a Buonvicino che Franciscòlo dovesse essere il caso per rendere felice la Margherita. Già le due famiglie erano legate d'amicizia: i difetti della gioventù colla gioventù se n'andrebbero, e il Pusterla troverebbe in lei quanto bastasse ad appagarne i sensi, la ragione, l'immaginazione; la Visconti, collocata in alto luogo e di lei degno, avrebbe potuto, fortunata in casa, rendersi di fuori modello alle dame lombarde. Quindi colla dimestichezza onde usava con entrambe le famiglie, Buonvicino agevolò una parentela, la quale sommamente gradiva ad Uberto Visconti, lieto di vedere con sì nobile soggetto accasata la diletta sua figliuola, ed al Pusterla ancor più, sì per trovarsi possessore di una, che sull'altre otteneva il pregio della bellezza e dei modi colti e gentili, sì per legarsi in affinità colla casa dominante.
La Margherita, come prima si accorse del raffreddamento di Buonvicino, come lo vide diradar le occasioni di trovarsi da sè a lei, più sempre allontanarsi dalle cure che solevano aver comuni, dal toccare di concerto il liuto, dal leggere insieme la Divina Commedia di Dante e alcuni libri francesi e provenzali, non occorre ch'io vi dica se ne rimase melanconica. Esaminava a minuto ogni atto, quasi ogni pensier suo, se mai potesse averlo in qualche maniera disgustato, e non trovandosi in colpa si accorava, piangeva. Allora confessava a sè stessa di amarlo; allora chiamava crudele lui, che più non la ricambiasse di altrettanto affetto.
Poi riflettendo, tacciava sè stessa d'inconsiderata e vana, che si fosse lusingata d'essergli cara, quantunque egli mai non glielo avesse detto, quantunque forse mai non vi avesse egli fissato il pensiero. E qui si ingegnava di convincere sè stessa che quelle cortesie erano forse in lui naturali, erano forse consuetudini di tutti i cavalieri verso tutte le giovinette: ma il cuore voleva la sua ragione, e la faceva rincorrere quei mille ineffabili nulla che sono tutto per gli amanti: le ravvivava tutta la poesia dei primi turbamenti; tante esaltazioni in fondo al cuore non rivelate dal viso; tanti timori di non essere compresa, tanta gioja di esserlo stata; nei quali ricordi, mentre si veniva a convincere d'essere stata cara a Buonvicino, vie più l'anima sua si avvolgeva tra il labirinto di quei varj affetti che esacerbano un voto fallito, una speranza delusa. Talvolta lagnavasi con sè stessa di non avergli abbastanza mostrato il cuor suo: tal altra condannavasi d'averlo mostrato troppo: indi ritrovando penoso il passato e il presente, cercava stordirsi, e non vedere in queste memorie se non tante illusioni, di cui sforzavasi sorridere ella stessa compassionevolmente. E si vantava libera, guarita, smemorata; tornava ai libri, al suono, ai passeggi; ma che? quei suoni le recavano a mente una voce che li soleva accompagnare; in quei libri occorrevano cento allusioni ai casi suoi passati e presenti, cento cose ch'egli le aveva spiegato altre volte, e che ora desideravano una spiegazione; come riuscivano triste, monotone quelle passeggiate ora che più non ve l'accompagnava la speranza d'incontrare qualcuno!
Pure il tempo è gran rimedio anche alle grandi passioni: e la Margherita si dovette alfin persuadere di essersi veramente illusa quando vide Buonvicino intramettersi delle sue nozze col Pusterla. Trattandosi di un amore che non aveva ricevuto fomento sia da lusinghe di lui, sia da fondate speranze, ella non penò molto per rassegnarsi a deporlo. Del Pusterla udiva parlare da tutti colle lodi che al merito si profondono più facilmente quando sia dovizioso: le prodezze da lui compite nell'ultima spedizione di Piacenza, che ne avevano esaltato il nome per tutta Lombardia, non sarebbero no bastate a suscitare nella Margherita un nuovo amore, ma qual è la donna che, all'udire lodato un uomo, non si compiaccia di poter dire: È mio?
Richiesta dunque dal padre se sarebbe contenta di avere a marito il Pusterla, non negò: poi quando prese a conoscerlo da vicino, trovandolo ricco delle qualità che meglio stanno in un uomo gentile e in compito cavaliero, pose in lui ogni ben suo, benedisse il cielo d'averla tanto fortunata, e dacchè ebbe la persuasione di amarlo, di esserne amata eternamente, gli promise all'altare il più vivo, il più tenero, il più immacolato affetto.
Le memorie del tempo non pajono d'accordo che nel lodare la nuova sposa: essa bella, essa spiritosa, di affabile amorevolezza coi subalterni, d'inesausta carità coi bisognosi, eguale d'umore conversevole, costante in quella dolcezza di naturale, che nelle donne equivale a quasi tutte le altre doti, e che è il più opportuno avviamento ad essere e a rendere felici gli altri. Difetti ne avrà certo avuti; e chi no? ma gli storici non ce ne ricordano, forse perchè, così giovane fu così sfortunata: e l'uomo è tanto proclive a dimenticare i falli di chi merita la sua compassione, quanto a trovarne in chi gli desta invidia. Per altre vie però noi sappiamo che le sue pari la tacciavano di voler parere bella e buona e virtuosa: alcuni, per cui la massima delle virtù consiste nel non far male, davanle colpa del volersi frammettere nelle faccende altrui: beneficava, quindi fece degli ingrati, e questi palliarono l'ingratitudine col menarle dietro la lingua: so di chi la chiamava bacchettona: so di chi asseriva le opere sue non movessero sempre da buone e semplici intenzioni: so di molti più che la accusavano di non conoscere il viver del mondo perchè sostituiva il sentimento e la schietta sincerità alle compassate cortesie che il mondo insegna e pretende. In somma, ella aveva quante qualità bastassero per dar presa alla maldicenza, e per far beato chi la conosceva e l'avvicinava, tanto più chi la possedeva.
Le strane idee che correvano allora sull'amore maritale, faceano che una donna potesse, anzi (se bella e di garbo) dovesse avere uno o più cavalieri, che a lei dedicassero le imprese loro, o davvero in guerra, o da giuoco ne' tornei. Anche in ciò la Margherita scostavasi dalle contemporanee, perchè non credeva che della moralità si abbia a far un affare di moda.
Se il pensiero di Buonvicino mai non le ritornasse alla mente, se non ricorresse ella mai sulle prime fantasie di sua giovinezza, non ve lo saprei dire: ben so come un primo amore difficilmente si cancelli o non mai; so ancora che neppure la più rigida virtù può condannare un'incolpevole rimembranza.
Ben altrimenti corse la cosa per Buonvicino.
A torto aveva creduto spenta la sua passione: era soltanto sopita; e quando scorse la sua diletta rendere più l'un dì che l'altro felice il Pusterla, sentì ravvivarsi la fiamma antica. Per la comune amicizia frequentando la casa di questo, potè notare sviluppate nella nuova sposa le qualità, che aveva indovinate in genere nella fanciulla; nella serena e temperata giocondità che essa preparava al marito, vide maturi i frutti della apprestatale educazione. I sonni di incolpati gaudj e tranquilli, che tante volte lo avevano lusingato in quei giorni di floride immaginazioni, quando gli sorrideva la lusinga che di tanto bene potesse una volta divenir possessore, ora li scorgeva ridotti a realtà; ma per vantaggio di un altro. E quest'altro era un amico suo, alla cui contentezza aveva egli dato opera efficace: un amico che, qualvolta si trovavano insieme, sfogava con esso la piena di un cuore in giubilo, ragionandogli della sua fortuna, o coll'ardore di un nuovo sposo dipingendogli le doti, che, ogni giorno maggiori, veniva scoprendo nella sua Margherita; e lo benedicea di averlo consigliato a fissare in essa i suoi voti.
Così da una parte alimentata dalla convinzione dei meriti di essa, dall'altra rinchiusa a più potere sicchè nulla ne trapelasse, la fiamma sua cresceva più sempre. Ben chiamava egli a soccorso la ragione:—la ragione! ottimo rimedio contro il passato e l'avvenire; ma quando il presente incalza, che vale essa mai?
Il Pusterla frattanto, voltosi tutto ad ingrazianirsi la Corte, si era allentato nell'amore verso la sposa. Dissi male: non avea diminuito l'amore: ma, un poco alla moderna, vi combinava tutte le piccole ambizioni sociali: lo soffocava sotto un tumulto di altri pensieri, e per segnalarsi nelle cariche, nelle armi, nelle pompe, posponeva le dolcezze incomparabili della vita casalinga. Di gustar questa era egli poco capace, inclinato, come dissi, a non trovare felicità che nella tempesta del cuore e delle azioni: difetto che, dopo sbollito il primo amore verso la Margherita, lo recò persino a cercare altre gioje turbolente in amori contrastati, o nelle rinnovate vicende di effimere passioni. Eppure, lo ripeto, di nulla scemava la stima e cordialità sua verso la moglie, fenomeno che mi arresterei a spiegare se fosse più raro.
Mesi interi egli si teneva lontano dalla città; anche quando vi stava, occupato tutto alla Corte e nei crocchi brillanti, ben poche ore gli avanzavano di rimanere a fianco della sposa. Allorchè a questa toccò il dolore di veder morto il suo dolcissimo padre, il Pusterla viaggiava col principe fuor di paese, nè accorse a consolarla, pago d'inviarle per iscritto quelle condoglianze, che sì poco ristorano quando non escono dal labbro stesso della persona diletta.