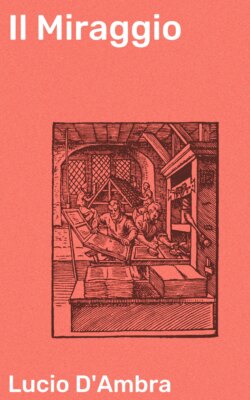Читать книгу Il Miraggio - Lucio d'Ambra - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеIndice
Fin dalle sue prime armi, Giuliano Farnese era stato favorito da un'insolita fortuna. I suoi primi passi nell'aspro cammino della letteratura erano però stati sostenuti dal forte appoggio di uno scrittore illustre, Claudio Sanna, che affascinato dalla sincerità e dalla ispirazione del primo ed unico libro di versi di Farnese, Sotto i salici — libro tutto impregnato di una melanconia senza dolore — sostenne i passi successivi del giovane poeta. Oggi quel libro è dimenticato ed i cinquecento esemplari che ne furono stampati sono perduti fra le pubblicazioni più recenti e rumorose, dove solo qualche spirito delicato va a ricercarlo, per riviverne il molle fascino autunnale. Farnese ha avuto il torto di rinnegare quel libro dove pure tanta parte della sua anima aveva cantato, con la spontaneità dell'adolescenza; quando i versi fioriscono sotto la penna, naturalmente, senza paralizzanti preoccupazioni di rime e di scuole estetiche. Tuttavia da quel libro data il principio della sua fortuna. Anche i due romanzi che lo seguirono sono semplici e sinceri, intimi come L'ultimo incontro, freschi e famigliari come Accanto al fuoco. Questi due romanzi furono scritti in una modesta camera di un piccolo albergo a Padova, dove, all'uscire dall'Università, Farnese insegnò lettere in quel liceo, durante un anno. Claudio Sanna fu il pioniere di questo nuovo scrittore e ad ognuno di quei primi romanzi egli consacrò magnifici articoli su i principali giornali. Anche altri critici ed altri romanzieri consacrarono studî ed articoli a quei romanzi, poichè il loro autore, oscuro professore di lettere in un liceo di una lontanissima provincia, non era ancòra e forse non sarebbe stato mai, un rivale temibile e perciò da combattersi con ogni arma, silenzio o denigrazione, pur di rovesciarlo e demolirlo, non per prenderne il posto, ma per l'ira del piccolo verso il grande, del debole contro il forte, per il rancore e l'odio eterni del mediocre verso quel che emerge e s'innalza. Ma allora al giovane scrittore festeggiato la misera fatica didattica pesava e non poteva resistere alla brama di correre a Roma, di scrivere, di parlare, di sentire da vicino il suo bel successo, di entrare anche lui decisivamente in lizza. L'affezione di Claudio Sanna gli permise di realizzare questo sogno, e nel novembre del mille ottocento ottantacinque, Farnese entrò, incaricato della critica drammatica e di una cronaca letteraria, in un gran giornale romano L'Eco di Roma, diretto da Marco Torrero.
Cominciarono, allora, le illusioni a sfrondarsi, le speranze a impallidire. In molti scrittori illustri, ch'egli venerava da lunge e pei quali aveva arso nei fogli letterari dei giovani molti granelli d'incenso, trovò gelosia ed invidia; in altri, che sembravano alla sua ignara fantasia giovanile modelli di austerità artistica, non trovò altro che orpello ed inganno, la più urtante abilità commerciale, le tele variopinte e le frange d'oro che nascondono la miseria intellettuale e la corruzione morale. Allora dal giovane irruppe l'uomo, e, sfogliate le ultime illusioni, considerando con un sottile riso ironico quel che prima lo colmava di ira e di disprezzo, scrisse sul giornale di Torrero, quella lunga serie di Saltimbanchi, dove, in brevi articoli, secchi e schioccanti come colpi di scudiscio, metteva in luce le vere figure zingaresche di molti romanzieri, autori drammatici, critici, poeti, musicisti, scultori e pittori. Ebbe un paio di duelli con due di quei saltimbanchi, un autore drammatico ed un pittore, che si offesero; ebbe la fortuna di ferirli entrambi; così che la muta, con la coda fra le gambe, sopportò le scudisciate; qualcuno tentò di abbaiare, ma da lontano e prudentemente, qualche altro leccò le mani al castigatore per propiziarselo, molti infine ostentarono a quelli attacchi un'ilarità non troppo sincera. Quella serie di Saltimbanchi constò di sessanta articoli, pubblicati tutti sul giornale di Torrero in meno di quattro mesi. Dopo, Farnese li raccolse in un volume sotto lo stesso titolo e ad ognuno di quei sessanta inviò il volume con dedica autografa. Egli vide allora come nella letteratura, non diversamente che nella politica, valga più il rumore che il valore. I suoi buoni romanzi erano rimasti invenduti su gli scaffali dei librai, ma il suo libro di critica, che pure nelle sue idee morali aveva le apparenze di un pamphlet, ebbe un successo insperato e sei edizioni ne furono esaurite in brevissimo tempo. Egli aveva perduto con quel libro la maggioranza di coloro che si dicevano suoi amici: su quei sessanta, solo sette od otto, e dei meno attaccati, ebbero lo spirito di avvicinare il Farnese e di raddoppiare in cortesie a suo riguardo, se non in cordialità. Ma gli altri, coloro che non erano stati compresi nel fustigato e sanguinolento battaglione, furono di ciò grati al Farnese ed alcuni con l'adulazione e le amabilità prevennero il pericolo d'essere incorporati in un secondo battaglione a venire. Ad ogni modo il pubblico conosceva ed amava, ormai, il nome battagliero del Farnese e quei successi ripetuti gli avevano creata una lusinghiera posizione finanziaria.
Allora egli, l'austero critico ed il giustiziere, pencolò un poco verso il pubblico ed è l'unica macchia, ma perdonabile, della sua carriera letteraria. Nel suo appartamento elegante della via Sistina, Farnese lavorava a quel romanzo Amori d'Autunno, che fu poi uno dei suoi più grandi successi editoriali, fra le visite delle ammiratrici generose, quelle delle attrici che lo volevano più propizio a loro nelle sue critiche drammatiche sul giornale di Torrero, e quelle di qualche raro amico che veniva nei pomeriggi d'inverno a scaldarsi il corpo in quella casa tiepida e simpatica, l'anima e l'intelligenza all'ardore di quel pensiero di artista tanto geniale. Nel frattempo il teatro l'aveva tentato ed al teatro Valle era stata rappresentata una sua commedia in quattro atti dal titolo curioso, Le nozze di Don Giovanni. In quell'affollato teatro di prima rappresentazione solenne s'eran dati convegno tutti gli astii ed i rancori ardenti verso il notissimo scrittore. Tutto il battaglione dei sessanta saltimbanchi ed i loro adepti, tutti i giovani poeti cui egli aveva consigliato più la lima che la rima, tutti i giovani autori i cui aborti drammatici non avevano incontrato il favore del famoso critico e le loro famiglie ed i loro domestici, tutti gli attori ch'egli aveva ammonito e biasimato dai pianterreni dell'Eco di Roma, tutte le attrici ch'egli non aveva pensato di baciare e i loro madri, tutti i confratelli gelosi dei suoi successi e le loro signore mogli e le loro signore amanti, tutti gli eleganti e tutti i mondani irosi contro di lui per le sue fortune di salone e di alcova, tutti i nemici più acerrimi dello scrittore celebre a ventotto anni si eran dati convegno in quella sfolgorante sala di teatro. E subito, dal primo levarsi del sipario, l'insuccesso s'era pronunziato; i mormorii eran presto divenuti risate, le risate grugniti, i grugniti urli. I quattro atti si erano svolti fra le grida ed i fischi, le risate e le grida; gli attori assistevano impassibili allo scempio di quella geniale ed ironica commedia, ma vollero per rispetto all'autore condurla fino alla fine, malgrado i gridi sempre più forti ed insistenti che chiedevano l'abbassarsi del sipario. Alla fine del quarto atto qualche applauso fremente di pochi onesti fu coperto dalle salve di fischi. La jeunesse dorèe di un circolo elegante, furiosa di vedere andare a Farnese quelle fortune femminili che le loro anime grigie attendevano in vano, dava in un palco un pietoso spettacolo di sè, eseguendo coi fischi una fanfara volgare. Finalmente lo charivari era finito. I veri amici di Farnese non avevano avuto il coraggio di cercarlo; gli altri, gli ottimi amici, avevano frugato tutto il palcoscenico per trovare lo scrittore, mentre un'altra squadra volava al suo appartamento di via Sistina, per godere sotto le ipocrite condoglianze, l'effetto malvagio della malvagia opera compiuta. Ma Farnese, avvertito dai reporters dell'Eco di Roma intorno alla cabala che si montava contro di lui, era partito la sera innanzi, dopo l'ultima prova delle Nozze di Don Giovanni, per recarsi qualche giorno a Firenze. Così che a teatro gli ottimi amici non avevan trovato che camerini chiusi e macchinisti affaccendati, tutti nervosi in quella sera di lutto teatrale; ed avendo alla casa dello scrittore trovato chiuso il portone, la banda dovette sciogliersi, dolente del contrattempo, ma felice in fondo del risultato.
E la mattina e la sera appresso, trepidanti, avevano aperto i giornali perchè se al Farnese non era giunto l'eco delle disapprovazioni, ne avrebbe avuto almeno conto dagli attacchi dei critici. Se non chè anche questo loro desiderio doveva andar deluso. La critica aveva un linguaggio rispettoso verso Farnese, ammirativo per la commedia e stigmatizzante con parole pungenti il contegno della maggior parte del pubblico. Trovavano la commedia fine e sottile, con pregi di dialogo, di sceneggiatura, di finitezza di caratteri, ma con difetti di lungaggini. Tutti, meno due o tre, predicevano un vero successo alle Nozze di Don Giovanni, quando fossero riprese con un pubblico più spassionato. Intanto i buoni amici anonimi avevan messo sotto fascia quei due o tre giornali discordanti e li avevan spediti, falsificando le loro calligrafie, a Firenze, al Savoie-Hotel, dove Farnese era disceso. La sera, su l'Eco di Roma, era apparso un rovente articolo di Marco Torrero, che, ricercando le cause dell'insuccesso e citando anche i nomi dei promotori, esaltava la commedia e prediceva al Farnese un grande avvenire di autore drammatico.
Al suo ritorno a Roma, apparvero quei suoi due romanzi, seconda maniera, Anime in sogno ed Amori d'autunno. I successi ne sono rimasti memorabili. Tuttavia erano due romanzi falsi e manierati, ove ogni anima aveva un lembo di cielo, ove il mondo era osservato a traverso ad un prisma roseo e brillante. Il romanziere aveva voluto forzare la semplicità e l'intimità della sua prima maniera ed era caduto nell'estremo della semplicità complicata e della falsa intimità. Un giornalista, Giacomo Spada, attaccò alle spalle del Farnese l'etichetta, «un Medoro Savini anglomane e decadente». L'etichetta rimase e pesò presto sulle spalle di Farnese che, da principio, ne aveva riso con la noncuranza sprezzante che viene dal successo. Da allora, dalla fine del mille ottocento ottanta nove data quel romanzo L'Aurora, che fu una vera aurora artistica per lo scrittore e che lo sacrò indiscutibilmente grande romanziere. In esso il Farnese, spogliandosi di ogni preconcetto, aveva chiamato a raccolta tutte le mirabili sue facoltà, per rispondere con un capolavoro alle ironie ed ai sottintesi melati. Ed il capolavoro era riuscito: v'era nell'Aurora un vasto affresco della corruzione e della decadenza moderna e la maestosa pittura si chiudeva con l'apoteosi di un'Idea e la visione simbolica di un futuro secolo ideale. Molte edizioni si esaurirono una dopo l'altra, l'inno concorde salì dalle colonne dei giornali e dalle pagine delle riviste. Una schiera di giovani si entusiasmò per Farnese, divenne il suo drappello, fu pago di vivere del riflesso della sua luce. Altre commedie erano seguite, prima Una Rivolta, che, dopo alcune ostilità della prima sera, filò tranquillamente fra gli applausi un lungo corso di rappresentazioni. Pochi mesi dopo, durante il successo dell'ultimo suo romanzo, una geniale e delicata attrice, la signora Teresa Mariani-Zampieri volle mettere in iscena con gusto d'artista una commedia in tre atti, Messer Arlecchino, che Farnese aveva scritto durante un suo viaggio in Spagna, per non perdere l'abitudine della penna e senza alcuna intenzione di destinarla al teatro. Era una delicata fantasia, il ritorno delle maschere della commedia dell'arte italiana, una follia carnevalesca ed amorosa in un quadro di Watteau, con la grazia autunnale di una festa galante di Verlaine. La signora Teresa Mariani-Zampieri nel variopinto costume di un Arlecchino pieno di grazie vi ebbe un successo squisito, ovunque. E Farnese, senza riposo, si mise di nuovo al lavoro nel suo continuo inseguimento del meglio e del bello ed in un anno, uscirono due altri romanzi suoi: L'infamia umana, dove dieci tipi balzacchiani di vili e d'infami torturavano e macchiavano per sempre una serena anima di giovinetta; Cecilia, dove era narrata la storia di quella giovinetta aristocratica, Cecilia Armenieri, che, fuggita di casa con un uomo alla moda, aveva voluto essere attrice e trionfare su la scena, dove comparve con fortuna ma per breve tempo, per scomparire pochi mesi dopo, non si seppe mai dove, non si seppe mai come.
Stanco delle sue fatiche di romanziere, Farnese aveva pensato di riposarsi scrivendo tre ampii saggi intorno all'opera di tre pittori veneziani, che egli singolarmente prediligeva, Giorgione, Paolo Veronese e Carpaccio. Nella primavera del 1891, mentre correva l'Italia il suo nuovo libro, Cieli stranieri, libro d'impressioni dei suoi viaggi in Spagna, in Irlanda, in Olanda, in Fiandra, in Palestina ed in Oriente, egli rimase quattro mesi a Venezia, in un appartamento originalissimo ch'egli aveva affittato in quel curioso palazzetto Dario sul Canal Grande, che pencola un po' da un lato, e che si trova quasi prospiciente alla misteriosa casa di Desdemona. In quei soavi mesi di adorabile primavera veneziana, levato a primo mattino, Farnese sbrigava qualche articolo e qualche cronaca che, non ostante il suo riposo, doveva dare ai giornali ed alle riviste. Passava la mattina e metà del pomeriggio a percorrere i luoghi dove erano quadri dei suoi tre pittori, l'Accademia Reale di Belle arti, le chiese più lontane, S. Sebastiano, i Frari, Santi Giovanni e Paolo, — San Zanipolo, come abbreviano i veneziani — San Giovanni in Bragora, la Madonna dell'Orto. Verso il mezzogiorno, dopo una breve colazione al Caffè Quadri o al Florian, ritornava al lavoro e guardava, frugava, raffrontava, prendeva note, fino al tramonto quando, salito in gondola, amava goderselo su lo smisurato specchio della laguna o si faceva scivolare lungo il Canalazzo per vedere luccicare all'oro del tramonto i bei marmi orientali del palazzetto Dario dove abitava, o la facciata diamantata della Cà d'Oro, o per vedere tingersi ancòra di rosa le marmoree facciate del palazzo Contarini dalle Figure o del palazzo Foscari. Pranzava quasi sempre con qualche amico in un caffè sul mare, rientrava presto e prima di coricarsi leggeva, sbrigava la sua corrispondenza, ordinava le moltissime note raccolte nella laboriosa giornata. Poi dormiva d'un quieto sonno quasi infantile senza sogni e senza incubi affannosi. Gli era quasi ogni giorno compagno in quelle esplorazioni artistiche, Leonardo Loredano, bell'uomo di trentacinque anni, scrittore rinomato, amico fedele, gentiluomo perfetto appartenente ad una delle più nobili famiglie veneziane. Loredano aveva scritto romanzi e commedie che avevan dato molta voga al suo bel nome: — romanzi che erano quadri originali, grandi affreschi di quella vita cosmopolita così ardente oggigiorno e così vibrante, ch'egli viveva continuamente; commedie che eran fini esercitazioni di casistica sentimentale, opere delicate di un Marivaux del secolo decimonono, un Marivaux che bevesse l'extra-dry, fumasse i londres e leggesse la Vie Parisienne su la terrazza marina di un caravanserraglio cosmopolita di Cannes o di San Remo. Loredano era una delle figure più eminenti di Venezia: appena trentacinquenne, era già stato per due anni e con molto onore sindaco della sua divina città: gli avevano offerto la candidatura politica, ma egli aveva preferito tornare ai suoi calmi lavori letterari, riprendere i suoi incessanti viaggi a traverso il mondo. In quella primavera la sua sosta a Venezia si prolungava per restare con Farnese ch'egli amava molto. Qualche sera lo tratteneva a pranzare con lui in casa sua, e fu ad uno di quei pranzi che Farnese conobbe la sorella di Loredano, Beatrice, una snella figura di donna, con due occhi neri, dolci e sognatori, un colorito pallido che aumentava la sensazione di aristocrazia emanata da tutta la sua ammaliante persona. Farnese era stato preso a poco a poco da quel fascino, ed il poeta, che sonnecchiava in lui sotto il giornalista ardente ed il romanziere crudele, si ridestava in quelle notti lunari, quando i tre amici restavano su la terrazza tessendo sogni, allo sciacquìo sonnolento dell'acqua nel canale sottostante. I suoi lavori su Giorgione, Veronese e Carpaccio eran finiti da tempo e Farnese, nel giugno, non accennava ancora ad andar via. Una sera egli seppe che Loredano era improvvisamente partito per due giorni alla volta di Milano. L'innamorato si era subito diretto alla casa dell'assente, aveva chiesto della contessina Beatrice, rimastavi sola con la governante inglese e, contro ogni probabilità, egli era stato ricevuto in un salone sul Canalazzo, salone che l'unica lampada coperta da un paralume rosa lasciava in misteriosa penombra. Beatrice, tutta bianca, era seduta presso la finestra ed un raggio di luna l'inargentava. Il poeta in Farnese aveva trionfato. Ed egli, lo scettico, il misogino, il professional Woman's hater, l'odiatore professionale delle donne, disse d'un tratto tutto quel che sentiva, il bisogno da cui era commossa la sua anima, di una casa, di un'intimità, di una famiglia, in quella sua spossante vita di lotta e di lavoro. Era stato lirico, lui, solito di essere ironico; ma l'ironia aveva subito ripreso il sopravvento; e, mentre la donna rispondeva commossa e propizia all'offerta dell'innamorato, quel raggio di luna, quella veste bianca, quella giovinetta tremante, quella penombra, l'eco dello sciacquìo di quell'acqua nel canale sottostante, le grida lontane dei gondolieri, l'avevano costretto ad una grande risata, mentre diceva alla donna, già col cappello ed il bastone in mano: — «Noi facciamo il melodramma ed io fuggo. Vi lascio su queste buone parole». — Poi, l'innamorato avendo suggerito di tener per buone quelle promesse, egli aveva aggiunto: — «Per tutto il resto m'intenderò con vostro fratello». Ed era andato via, ridendo di sè stesso. Loredano, al ritorno, aveva accolto con gioia e con bonomia quelle recentissime notizie insperate. L'innamorato era partito subito dopo. Tornato in ottobre a Venezia, lo scrittore ne ripartiva, poche ore più tardi, avendo al suo braccio la signora Beatrice Farnese. Loredano contemporaneamente prendeva l'express per Londra, felice di poter ricominciare la sua vertiginosa esistenza nella società di Cosmopoli.
La fortuna ed il nome di sua moglie s'erano aggiunti per Farnese alla propria fortuna ed al vanto del proprio nome nel sospingerlo in un mondo di eleganze e di raffinatezze che non era il suo. Fino ad allora egli aveva vissuto in un mondo speciale ed originale di costumi e di bisogni, un mondo di scrittori, di giornalisti, di artisti, di attrici e di cavallerizze. Egli aveva amato le falsità delle quinte, i cattivi sentori del palcoscenico; le parrucche incipriate delle cavallerizze e delle clownesses lo avevano affascinato, ed all'uscire dalle austere sedute di lavoro o dalle serene discussioni con gli uomini più eminenti, lo scrittore aveva sempre veduto la vita sotto una cipria rosea, in uno sfolgorio di lumi, in un succedersi repentino di desiderj e di ebbrezze. Raramente egli aveva frequentato quel che oggi giorno chiamano il gran mondo, quasi i pettegolezzi e le ciancie di cinquanta saloni potessero raccogliere gli innumerevoli brividi elettrici della vita modernissima. In quei saloni egli aveva fatto rapide comparse quando qualche successo metteva di moda fra le belle duchesse il suo nome battagliero. Se ne era però subito allontanato, a causa di quelli uomini eleganti che volevano far sentir troppo al letterato la loro supremazia, e che anche nelle cortesie svelavano quella protezione che si ha verso un intruso compatito e sopportato perchè non se ne può fare a meno. Ma sua moglie nei primi anni di matrimonio aveva sùbito voluto godere i fascini della vita mondana, e tutti i saloni più esclusivisti di Roma si erano aperti per lei. Farnese era stato accolto questa volta, dagli uomini, come un buon compagno, — perchè vedevano in sua moglie una caccia probabile; non gli parlavano più quasi disdegnosamente di letteratura, ma lo intrattenevano intorno alle maggiori probabilità di riuscita di un cavallo a uno steeple-chase qualunque, intorno all'ultima partita intavolata al Circolo, o al miglior paio di scarpe per il lawn-tennis.
Farnese si rifaceva di quelle sere di costipazione intellettuale — come egli diceva ridendo alla moglie — con ottime mattinate di lavoro incessante e fecondo. Lo scrittore non aveva perduto le sue ottime virtù di lavoratore metodico, di buon artigiano, com'egli soleva dire asserendo che bisognava essere un buon artigiano per essere un vero artista. Levato per tempo, lavorava sino a pomeriggio inoltrato; ma alle quattro la vita mondana lo riprendeva nel suo rumoroso vortice, sino al mattino seguente. A poco a poco, quelle eleganze e quelle squisitezze avevano affascinato in lui il borghese rimasto sotto la maschera dello scrittore scettico e la corazza dell'uomo rotto alla vita. In breve, egli sentì l'ossessione di quelle eleganze, non seppe più farne a meno, e qualche volta quasi avrebbe preferito al suo bel nome di autore celebre un titolo qualunque, l'onore solenne di duecentomila lire perdute in una notte di baccarat, il fascino irresistibile d'essere stato vincitore di un derby. Ma erano passeggeri e brevi momenti di debolezza: una seduta di lavoro lo liberava da tutte quelle elegantissime ubbìe.
L'ironista risorgeva in lui. Venne allora la terza maniera di Farnese, che fu quella che ebbe più successo di critica e di vendita. La sua vita mondana a Roma, a Cannes, a Montecarlo o ad Aix-les-Bains, lo indusse a riprodurre quella futile esistenza noncurante e nella serietà medesima con cui il romanziere descriveva le eleganze più deliziose e le etichette più infrangibili, si scandalizzava per la minima scorrettezza, si entusiasmava a freddo per una marsina di taglio inappuntabile o per l'impassibilità di un giocatore elegante al tavolo verde, era un feroce fondo d'ironia, che sfuggiva agli interessati ed ai colpiti, e divertiva tutti gli altri. Quei primi due romanzi della sua terza maniera, Catene d'Oro e Sirene furono sui tabourets di tutte le principesse, nei gabinetti da fumo di tutti gli elegantissimi. Intanto altre sue commedie trionfavano: Una parabola, Flavia, I tramonti. Pubblicò anche sul giornale di Torrero, un piccolo capolavoro di satira una serie di note intitolata Giornale di uno snob, dove si risolvevano con la più esilarante compunzione questi ardui problemi: se fossero migliori le cravatte di Boivin o di Kent, quale ne fosse il nodo più acconcio, quale il più inglese taglio per le giacchette; e sopra tutto una Teoria dello smoking, rimasta indimenticabile, dove dieci uomini alla moda discutevano quattro ore se fosse lecito o no indossare lo smoking per teatro nelle sere d'inverno.
Nel frattempo, egli aveva avuto due bimbi, uno maschio, Luca, che presentemente aveva circa sei anni, ed una femmina di un anno minore, Anna Maria. La moglie si era stancata della vita mondana, si era tutta consacrata ai suoi bambini ed al marito e questi aveva continuato, ma per poco tempo ancóra a correr solo i saloni, le sale d'armi, i circoli e gli alberghi internazionali, poichè come un articolo di Claudio Sanna, l'aveva lanciato nella bolgia letteraria, un altro articolo, anche a firma di Claudio Sanna, lo salvò da una rovina verso cui egli precipitava nell'incoscienza della sua nuova ebrietà. In quell'articolo severo il vecchio maestro avvertiva Farnese delle cattive tendenze che egli lasciava prendere alla sua opera, lo metteva in guardia contro le sorprese dei successi troppo repentini; gli consigliava e augurava un sano periodo di lavoro ed una nuova opera fortissima che potesse accoppiarsi a quell'Aurora, rimasta fino allora il suo capolavoro.
Questo libro venne, frutto di un anno di raccoglimento e spoglio di mondanità, e s'intitolò I merletti. Erano i merletti posti dalle belle dame su le ferite sanguinolenti e turpi, l'inganno del ricamo, la maschera di trina messa su la vergogna e sul peccato, l'eleganza che giustifica, la massoneria morale dell'alta società: libro fecondo ed inquieto, vera opera della maturità dell'artista. Pubblicati prima su la Nuova Antologia e poi in volume, I merletti ebbero un successo nel quale nè Farnese nè alcun altro avrebbe mai potuto sperare. In una con tutte le sue virtù di narratore facile, elegante e drammatico, con quelle delicatezze che pure solleticavano il gusto di qualcuno, la sua spietata analisi psicologica, Farnese era in quel romanzo filosofo e moralista; l'opera assurgeva a commento di un'idea, una morale vi trionfava oramai.
Il romanziere aveva scritto questo romanzo in una villa presso Siena, tra le tenerezze di sua moglie e le primavere gioconde dei suoi bambini. Qualche raro amico rompeva per pochi giorni la monotonia di quell'eremitaggio affettuoso e pensoso: Farnese serbava di quell'anno un ricordo profumato, come del periodo più felice e più squisito della sua vita. L'amore di Beatrice l'aveva sostenuto in questa opera di maturità, spronandolo nelle ore di sconforto e di sfiducia, quando pare che tutto crolli intorno all'artista in una notte densa e che il pensiero vacilli; confortandolo nelle ore di tristezza, distraendolo quando la sera, seduto per terra, egli chinava la fronte stanca sul grembo di lei, al lume roseo della lampada, mentre dalle stanze contigue giungevano i gridi spensierati del piccolo Luca e della fragile e bionda Anna Maria. Ella era stata la guida e la mèta, lo sprone e il riposo, collaboratrice e compagna, amante ed amata.
Giuliano Farnese aveva allora trentacinque anni. Finito il romanzo I merletti, mentre questo correva trionfalmente l'Europa nel testo autentico ed in quattro traduzioni, lo scrittore condusse la piccola famiglia al mare, a San Remo, dove egli aveva una villa e dove Loredano li raggiunse da Vichy; Farnese vi si riposò per due mesi senza toccare la penna. Al loro ritorno in Roma, dopo un'assenza di più di un anno, Farnese si era dedicato a una nuova commedia: La chimera. Ultimatala nel febbraio, aveva ricevuto un bigliettino da Savarese, direttore del Teatro Nazionale, che gliela domandava a ottime condizioni. Egli aveva volentieri acconsentito, stabilendo col Savarese un convegno. Questi si era ben guardato dal mancarvi e si era presentato nell'appartamento che Farnese abitava in un villino del Macao, (accompagnato da Claudina Rosiers che il commediografo non conosceva), avendo già nella tasca del soprabito il contratto da firmare.
Claudina Rosiers aveva ascoltato nervosamente la lettura della commedia. In certi momenti aveva pianto, mentre Farnese ironicamente sorrideva. Poi, andandosene con Savarese, ella aveva guardato lo scrittore con gli occhi ancóra pieni di lacrime, convulsa. Questi era rimasto un momento a guardare la porta donde i due erano usciti. Poi, scosse le spalle, aveva acceso una sigaretta e si era rimesso al lavoro.
Una settimana dopo le prove erano incominciate.