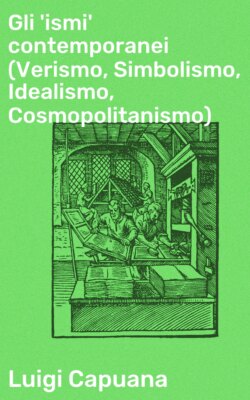Читать книгу Gli 'ismi' contemporanei (Verismo, Simbolismo, Idealismo, Cosmopolitanismo) - Luigi Capuana - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA LETTERATURA ITALIANA NEL 1896
Оглавление—Ma che inventario vuoi fare? L'inventario della miseria?
—Non esageriamo. Io non sono un gran lettore e per parecchie ragioni: primieramente perchè non ho molti quattrini da spendere in libri—e questo mi dispenserebbe di dirti il resto—; secondariamente perchè non leggo o leggo mal volentieri un libro che non è di mia proprietà, eccetto, e soltanto da due anni a questa parte…
—Terzo, aggiungo io, perchè tra i due mali di spendere tre lire e cinquanta centesimi per un libro italiano o uno francese tu scegli giudiziosamente il minore e compri il libro francese. Ho indovinato?
—No. Da due anni non ne compro più; appunto stavo per dirti questo, quando tu mi hai interrotto: me li fo prestare, eccezionalmente, da un amico a cui il suo libraio manda tutte le pubblicazioni letterarie dei nostri cari vicini. Io faccio all'amico il servigio di tagliare i volumi leggendoli il primo, e intanto sottraggo al commercio librario francese il mio piccolo aiuto. Se fossimo parecchi, tutti a fare così!…
—Per incretinirci coi libri italiani?
—Quasi incretiniscano poco quegli altri! Oh, fammi il piacere! Con te, e con tutti coloro che la pensano come te, ci sarebbe da fare un esperimento: prendere, zitto zitto, tre, quattro romanzi italiani inediti, tre, quattro volumi di novelle inedite anch'esse, farli tradurre bene in francese, mutando i nomi delle persone e dei paesi, sostituendo eterocliti pseudonimi in aux, in our, in y al nome degli autori, e darli a pubblicare al Levy, allo Charpentier, al Lemerre. Poi, stampato sui giornali quotidiani francesi (a tanto la linea, s'intende): Vient de paraître l'interessantissimo romanzo, ecc. ecc.—giacchè, tu lo sai, colà sbocciano a questo modo, sui giornali politici, due, tre capolavori ogni giorno—il giuoco sarebbe fatto. Abbocchereste tutti. Ma i letterati, sventuratamente, non possono usare la malizia degli industriali italiani che battezzano per carta inglese e per stoffe inglesi i prodotti delle loro cartiere, dei loro telai, e così ottengono gran spaccio.
—Ragioni seriamente o fai la burletta?
—Ragiono seriamente.
—Metti a paragone la produzione letteraria francese con la italiana?
—Per quantità, no, ma per qualità, proporzionalmente—bada bene a quel che dico—perchè no?
—Eh, via! Tu scherzi!
—Niente affatto. Tu e i tuoi pari avete la mente pregiudicata. Prendendo in mano un libro italiano, siete già convinti che dev'essere noioso; nessuna meraviglia dunque che esso vi sembri noioso davvero. E lo predicate nelle conversazioni, e lo gridate alto dalle colonne dei giornali, e come vi guardate dal comprarlo e forse dal leggerlo, incitate gli altri a far lo stesso. In Francia il libro non è soltanto opera d'arte è anche e soprattutto industria. I capolavori che sbocciano oggi sono belli e appassiti domani; spesso spesso dalla mattina non arrivano neppure alla sera. Ma non vuol dire; l'articolo è venduto; l'autore ha intascato i quattrini, l'editore pure. Tant'è vero che è avvenuta colà una crisi libraria per pletoria di produzione; l'offerta anche colà è stata superiore alla richiesta. E nota che i francesi hanno il beneficio dell'esportazione, che noi non abbiamo.
—Non l'abbiamo perchè non sappiamo fare. Siamo mal preparati? Siamo stanchi, esauriti? Non so. Vedi intanto il D'Annunzio. L'abbiamo screditato, o almeno abbiamo tentato di screditarlo…
—E abbiamo fatto malissimo, per ingenuità e anche perchè da noi il lato commerciale della letteratura s'intende poco. I primi a non badarci sono gli autori, che pure sarebbero i più interessati. Ma tu svii il ragionamento. Le traduzioni non sono esportazione sono una piccolissima parte di essa. L'esportazione francese dipende da condizioni che per ora non esistono da noi.
—Per ora?
—È forse vietato che possano verificarsi per l'avvenire, se si sono già verificate una volta, nel Rinascimento? Allora la letteratura europea era quasi tutta italiana, forse più che non sia oggi europea la francese.
—Che illusioni! Sembra impossibile che un uomo come te….
—E questo appunto è il male: il non avere più illusioni di sorta, in politica, in arte, in ogni cosa, se pure si debbono chiamare illusioni le aspirazioni all'ideale.
—Guarda dove sei arrivato dall'inventario che intendevi di fare!
—Caro mio, l'inventario della letteratura e dell'arte d'una nazione non si mette su, anno per anno, come quello di un negozio di merci. In questo caso, ti dico che bisogna attendere ancora. La produzione letteraria del '96 non è ancora venuta alla luce. Gli editori hanno appena annunziato i volumi che stanno sotto i torchi: e i pochi volumi già comparsi non mi paiono cattivi. Il fatto poi di veder sorgere nuove ditte editrici è sintomo consolante: il Brigola in Milano, il Voghera in Roma, e altri di minor conto. Per fare proprio l'inventario della produzione letteraria del '96 bisogna dunque attendere per lo meno fino all'aprile del '97. Quello del '95, che può farsi oggi, non è punto scoraggiante.
—Ah, sì! O dov'è il capolavoro?
—Lasciamo stare, per carità, i capolavori. Ne spunta fuori appena uno ogni tanto, e non è poco. Facciamo un po' di confronto col nostro passato più recente, con la prima metà di questo secolo, quando i produttori si chiamavano Monti, Foscolo, Guerrazzi, D'Azeglio, Giusti, Grossi, Manzoni, Niccolini, per citare le cime. Il capolavoro fra tanta produzione è uno solo, i Promessi Sposi, e basta per tutto il secolo. Se ti dovessi dire il mio parere intorno alla produzione letteraria della seconda metà, ti confesserei che mi sembra più vitale di quella dell'altra metà; ha maggiori qualità di resistenza; è opera d'arte schietta, senza mistura di politica o di altro. Ma già è inutile fare previsioni di quel che resterà di essa o non resterà. Noi c'inganniamo facilmente su questo punto. La letteratura ha pure la sua moda; e se, giudicando, ci affidiamo al criterio della voga, corriamo il pericolo di sbagliare. Lasciamo all'avvenire la cura della scelta di quel che dovrà o no sopravvivere. Io non sono un letterato di professione, sono un lettore, un osservatore, e con questa mia qualità ti dico che il '96 non termina male per la letteratura italiana. C'è una serietà di propositi, un culto riverente dell'arte, un'intenzione evidentissima di procedere di bene in meglio, e il fatto, evidente anch'esso, da cui si scorge che le intenzioni non rimangono tutte lettera morta. Per voi spericolati, per voi che siete italiani soltanto di nome, lo so bene, non c'è niente, o c'è il chiacchierío di non so che teoriche delle quali non voglio neppur parlare, perchè io, in fatto d'arte, alle teoriche bado poco; chiedo lavori, lavori, lavori! Le teoriche sono buone per le discussioni tra critici, o per mettere, tutt'al più, un'etichetta su la produzione; inutile, se la produzione è cattiva; inutilissima, se l'etichetta vien preparata anticipatamente, per poi incollarla su la produzione che dovrà venir fuori Dio sa quando!…
—Mi fai sbalordire con tutta questa tua fede!
—Ma sì, fede ci vuole! Fiducia in noi stessi ci vuole! Ti ripeto a questo proposito quel che ho letto tempo fa non ricordo dove, nè da chi scritto; ma le parole mi son rimaste impresse nella memoria perchè corrispondevano esattamente a un sentimento mio. Quelle parole dicevano, press'a poco:—Come? Un popolo che ha confuso la sua storia con quella del mondo e che—dopo aver dato alla Civiltà il Diritto romano, la Divina Commedia, la Commedia dell'arte, Raffaello, Michelangelo, il da Palestrina, il Vigo—oppresso, deriso, umiliato, trova in sè tanta forza da ridiventare nazione, compire il più prodigioso atto del secolo XIX, l'abolizione del temporale dei papi, e far convivere nella stessa città il Pontefice del mondo cattolico e il Re degli italiani; come? questo popolo che resiste alla cattiva fortuna, agli errori e alle inesperienze della sua vita politica, sarebbe dunque un'effimera apparizione nella storia contemporanea, senza una ragione, senza uno scopo? Non è possibile. Verrà di nuovo l'ora sua. E di nuovo, nell'avvenire (vicino o lontano, che importa?) quel che di civile, di santo e di pio avranno il vecchio e il nuovo mondo sarà soltanto italiano, come una volta fu romano. Questa dovrà essere la nostra coscienza, il nostro ideale!—Non sorridere; lascia che sorridano o ridano di noi i nostri nemici.
—Tutto questo a proposito di letteratura italiana?
—A proposito di cose spirituali, non ti dispiaccia…. e anche a sproposito, se così ti piace. L'arte letteraria non è un fenomeno accidentale nella vita di una nazione. E se anche riguardo all'arte noi avessimo quella coscienza, quell'ideale, quella fede, come tu ironicamente la chiami…
—Apostolo, va' a predicare il tuo vangelo alle turbe!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In quell'angolo di caffè dove io sorbivo, ascoltando, un'equivoca bibita, il dialogo fra quelle due persone a me ignote fu interrotto a questo punto dall'intervento di una terza persona, Così monco com'è, non mi è parso inutile trascriverlo.—E da ier l'altro—augurio? aspirazione?—mi risuona incessantemente nell'orecchio:
"Verrà di nuovo l'ora sua!… Quel che di civile, di santo e di pio avranno il vecchio e il nuovo mondo sarà soltanto italiano, come una volta fu romano!"