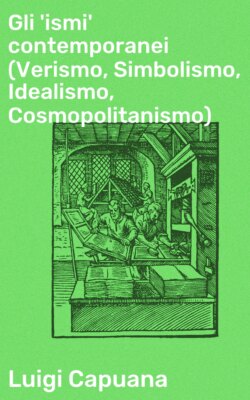Читать книгу Gli 'ismi' contemporanei (Verismo, Simbolismo, Idealismo, Cosmopolitanismo) - Luigi Capuana - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
Оглавление—Ma dunque lei è un codino!
—Niente affatto. Nessun nuovo ideale umano mi lascia indifferente. Ma qui si tratta d'arte, non di pensiero filosofico o scientifico.
—Vorrebbe forse un'arte vuota di contenuto, forma soltanto?
—Niente affatto. Tutto il contenuto possibile, a patto però che egli prenda forma vitale per via dell'immaginazione creatrice. Intendiamoci. Io odio le cose a mezzo, gli ibridismi. Il puro concetto, se mi occorre, vado a cercarlo nei libri dei filosofi o in quelli degli scienziati. Lì trovo la verità astratta o nuda, cioè quella che provvisoriamente sembra verità; e coi filosofi e con gli scienziati mi insuperbisco della divina potenza dell'intelletto umano, e insieme con loro mi umilio e mi scoraggio davanti all'infinità dell'Ignoto che riduce a ben misera cosa la nostra più profonda filosofia, la nostra più ardita e più meravigliosa scienza. Quando poi mi rivolgo all'opera d'arte, ricerco invece sensazioni, impressioni, caratteri, rappresentazioni nelle quali quel tal concetto filosofico o scientifico, prima ricercato altrove, può benissimo tornarmi dinanzi ma incarnato nella forma, divenuto uomo, donna, paesaggio, passione, azione; e incarnato in modo così perfetto, che io dovrò avere l'illusione di trovarmi faccia a faccia con questa nuova e più eccelsa Natura, e rifare intorno ad essa l'identico lavoro fatto dal poeta, dal romanziere, dal drammaturgo allorchè ricavavano dalla vita sociale il soggetto che li aveva prima commossi e poi spinti a riflettere. Insomma dovrò estrarre io, se sono capace, il concetto condensatosi nell'organismo dell'opera d'arte, e rimuginarmelo senza che il romanziere o il drammaturgo abbiano a fermarmi a ogni po' e picchiarmi la spalla con un:—Bada! Qui sotto c'è un gran pensiero; bada!—
In questo senso, ogni grande opera d'arte è un simbolo: se non che divien tale spontaneamente, per virtù della propria natura intellettuale. Ma appunto per questo ella conserverà tutti i suoi caratteri particolari di tempo, di luogo; sarà prettamente italiana, prettamente francese, prettamente inglese, tedesca, russa o non sarà opera d'arte. Il cosmopolitismo invece toglie via, o tenta di toglier via, tutti i caratteri particolari, e per ciò intende ridurci al simbolismo forzato, al simbolismo artificiale.
Prendo i due scrittori che mi è piaciuto mettere in riscontro nella questione dello stile, il Verga e il D'Annunzio, per non uscire di casa nostra. Tutti e due hanno un concetto filosofico, scientifico che serve di sostrato anzi di lievito alle loro creazioni.
Nella serie dei Vinti, della quale abbiamo per ora soltanto due episodi—avremo il terzo fra poco—il Verga vuol studiare le diverse fasi della lotta pel benessere nella vita, e interessarsi specialmente dei deboli che restano per via, dei fiacchi che si lasciano sopraffare, dei vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvegnenti, dei vincitori di oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi di arrivare e che saranno sorpassati domani. Dalla lotta per i più umili e più urgenti bisogni materiali, si andrà in su fino a quella elevatissima pei bisogni dello spirito, dove tutte le bramosie, tutte le vanità, tutte le ambizioni umane si condenseranno e diverranno più dolorose per la intensità acquistata lungo la loro corsa vertiginosa.
Il romanziere ha dovuto esporre il suo concetto fin da principio perchè non poteva presentare tutt'a una volta la intera serie e non voleva correre il pericolo di essere frainteso o non capito.
Ma appena ha terminato di esporlo, astrattamente, da pensatore, da sociologo, non ne ha più fiatato. Ha preso i suoi personaggi e li ha mandati pel mondo: povere creature per le quali una barca e un carico di lupini travolti dalla tempesta divengono disastro irreparabile; creature agitate dall'avidità di arricchire, di elevarsi oltre la propria condizione, e che incontrano nella stessa avidità e nella stessa ambizione soddisfatte il loro inevitabile gastigo. E queste creature si chiamano Padron 'Ntoni, Alessi, Zi' Crocifisso, Piedipapera, Mena, Maruzza, la Zuppidda; si chiamano Mastro Don Gesualdo, don Ninì, i fratelli Trao, la baronessa Bianca Trao; e tutte hanno il loro carattere spiccato, la loro individualità, nelle passioni, negli atti, nel linguaggio; e sono di quel piccolo scoglio di Aci Trezza, di quella cittaduzza siciliana della provincia di Catania, e ne incarnano così stupendamente i modi di sentire e di pensare, che non possono essere scambiate con persone di altre provincie neppure nella stessa Sicilia.
Un senso di gran malinconia e di tristezza scaturisce dalle pagine di quei due volumi, ma quale scaturirebbe dalla diretta impressione, se quei personaggi e quelle azioni ci si fossero presentati, nella realtà, sotto gli occhi. Certamente, personaggi ed azione sono simboli, velami di idee; ma simboli vivi, che ignorano la loro qualità di simboli, e non si analizzano da per loro e non si spremono da per loro per cacciar fuori il succo del concetto che sanno di contenere.
Il D'Annunzio vuol rappresentare _stati d'animo dei più complicati e più varii, di cui analista si sia mai compiaciuto da che la scienza della psiche è in onore. Egli tende l'orecchio alla voce del magnanimo Zorathustra e vuol preparare con sicura fede l'avvento dell'__Uebermensch__, del Superuomo._ E sta bene. L'un concetto vale l'altro. Sia la darwiniana lotta per la vita, sia la pessimista e aristocratica filosofia del pensatore tedesco finito miseramente in un ospedale di matti, alla quale il D'Annunzio mesce l'idea pagana del Rinascimento e l'entusiastico culto della bellezza del corpo umano, non importa. Quel che importa di vedere è se gli stati d'animo astratti siano divenuti persone, individui della tal città, della tal provincia; eccezioni, rarità quanto si vuole, ma rarità, eccezioni che debbono fare il miracolo di incarnare più schiettamente, più vigorosamente il carattere della razza, del paese dove son nati, perchè l'eccezione e la rarità consistono in questo.
Io prendo in mano le Vergini delle Rocce e tento di scorgere questa rarità, questa eccezione organica, e non la trovo. Claudio Cantelmo ragiona, analizza, si esprime con lingua e stile elevatissimi; non sa muovere un dito senza distillare tutte le conseguenze più riposte e più misteriose di quella mossa; non può osservare le mani di una ragazza, senza che esse non gli sembrino come ricettacoli d'infinite forze innominate da cui potevano sorgere meravigliose generazioni di cose nuove. Ed eccolo invasato dall'idea di creare il tipo supremo dell'italiano, anzi il futuro Re di Roma!
Dobbiamo supporre che questa persona, a cui sembra non sia ignota nessuna conquista della scienza positiva odierna, non intenda creare un essere umano con mezzi e modi diversi da quelli stabiliti dalla natura. Infatti non si rivolge al crogiuolo del chimico che crea, con sintesi, le sostanze organiche, per chiedergli di anticipare il miracolo scientifico preannunziato dal Berthelot; ma va in cerca di una sposa, di colei che dovrà essere l'eletta cooperatrice nella nobilissima impresa della reale generazione. Se non che, col pretesto che nelle razze di antica origine sangue, nervi, cervello siano necessariamente più raffinati, Claudio Cantelmo va a cercare la madre del futuro re di Italia in una famiglia, principesca, sì, ma composta di idioti, di pazzi, di nevrotiche, di isteriche. E non giudica a prima vista che di quelle tre ragazze estenuate, vissute lontane dalla società, nessuna potrà concorrere a formare la fibra nuova, vigorosa del rigeneratore del regno d'Italia; e va tastoni, ed esita e non arriva a decidersi.
È forse creatura umana Claudio Cantelmo? Diciamo pure, se così si vuole, che sia un simbolo. Diciamo pure, con l'amico Rod, che le tre vergini Massimilla, Violante, Anatolia rappresentano non so quali altri simboli più reconditi e più profondi di quello di Claudio. I lettori spassionati confesseranno che queste tre preraffaellitiche figure li colmano di vivo piacere soltanto quando, di tratto in tratto, accennano di diventare o diventano persone vive; e che più viva di loro è la loro madre, la pazza principessa Montaga, la quale non ha missione, a quel che sembra, di rappresentare simbolo alcuno.
Le bellezze, i lenocinii dello stile, caro Ojetti, risultano cosa molto secondaria, mera esteriorità, quando non diventano cosa organica con quel che costituisce la essenza della forma in un'opera d'arte.
E il cosmopolitismo è costretto a rifarsi con la retorica—diciamo francamente la parola—rinunziando, per partito, al carattere particolare che dovrebbe imprimere in ogni opera d'arte la razza, la tradizione, il genio di ciascun popolo.
I grandi intendimenti filosofici, scientifici, si riducono a lustre, a ciarlatanerie per chiappare il momentaneo favore del pubblico, se poi non riescono a creare persone vive. Omero, Shakespeare, Balzac, che avevano reni solide per la bisogna creativa, non andavano tanto per le vie traverse: mettevano al mondo creature immortali, non vuote parvenze. Ed Elena e Andromaca e Nausica daranno, fino alla fine dei secoli, da pensare e da discorrere più di qualunque nostro simbolo moderno; e Amleto ha fatto e farà scervellare filosofi e scienziati più che non abbia fatto e non possa fare una persona realmente esistita; e Madame Marneffe, e il Barone Hulot, e il Pére Goriot e il Cousin Pons, perchè creature vive, iscritte con inchiostro indelebile nel registro dello stato civile dell'Arte, si prestano compiacentemente a fare da simboli con Elena, con Amleto, con tutti gli altri loro pari. E come no, se l'opera d'arte è pensiero condensato in una forma viva, il quale può benissimo venir di nuovo ridotto alla sua primitiva essenza di puro pensiero?
—Ma il cosmopolitismo non l'ho inventato io!—può dirmi l'Ojetti.—È un fatto storico contemporaneo. Io lo accetto; perchè voglio essere del mio tempo, perchè sono giovane, perchè il mio cervello affollato di concetti filosofici, scientifici, non può funzionare più, come nelle età infantili, barbariche, da pura immaginazione e gingillarsi con semplici fantasie. Con l'arte nuova noi vogliamo rifare il mondo. =E libro lux=, non ha sentito? ha detto il D'Annunzio. E io non ho creduto d'ingannarmi aggiungendo che l'opera letteraria =Lux= sia appunto la trilogia delle Vergini delle Rocce. La odierna letteratura italiana, o meglio la nostra produzione letteraria è fuori di questo movimento, e quasi non ha ragione di esistere. Per l'avvenire? Ripeto quel che ho scritto nella Revue de Paris: "assai prima che si formi tra noi una letteratura italiana, avremo anche in Italia una letteratura europea."
Ah, egregio Ojetti, io voglio mostrarmi più radicale e più cosmopolita di lei! E siccome una cosa o è quel che dev'essere o non è niente; e siccome un'opera d'arte non può essere altro che pensiero incarnato in una forma viva, così io credo che noi assisteremo in tal caso alla solenne agonia dell'Arte. Troppa riflessione, troppa scienza positiva ci pervade ogni fibra. L'opera d'arte che pretende di usurpare le funzioni della filosofia e della scienza non caverà un ragno dal buco. =E libro lux=, sì, sì; ma questo libro (ed è giusto che sia così) non lo scriverà un artista. Io, per mio conto, mi contenterei che qualcuno dei nostri artisti ci desse—vede come sono poco esigente?—di quando in quando, in Italia, un nuovo Don Abbondio!
Amen.