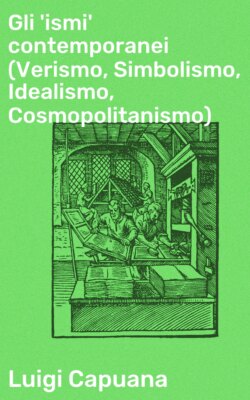Читать книгу Gli 'ismi' contemporanei (Verismo, Simbolismo, Idealismo, Cosmopolitanismo) - Luigi Capuana - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
Оглавление"Il campanilismo ormai è ridicolo, specialmente in materia d'arte. Di là dai monti, di là dai fiumi, di là dai mari ecco artisti che rinascono, e si levano, e si chiamano ad alta voce, e si nutrono fraternamente dello stesso pane, al sole. L'arte è universale; l'artista non è più nè italiano, nè francese, nè norvegiano: il suo genio è umano!"
Ben detto, caro Ojetti; se non che è stato sempre così. L'opera d'arte italiana o francese o norvegiana è stata sempre opera del genio umano, e non poteva essere diversamente. Tempo fa il pregiudizio retorico, pedantesco non riconosceva altra arte all'infuori di quella greca e latina. Ma noi ci siamo finalmente liberati dal giogo dei greci e dei romani, abbiamo allargato il nostro orizzonte. Shakespeare non ci apparisce più un barbaro, come al signor di Voltaire; da qualunque parte ci venga, qualunque forma rivesta, qualunque concetto esprima, pur che abbia assunto una forma vivente, l'opera d'arte è accolta, compresa, festeggiata, ammirata. Nazioni che prima non avevano preso parte al banchetto artistico—che non hanno tradizioni classiche nè di nessuna sorta, e non intendono certi nostri pregiudizi—sono venute a sedervisi insieme con noi, balde, piene di entusiasmo, giovanilmente sincere, e anche, non le dispiaccia, giovanilmente ingenue; e ci hanno mostrato, col fatto, l'inanità di certe convenzioni dalle quali non sapevamo sottrarci. Queste nazioni avevano qualcosa di nuovo da dirci: il loro particolar modo di sentire, di pensare; e ciò dava alle loro opere aspetto insolito, attraente, suggestivo. La natura e la vita ci apparivano guardate da occhi diversi dai nostri, da intelligenze più libere e quindi più forti. Noi abbiamo sentito trasfondere nelle nostre vene un'onda di sangue più fresco, ci siamo sentiti ringiovanire. Abbiamo guardato la natura con altre intenzioni anche noi; e anche noi abbiamo osservato la vita che quasi avevamo perduto di vista, tanto ci eravamo abituati a guardarla non direttamente, ma a traverso l'altrui opera d'arte. Per dire la verità, questa trasformazione, questa rinnovazione l'avevamo già iniziata da un pezzo, un po' per istinto, un po' per riflessione; ma i nuovi venuti l'hanno affrettata, l'hanno compiuta. Si trovavano in migliori condizioni; arrivavano ultimi; e senza accorgersene, senza volerlo, usufruendo del nostro lavoro di preparazione, lo hanno spinto molto avanti.
Tutto questo, ripeto, sta benissimo, non fa una grinza. Ma c'è un equivoco prodotto dalla parolina umano buttata là dall'Ojetti, quasi sbadatamente, la quale vuol significare quel sentimento di pietà, di carità universale, più profondo e più vasto, che pervade la società moderna, la rimescola e che, creato il socialismo in politica, vorrebbe pure importarlo tale e quale nell'arte.
Nella politica esso nega il concetto di patria, nell'arte il concetto di letteratura nazionale. Da questo strano equivoco è venuto fuori il cosmopolitismo letterario di cui l'Ojetti è uno dei più caldi e dei più ingegnosi banditori.
È un'astrattezza. Se con quella parola si volesse soltanto significare l'alto senso di comprensione che ci fa penetrare, intendere e ammirare tutte le forme artistiche da qualunque parte del mondo ci vengano: o la urgenza vitale dell'assimilazione delle varie forme quando esse rappresentano qualcosa di organico nell'arte, non ci sarebbe niente da ridire. Ma il fatto dimostra che per cosmopolitismo artistico s'intende tutt'altro. S'intende una certa uniformità di sentimenti, di concetti, e per conseguenza, un'uguale corrispondenza di forma che dallo stile va su su fino al modo di concepire l'opera d'arte: e lo stile diventa quindi un gergo comprensibile soltanto dagli iniziati, e la personalità umana si assottiglia, si assottiglia per diventare simbolo più o meno trasparente. In questo caso non veggo una bella ragione di dare il bando ai greci e ai latini, che sono chiari, solidi, risplendenti, e parlano un linguaggio armonioso, comprensibile da tutti, per sostituir loro qualcosa di inconsistente, di torbido e, quel che è più, di mortalmente uniforme.
Si perdonino queste astrettezze anche a me; era impossibile scansarle. Veniamo ora a qualche esempio. Le nazioni sono degli individui grandi, direbbe il De Meis; e come tutti gl'individui hanno un modo speciale di sentire e di pensare e un modo altrettanto speciale di dar forma ai loro concetti.
Ora ecco una poesia di amore di un poeta cosmopolita. Non ne ho il testo per le mani, e la trascrivo quale è stata recentemente tradotta da Vittorio Pica, nel suo studio premesso alla Belkiss, poema drammatico simbolista del giovane poeta portoghese Eugenio De Castro. Descrive l'istante in cui apparve al poeta l'Amata.
"Trionfale, vespertino, mineralmente rosso—nella diafana pace d'un tramonto di ottobre,—il sole, lacerando l'incenso degli spazii,—cammina verso la morte ad indugiati passi,—come le bande che vanno a suonare nelle esequie….
"Fu in un'ora così soave, crepuscolare—che, lungo questo esteso e fogliuto viale,—altiera, imperiale, tra un fruscìo di seta,—vidi per la prima volta l'Eletta della mia anima—il grande Fiore sottile, impareggiabile, almo—la Maggiore, la più Bella, la più Amata, l'Unica.
"Incedeva gloriosa e triste, ravvolta in nera tunica,—che sul suolo strisciava in ondeggianti pieghe;—aveva nel calmo andare l'eleganza della serpe,—la leggerezza d'uno spettro e la grazia d'un'anfora…
"Il gran Fiore passava, imperturbabilmente,—col suo volto enimmatico ed il suo sguardo vago—ieratico, ricordanti le mistiche immagini,—mentre i miei occhi seguivano come paggi—il suo ritmico incesso sonnambulo e triste…."
Basti questo saggio. Aprendo a caso qualunque volume di poeti cosmopoliti, troveremmo gli stessi aggettivi: trionfale, mineralmente rosso, applicati indeterminatamente e un po' a caso; e troveremmo Belle, Amate, Uniche, ugualmente imperiali, o reali, o ducali; e tutte avranno l'eleganza della serpe, e tutte si muoveranno leggere come spettri, e tutte avranno la grazia di un'anfora. Il poeta che ho citato è portoghese; ma potrebbe anche essere francese, tedesco, italiano, esquimese, come, viceversa, i suoi confratelli esquimesi, italiani, tedeschi, francesi, potrebbero essere benissimo portoghesi. Sono state soppresse nel paesaggio e nella figura umana le particolari caratteristiche; non più quel tal paesaggio, o quella tale persona, ma dei sostantivi astratti, degli aggettivi astratti. Avremmo voluto avere l'impressione di un angolo di cielo e di terra portoghese; avremmo voluto vedere una signora o una signorina di Lisbona o di Oporto, vestita in una certa foggia che neppure la universalità della moda riesce a sopprimere, soprattutto una signora e signorina che sente e pensa in modo assolutamente individuale; e invece non abbiamo niente.
Ed ecco i drammaturgi norvegiani, ecco i romanzieri russi.
Ibsen irrompe sul palcoscenico spingendosi innanzi una folla di creature della sua Norvegia, strane, malate d'ideali, con la coscienza sconvolta dai problemi religiosi e sociali che colà lavorano sordamente i cuori e le teste; nature complicate, nevrotiche, che soffrono e fanno soffrire.
Per condurle sul palcoscenico, l'Ibsen non bada alle forme drammatiche usate altrove. È artista, e capisce istintivamente che quelle creature devono parlare e agire a modo loro, sincere, senza preoccupazioni del pubblico; ma è complicato, nevrotico, malato d'ideali pure lui; com'esse, è lavorato dentro sordamente dai più alti problemi religiosi e sociali; e per ciò s'interessa di costoro fino a un certo punto. Artista, non può vedere il concetto altrimenti che come forma; ma, pensatore, vuole poi così spietatamente che quelle creature agitate e sconvolte dicano chiaro e aperto che non sono loro, soltanto loro, lo scopo di lui, ma l'intimo concetto che le anima; lo vuole così spietatamente, che all'ultimo le sforma, le strappa, le distrugge, e non permette che arrivino fino in fondo dell'atto quinto creature reali e vive quali le avea mostrate sin dalle prime scene.
Intanto, invece di contentarsi d'intendere e d'ammirare l'opera dell'Ibsen, invece di limitarsi all'assimilazione dei perfezionamenti di forma ch'egli ha recato nella drammatica, si è voluto norvegizzare tutte le creature del teatro europeo, anzi cosmopolita.
Il Tolstoi, il Dostoiewski appartengono a una razza che si occupa anch'essa del mondo interiore, e rimugina le proprie sensazioni, e si tormenta con i casi di coscienza. I tre grandi artisti rappresentano la concentrazione, la somma di queste qualità morali e intellettuali. Il Dostoiewski, inoltre, è un nevrotico, un perturbato, e nelle sue creazioni rispecchia lo stato irregolare della sua mente. Con essi la forma si è avvantaggiata dei pregi di sincerità, di rappresentazione evidente e vigorosa di cui hanno dato esempi meravigliosi. Non trovandosi però alle prese con i limiti e le convenzioni della forma drammatica, i tre romanzieri non sono stati costretti a sformare, alla fine, le loro creature per mettere in maggiore evidenza il loro intimo concetto; e così esse han conservato, più delle figure ibseniane, la loro caratteristica di pure opere di arte.
Intanto, invece di assimilarsi quel che c'è di nuovo e di organico nella forma del romanzo russo, operando una confusione tra forma e concetto, è stata egualmente tentata la sciocchezza di russificare alla lor volta i personaggi del romanzo europeo.
E passi per l'Ibsen, passi pei romanzieri russi! Nell'uno e negli altri il concetto ha preso vera forma; l'uno e gli altri hanno creato persone vive della loro nazione, del lor tempo. Il cosmopolitismo va più in là. Per quanto ossessi dei problemi di religione, di morale, di sociologia, i personaggi dell'Ibsen, del Tolstoi, del Dostoiewski sono figure vive, consistenti, e in che modo!
Il cosmopolitismo non sa che farsene di queste figure vive e consistenti. Simboli! Astrettezze! Ecco quel che egli vuole, cioè cose che sono l'opposto, anzi l'assoluta negazione dell'arte.
Il norvegizzare e russificare l'opera d'arte è stata insomma l'operazione preliminare del cosmopolitismo letterario, in Francia, in Germania e, pel poco che ha potuto, in Italia.
Ora esso vuole andar oltre, è andato già oltre.
Ha tutto un programma pieno di concetti che sembrano elevati, pieno di buone intenzioni da lastricarne non uno ma più inferni. E bisogna guardarlo da vicino, sviscerarlo per convincersi se mai si tratti di cosa seria, o piuttosto di aberrazione passeggera, o di risibile ciarlataneria che vuol mascherare coi paroloni un'irrimediabile impotenza creatrice.
Sventuratamente forse si tratta di ben altro.