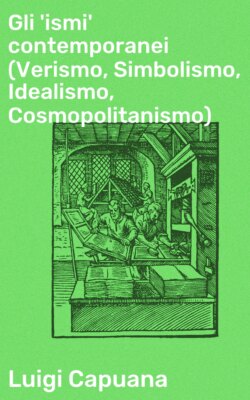Читать книгу Gli 'ismi' contemporanei (Verismo, Simbolismo, Idealismo, Cosmopolitanismo) - Luigi Capuana - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA DIFESA DI EMPEDOCLE
Оглавление(Lettera aperta a Luigi Capuana)
Amico mio, come ella sa, un suo conterraneo il filosofo Empedocle d'Agrigento, stanco di operar miracoli e di discutere sui quattro elementi, quattrocento anni prima di Cristo si gettò a capo fitto nel maggior cratere dell'Etna per assicurarsi tra gli increduli fama divina.
Secondo quel che narrano i suoi tre cortesi articoli, io che sono un poco filosofo ma non ho operato miracoli mai, mi sarei gittato dall'alto della Revue de Paris nella ardente voragine del Cosmopolitismo (la parola è tutta sua, non è mia) proprio per acquistarmi un po' di fama tra gli increduli che in Italia sono molti.
…Deus immortalis haberi Dum cupit Empedocles ardentem frigidus Aetnam Insiluit.
Ora, per mostrare ai suoi lettori che ancora son vivo e non mi son bruciato manco un capello, mi permetta di risponderle qualche parola.
Io credo—questa è la mia impressione concisamente e francamente—che i suoi tre articoli che si chiudono con un deprofundis all'Arte vinta, mutilata, asservita dalla scienza positiva, sarebbero stati non solo giusti, ma profetici, per lo meno quindici anni fa, quando per Arte si intendeva l'Arte naturalista, materialista Zoliana (la chiami come vuole), quell'arte che in Italia apparve vestita da siciliana nel Mastro don Gesualdo, nei Malavoglia, e—perchè non dirlo?—nelle sue Paesane.
Adesso, amico mio, le sue idee su l'arte—perchè noi in questa discussione tocchiamo proprio i culmini dell'estetica—hanno contro di loro i fatti compiuti, e non solo compiuti ma constatati da filosofi come il Guyan, come il Brunetière, come il Fouillée, come il Gosse, come l'Hennequin, e anche come il Tolstoi: fatti compiuti e constatati dagli stessi avversarii. Ieri, quando è giunto qui nel mio eremo d'Umbria il suo ultimo articolo, mi giungeva pure il Rome che Emilio Zola mi mandava da Parigi. E per lei che è stato ed è uno dei capi dei naturalisti italiani (in fondo son tutti capi e tutti siciliani, loro naturalisti) quel solo libro nell'intenzione e nel fatto deve valere più di tutte le mie argomentazioni. Non è vero?
Questo periodo è suo; Come lo Zola disse della letteratura francese: Sarà naturalista o niente, l'Ojetti oggi dice dell'italiana: Sarà simbolista o niente, o meglio: "Sarà cosmopolita o niente".
I due termini del paragone, lasciando stare per comodità di discussione la gigantesca altezza dell'uno e la piccola statura dell'altro, non si corrispondono affatto, malgrado quel suo o meglio il quale mostra che ella stesso scrivendo non li trovava molto adatti alle nozze. Prima di tutto io nego recisamente di aver mai parlato di simbolismo, una parola che ormai ha troppi sensi e quasi tutti falsi, e a prenderla nel senso in cui l'hanno presa Emile Verhaeren, Henry de Regnier, Ferdinand Herold, Francis Vielé-Griffin e leur critique à tous Remy de Gourmont dovrebbe significare puramente l'individualismo nella genesi e nell'effetto dell'opera d'arte: un significato che, come ella vede subito, fa ai pugni con quel cosmopolitismo di cui ella vorrebbe in vece fare un sinonimo di simbolismo.
Ella poteva dire invece semplicemente Idealismo, e il paragone avrebbe filato via come due paranze in pesca unite da una sola rete.
E l'Idealismo appunto io, con le mie forze tutte se pure poche, ho venti giorni fa difeso nel mio discorso di Venezia su L'avvenire della letteratura in Italia, il quale non è (come ella pensa) la ripetizione del mio articolo su la Revue de Paris, ma dice molte altre cose che—credo—anche i sunti telegrafici dei giornali hanno cortesemente ripetute.
Dunque Idealismo, e niente Simbolismo.
* * *
E anche niente Cosmopolitismo se lo si ha da intendere come lo intende lei. L'universalizzarsi dell'arte—non nella forma che è e deve restare nostra e sarà anzi per il suo tradizionale senso di misura e per la sua tradizionale nobiltà il segno in cui noi italiani vinceremo nella ventura giostra mondiale—è un fatto che si è constatato dopo che si sono viste opere come quelle di Tolstoi, di Dostojewski, di Maeterlink, di Ibsen, di Björnson, di D'Annunzio, di Fogazzaro passare i confini di Stato e di lingua, appassionare gli stranieri più lontani, rivelar loro qualche nuovo significato della Vita, aiutarli a intendere il senso della Vita, il problema dell'Anima, a cui nè i contadini di Malavoglia, nè i signorotti dei Vicerè, nè i bruti delle Terre avevano mai pensato o potevano mai pensare.
Invece ella, parlando del Cosmopolitismo in arte, pare che creda che ognuno dei Cosmopolitisti (questa parola per fortuna non è nè sua nè mia) quando deve scrivere una pagina o disegnare un quadro o tentare su la tastiera un accordo, si dica, bevendo prima un bicchierino di Kûmmel in omaggio ad Hauptmann e accendendo una sottile sigaretta russa in omaggio a Tolstoi:
—Oh adesso facciamo un'opera cosmopolita!
Ma no, amico mio! La questione non è di forma, non è di adottare un'allegoria doppia invece di una immagine piana, non è di imitare un po' i francesi, un po' i russi, un po' i portoghesi, un po' i norvegesi perchè quel miscuglio piaccia a tutti loro. Con questo metodo i frati francescani fanno qui in Umbria la misticanza, una insalata fresca arguta e deliziosa che contiene trentatrè erbe diverse. Ma con questo metodo non si fanno libri, o quadri, o musiche.
Quando invece di guardare fra tre persone presenti ciò che le distingua le une dalle altre, un baffo più o meno folto o un occhio strabico o un tic nervoso, si cercherà oltre le loro apparenze quel che l'anima loro ha di più profondo e quindi di più comune e quindi di veramente umano (in questo senso io dissi umano là dove voi mi citate, non nel senso di pietoso o di socialistico), allora scrivendo, si farà un'opera che interesserà e commoverà tutte e tre quelle persone. Allarghi il conto, e verrà l'arte cosmopolita che le fa fare il segno della croce.
Certo per ciò è necessario di essere idealisti, di cercar di sorprendere al di là dell'occhio oscuro o chiaro l'anima, la tenue timida anima che solo ai credenti si rivela, perchè, se ella si fermerà all'esterno o anche dei fenomeni psichici farà un macchinismo e osserverà solo quelli più prettamente legati alla carne, allora l'opera sarà vana, sarà un permesso di caccia coi tratti caratteristici dei varii personaggi, non sarà un libro dell'anima.
Ella per persone vive intende quelle mirabilmente disegnate dal verismo del Verga, ossia persone che siano quelle e non altre e non confondibili con nessuna altra. E ha ragione. Io (dovrei dir noi, ma mi sembrerebbe anche più orgoglioso e mi contento della mezza misura d'orgoglio contenuta in quell'io) intendo per persone vive non astrazioni, non nuvole grige e mutevoli a ogni vento, non fantasmi lividi che spariscono alla luce d'una candela, ma tipi (e qui in un certo specialissimo senso ella potrebbe—col Guyan e col Brunetière dire simboli) dove ogni uomo ritrovi qualche sentimento, qualche pensiero suo, dove ogni uomo ritrovi una qualche immagine fraterna, dove ogni uomo ritrovi l'anima sua compresa come una goccia d'acqua è compresa nell'infinito mare.
Amico mio, buon amico mio, perchè discutere? Perchè parlar di D'Annunzio o di Verga, di Eugenio de Castro di Edouard Rod? Ma quando un libro piace a lei nel suo bello studio arioso fra gli scaffali eguali ed eleganti e piace a me quaggiù nella mia villetta fiorita di rose e di lillà, è che ella ed io ci commuoviamo, sentiamo o pensiamo, non guardando persone vive sì ma indifferenti, disegnate benissimo, scolpite benissimo ma estranee, ma ritrovando invece dentro quella scrittura, fra quelle righe qualche cosa di noi, qualche cosa che è in noi come è nelle persone finte dello scrittore, qualche cosa anzi che è in noi ed è anche nello scrittore. E di tutti i libri oggettivi, ontologici, positivisti del Verga, dello Zola, del Bourget, dell'Hervieu, quelle sole pagine sopravviveranno dove, malgrado loro, per una fatale incosciente trasgressione alle loro teorie pseudoscientifiche, essi avranno messo un po' d'anima, un po' d'anima loro. Ho torto?
Questa differenza essenziale, non formale, spiega perchè il Verga malgrado sia stato tradotto dal Rod non sia stato compreso in Francia. Al più poteva avere un successo di curiosità come rarità esotica come siciliano. Il confronto che ella fa fra il successo del D'Annunzio e l'insuccesso del Verga si ritorce contro di lei, così, facilmente.
E per lasciar questi due nomi che potrebbero far supporre al pubblico che ella ed io difendessimo gli amici più che gli autori, guardi il successo del Daniele Cortis di Antonio Fogazzaro, e me lo spieghi. Lì non c'è nulla (io non lo trovo nemmeno altrove dove ella lo trova così prontamente) di questo gergo cosmopolita, di questo aggettivare convenzionale. Lì son persone di carne e d'ossa, perdio: ma dentro la carne e dentro l'ossa hanno un'anima profonda come un abisso e come un sereno.
Lasci agli Stecchetti e alle Argie Sbolenfi la convinzione che l'arte idealista sia un'accozzaglia di trionfale, imperiale, ducale, minerale. Ella sia con noi, che siamo forse pochi ma siamo nuovi e giovani e abbiamo davanti a noi tale una via lunga, che ai nostri occhi ansiosi essa sembra in fondo all'orizzonte confondersi col cielo.
In quella prefazione del Trionfo della morte lasci un po' stare il Cenobiarca e il magnanimo Zarathustra e legga in principio quell'aspirazione a "un ideal libro di prosa moderno che sembrasse non imitare ma continuare (qui è la differenza fra sua teoria estica e la mia) la natura, libero dai vincoli della favola, portasse alfine in sè creata con tutti i mezzi dell'arte letteraria la particolar vita—sensuale, sentimentale, intellettuale—di un essere umano collocato nel centro della vita universa".
Ella non guarda e non vuol guardare che a riprodurre la vita; per noi l'arte è una vita superiore, è un eccesso di vitalità e di gioia cosciente (adesso è nientemeno Alfredo Fouillée che parla); a noi l'arte deve dare la coscienza di un massimo di energia con un minimo di sforzo ma non nella nostra sensibilità soltanto ma anche nella nostra intelligenza e nella nostra volontà. Questo, la natura e tanto meno l'imitazione della natura non ci sa dare.
L'arte agonizza? E la scienza positiva l'ha ferita a morte? Ma dove? Ma come? Ma la scienza positiva sta troppo giù per giungere a ferire fino a lassù. E in questi giorni in cui Ferdinando Brunetière mostra in un discorso mirabile La Renaissance dell'Idéalisme, in questi giorni in cui Melchior de Vogue studia lo spiritualismo di Pasteur e di Claude Bernard, in questi giorni in cui lo Zola, il vostro Zola pubblica Rome, in questi giorni in cui Maeterlink mostra ansioso Le Réveil de l'Ave, ella mi annuncia che l'arte agonizza? Eh via, amico mio!
E allora perchè ella ci promette Il marchese di Roccaverdina e Verga il terzo volume dei Vinti? Parleranno da oltre tomba, loro due, se è lecito.
* * *
Credo che, dopo questa difesa, mi sia inutile dire che non certo le parlo della presente letteratura d'Italia "con una modestia che confina col disprezzo." Sono parole sue, nel primo articolo.
Ma però due piccole spine mi voglio levare dalle mani due spine che senza sangue mi si son confitte nella pelle cercando gli sterpi fra i fiori delle sue tre critiche.
La prima spina sta nella frase: "Tutto questo l'Ojetti, lo sa meglio di me, ma non ha voluto tenerne conto… Scriveva per una rivista francese…" Scusi, scusi, amico mio; ma in Italia o in Francia io scrivo solo quello che penso; e a Venezia ho detto su l'inesistenza di una comune anima italiana e su la divisione morale e intellettuale che è fra le razze italiane e su la turpe invasione della piccola politica in ogni più sana terra d'Italia, cose che stimo vere e che domani scriverei in Francia con le stesse ardenti parole.
E la seconda spina sta nella frase: "Io accetto il cosmopolitismo perchè voglio essere del mio tempo, perchè sono giovane."—E anche questa spina punge la mia sincerità e me la tolgo e la gitto via. Io constato il cosmopolitismo non lo difendo; io difendo solo l'idealismo e non perchè sia di moda, ma perchè risponde meglio al concetto che dell'arte mi son fatto dopo aver molto studiato e libri e pitture e musiche e filosofie. E, se sbagliassi, a tutto ella dovrà dare la colpa del mio errore, meno che alla mia sincerità, o (errore accettissimo!) alla mia gioventù! Se la frase "Mi vanto d'esser giovane" non chiudesse un nonsenso, sarebbe davvero da gridarla ai quattro venti a testa alta, vedendo quel che i vecchi hanno fatto della patria.
E qui vorrei mostrarle la terza spina, ma non mi punge e la lascio dov'è. Sa che intendo? Quell'idea di riunire l'internazionale cui aspira il socialismo, all'arte cosmopolita cui molti scrittori aspirano. E se fosse? Certo è che on n'etouffe pas le feu avec de la paille.
A lei sarebbe dispiaciuto che io non avessi chiusa la mia difesa con un po' di francese.
Una stretta di mano sinceramente affettuosa dal suo
San Giacomo di Spoleto, 13 maggio 1896.
__Ugo Ojetti.__
Ah, caro Ojetti! Dopo la sua risposta, io credo di avere più ragione di prima.
La sua difesa poggia tutta sopra tre o quattro equivoci. Cosmopolitismo no (la prego di credere che questa parola non l'ho coniata io; si trova nei vocabolari della lingua italiana); Simbolismo, no; parola che, secondo lei, ha troppi sensi e tutti falsi. Idealismo! Se non è zuppa è pan molle. Vede? Io ragiono d'arte e lei mi risponde picche, cioè filosofia.
Una delle due: o l'arte nuova, l'arte anzi dell'avvenire, si deve ridurre a trattati più o meno astratti di psicologia individuale, e allora non capisco perchè se n'abbiano a fare dei drammi e dei romanzi; o quel tal concetto psicologico individualista deve prendere forma incarnandosi in una o più persone, e allora non capisco la sua commiserazione per le persone vive mirabilmente disegnate dal verismo del Verga. Non sono forse creature umane anche quelle, quantunque nate negli infimi gradini della scala sociale? Non soffrono, non amano, non odiano, non appetiscono in modo che ogni uomo vi possa ritrovare qualche sentimento, qualche pensiero suo, una qualche immagine fraterna, e anche l'anima sua compresa come una goccia di acqua è compresa nell'infinito mare?
Può darsi che m'inganni, ma io suppongo che loro idealisti siano diversi da quelle povere creature soltanto perchè la buona sorte, l'accidente e la volontà e i facili mezzi di cultura li hanno posti o fatti salire parecchi scalini più in su di esse.
Hanno pure un ideale quelle povere creature, che è certamente il nucleo, la prima forma dell'ideale umano, ma non disprezzabile, non trascurabile, no, se è vero che niente sia trascurabile e disprezzabile nello studio di questa multiforme umanità.
E quelle creature sa perchè io le chiamo persone vive? Non perchè sono esteriori, disegnate mirabilmente, ma perchè sono nello stesso tempo esteriori e interiori; perchè ogni loro parola, ogni loro atto rivela uno stato d'anima—passione, calcolo, brutalità, sentimentalità—e non già per indicare, come segno algebrico, il tale o tal'altro principio psicologico che passa pel capo dell'autore, ma perchè proprio continuano nel libro la Natura, perchè proprio portano in sè creata con tutti i mezzi dell'arte letteraria la particolar vita sensuale, sentimentale, intellettuale, di esseri umani collocati nel centro della vita universa, come vuole il D'Annunzio nella prefazione-programma da lei citata. Questo bel programma (accenniamolo di passaggio) il Verga nè altri hanno stimato opportuno metterlo in fronte a un loro libro; gli sarebbe parso d'insultare i lettori, supponendoli così ignoranti da non sapere cose elementarissime. Non le pare? I programmi bisogna lasciarli imbastire ai signori provveditori delle scuole. Gli artisti devono metterli in atto; e il lor dovere d'artisti, perchè, come diceva il buon marchese Colombi:
Le accademie si fanno o pure non si fanno.
—Noi creiamo dei tipi!—dice lei.
Peggio per loro. Il tipo è cosa astratta: è l'usuraio, ma non è Shylock; è il sospettoso, ma non è Otello; è l'esitante, il chimerizzante, ma non è Amleto, e via via. Potrei facilmente moltiplicare gli esempi; ragionando con lei, basta un semplice accenno.
Dei tipi? Ma tutta la letteratura moderna è la negazione di questo principio estetico classico, già sorpassato; lo afferma involontariamente lei stesso quando parla d'individualismo. L'arte, sissignore, oggi crea (quando riesce a crearli) individui non tipi. L'artista moderno si è convinto—e a questo convincimento l'ha indotto la scienza—che ogni creatura umana è un mondo a parte, immensamente ricco, immensamente vario, quasi altrettanto infinito quanto l'universo.
L'arduo, il difficile sta nel penetrare, nello scrutare quell'abisso e illuminarlo con la viva luce dell'arte.
Con lei, filosofo, posso anche permettermi certe formole metafisiche, e aggiungere: ogni individuo è il pensiero umano sotto una data forma particolare di carne, sangue, ossa, che è quanto dire di sensazione, di immaginazione, di riflessione. Il mondo non esiste e forse non può esistere altrimenti che con quella forma. L'ideale dell'albero, dell'animale, dell'uomo non l'ha visto nè lo vedrà mai nessuno; ma questo o quell'albero, sì; ma questo o quell'animale, sì; ma questa o quella creatura umana, sì. Dell'ideal mondo ragionino a lor posta i filosofi, che fanno bene ad astrarre; è il loro mestiere. Il mestiere dell'artista è l'opposto. Ogni artista dovrebbe poter dare la stessa risposta del Goethe a chi gli domandava qual concetto filosofico avesse egli inteso adombrare col Fausto:—Oh, io non son uso di poetare astrattezze!—
Dei tipi! Ma le creature dell'arte diventano tipi da per loro, per intima virtù propria, quando riescono persone vive; e rivelano (senza volerlo, aggiungo io) nuovi significati della Vita, e problemi dell'Anima. E questo fanno—mi dispiace di doverla così apertamente contraddire—anche i contadini dei Malavoglia e i signorotti dei Vicerè. Non ci hanno pensato e non potevano mai pensarlo costoro—qui lei ha ragione; ci pensavano però, per conto di essi, il Verga e il De Roberto che li hanno creati di sana pianta, con lungo lavoro di osservazione e d'immaginazione e non con semplice meccanismo fotografico. D'immaginazione sopra tutto, dopo che il materiale, penosamente e diligentemente raccolto, si è organizzato nella loro fantasia e si è individuato in quei tali personaggi. Il nuovo ideale della Vita, il nuovo problema dell'Anima—tutte e due con l'iniziale maiuscola, come lei le scrive—sono stati precisamente le forze che hanno spinto quegli artisti a creare.
Per questo tutto è condensato, tutto è concentrato, tutto è visto di scorcio nella loro rappresentazione narrativa. Nella realtà non è così; ed ecco in che modo l'Arte riesce ad essere una Natura più elevata, più purificata, idealizzata, come direbbe lei e come dico pure io.
Nel Verga quel suo particolar ideale prende un senso di commozione, di pietà; nel De Roberto, diventa un atteggiamento di ironia contenuta, di spietata crudezza: senso e atteggiamento che s'intravedono, che s'indovinano tanto meglio, quanto più i personaggi e i loro atti, e i loro sentimenti sono esposti oggettivamente, e quanto meno si scorge che tali atti e sentimenti abbiano qualche relazione col pensiero individuale dell'autore.
E questo, caro Ojetti, è individualismo, è idealismo dei più schietti e dei più sinceri. E quando io dico che nel D'Annunzio ciò non avviene, o avviene a intervalli, sì che l'organismo dell'opera d'arte ne soffre, non intendo biasimare l'elevatezza del concetto che vorrebbe informare i Romanzi della rosa e i Romanzi dei gigli. Intendo dire che vorrei meno rose e meno gigli sul frontespizio, meno programmi nelle prefazioni, e più creature vive nel testo; vive in quel loro ambiente elevato, aristocratico, filosofico, ideale, se le pare che così possa dirsi.
Le scrivo da quell'alta scrivania che lei sa, con attorno quei bei scaffali che le è piaciuto ricordare, a la smagliante luce di questo bel giorno di maggio che invade il mio studio dalle sue quattro finestre. E negli scaffali posso scorgere da qui, in volumi dalle coperte pergamenate, Platone, Hegel, e Guyau, e Fouillée, e Tolstoi, e Dostojewski, e Maeterlink, e Ibsen, e Björnson, e il mio Zola, come lei dice con sottile ironia, e i miei Verga e De Roberto—questo lo dico io e ne sono orgoglioso—e il suo D'Annunzio che, se me lo permette, è un tantino anche mio, lei lo sa. (Gli ho letti e studiati e li rileggo e li ristudio anch'io; non li ho comprati soltanto per ornarne gli scaffali). E sul rotondo tavolino di mezzo, veggo il Rome dello Zola mandatomi dall'autore, e che aspetta che io lo rilegga per intero, perchè ne ho letto saltuariamente parecchi capitoli nelle appendici del Journal e della Tribuna.
Eh, no, caro Ojetti—e questo non mi sembra il minore dei suoi equivoci—no, quel romanzo non è per me un argomento di dimostrazione in favore delle mie teoriche.
Da un critico arguto come lei e sdegnoso di ripetere pappagallescamente le opinioni degli altri, io non mi aspettavo di sentirmi dire che sono stato e sono uno dei capi dei naturalisti italiani. Mi ha tirato in ballo e perciò sopporti che io parli di me.
La mia meraviglia le parrà vanità, orgoglio e peggio. Essa suppone che lei abbia letto tutte le cose mie, dai Profili di donne, mio primo libro, al Drago libro di novelline per bambini e al Raccontafiabe. Convenga però che io mi meraviglio con ragione, sapendo quanto lei sia coscienzioso nei suoi giudizi.
Io naturalista? Ma quando e perchè?
Perchè quasi vent'anni fa ho dedicato un mio romanzo allo Zola? E in che modo, di grazia, le mie Paesane, concepite e scritte con metodo che si può dire l'opposto da quello usato dallo Zola, debbono appartenere allo zolismo travestito da siciliano? E le mie Appassionate e le fiabe del C'era una volta… e il Raccontafiabe (ho torto credendole opere d'arte?) e Profumo sono dunque tutti zolismo mascherato? Davvero?
Un critico francese, (mi sia concesso quest'impeto di vanità che sarà il primo e l'ultimo, glielo giuro) un critico francese, anni fa, scriveva di me: La nature extérieure n'est pour lui come elle est pour beaucoup d'autres, la gran tout dont l'homme n'est qu'une parcelle, qui le domine, qui lui impose ses sensations, qui tyrannise sa volonté—décor immense dans lequel se fond tout le théâtre. Loin de là, il la voit et la laisse au second plan.—L'homme seul lui paraît digne d'intéret… N'est-il pas plaisant de constater cette indifférence pour le monde matériel chez un écrivain auquel on a attaché l'étiquette de réaliste? E conchiude: M. Capuana est bien plus près de nier la réalité du monde extérieur que celle de la personnalité humaine. Volontiers il s'écrierait avec le poète:
En spectacle pompeux la nature est féconde, Mais l'homme a des pensées bien plus grandes que le monde.
(Édouard Rod, Études sur le XIX siècle, pag. 179).
Ho citate queste parole perchè non contengono lodi, ma affermano un fatto. E le ho citate perchè a me, supposto uno dei capi dei naturalisti italiani, sembrano esattissime.
Ed ecco perchè il Rome dello Zola non mi servirà a rinforzare le mie teoriche, ma mi servirà a combattere le sue. Il Rome è la più splendida dimostrazione della mia fede, ma in senso negativo: è un romanzo dove il concetto astratto non è riuscito a prendere forma vitale. Non ostante l'etichetta naturalista, il Rome è un romanzo eccessivamente idealista, e per questo, secondo me, sbagliato di sana pianta. Tenterò di dimostrarlo fra qualche giorno, appena avrò rilevato gli altri equivoci della sua difesa di Empedocle.