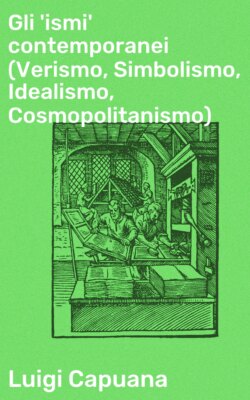Читать книгу Gli 'ismi' contemporanei (Verismo, Simbolismo, Idealismo, Cosmopolitanismo) - Luigi Capuana - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеUgo Ojetti ha predicato, giorni fa, a Venezia il suo vangelo letterario. Ripercosso dall'eco del telegrafo e dalle rassegne dei cronisti, è giunto fino a qui il rumore degli applausi prodigati dall'uditorio al conferenziere. Me ne rallegro con lui. Egli possiede tutte le qualità necessarie per farsi applaudire: è bel giovane, ha lo stile vivace, immaginoso, un po' vaporoso, ora di moda; dice delle cose non comuni e le afferma con calda convinzione di neofita, senza esitanze, senza riserve. La foga giovanile lo ha spinto a cercarsi, prima del pubblico veneziano, un pubblico più vasto, quasi mondiale. Per ciò, nel febbraio scorso, si è rivolto alla Revue de Paris per bandire da quel pulpito che questa povera Italia non ha una letteratura contemporanea e non l'avrà per un buon pezzo. I signori della Revue e i francesi che la leggono devono essere stati lietissimi di vedere un italiano chieder loro ospitalità per ragionare della letteratura della sua patria quasi con lo stesso tono d'un francese della più bell'acqua.
Immagino che, gratissimo dell'ospitalità accordatagli, l'Ojetti abbia voluto comportarsi verso quei signori con straordinaria cortesia, e sapendoli d'una ignoranza a tutta prova riguardo alle cose straniere, ha avuta la compiacenza di mettere anche lui nel suo scritto qualche inesattezza, sia intorno alle cose letterarie nostre, sia intorno a quelle francesi. A gentiluomo, gentiluomo e mezzo: ove così non fosse, quelle inesattezze e certi suoi giudizii rimarrebbero proprio inesplicabili.
La sua conferenza di Venezia, dal sunto dei giornali, pare una nuova edizione, anzi una semplice traduzione dello scritto pubblicato nella Revue de Paris. Se gli applausi non dimostrano che il pubblico sia rimasto convinto (in fatto di letteratura il pubblico italiano, lo confessa lo stesso l'Ojetti, est naturellement sceptique et somnolent) dimostrano che gli italiani di oggi sono molto diversi da quelli di mezzo secolo fa. Il Gioberti del Primato e i suoi contemporanei strabilierebbero, se per un miracolo potessero tornare in mezzo a noi. Dall'eccesso dei vanti un po' declamatori, quarantotteschi, siamo balzati all'eccesso opposto, a una modestia che confina col disprezzo di noi stessi. Fra i due, non è forse preferibile il primo? Almeno n'è nata l'unità d'Italia. Non so prevedere che cosa di buono possa produrre il secondo.
L'Ojetti però non è giovane per nulla; non scettico nè sonnacchioso, ha anzi una fede profonda e la proclama ad alta voce: crede nell'arte cosmopolita. Come lo Zola disse della letteratura francese: Sarà naturalista o niente, l'Ojetti oggi dice dell'italiana: Sarà simbolista o niente, o meglio: Sarà cosmopolita o niente.
Infatti quel che più l'attrista è il vedere che i letterati italiani non hanno un indirizzo comune, non formano una scuola, non vivono nella capitale, nè in un gran centro qualunque. Lavorano, disseminati qua e là, ognuno per proprio conto, secondo il proprio ideale: il Carducci a Bologna, il Fogazzaro a Vicenza, il Verga a Catania o a Milano, Matilde Serao a Napoli. Fin i giovani, egli dice, hanno orrore della parola scuola; preferiscono avventurarsi, ribelli e orgogliosi, per le vie dell'arte, invece di stringersi, non fosse per altro, per istinto di conservazione, attorno alla bandiera d'un capitano insigne per vittorie riportate o per gloriose disfatte; e così finiscono, spesso, miseramente. Tanti capi, tante sentenze. La baraonda dei concetti artistici, si traduce naturalmente in una peggiore baraonda di lingua e di stile. Chi può credere che lo stile e il vocabolario del Carducci, del D'Annunzio, del Fogazzaro, di Ferdinando Martini, del Verga, della Serao, di Edmondo de Amicis appartengano a scrittori della stessa epoca e della stessa razza?
Non lo dice, ma l'Ojetti sembra voglia mettere in confronto la letteratura italiana contemporanea con la letteratura francese, dove le scuole sbucciano e fioriscono a ogni pie' sospinto, dove gli scrittori, coloro che vivono d'arte, se ne stanno accalcati nel cervello della Francia, Parigi. Ed è strano che egli guardi con invidia quest'accentramento appunto quando in Francia si manifesta già qualche sintomo di reazione contro di esso. È strano che egli, autore di un libro Alla ricerca dei letterati, evidentemente ispirato da uno consimile dell'Huret, si lasci ingannare dalle apparenze e non ricordi che baraonda d'ideali d'arte, di lingua e di stile risulti dall'inchiesta del suo predecessore francese. Tralasciando, per un istante, di parlare d'ideali, consentiamo che l'italiano del Carducci, del D'Annunzio non sia l'italiano del Verga e del Fogazzaro; ma forse il francese dello Zola, del Daudet è una stessa cosa con quello dei De Goncourt e del Mallarmè, per citarne soli quattro?
Tra la baraonda italiana e la francese quale apparisce dai due libri, la differenza più notevole è questa: l'Ojetti non ha trovato un solo letterato italiano che abbia detto male di un collega, mentre la enorme vanità dei letterati francesi si è manifestata nel libro del'Huret con una gara, edificantissima, di morsi e di calci fraternamente dati e resi, e non solamente fra artisti di scuola diversa, bensì tra proseliti di una stessa scuola.
Ma per tornare alla questione veramente seria della lingua e dello stile, l'Ojetti, parlando della baraonda italiana su questo punto, ha dovuto far sorridere i colti lettori della Revue de Paris, che sanno di stare quasi peggio di noi. Lo Zola, il Daudet, i De Goncourt sono stati accusati di barbarismi e di sgrammaticature per lo meno quanto la Serao, il Verga, il De Roberto e qualche altro citati all'Ojetti dalla scrittrice napolitana; il Mallarmè e i suoi seguaci vengono giudicati o matti o incomprensibili dalla maggior parte dei loro contemporanei; ognuno di essi ha il suo vocabolario, il suo modo di esprimersi, precisamente come i poveri scrittori italiani; stavo per dire il suo gergo. Parecchi di loro si regalano a vicenda gli epiteti di puri, d'impeccabili; ma ci sono tant'altri che chiamano con nome diverso quell'impeccabilità, quella purezza, e preferiscono qualcosa di impuro e di peccaminoso, se l'impurità e il peccato recano con loro il compenso dell'originalità e della vita.
Tra gli scrittori italiani e i francesi, da questo lato, la questione si riduce a una proporzione aritmetica. Quelli sono molti, i nostri pochi. Avrei dovuto forse dire: a una questione commerciale; giacchè la produzione letteraria si sviluppa (e l'arte non ci perde, anzi!) in ragione dei vantaggi che arreca con la facilità dello smercio. Non credo che, in un problema d'arte, l'Ojetti voglia dare molta importanza al valore numerico.
Nel suo scritto la questione della lingua e dello stile vien posta da due che hanno nome autorevole, dal Verga e dal D'Annunzio. "Lo stile non esiste fuori dell'idea. Se lo stile consiste soprattutto nella forma della frase, deve adattarsi all'idea, deve vestirla e rivestirla. Quanto più intima sarà questa corrispondenza questa fusione, tanto lo stile sarà migliore. Le forme di frasi fisse, apprese in qualche classico, applicabili a tutte le idee, sono mortali per esso." Questo è il concetto del Verga. Pel D'Annunzio le frasi, le parole hanno un valore di trasformazione, di idealizzazione, se si può dire, dell'idea, un valore quasi per sè stesse. Così il Verga, per esempio, se dovrà parlare di una vecchia contadina, la chiamerà semplicemente za Maruzza e la descriverà, se occorre, in guisa da mettercela viva sotto gli occhi. Il D'Annunzio non saprà resistere alla tentazione di chiamarla ripetutamente antica Cibele. Pel Verga, una comitiva di ragazze, che coglie uva o sarchia grano, sarà semplicemente una comitiva di ragazze che lavorano, ridono, cantano; e le descriverà, se occorre, parcamente, incisivamente, in guisa da mettercele vive sotto gli occhi; il D'Annunzio la chiamerà classicamente una teoria.
E, a proposito dello stile di questi due autori, un'altra prova concludentissima. Prima assai dell'avvento del D'Annunzio in Francia, il Verga aveva visto tradotti i suoi Malavoglia per opera del Rod e pubblicati dall'editore Savine. Il Rod ha compiuto un miracolo di lucidazione del testo italiano, sorprendente per fedeltà ed esattezza; ma il lavoro del Verga non ha avuto però successo presso i lettori francesi, e non poteva averne soggiungo io. La personalità del suo stile, il carattere speciale di esso nella traduzione era sparito; il traduttore era riuscito traditore per la evidentissima buona intenzione di non tradire l'originale. Invece quello era il caso, se mai, di rifare con colorito francese, con forme dialettali di qualche provincia francese, un libro dove le forme dialettali si fondono assolutamente nella lingua comune e vestono e rivestono l'idea in modo così organico che la forma non può scindersi dal concetto. Che ne è avvenuto? L'opera del Verga nella veste straniera è apparsa scialba, stinta.
I lavori del D'Annunzio nella traduzione del d'Herelle si sono trovati come a casa loro; il traduttore non ha dovuto penare molto; gli è bastato togliere in prestito a questo o a quello scrittore francese decadente certe forme in voga tra i seguaci della letteratura cosmopolita (or ora mi scappava dalla penna: della massoneria letteraria cosmopolita) e il colpo è riuscito.
Dico questo senza nessuna maligna allusione a recenti polemiche, senza voler discutere o menomare il valore del nostro fortunato romanziere: e posso affermarlo con faccia franca, perchè intorno ai lavori del D'Annunzio io ho scritto quasi un volume; e se ho fatto degli appunti, ho ammirato anche senza mezzi termini, pur sapendo e accennando, tra i primi, i plagi, o assimilazioni ecclettiche che si vogliano chiamare, insomma quelle cose dalle quali sarebbe stato bene che il D'Annunzio non si fosse lasciato allettare.
Il problema dello stile e della lingua va proposto come l'ha proposto il Verga. Lasciamo stare se egli lo abbia o no praticamente risoluto; potremo ragionarne un'altra volta. Se pare che l'abbia risoluto il D'Annunzio (e l'Ojetti non ne dubita punto) la ragione di questa illusione bisogna cercarla altrove, nel concetto. Il Verga crea delle creature vive, di sangue, carne e ossa; il D'Annunzio, finora almeno, ha creato quasi sempre fantasmi di creature, ombre vane. Un nuovo Dante che volesse abbracciarle, sentirebbe cingersi il petto dalle proprie braccia passate a traverso quei corpi inconsistenti.
Ed ho detto:—Quasi sempre—perchè nel Trionfo della morte per esempio, c'è un punto, a metà del volume, in cui il protagonista e la sua famiglia riescono persone vive, di sangue, carne e ossa; ma allora il D'Annunzio si vede costretto dal suo istinto di artista, a mutar tono; non sembra più lui, o per lo meno non rassomiglia più a quel tale D'Annunzio che la leggenda ha foggiato e che poi, di rimpallo, si è foggiato secondo la leggenda. Il primo è il D'Annunzio che fa sperare possibile e augurare assai prossimo un completo rinnovellamento dell'artista, appena gli sarà passata la cosmopolitíte acuta che ora lo ha invaso. L'altro D'Annunzio lasciamolo ai francesi o a chi lo vuole.
Tutto questo l'Ojetti lo sa meglio di me, ma non ha voluto tenerne conto. Ed era, se non sbaglio, il cardine della questione della letteratura italiana contemporanea. Egli però scriveva per una rivista francese, e preso il la, si è sentito forzare la voce. Ma, forse, con tutto quel la, non avrebbe stonato, senza l'altro pregiudizio della letteratura cosmopolita.