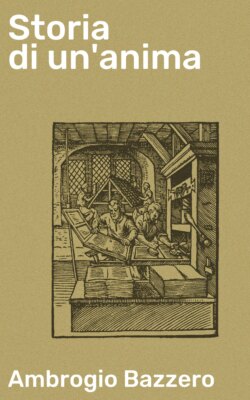Читать книгу Storia di un'anima - Ambrogio Bazzero - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AMBROGIO BAZZERO
ОглавлениеErano i tempi della nostra Vita Nuova.
Con questo titolo uscì nel 1876 a Milano un giornale letterario sostenuto in parte dai raminghi scrittori dell'antica Palestra letteraria e da altri nuovi venuti. Furono e l'uno e l'altro due bagliori, più che due fuochi, ma a quella vampa molti giovani si conobbero a tempo, molte volontà si sgranchirono, molti ingegni si accesero. Poi venne la vita vera per alcuni, l'oblìo per altri, la morte per i migliori.
Fu in quell'anno ch'io conobbi Ambrogio Bazzero, il primo dei nostri morti,
Non molto alto di persona, di capelli rari per grave malattia sofferta qualche anno prima; con bei baffi rossicci, di fattezze regolari, parlava con una voce chiara, ora argutamente, ora in tono di profonda tristezza. Mobile, nervoso, fuggevole, caro, fu il più attivo, il più ordinato, il più candido di quella babilonia che si diceva per burla Amministrazione della Vita Nuova.
Il Bazzero era nato il 15 ottobre 1851 a Milano, da una ricca famiglia. L'essere ricco non nocque a lui, come nuoce a molti che la troppa fortuna confonde e stanca, perchè il denaro non gl'impedì mai di studiare e di fare del gran bene alla povera gente.
Fin da fanciullo, dice un santo libricciuolo che mi fu dato di consultare, Ambrogio mostrò animo così pietoso, che non osava far male a una formica. D'inverno spargeva miglio e briciole di pane sul davanzale della finestra e godeva a vedere gli uccelli che venivano confidenti a mangiare. Era così semplice ne' suoi gusti che un fiore, un frutto, un bambino, un cagnolino rapivano subito la sua attenzione e bastavano a consolarlo e a rallegrarlo.
Questa semplicità di gusto egli conservò sempre, e passeggiando con lui, era curioso il vedere come egli sapesse rilevare il bello e il grottesco nelle cose più comuni, nel saltellare elastico d'un passerotto sull'erba, o nel subito atteggiarsi d'un gatto, o nei ghirigori d'un'inferriata, o nella frase volante d'un vetturale, o in un proverbio di contadini, dei quali sapeva ingegnosamente imitare la cadenza e i fiori del linguaggio.
Dopo il Liceo, in cui fu suo caro maestro Leopoldo Marenco, studiò legge privatamente, cosa di cui si lamentava sempre per non aver potuto apprendere nel libero consorzio universitario la scienza della vita e una maggiore sicurezza di sè stesso. E veramente in lui a trent'anni tremava ancora il fanciullo.
Il pensiero era libero e audace, ma la volontà paurosa. Di questo squilibrio di forze, fra l'occhio che vede e la mano che non osa, egli si querelava spesso con me durante il nostro viaggio di piacere a Firenze e a Venezia, e spesso ne piange anche in questo libro, che è la storia dell'anima sua. Più che i codici amava le sue armi antiche di cui aveva in casa una ricca collezione, i suoi elmi, le sue spade rugginose, le celate, gli stocchi, gli archibugi a ruota. Nè minore era il suo entusiasmo per ogni altra sorta d'anticaglia, mobili, stipi, poltrone, inferriate, tappeti, e non già per moda, come usarono poi molti dei nostri ricchi, ma per il sentimento che gli faceva credere d'abbracciare in quelle cose lo spirito di più generazioni. Alle anime generose è poca soltanto una vita.
Io me ne accorsi in quel nostro viaggio del 1876. Era la prima volta che si spiccava il volo dalla casa, e freschi entrambi di studi e di affetti, corremmo a contemplare le porte del paradiso, il campanile di Giotto, e poi San Marco e la laguna. Quali giorni nella mia vita e come sento che molta parte della vita di lui è rimasta come trasfusa in me! Quando entrando nella sala del Bargello a Firenze, vide una stupenda raccolta di fucili d'ogni tempo, egli gettò un grido di gioia e per poco non mi abbracciò, senza chiedermi pure se io avessi mai letta la sua monografia: Sopra gli archibugi a ruota ch'egli aveva pubblicato a vent'anni.
Nella sala della Morte a Firenze, volle provarsi la veste, il cappuccio e la buffa della compagnia. A Parma pagò il chierico perchè si lasciasse mettere in testa l'elmo e brandisse la spada di Alessandro Farnese, giù nella cripta al chiarore delle torcie. A Ferrara, entrando nella celletta di Sant'Anna, mi accorsi ch'egli tremava di commozione, e pallido lo vidi uscire dal carcere ove fu chiuso il povero amante di Parisina. E intanto preveniva nuove emozioni desiderando, sognando Venezia e i quadri del suo Tintoretto, sul quale aveva due anni prima scritto il suo prediletto dramma.
Non so dire se più dell'arte egli amasse la libera natura, Fin da fanciullo ebbe sotto gli occhi i malinconici dintorni del suo Limbiate e i grandi boschi di pino silvestre che coprono una vasta zona dell'alto Milanese, luoghi di caccia una volta e di sontuose villeggiature, oggi ingiustamente abbandonate. Per quei boschi, nati nell'ingrato solco della sodaglia, i sentieri si avviluppano in un inestricabile labirinto di selve, fra eserciti agglomerati di conifere, sottili, diritte, vicine, che quasi si toccano, che tolgono la luce del cielo o la lasciano solamente biancheggiare fra ciuffo e ciuffo pallidamente. E scendono e salgono le viottole in un mare di eriche e di felci. Stride la gazza, passa a volo, e va squassando le ali a posarsi sull'orlo d'un laghettone, in cui la piova del bosco si riversa in uno stagno viscido e giallastro che dorme nel silenzio verde della pineta. Tu vai e vai per miglia e per ore e non trovi che solchi, avvallamenti e nuovi eserciti di pini scaglionati su una vetta, talchè ora ti pare d'essere a un valico alpino, ora in un parco reale, ora in un deserto. Non una voce odi, non un fiato, se non è quello del vento che passa al disopra: o tutto a un tratto lo scoppio aspro d'un fucile e il frascare d'un cane. Vai ancora. Il bosco si schiarisce.
Al di là scorgi un non so che di bianco. È un cimitero abbandonato, sepolto nel verde, dove vorresti sdraiarti tutto supino, colle mani in croce, e chiudere gli occhi, e dormire, dormire nel seno molle della madre terra.
Fra questi boschi era solito errare il giovinetto colla mente accesa dai tanti romanzi storici che noi tutti in quegli anni abbiamo avidamente cercati. E il bosco a lui pareva d'un subito che si popolasse di cavalieri erranti, armati di ferro, di donzelle bionde e di tutti i più bei fantasmi che uscivano soltanto al tocco degli antichi liuti.
I boschi non soffrono d'anacronismo e a chi le chiama bene vengono incontro anche le vergini amadriadi.
Il romanticismo vinceva negli anni che corrispondono alla giovinezza d'Ambrogio Bazzero le sue ultime battaglie, accompagnando il frastuono delle battaglie vere per la patria. Tutti abbiamo avuto, qual più qual meno, qualche castello nel cuore e una spada di Toledo nel pugno. I più giovani, i più timidi erano i più leggieri alle immaginazioni. Il Bazzero, d'ingegno facile, senza le noiose distrazioni del bisogno, con un'anima semplice, con tanto medioevo appiccato alle pareti del suo studio, potè meglio di molti altri ricreare quel mondo morto intorno a sè. Nè lo ricreava per sola vaghezza d'antiquario, come si disse, ma perchè gli pareva che in quel mondo astratto i suoi sottili ideali respirassero meglio che nell'aria grossa della realtà pregna di cose. Da questo raccoglimento uscì il suo Buondelmonte, l'Angelica Montanini e l'Ugo, in cui la conoscenza dei tempi e dei costumi è così ricca e precisa e i rapporti così studiati nella lontananza dei tempi, che il lettore moderno, sorpreso dal gran numero delle evocazioni rimane confuso, e accusa d'oscurità e di confusione un'arte che ha il difetto di essere troppo minuziosamente precisa.
Ma chi ha tanta pazienza di rileggere e d'aspettare che l'impressione si snodi trova cento luoghi d'ammirare e finisce col sentire in sè la forza e l'anima dei tempi. Nell'Ugo specialmente, romanzo che stancò lo stesso autore, l'impressione finale è propriamente quella di sentirsi sotto il peso cupo del più cupo secolo della nostra storia, il decimo.
Chi più di tutti sentiva il fascino di queste risurrezioni era l'autore, quando si svegliava dalla sua meditazione con tutte le prove vive e parlanti intorno a sè dell'opera sua.—Chi può capire la potenza di certe mie pagine?—scriveva nel libro dell'Anima, in un sincero abbandono con sè stesso; non fa meraviglia, quindi, che al vedere gli amici suoi impassibili o indifferenti, il pubblico non curante, la critica scempia e ingiusta, provasse tanto dispetto da buttar via la penna, da chiudere i libri negli scaffali, da maledire le sue armi, le sue notti perdute. Erano i mesi dello sconforto: poi ritornava da capo, e avrebbe vinta la partita, son certo, se la morte non avesse voluto vincere prima di lui.
* * *
Di questi scritti che non fanno parte del presente volume, e che bene o male appartengono già al pubblico da molti anni, dirò soltanto quel che importa per la migliore conoscenza dello scrittore, augurando che la devozione di chi volle raccolti questi primi fogli consigli a tentare una nuova raccolta anche di quelli.
Lasciando stare qualche piccolo tentativo troppo giovanile e troppo acerbo, ch'egli pubblicò in privata edizione, mi pare che coll'Angelica Montanini tentasse veramente di scendere nel campo letterario(1).
L'azione di questo dramma ha luogo a Siena alla fine del secolo XIV, durante la guerra di Siena contro Firenze. Il dramma è dedicato a Leopoldo Marenco, che con una parola d'affetto aveva cambiato, come dice la dedica, in speranza il tormento ineffabile dell'arte. Molte sono le esuberanze e le inesperienze in questo lavoro, che è congegnato sopra un odio di parte e sopra una spada, e manca in molte parti quella chiara prospettiva dei caratteri e delle cose che è tanto necessaria sulle scene. Evidente è l'imitazione del Guerrazzi.
Al Guerrazzi, per le lettere sue all'autore, è dedicato il Tintoretto(2). La tela di questo dramma è più distesa, più ben dipinta e qua e là tocca ad una larghezza quasi di poema storico. Chi lo giudicasse soltanto dal punto di vista della teatralità potrebbe trovarlo anche una meschina cosa, ma noi sappiamo da un pezzo che teatralità è parola volgare, buona per un successo, e che quasi sempre finisce là dove l'arte comincia, mentre non c'è parola nei drammi de Bazzero, che non sia collocata senza una sicura convinzione artistica. Quei grandi artisti del cinquecento, voglio dire il Vecellio, il Sansovino, lo Schiavone, il Tintoretto e quel grande ludibrio che fu messer Pietro Aretino, si muovono in una scena sfarzosa, piena di colori, e parlano un linguaggio che arieggia il classico del Vasari e del Cellini. Nel Tintoretto ha voluto il Bazzero rappresentare gli sforzi d'un uomo alla conquista delle due più grandi gioie della vita, l'arte e la famiglia, contro tutte le minaccie della fortuna e della volgarità. Al Tintoretto vien sciupato il nome dall'Aretino, e tolta la figliuola diletta dalla peste. Eccone le ultime scene:
Infierisce la peste in Venezia. Due commessari di sanità vestiti in nero e sdrusciti, salgono dal mare al terrazzo ov'è la casa del Tintoretto:
PRIMO (salendo, grida al basso). Ohe, maledetta ciurma, legate la gondola chè l'onda non la rovesci.
SECONDO. È tanto piena! Pescare i morti non s'è mai dato.
PRIMO. Pesca i vivi, pesca i morti, è tutt'una; quello che non si è mai dato in dieci notti che faccio questo mestiere da corvo, si è pescare qualche borsuccia d'oro.
SECONDO. Senza il fiasco e la gonnella fanno pietà anche i morti.
PRIMO. Orsù, ci hanno chiamato con tanta furia (ridendo). Date qua….. (si avvia alla porta del Tintoretto, e vi dà un calcio). Messeri e madonne! (apre ed entra cantacchiando).