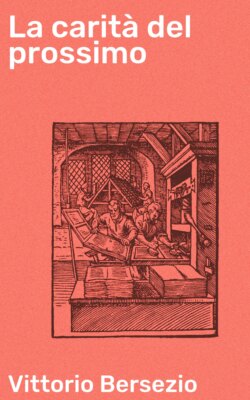Читать книгу La carità del prossimo - Bersezio Vittorio - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I.
ОглавлениеIndice
Siamo in una stanzaccia ampia, alta, nuda, illuminata da un lucernario di vetro a mezzo il soffitto, colle pareti grigiastre tappezzate di quadri abbozzati, di braccia e di gambe di gesso, di pipe e di ragnateli: in una parola, lo studio e l'abitazione di un pittore. Non occorre dire che ci troviamo sotto le tegole del tetto, al di sopra di quattro piani d'una gran casona, alveare umano che alberga una quantità di famiglie.
Questo studio è anche la dimora del pittore—che sto per presentarvi—e della sua famiglia; poichè il nostro eroe, per dirvela ad un tratto, possiede un gran buon cuore, buon umore da venderne, poco coraggio, non troppo ingegno, povere fortune, una moglie borbottona e quattro bimbi.
I misteri famigliari sono nascosti agli occhi dei profani che penetrano nello studio, da un lungo paravento, di dietro il quale suonano quasi senza intermittenza grida e pianti di bambini, rampogne ed impazienti esclamazioni della madre, e fanno di quando in quando irrefrenabile sortita i tre più grandicelli ragazzi a cavallo del bastone del papà, dell'ombrello della mamma e dell'appoggiamano per dipingere.
Al momento in cui vi prego di penetrar meco nello stanzone del pittore, le fortune di Antonio Vanardi—questo è il nome dell'artista—sono più povere che mai. È pieno di debiti; da ogni parte da cui si volga corre rischio di vedere la faccia corrucciata di un creditore che non può pagare; e più corrucciato e più inesorabile di tutti fra questi creditori lì il padrone di casa, a cui Vanardi deve due semestri d'affitto, e non sa dove battere la testa per avere di che pagarlo.
Questo padrone di casa—come tutti quelli delle commedie, dei drammi e dei romanzi—è un uomo che non conosce guari dove stia di casa la pietà, e non capisce che un'attinenza verso i suoi locatari: riceverne danaro per la pigione a tempo debito e scrivere loro una buona quietanza colla sua buona firma sotto, nella sua scrittura commerciale che finisce sempre l'ultima lettera con un ghirigoro pieno di eleganza: Fiorenzo Marone.
Benchè egli abbia questo nome illustre, non lo crediate già discendente dal celebre poeta mantovano. Di Virgilio il brav'uomo non aveva inteso mai nemmeno a parlare, ed i versi non sapeva che razza di bestie si fossero.
To', poichè il signor Marone mi è capitato qui sotto il becco della penna, ci stia un poco; ed abbiate pazienza, cari lettori, mentr'io mi indugio un tantino a schizzarvene il ritratto alla sfuggita.
È un uomo oltre i sessanta, grande, grosso, a faccia di villano e maniere uguali, a spalle larghe, naso lungo, occhi di gatto, denti di rosicchiante, mento quadrato, mani grosse, piedi da lacchè, sorriso falso, fronte stretta e coscienza Dio sa come. Vuole dare alla sua fisonomia un aspetto d'umiltà e di bonarietà che stona maledettamente colla grossezza delle sue forme; mette la sordina alla sua voce da boattiere, e non guarda mai negli occhi la persona a cui parla.
La sua storia è contata in quattro parole. È figliuolo d'un villano che nei primi anni del secolo veniva in Torino i giorni di mercato, spingendosi innanzi un asinello, a vendere formaggioli sulla piazza delle erbe, che ora è piazza del Palazzo di Città. Fiorenzo, sbarazzino di due lustri incirca, l'accompagnava trottando coi piè nudi, una bacchetta in mano, dando il cis-va-là e le botte al somarello restio. Più tardi successe egli, fatto giovinotto, nel commercio paterno. Seppe governare così bene e rammontare colla parsimonia, che era un'avarizia, soldo sopra soldo, che un bel dì si trovò a capo d'un certo capitale, colla buona voglia di moltiplicarlo il più possibile e coll'accortezza necessaria per riuscire in questa operazione aritmetica, per cui si sentiva una vera vocazione datagli dalla natura.
Su quella medesima piazza che lo aveva visto compagno all'asinello paterno, Fiorenzo apriva una bottega da spacciarvi formaggi, ed andatagli prospera la fortuna accresceva in poco tempo il suo fondaco e i suoi guadagni; finchè, sopraggiunta la guerra del quarantotto, egli pigliava l'impresa di provvedere di formaggi l'esercito piemontese, ed ingrassava così bene di quello che non mangiarono i nostri soldati, che rimetteva ad altri la bottega, comprava case, tenute, e cartelle del debito pubblico, e si ritirava a viverla in panciolle, ricco di più dozzine di mila lire di rendita.
Egli è solo, celibe, senza parenti. Fa il pinzocchero; non dà mai un soldo ad un povero, ma regala alla parrocchia di quando in quando od una lampada d'argento indorato, od una corona per la Madonna con gemme false, e nei giorni solenni, per esempio la settimana santa, si mette sulla porta della chiesa colla tasca in mano a gridare a chi va e viene: pel santo sepolcro! È avaro come una tigna, senza cuore, e non ama che il denaro: nessuno lo stima, meno ancora gli si vuol bene; e tutti gli fanno tanto di cappello.
Ebbene gli era a codestui che il povero Vanardi doveva duecento cinquanta lire di pigione. E meno male fosse stato quello il solo suo debito! Ma il pizzicagnolo della cantonata non voleva più vendergli nè lardo nè burro, nè niente del tutto, se non gli pagava le sessanta lire di cui andava in credito; ma il panattiere gli rompeva la testa per averne finalmente i due napoleoni d'oro (in quel tempo v'erano ancora i napoleoni) che gli si dovevano; ma il venditore di legna e carbone aveva protestato che se entro una settimana non lo si soddisfacesse dei 14 franchi ed 80 centesimi ch'egli domandava pei combustibili somministrati, sarebbe andato senz'altro dal giudice. E lascio stare il macellaio, il venditore di vino al minuto e tutti gli altri creditori, che se volessi annoverarli un per uno farei una rassegna lunga e noiosa, come quella degli eroi combattenti in un'epopea che si rispetta.
Il misero Antonio passava mogio mogio nella strada che abitava, la testa bassa e il cuore piccino piccino, e non osava guardare che di sottecchi nelle botteghe che si aprivano in quel quartiere. Da ciascuno di quegli usci a cristalli potea sbucar fuori una faccia ostile ed una voce minacciosa a domandargli del danaro.
Era solamente innanzi allo speziale, la cui bottega s'apriva proprio d'accanto all'uscio da via della casa di Marone, che Vanardi osava levare il capo e passar fiero. Di quel benedetto farmacopola egli non era debitore; anzi!…
Ai due stipiti della bottega farmaceutica stavano appiccate due tavole, in cui meditavano con faccia severa e barba grigia due uomini dipinti in vesta lunga, un grosso libraccio in mano. Erano le opere del nostro artista che da pochi dì facevano bella mostra di sè a que' pochi raggi di sole che fra i comignoli delle case trovavan modo di filtrare sino al fondo della stradicciuola: opera che lo speziale non solo non aveva ancora pagato, ma non aveva accennato nemmeno la buona intenzione di pagare.
Anche codesto signor speziale era da novella e da commedia; voglio dire che tutti s'accordavano, ed avevan ragione, in dirlo il maggior ciarlone e la peggior lingua del quartiere, come ogni speziale sulla scena o in un racconto ha lo stretto obbligo di essere.
Per poco fosse buona la stagione e tollerabile il tempo, egli si piantava sul passo della sua porta, le gambe larghe, le mani nelle tasche de' calzoni, il suo naso lungo ed acuminato all'aria, in capo il suo berretto di panno nero unto e bisunto con lunga visiera innanzi agli occhi, e arrestava al passaggio tutti quelli che conosceva—ed egli conosceva tutta la città—per offrire a ciascuno una presa di tabacco e smaltirgli la sua buona dose di chiaccole e di maldicenza.
Chiaccherava coi garzoni, chiaccherava cogli avventori, chiaccherava coi vicini, chiaccherava coi passeggieri, chiaccherava colla sua nipote (una poveretta di ragazza povera e brutta, ma buona come il pan buffetto, cui sotto pretesto d'usarle carità, egli aveva presa seco a soffrire i mali di lui tratti ed a fargli da serva senza paga), chiaccherava colla portinara (figuratevi!), chiaccherava perfino colla gatta, chiaccherava sempre da mattina a sera; sapeva i fatti di tutti i casigliani, di tutti gli abitanti di quella strada, di tutta la cittadinanza; contava non senza vivacità l'aneddoto, correva dietro a stupidi giuochi di parole che egli credeva prova d'ingegno, scoccava con qualche malizia l'epigramma, era noioso come la piova, aveva un tesoro inesauribile di curiosità e diceva male di tutto e di tutti.
A Vanardi ed a sua moglie toccava passare sovente innanzi alla farmacia. Messer Agapito (è nome classico di speziale) aveva incominciato per salutare la moglie e poi anche il marito, accompagnando però il primo saluto d'un sorriso particolare: poi aveva fermato la donna per chiederle novella del marito, l'uomo per domandargli le nuove della moglie, e se erano tutte due insieme, per informarsi della salute dei bimbi.
In quel tempo la moglie del pittore portava nel suo seno il quarto frutto dell'amore coniugale, e il farmacista mostrava sentire il più vivo interessamento per quello stato interessante della giovine donna.
Appena vedeva spuntare Antonio, cessava di rimestare colle sue dita lunghe e sporche nella sua tabacchiera di corno fuso—movimento che gli era abituale—e gli gridava fra ilare o domesticamente amichevole:
—Ebbene, caro signor Vanardi? E madama come va?
Qualunque cosa gli venisse risposta, era per lui un'occasione ad una ciarlatina d'un quarto d'ora. Madama tale in un simile stato, aveva sofferto questo, aveva sentito quello; egli l'aveva consigliata di far così, e poi così, ed erano stati meravigliosi i buoni effetti che la ne aveva provati. Madama tal'altra doveva a lui la sua salvezza; e madama quest'altra poi? Gli è vero che la poteva dirsi una smorfiosa, che la più sazievole non s'era mai vista: ed il marito era un imbecille, a cui la si dava a bevere come a nissuno al mondo; e riparava in quella casa un certo signorino coi pizzi all'inglese, e poi anche un uffizialetto coi baffetti all'insù, i quali non era senza un perchè se stringevano tanto forte la mano di quel gaglioffo di marito, eccetera, eccetera. E passava senza arrestarsi da una famiglia all'altra, da un pettegolezzo ad un maggiore, da una maldicenza ad una calunnia, con una volubilità di parola, con una facilità di discorso, con una malizia di sogghigni e di ammiccamenti, con una varietà di espressioni, con una certa bonarietà maligna che ti facevano restare sbalordito.
—Buono! diceva il nostro pittore ad ogni volta; meglio aver da fare colla prima fra le vecchie pettegole che con codesto gaio manipolatore di purganti.
E faceva di tutto a tagliar corto i discorsi e tirar via pel suo cammino.
—È molto superbo quell'imbrattatele da dozzina, diceva lo speziale a' garzoni, ai vicini, alle serve del quartiere; che cosa si crede di essere?
Un dì finalmente, messer Agapito, d'in sull'uscio della bottega, vede precipitarsi fuor di casa il pittore tutto sollecito e conturbato.
—Che c'è? gli grida dietro, lasciando cadere a terra la sua presa di tabacco, nell'eccesso della curiosità.
Vanardi agita le braccia in una risposta di mimica concitata, e seguita la sua corsa!
—Che? rigrida lo speziale, scendendo giù dallo scalino della bottega nella strada; sua moglie forse?…
Antonio fa dei cenni affermativi per isbarazzarsene, e continua il suo cammino.
—-Ah! siamo dunque al buono, eh? ripiglia messer Agapito. Non tema di nulla; vado su io. Son pratico meglio di qualunque cerusico. Lasci fare a me.
Vanardi non gli ha più badato ed è sparito: lo speziale rientra in bottega.
—La moglie del pittore qui su fu sovrappresa dai dolori: dice egli ai due garzoni che sbadigliano ai barattoli delle scansie. Datemi qui dei sali, una boccettina di cordiale, e vo in suo soccorso. Quel marito è una bestiaccia che non sa di niente. Corre in cerca chi sa di qual medico ciarlatano, o di che donnaccia ignorante che gli accopperebbero senza fallo la moglie e il bambino… Una donnina abbastanza graziosa quella signora Rosa… Non sono mai entrato nel loro quartiere. Vo' vedere come ci è alloggiato questo superbioso che mi fa grazia a colloquir meco.
Ci va diffatti, trova la donna dietro il paravento che ha pensato di sbarazzarsi d'un bel maschiotto senza aspettare aiuto di comare: e quando il marito poco dopo torna con una levatrice, ecco lo speziale che gli presenta in aria di trionfo il quarto figliuolo neonato.
Come trovar modo di mettere alla porta un uomo dopo simil fatto? Lo speziale si fece di casa come la granata: ci andava a pigliar novelle della puerpera due volte al giorno; paragonava il neonato ad un angelo, ad un amorino, pigiava le gote fra le dita agli altri tre bambini, e snocciolava fuori gli affari di tutti i casigliani.
La moglie del pittore, a metterla fra le bracone (per dirla alla toscana) non le si faceva gran torto: epperò ebbe a dilettarsi non poco delle visite e delle ciarle del signor Agapito.
Antonio, se avesse osato andar contro ai borbottamenti della sua donna, se non avesse temuto d'essere soverchiamente incivile verso il farmacista, avrebbe volentieri preso costui per le spalle e messolo fuori dell'uscio con una viva raccomandazione a non più tornarci, tanto e' gli dava sui nervi; ma il buon uomo non era e non sarebbe stato mai capace di tanta risoluzione e di tanto coraggio.
Era trascorso quasi un anno, quando una bella volta il signor Agapito fermò il pittore che passava, e gli disse con un piglio affatto nuovo, tutto piacenteria:
—Mio caro signor Vanardi, vorrei parlarle d'una cosa.
—Parli pure.
Lo speziale annasò una presa e ne offerse ad Antonio che, come sempre, fece un cenno di no, tirando in là la tabacchiera e la mano di Agapito.
—Ah, ah! Ella rifiuta, perchè non ne fiuta: disse questi grattandosi il naso lungo e sottile e ridendo grossamente. Oh, oh! il bisticcio non è cattivo. Lo dirò al suo amico il signor Selva, che passa per uomo di talento, perchè fa dei versi e scrive delle sciocchezze su pei giornali.
—Che cosa è che la mi vuol dire, signor Agapito? ridomandò Vanardi impaziente.
—Ecco qui.
Additò le due tavole di legno screpolate che ornavano i battitoi della sua bottega: sovra esse erano a mezzo cancellati due gran vasi dipinti con avvolti intorno due serpenti verdescuri.
—Ecco: queste mostre di bottega sono già un po' scadenti. Le serpi hanno perso le squame e somigliano anguille: e i vasi, altro che di marmo, paiono di gesso sporco. La mi dovrebbe, lei che ha un sì valente e facile pennello, rimpiastrarmi costassù qualche bella dipintura a suo modo, che sarebbe per me proprio quel che ci vuole. Oggidì, la vede, anche le spezierie si mettono in isfarzo e sembrano salotti da coiffeurs di Parigi: le medicine fanno competenza ai sorbetti in punto a specchi ed ornamenti delle botteghe in cui si spacciano. Lo speziale X ha addobbato il suo fondaco che pare una sala da ballo: è vero che se ne ricatta vendendo susine per tamarindi, corteccia di salice per china, ed ogni fatta porcherie per droghe… Ah, mio caro signor Antonio, non è spacciando roba buona e governandosi onestamente, come noi si fa, che si diventa ricchi di quella guisa. Il signor X ha più di ventimila lire all'anno, sa! Eh! ce ne vuole della cassia a metterle insieme! Ma quel birbo là è sempre stato un ladro, ed è perciò che ha sempre avuto fortuna. Mi ricordo che quando ha cominciato…
Vanardi a cui stava troppo a cuore un'ordinazione di lavoro, l'interruppe, ma sforzandosi a sorridere il più amichevolmente che potesse.
—Ella dunque, signor Agapito, vorrebbe ch'io dipingessi a nuovo queste mostre?
—Appunto. La vede: il legno è buono…. qualche tarlatura, ma con un po' di mastice, gli è nulla. Senta come suona!—E vi picchiava su colla nocca delle dita.—Una lisciatina di che so io, una figura, due fregi, una mano di vernice ed avranno un rispicco da farne stare ammirato chi passa.
—Bene. Lei ha detto una figura, vorrebbe dunque surrogare questi vasi?…
—Oh quanto a ciò faccia lei. Ho detto una figura così per dire…. Ma non ho voluto dire nè una figura rettorica nè un'algebrica…. oh, oh, oh! Ha afferrato il bisticcio? Non è cattivo…. Dunque, ci metta ciò che vuole, purchè sia qualche cosa d'acconcio…. Per esempio se fossero i due ritratti d'Ippocrate e di Galeno… C'è qualche farmacia che li ha… Due personaggi da capo a piedi con aria severa, una gran barba, un manto, andrebbe addirittura a meraviglia. Ma non la voglio mica legare…. L'ispirazione… Oh so anch'io cos'è l'ispirazione… Dunque la lascio affatto libero. Le manderò su di quest'oggi pel garzone al suo studio le due tavole. Non c'è nulla che prema… affatto nulla: ma se non avesse più pressanti lavori… quanto prima si può sfoggiarla e meglio è… insomma, se me le desse per la fine dalla settimana entrante, mi sarebbe molto a grado.
Vanardi in quel tempo, e già da troppo ciò gli avveniva, non aveva precisamente nulla da fare. Il bisogno di denaro cresceva in ragione inversa alla mancanza del lavoro; e questa che gli parve una bella e buona proposta dello speziale gli tornò come una benedizione della fortuna. Non istette a discorrerla davantaggio, e promise che pel tempo accennatogli i due eroi della medicina, dalle loro tavole di legno, inviterebbero i passeggeri a purgarsi colle droghe di messer Agapito.
Bene ebbe in pensiero di domandare fino dapprima un prezzo, ma secondo il solito glie ne venne meno il coraggio, e si quietò nel pensiero che per quanto poco volesse lo speziale pagarlo, n'avrebbe sempre avuto tuttavia da comprar pane per un poco di giorni alla sua famiglia.
Ci si mise intorno a tutt'uomo, impiegò in questo lavoro tutti i colori che gli rimanevano ancora e tutto il suo talento; fece due faccie storte che lucicchiavano meravigliosamente collo splendore della loro fresca vernice.
Messer Agapito lodò molto l'artista, ma non parlò di pagare. Antonio aveva sempre sulle labbra la parola per dimandargliene il prezzo, ma non la osava pronunciar mai: i debiti crescevano, i bimbi strillavano da mane a sera e la moglie borbottava senza soluzione di continuità.
Voi direte:—Questo tuo protagonista è uno scioccone che si merita la sua sorte. Perchè si è ammogliato, se non aveva fortune da mantenere la sua famiglia, se non aveva talenti da guadagnarsene il sostentamento? Perchè fare il pittore se non era buono che a scombiccherar faccie storte? Perchè ha dato la vita a quattro creature, le quali non avrebbero sofferto di miseria quand'egli non le avesse fatte venire al mondo? Perchè sopratutto ha sposato una moglie borbottona?
Egli, se vi udisse, potrebbe rispondervi:
—La mia Rosina era più mite d'un agnello quando me la sono sposata. Le volevo bene; era sola, onesta o belloccia, e perchè la era povera, avevo io da sedurla ed abbandonarla? Sono un onest'uomo, corpo di Bacco! Allora io, oltre la tanta buona volontà di lavorare, aveva le illusioni della prima giovinezza, che mi dipingevano in tinte ridenti l'avvenire; aveva la lusinga d'essere o di poter diventare un buon pittore e la speranza di poter guadagnare col mio pennello tanto quanto colla punta dei piedi un maestro di ballo. Che colpa ne ho io se le mie illusioni ebbero il torto marcio; se il lavoro non venne; se mio zio il droghiere non volle mai più perdonarmi; se mia moglie si ostinò a volermi far padre quattro volte; e se per soprammercato le sciagure la fecero dispettosa e peggio?…
Ma qui sarà meglio che, senz'aspettar altro, io entri a darvi maggiori e più intime informazioni di questo povero diavolo.
Attenti bene!