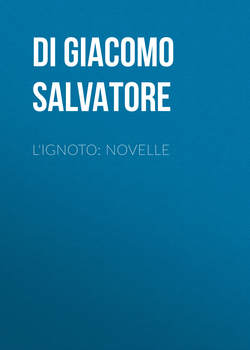Читать книгу L'ignoto: Novelle - Di Giacomo Salvatore - Страница 8
PESCI FUOR D’ACQUA
I
Оглавление– Son deciso, ecco! – ripetette seduto di faccia a me alla medesima tavola, il mio compagno d’ufficio de Laurenzi – Ormai son deciso a resistere! E staremo a vedere! L’ufficio? I doveri dell’ufficio? L’orario? Ma l’ufficio non conta nulla, mio caro, a fronte di tutta una vita, di tutti i ricordi che v’inchiodano al posto ov’è stato il padre. Il padre, capisci? E io dunque dovrei rinunziare alla scrivania di mio padre, alla stanza dov’è stato mio padre, all’aria che ha respirato mio padre! Ah, sì per esempio! Ma voglio vederlo, perdio!
S’interruppe. Il cameriere, uno de’ più anziani di quella ignobile gargotte ove s’andava a far colazione tra preti, avvocati, studenti e cantanti del teatro vicino, ora gli poneva davanti un piatto di baccalà alla livornese fumigante in una brodaglia rossastra. Gli occhi miopi del de Laurenzi s’appressarono al piatto e vi si sprofondarono e lo interrogarono avidamente: tra quel vapore succulento le nari di un lungo naso floscio palpitarono e si dilatarono.
– Alla livornese, professore – disse il cameriere – Poi me ne parlerà. E appresso ha ordinato?
– Un formaggio e un finocchio.
– Il vino solito?
– Solito.
Si mise a mangiare, voracemente. E io, che avevo terminato il mio modesto asciolvere, sorseggiando un caffè e fumando mezzo toscano mi misi a guardarlo come se lo vedessi per la prima volta.
Alto, magro, con le spalle incurvate, con una gran barba grigiastra e incolta pel cui pelo intricato or si disseminavano le briciole del pane e le gocce del brodo untuoso, con orribili mani dalle dita nodose e lunghe che parevano artigli, mal vestito, tutto chiuso in un vecchio cappotto stinto e rattoppato il cui bavero che un tempo era stato ornato di pelo marrone or ne serbava solo quattro o cinque ignobili ciuffetti, il mio compagno di ufficio de Laurenzi, un uomo sui sessanta anni suonati, incarnava pittorescamente la pietosa straccioneria del travettismo. Ammogliato, carico di figliuoli e di piccoli debiti pe’ quali il suo stipendio era strappato a brani e giorno per giorno alla cassa dell’economo, egli era un di quelli sciagurati il cui contatto uggioso ve ne sollecita quasi a non indulgere alle volgari abitudini e a’ miserabili vizii, ma ch’io m’inducevo a creder degno, il più delle volte, della più malinconica commiserazione.
Era stato – raccontava – giornalista di grido, nell’Alta Italia, a’ suoi be’ tempi: lo era ancora qui, adesso, in una gazzetta quotidiana che stentava parecchio la vita e nelle cui trascurate colonne il de Laurenzi poneva, di volta in volta, certe sue rievocative narrazioni partenopee scialbe e sciatte, disseminate di ampollosi rimpianti e miserabilmente intessute sulle cronache de’ giornali del tempo, in cui frugava tutta la santa giornata.
Nella biblioteca governativa, ov’ero anch’io, il de Laurenzi era entrato quando essa aveva a capo un prelato di cui bastava soltanto soddisfare l’olimpica vanità per guadagnare, se non la stima, la indifferente acquiescenza. Morto costui la biblioteca non aveva più potuto offerire alle gratuite libertà che l’ex giornalista vi s’era conquistate un comodo asilo remuneratore. Ora bisognava lavorare e frequentare l’ufficio. Il nuovo bibliotecario era severissimo: guardava nel registro d’ingresso degl’impiegati, segnava le ore e i minuti a’ tardi arrivati, mandava in giro, di volta in volta, ordini del giorno in cui si raccomandavano lo zelo, l’ossequenza all’orario, la diligenza ne’ compiti, e pretendeva che tutti firmassero quelli ukase in segno di rispettosa adesione.
Una schiavitù, sissignori: una soppressione spietata, implacabile, dell’ingegno e della personalità, una scettica considerazione dell’io pensante e creante, degli altrui nervi, dell’altrui cultura quando non fosse quella delle scienze naturali e delle matematiche, nelle quali quel nuovo direttore era spaventosamente agguerrito.
Ah, sì: portate in questi polverosi e silenziosi antri, foderati della storia cartacea del pensiero umano, portatevi, se vi riesce, la giovialità, l’arditezza, il libero arbitrio, la poesia, l’indipendenza: portatevi il vostro talento, la vostra modernità, le vostre abitudini sincere e svegliate, se vi vorrete vedere a mano a mano sfiorire tutta codesta ancor viva giovinezza dell’animo vostro! Mio Dio, che aridità e che tristezza tra queste mute pareti, gravi d’in folio e d’enciclopedie: tra queste mura sorde a ogni voce impulsiva e pur così impregnate de’ pettegolezzi, delle invidie e delle guerricciuole che costituiscono il tessuto connettivo della vita degl’impiegati, il continuo esercizio della loro parola aspra e mordace, l’alimentazione quotidiana dell’ozio e dell’ignoranza del loro pensiero!
Che diamine, dunque, pretendeva di non volere lasciare qui, come un brano del suo cuore dolente, il mio compagno de Laurenzi? E di dove gli veniva tutto questo attaccamento atavo-topografico, espresso con tanto impeto melodrammatico? Io non sapevo, in verità, figurarmi e ammettere tra il baccalà alla livornese e l’evocazione paterna alcuna tollerabile analogia. Quest’uomo dunque componeva con tanta assoluta ignoranza della loro espressione dissimile le sensazioni della psiche e la più brutale delle soddisfazioni fisiologiche?
– Comprenderai – disse lui, quasi come per rispondere al mio pensiero, e dopo aver vuotato il suo terzo bicchiere di vino bianco siciliano – comprenderai ch’io mi trovo nelle biblioteche non per le mie aspirazioni, non per elezione mia. Ti pare? Un impiego governativo! Cioè una sgobbatura! Una servitù! Ma, poi che là dentro mio padre, ch’era uno studioso, è stato impiegato anche lui e ha vissuto metà della sua vita io vi ho voluto iniziare come una tradizione metodica ed esemplare nella storia di queste successioni familiari. Usciamo?
– Usciamo. Bada ch’è ora di tornare lassù.
De Laurenzi afferrò un tovagliolo e si forbì le labbra, in fretta, e poi lo buttò sulla tavola tutto insudiciato, come uno straccio. Si levò: cacciò la mano nella profondità d’una delle saccocce del suo cappotto, vi pescò e ripescò per buon tratto, e infine cavò fuori quell’artiglio armato d’un mozzicone di sigaro.
– Andiamo – mi fece, dopo avere acceso il mozzicone.
Sulla soglia della trattoria s’arrestò, per ricominciare il discorso.
– E così eccomi in guerra aperta col signor direttore. Si capisce: io sono uno straordinario, pel momento: io sono entrato nel sancta sanctorum senza i titoli che ci vogliono. Titoli? E il mio ingegno, il mio passato? Questi signori non vedono che bibliografia, schedatura, inventarii. E guai a chi è qualcuno o qualcosa! E poi sotterfugi, rapporti segreti, denunzie: ecco la loro maniera di battagliare. Ora, come l’hanno insegnato anche a me, loro mandano ufficii – e io mi dò per malato e vado a Roma.
Si scappellò, con un saluto profondo.
Colui ch’egli aveva salutato gli fece pur di cappello e passò via, in mezzo a quattro o cinque altri che lo accompagnavano e con cui discuteva calorosamente.
– Lupus in fabula– disse de Laurenzi – L’onorevole Maliberti. Non lo conosci?
– No.
– Vuoi che ti presenti, un’altra volta?
– Ma no!..
– Fai male. Una potenza, sai. È lui che m’ha presentato al ministro. Ed è così che sono a posto, adesso.
Riaccese il suo mozzicone di sigaro, che s’era spento. E soggiunse:
– Vedrai, mio caro. S’è battagliato, a Roma, giorni addietro. Ma l’ho spuntata, questa volta. Francamente, se io fossi te, cercherei di conoscere l’onorevole. Non sei elettore, tu? No? Come, non sei elettore, non ti sei fatto inscrivere?..
Affrettavo il passo. Egli s’accorse della poca attenzione onde accoglievo le sue parole e s’arrestò, a un tratto.
– Tu dunque rientri in ufficio?
– E tu non ci vieni?
– Io no. Vado al giornale. Ho un articolo da correggere in bozze di stampa. E mi preme più quello, naturalmente.
Feci l’atto di rincamminarmi.
– Se domandano di me…
– Ho capito…
– Ecco… Si potrebbe inventare una frottola. Un figlio malato, per esempio. L’influenza. Si può dire che mi sono venuti a chiamare da casa mia, d’urgenza. Una malattia a tua scelta. E poi mi telefoni al giornale. D’accordo?
– Sì – mormorai – d’accordo.
Egli s’era già allontanato, a gran passi, trascinando pel fango di via Costantinopoli le sue scarpacce inzaccherate sulle quali sbattevano, molli e intrise di mota, le bocche larghe e logore de’ suoi pantaloni.
Ora passava un carro funebre, di quelli che fanno continuamente la via di Foria e s’avviano al cimitero. Il de Laurenzi, curvo, con la mano alla falda del cappello, scivolò accanto all’enorme e nero carrozzone dalla cui cimasa dorata pareva che volessero spiccare il volo, ad ali spiegate, quattro polisarcici angioli di legno. La via, su quel transito, s’era fatta silenziosa, a un tratto. E a me parve che tanto da quel lento carro come da quell’uomo pur funebre si sprigionasse in quel punto una medesima espressione mortuaria il cui senso mi durò dentro per qualche secondo. Poi tutto si tolse dalla mia vista. Ma sopra di me e sull’animo mio, mentre m’avviavo alla porta del mio ufficio, pesava ancora, come l’ultimo segno di tanta malinconia, un cielo invernale plumbeo e greve. L’aria mi pareva satura d’una umidità uggiosa, e associata a tutta quella tristezza, a tutta quella miseria.
– Spero che non mi chieggano di costui! – m’auguravo, salendo le scale della biblioteca.
Come mi seccava di dover mentire, se mai! Una collera sorda, commista d’insofferenza e di sprezzo, mi sommoveva contro quest’uomo che intendeva piegarmi a una ripugnante complicità. Lui tenero dell’ufficio, della stanza paterna, della vita di quel luogo severo e nobile – lui, così svogliato, così cinico, così pronto a barattare la sua dignità e il suo amor proprio con una menzogna da scolare?
Un uomo di quasi sessant’anni!