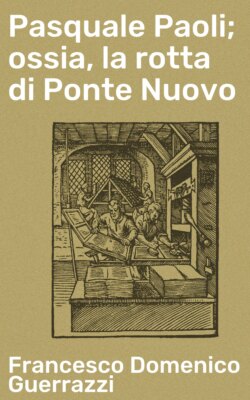Читать книгу Pasquale Paoli; ossia, la rotta di Ponte Nuovo - Francesco Domenico Guerrazzi - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAlfonso ordinò l'assalto,..... ma rimasero ributtati valorosamente. (pag. 76)
— La Corsica adesso è capitata nelle branche a san Giorgio, voglio dire della Banca di S. Giorgio. Questa compagnia è un banco che ha leggi e governatori a parte, prestava e presta al governo, il quale gli commise in appalto bestie, cristiani, gabelle, rendite, città, castelli e provincie quando il governo ne aveva: San Giorgio arrolò eserciti, allestì armate, sottomise paesi, dettò codici, istituì tribunali, fece giustizia; insomma fu ed è Stato dentro lo Stato: non manca gente che lo ammiri; gusti da donne gravide. Quanto a me lo giudico censura solennissima della repubblica ligure; imperciocchè badate a me, aut, aut: lo sperimentano buona cotesta amministrazione in preferenza del governo ordinario, e allora quella si tengano, questo mandino allo scorticatoio; o la faccenda va all'opposto, ed allora io non capisco come un reggimento bene ordinato patisca quel calcio in gola. Sopratutto io poi lo considero prova manifesta ed incentivo ad un punto del disamore che i Genovesi hanno per la patria. Per lui si chiarisce come una parte di Genovesi, messi in salvo gli averi, si dieno senza pietà a ruinare la patria: per lui l'altra parte, sicura di non perdere i danari, lascia nabissare ogni cosa; mentre se, sprofondata la patria, vedessero andarle dietro le fortune private, se non per benevolenza, almanco per avarizia i Genovesi si rimarrebbero da mal fare. Il Banco, solito a volere i negozi spicci, conobbe che il nodo stava nello abbattere con gli aiuti della Terra del Comune i baroni pomontani; nè riputò disperato lo assunto, conciossiachè, quantunque costoro fossero parecchi, pure, nel modo che gli universi fiumi della Corsica mettono foce nel Golo e nel Tavignano, si riunivano tutti sotto le due case della Rôcca e da Leca. Pel Banco di san Giorgio ogni partito buono, ma sopra gli altri gli piacquero il fuoco, il tradimento, il coltello. Antonio Calvo, governatore, fece una ghiacciata di ventiquattro baroni ad un tratto; gli altri fuggirono via atterriti riparando a Napoli. Beati loro se la volontà o gli anni li persuadevano a starsi in esiglio! E' vollero perfidiare nel cimento delle armi; e su le prime andò bene, chè Vincenzo da Leca, sorpreso Ambrogio Marabotto in quella che stava per entrare in Cinarca, lo tagliò a pezzi con tutti i suoi. Se non che Antonio Spinola, governatore, considerando come a mantenere viva la nuova guerra contribuivano massimamente gli aiuti che cotesti signori cavavano dal contado del Niolo divotissimo a loro, trovò partito più certo essere quello di sterminarlo e così fece: la desolazione e la morte percossero tutto il tratto di paese che giace tra Soana e Calvi: il passeggero che attraversa quel deserto, il quale nel suo silenzio maledice la straniera dominazione più che non potrebbero fare cento predicatori, sente venirsi addosso il ribrezzo della febbre. Ciò fatto, per mezzo di congiunti da bene, fa sapere ai da Leca che, ove si disponessero venire alla obbedienza, li perdonerebbe; chiesto di confermare la promessa con giuramento, giura. Fidasi Vincenzo, ma non si fida Giocante, che la scàpola, conservandosi a tempo men reo. Lo Spinola, avuti nelle mani Vincenzo, Mannone suo padre di ottant'anni vecchio e due bastardi di Renuccio da Leca, senza misericordia macellò; ai quali aggiunse contro la religione dei patti quattro baroni di casa Rôcca, Antonio e il figlio, Arrigo e il figliuolo del conte Polo. Cotesto Spinola indi a poco moriva di un trabocco di sangue; ed era ragione, ne aveva bevuto tanto che non bastava a capirlo. In questa, Genova sciolto un nodo ne lega un altro: dopo avere sperimentato tanti signori paesani, pare che voglia rifarsi la bocca tastando la straniera servitù: cacciati pertanto i Fregosi, si dà in balìa di Francesco Sforza e poi gli porge pecore da tosare di seconda mano. Ecco in Corsica gente insolita, consueti supplizii: il Cotta, vice-duca, per conto di non so quale tumulto, manda di punto in bianco su le forche una brigata di vassalli di baroni; e poichè cane non morse mai Côrso ch'ei non volesse del suo pelo, i popoli di Terra di Comune presero le armi e si elessero a capitano un secondo Sambucuccio di Alando, che fece ritirare le mani a cotesto sollecito Cotta. Anco i duchi di Milano passarono; Francesco Sforza morì; Galeazzo Maria suo figliuolo rimase spento della morte dei tiranni senza che ne approdasse la libertà. Ora San Giorgio ripiglia l'isola, disfà la lega di Tommaso Fregoso e Giampaolo da Leca, cacciando l'uno in prigione, l'altro in esigilo. Sorge vendicatore Renuccio da Leca. Potevano i Genovesi vincerlo in guerra, ma parve caro e gli proferirono uno spediente di molto risparmio. Capitato a sorte un figliuolo di Renuccio a Genova, lo acciuffano, poi, pensando cavarne partito migliore, lo rimandano in Corsica in compagnia di Filippino Fiesco amico vecchio di casa.
Qui giunti il Fiesco fa sapere a Renuccio che, se ha caro il riscatto del figliuolo, vada per esso. Renuccio, che accivettato uomo era, non si fida e continua a starsi chiuso nel castello di Zirlina: allora Fiesco va a trovarlo e negozia con lui la restituzione del figliuolo e l'accordo con Genova. Renuccio, vergognoso di mostrare diffidenza o paura, si consiglia visitare l'amico; il diavolo lo tira; preso e incatenato, dopo breve spazio di tempo muore nelle prigioni di Genova; gli storici genovesi scrivono di malattia e non hanno torto, perchè anco un capestro al collo è una infermità e di che tinta! In questo modo finiva la potentissima casata dei baroni da Leca; rimaneva adesso l'altra della Rôcca, sbattuta è vero, tuttavia sempre tale, da mettere in suggezione. I Genovesi, prima di venire in essa a mezza spada, spedirono governatore nell'isola Ambrogio di Negri, personaggio rotto alle più sottili arti di governare i popoli. Costui s'ingegnò staccare i Côrsi dall'affezione dei loro signori eccitando la vanità del popolo, blandendo la superbia dei caporali e principalmente saziando la cupidità di tutti: così seminato il terreno da Ambrogio di Negri, il Banco di san Giorgio mandò la falce tagliente a mietere, e la falce fu Nicolò Doria. I Doria stettero un giorno e credo tuttavia durino emoli degli Spinola; e poichè si era poco prima acquistato Nicolò Spinola bella fama tra i suoi per avere menato sterminio del paese tra Calvi e Soana, Nicolò Doria, dopo avere vinto Renuccio della Rôcca, a fine di precidere i nervi ai baroni, delibera condurre all'ultima rovina il Niolo, sul quale essi per ordinario facevano fondamento. Essendosi pertanto il nuovo governatore introdotto nella terra, assai forte su le armi, chiese per pegno di fedeltà sessanta ostaggi delle principali famiglie promettendo averne buona cura: avutili nelle mani, bandisce tutto il popolo esca dalla isola non badati sesso nè età. Un popolo intero ebbe ad esulare disperdendosi per le terre d'Italia; e fu sentenza dove uomo durava fatica a distinguere se la empietà superasse la mattìa, perchè i villani stessi ingrassano l'agnello per ammazzarlo a pasqua, e nol cacciano via dal presepio. Peggio accadde a Talavo, se pure peggio può dirsi la morte in paragone della vita, sofferta lontano dalla patria. Il prode uomo manda a sangue tutto il popolo di cotesto paese alla rinfusa, tranne una donna chiamata Lucrezia delle Vie, la quale ebbe ad ammazzarsi da sè per fuggire vergogna. Grande cosa ella è questa, che il nome di Lucrezia comparisca fatale in Italia; imperciocchè tre Lucrezie ci si ammazzarono per istudio di pudicizia e di carità patria, Lucrezia Mazzanti a Firenze, Lucrezia delle Vie in Corsica e la più antica Lucrezia a Roma. Le prime due, forse le più innocenti, perirono invano; fortunata l'ultima. Di tre, una giovò, e se, come di quelli delle donne, andasse pei sacrifizi degli uomini, avventurosi noi! Quando Renuccio udì coteste nuove, dubitò tutto il mondo gli cascasse addosso: come poteva starsi in Genova tranquillo mentre menavano siffatto scempio dei popoli devoti alla sua casa? La sua quiete non sarebbe stata argomento ch'egli avesse venduto il suo sangue a oncia a oncia? Se lo appellassero Giuda, non gli sarebbe parso che gli dessero il suo avere. Racimola quello che può di genti e di armi, e ricomparisce su i campi. Le arti del Di Negri così partorirono pessimi effetti, chè i Genovesi poterono opporre a Renuccio cavalli côrsi capitanati da un Cacciaguerra côrso. Incontraronsi in campagna, e non appena si videro (chè di ogni odio più bestiale è il fraterno), l'uno si avventò contro l'altro, si annodarono, nè si sciolsero prima che Cacciaguerra cadesse in terra sbranato. Poichè i Côrsi per mutue ferite si fecero scemi di sangue, Nicolò cauto con molta brigata si presenta a disperdere Renuccio della Rôcca stremo di forze; impresa copiosa di sicurezza, vuota di gloria; ma che importava al Genovese la gloria! Qui fu che apparve intera la virtù di Renuccio; imperciocchè, essendogli morto sotto il cavallo, e trovandosi travolto nella fuga, appena potè districarsi dai suoi, egli tornò addietro solo per tagliare la cinghia della sella, la quale postasi sul capo in mezzo a un turbine di archibugiate nemiche riparò incolume fra i suoi gridando: «Di me Genova non vanti trofeo!»
La guerra tirava in lungo, e ormai questo Côrso diventava un cattivo affare nelle mani dei mercanti Genovesi: si posero a vedere se ci era verso di finirla a buon mercato, ed anco per questa volta lo trovarono. Renuccio della Rôcca fuggendo da Genova ci aveva lasciato a studio due figliuoletti: Nicolò Doria ordinò glieli mandassero, ed avutili nelle mani, intimò a Renuccio deponesse le armi, altrimenti guai! Questi, ora paventando la sconfinata perfidia del nemico, scingeva la spada; ora, parendogli impossibile che trascorresse a tanto nefanda immanità, ne stringeva l'elsa più forte, e così tra il sì e il no la sua mente tenzonava. Nicolò a rompere le ambagi di lui gl'invia per acconto la testa mozza di un figliuolo con la giunta di quella di un nipote; e siccome Renuccio preso da terrore non si risolveva sollecito come la sua impazienza desiderava, gli ribadisce il chiodo nella testa facendogli assassinare un altro nipote. Allora il barone sbalordito tremando per ogni vena scappa via dalla isola imprecando e supplicando che per l'amore di Cristo non gli ammazzino il figliuolo superstite: però riavutosi dal ribrezzo ritorna cieco di furore a brandire il ferro, niente altro cercando che sbranare od essere sbranato. Per questa volta gli si oppose Andrea Doria, cui non repugnando gli esempii del cugino, mise a ferro e a fuoco terre, case e cristiani: anch'egli intimò a posta sua Renuccio posasse le armi, diversamente gli ammazzerebbe l'altro figliuolo: ma Renuccio, ormai anima e corpo diventato una piaga, non sentiva percosse o non le curava. Dopo varie vicende tutte infelici, ridotto a sostenere la guerra con solo otto compagni, gli tesero insidie e lo lasciarono crivellato di ferite sopra la pubblica strada. Ecco come rimase estinta la schiatta dei baroni nella Corsica, nobile e valorosa gente, fiera, superba, larga del suo, per nulla oppressora, amica del popolo: gli spensero i Genovesi persuasi da diverse cagioni, delle quali principalissime queste: la prima fu, che i mercanti si sentivano umiliati da quel fare signorile dei baroni, che ostentavano disprezzare mentre formava la loro astiosa disperazione: l'altra perchè, tolti di mezzo i baroni, reputarono condurre i Côrsi al termine che fosse loro meglio piaciuto: il popolo, giudicavano essi, non ha sapore di libertà, e col sapore gli manca il valore: viva, lavori e serva: tanto ha da bastare a lui, e per noi ne avanza. I Genovesi però fecero il conto dello scarpatore,[14] che stiantata la siepe pensa non dovere attendere ad altro che a insaccare i cavoli, mentre di un tratto si trova faccia a faccia col cane, il quale gli brontola alla spartana: «Vieni a pigliarli!»
— Bene, così doveva essere, — interruppe il signor Giacomo; a cui fra Bernardino di rimando:
— Io dico male; e come regge il cuore a voi, che pure sembrate persona di garbo, di sostenere che fu bene?
— Ho detto così, non mica per lodare le colpe che mi siete venuto raccontando, Dio me ne liberi; bensì perchè esse mi inspirano reverenza pei miei maggiori, i quali, in grazia della bontà e prudenza loro, apparecchiarono a noi altri posteri termini di vivere libero e modi di migliorarlo.
— E che cosa fecero, in grazia, di bello i vostri nonni, signor Inglese?
— Oh! i miei nonni innanzi tratto non chiamarono mai lo straniero per aggiustare i conti loro; qualche volta egli ci entrò pur troppo, ma per forza, ed invece che gl'Inglesi diventassero o Danesi, o Sassoni, o Normani, questi ebbero alla lunga a farsi Inglesi: inoltre quando i diversi ordini ruppero lite fra loro, adoperarono la prudenza di non condurre ora l'uno, ora l'altro, secondo che vinceva o perdeva, alla disperazione; bensì, temperando il talento o l'ira delle ingiurie patite, chi vinse si contentò di costringere il provocatore in parte dove non potesse trasmodare, contento di essersi procurato un arnese capace di valersi della libertà presente e di ampiarla nell'avvenire. Voi altri meridionali costumate come i selvaggi, che per raccattare il frutto, tagliano l'albero. Mirate un po' i Genovesi: non si chiamano contenti finchè non hanno schiattato i baroni; dopo i baroni ecco il popolo, che non sa od abborre le vie di composizione; ed ecco per ultimo il principe, che, piuttosto che reggere con giusto impero, si dà in balìa di podestà straniera: a questo menarono le stemperatezze così dei popoli come dei principi in Italia.
— Signore Inglese, salvo vostro onore, vi dirò che dallo anteporre che voi fate la vostra gente alla nostra, anzi a quella dell'universo, vi lodo molto; ma che vi serviate della vostra predilezione per crescere la soma dei già troppo carichi, questo va contro alla carità ed al giusto. Alla carità, perchè bisogna compatire i miseri, non avvilirli; contro il giusto, perchè ho letto che i vostri re quando ci si misero fecero di tutto; e Guglielmo il Tegolaio e Giacomo Paglia informino che cosa importi anco tra voi fidarsi a pergamene regie giurate o non giurate, sigillate ovvero senza sigillo; e quando il popolo prese la rivincita non mondò nespole, chè non si tenne prima di avere giustiziato re Carlo: così un capo regio saldò il conto di due capi plebei, e non fu caro. Egli è vero, che il re condannarono i giudici a modo e a verso, e i plebei mandati alle coltella; ma ciò non vale; nelle faccende di Stato, sicarii o giudici, mannaia o pugnali sono tutti una cosa: rimane inteso sempre che, con le solennità o senza, il vinto ha da morire, e il coltello in questi casi parmi più spiccio; sopratutto più sincero. Quanto poi a chiamare lo straniero, voi ce lo chiamaste mercè le nozze di Maria con lo spagnuolo; ce lo chiamaste quando, cacciato l'ultimo Stuardo dal trono, vi commetteste alla fede del suo genero olandese; ce lo chiamaste, quando morta la regina Anna andaste ad accattare un padrone in Germania, quasi ve ne mancassero in casa vostra: ce lo chiamò Giacomo II, e potentissimo e cupido dello altrui, sicchè dalla dominazione straniera vi preservarono la tempesta, o la morte: qualche briciola di virtù, ma di prudenza nè anche un chicco. Leggiamo le storie anche noi altri, sapete? E leggendo, e meditando, siamo venuti nella sentenza di pregare Dio che non ci voglia male, imperciocchè allora il senno degli uomini diventi cenere, ed il ragazzo spacchi la testa al gigante.
Il signor Boswell rimase percosso dalle parole del frate, e non ardì per allora rispondere; seguitò un lungo silenzio, durante il quale la destra del signor Giacomo era un via va, un via vieni dalla tabacchiera al naso. Quando non ci trovò più tanto tabacco, che bastasse ad essere preso tra il pollice e l'indice, ne versò ogni residuo nella fossetta che contraendo i nervi si fa tra l'aggiuntatura della mano col braccio, e tirò su su da riporne i granelli in mezzo al cranio; alla fine quasi a dispetto disse:
— Signor frate, io ve lo confesso schietto; da prima quanto si trova nelle mie vene di sangue avvocatesco, e tutti ce ne abbiamo anche troppo, si era risentito, per disputare ogni virgola e ogni punto del vostro discorso, ma poi pensandoci su ho veduto, che nel sottosopra voi avete ragione. Ringraziovi per tanto di avermi annacquato il vino della superbia, e queste reputo tale guadagno, che, quando non me ne venisse altro, io giudicherei non avere gittato dalla finestra tempo nè danari nel venire in Corsica. Se vi piace tirate innanzi, ch'io sto ad ascoltarvi.
— Levati di mezzo i baroni, il Banco di San Giorgio prese a camminare di un portante sì dolce, da disgradarne Brigliadoro, ma e' fu il trotto dell'asino. Il sale da quattro soldi, come eravamo convenuti, al bacino, a mano a mano si portò a dieci; ci tolsero le cancellerie civili; subito dopo i giudizii dei potestà; scarsi gli ufficii conferiti ai Côrsi così, che valeva proprio meglio non darne loro punti: per ultimo i dodici caporali aboliti. Veramente i Côrsi non avevano molto a lodarsene, ma lo istituto piaceva, e quando lo istituto accomoda, gli uomini tristi che lo tengono, muoiono, e i buoni possono succedere: e poi in qual momento toccarono questi cofani! giusto allora, che Giocante della Casabianca, comandante della piazza di Genova, emendando con la sua molta fede la poca prudenza della Signoria e del Doria, salvava la città dalla congiura del Fiesco.
E' fu in questo tempo, che i capitani di Arrigo II di Francia, raccoltisi a Castiglione della Pescaia, misero partito se dovesse farsi la impresa di Corsica, e fu vinto di sì, perchè di utilità grande a mantenere viva la guerra che i Francesi combattevano grossissima contro le armi imperiali su quel di Siena ed in altre parti d'Italia. Mandarono innanzi Altobello Gentili sotto colore di visitare i parenti, ma in sostanza a riconoscere quali le difese e gli umori dei terrazzani: tornato, egli riferiva le prime inferme, non avversi i secondi, almeno in parte. Allora i Francesi vennero ed acquistarono il paese non senza valore com'essi costumano, ma con molte lusinghe altresì, e con frode non poca: indi successe una guerra promiscua: zarosa, piena di sterminio, vuota di concetto, imperciocchè i Francesi, intesi unicamente a divagare gl'imperiali d'Italia, non ne avessero alcuno che fosse buono pei Côrsi; nè questi, a cui pareva essere stati messi allo sbaraglio senza pro, nol tacquero al Termes. In fatti mentr'essi vedevano succedersi a sostenere la guerra per parte di Carlo V tedeschi, italiani e bisogni spagnuoli, di francesi non ne arrivava, e i pochi che ci erano, andavano stracchi ai cimenti; il Termes dava loro erba trastullo, e molto li tratteneva con la speranza del soccorso dei Turchi. Vennevi Andrea Doria, vecchio di presso a novanta anni, generale di tutta la impresa, e assediando San Fiorenzo sminuì la sua gloria, governando le altre faccende crebbe il nome di spietato, imperciocchè nello assedio dimostrasse senile ostinatezza, non già perizia, e nella rimanente amministrazione rabbia di non poter vincere.
Intanto i Francesi accorgendosi come male i Côrsi si pascessero di parole, mandarono a chiarirgli solennemente, che il re per levare loro del dubbio, e i Genovesi di speranza, aveva incorporato l'isola alla Corona di Francia; cosa non consentita mai nè prima nè dopo alle altre provincie da lui conquistate; e ciò essere avvenuto mediante partito del suo consiglio reale, vinto con tutti i voti favorevoli; fatto degno di grandissima considerazione, conciossiachè egli d'ora in poi non potesse abbandonarli, se prima non abbandonasse la propria corona. Questo nel 1557. Tuttavolta, non vedendo alla magnificenza delle promesse conseguitare gli effetti, i Côrsi stavano di mala voglia; i timori crebbero dopo il rovescio toccato dai Francesi a san Quintino, epperò i caporali si condussero da Giordano Orsini per venirne in chiaro. Giordano li confortò a non dubitare: quegli avendogli detto volere mandare gente al re per raccomandarglisi, rispose, non cadercene il bisogno, pure mandandola non farebbero altro che bene: senonchè la pace era già stata bella e conchiusa a Castello Cambrese; e l'Orsini la sapeva, ma la dissimulò per vergogna o per paura. Sul quale proposito certo storico genovese scappa fuori con due sentenze, una buona, l'altra cattiva; buona quella con la quale rampogna l'Orsini, il quale, se veramente cristiano e gentiluomo era, non doveva patire che gente in procinto di essere abbandonata da lui, aizzasse con nuove ingiurie l'animo dei signori abbastanza inacerbito, massime che le offese fresche cociono più delle vecchie: cattiva l'altra con la quale sgrida il re Enrico di avere preso le parti dei Côrsi, non dovendo egli scomodare la Francia pei fatti nostri. Nel raccontare queste avventure mi pigliano i sudori freddi, e l'attaccherei, Dio mi perdoni, anche co' santi: ma sopratutto io mi arrovello con Sampiero, il quale, a quei tempi, era, si direbbe, il sopracciò della Corsica. Costui avendo militato nella ultima guerra della repubblica di Firenze contro l'Imperatore, doveva rammentarsi come i poveri Fiorentini restassero conci dai Francesi. Anche allora re Francesco, con mille promissioni e giuramenti, gli assicurò non gli avrebbe mai abbandonati; giunse perfino a dire, che avrebbe preferito perdere i figliuoli in Ispagna che abbandonare i confederati, e questo non tolse; che indi a pochi giorni li tradisse a Cambraio, e così vituperosamente, che Giuda stesso non avria fatto peggio. Anzi quando gli oratori fiorentini andarono a moverne querimonia in corte, udite un po' come li saldassero i ministri regi: — o che presumevate, dissero loro quei cortigiani guardandoli a stracciasacco, che pei vostri begli occhi perdessimo i figliuoli? Mandate la lingua al beccaio se non volete, invece di un nemico, tirarvene addosso due. La pace di Cambraio, e quella del Castello Cambrese, aspettando altre che le facciano il vezzo, tornano agli orecchi della Francia come i pendenti alla sposa. Talvolta però mi arrapino più col popolo che coll'uomo, imperciochè questo sia caduco, e invecchi, e instupidisca, e dimentichi, ma quello si rinnovi sempre, goda di giovinezza perpetua, e, dove voglia, non gli fanno mai fallo la mente o le braccia. Ma tanto è, quando mi metto a considerare come l'uomo spicciolo, e le masse degli uomini dimentichino presto, mi cascano le braccia, e torrei piuttosto a scalpellare un pezzo di granito dell'Algaiola, che imprimere in cotesti capacci un ricordo per loro governo. Oh! quante volte, fatto un falò dei miei libri, mi sarei ridotto in qualche eremo lontano, dove non si sentisse nè anco il rumore dei ranocchi... ma poi me ne dissuase la speranza, che dài, picchia, martella, una volta l'abbiano a capire.
— La capiranno, con un grossissimo sbadiglio disse Ferrante Canale, e ci mise dentro un suono di voce, che male si distinse se attendesse approvare o piuttosto interrogare.
— Però, riprese il frate, di raccomandazioni e buone parole, secondo il solito, per la parte dei Francesi non fu penuria, e giovarono quanto l'incenso ai morti. In effetto i Francesi senza ridere chiesero guarentigia di buon governo ai Genovesi, e questi di proteste empirono loro le tasche, ma appena eglino ebbero svoltato il canto, ci acciuffarono peggio di prima, gravandoci di 20 soldi, non più a fuoco, bensì a testa, e con altra imposta troppo più incomportabile, ch'era un tre per cento sul valore delle terre. Sarebbe stato piuttosto agevole cavare a san Bartolomeo una seconda volta la pelle, che a Côrsi quattrini, sia che ne patissero a quei tempi inestimabile inopia, sia che le terre, a cagione di cotesti trambusti, andassero nabissate, ed anco a parte ciò, fossero state stimate quattro cotanti oltre il giusto prezzo. Dopo molti strazii il Banco di San Giorgio se ne accorse, e soppresse il balzello, ma il Senato, udito ciò, fece una lavata di capo a San Giorgio delle buone, e gli disse: che cotesto suo era un pigliare il male per medicina, e che per uscirne a bene co' Côrsi ci abbisognano tre cose: forche, e poi forche, e sempre forche; e Côrsi e forche stavano insieme come la pasqua e l'alleluia. San Giorgio, che se ne sentiva fradicio, rispose, che una volta voleva fare come gli tornava, e un'altra come gli piaceva, e a cui non garbasse gli rincarasse il fitto. Voi lo sapete, le parole sono come le ciliege una tira l'altra, sicchè alle corte il Senato ripigliò il governo della isola, dando licenza a San Giorgio, strano a dirsi, per la prima buona azione commessa durante la sua vita.
A carne di lupo dente di cane: tornò Sampiero in compagnia di undici fidati, e con esso la fortuna côrsa. Sampiero sì che avrebbe meritato la famosa tromba del signor Torquato, non quel coso del Buglione, il quale non leva mai un ragnatelo dal buco. Così è, signor Inglese, mentre per fare ammirande le geste di parecchi, che il mondo costuma salutare grandi, bisogna aggiuntarvi un terzo almanco di fantasia, per quelle di Sampiero è mestieri sminuire la verità a fine di non passare di sballone.
Soccorso il valentuomo non ebbe da veruno, chè tale non si potria dire quel po' di munizione speditagli da Cosimo duca di Firenze, nè gli ottomila scudi con le undici bandiere di Caterina regina di Francia, intorno alle quali occorreva ricamato in oro il motto: Pugna pro Patria!
Singolare aiuto in fede di Dio; tanto più singolare, se si consideri, che Federico re di Prussia mandò al degno erede della grande anima di Sampiero, generale Paoli, una spada con la medesima leggenda: Pugna pro Patria! senz'altro. Le quali parole voltate in buon volgare significano: — il nostro mestiere, che è quello di re, non ci permette aiutare repubbliche; se ti puoi reggere da te reggiti, se no impiccati. — Certo tra Caterina dei Medici e Federico di Brandenburgo ci correva, ma in fondo avevano ragione ambedue; e i principi fino da piccini si ficcano bene nel cervello la dottrina del dispotismo, mentre il popolo fin qui o non la seppe comprendere, o non la potè ritenere in mente. Le milizie genovesi intorno a Sampiero si consumavano a mo' delle farfalle intorno al lume; per la quale cosa i magnifici Signori avendo sperimentato come l'assassinamento costasse meno ed attecchisse meglio, commisero al Marcendino provenzale, e a Paolo Mantovano, di ammazzare quegli Sampiero, questi Achille da Campocasso, ed ambedue lo tentarono, il primo col ferro, col veleno il secondo, ma fallirono il colpo. I magnifici Signori non si sgomentarono per questo, anzi più alacri di prima si aggiunsero complici al delitto tre Ornani, e un Ercole d'Istria: questi chiamarono a parte della congiura frate Ambrogio di Bastelica (che Dio danni in eterno l'anima di quel maledetto frate), il quale, abusando della confessione, persuadea a Vittolo, fidato servitore di Sampiero, che avrebbe il favore della Repubblica, si guadagnerebbe la indulgenza plenaria e la remissione dei peccati, mettendo le mani nel sangue del suo padrone.
Ahi! Sampiero, perchè ti lasciasti cogliere alla ragna? E sì che gli anni della discrezione non ti mancavano contandone tu più di settantaquattro; ma tanto è, ognuno ha da filare la lana che gli ha messo tra mano la fortuna. Certa sera recano a Sampiero lettere false a Vico di taluni amici della provincia della Rocca, le quali lo avvisano essere disposti a tumultuare; corresse difilato su i luoghi. Sampiero con giovanile avventatezza, senza ombra di considerazione, tolti seco il figliuolo Alfonso, e Vittolo, con alquanti cavalli, cavalca forte fino a Corticchiati; il giorno dopo passa a Ciglio, dove in cognizione come un uomo della terra facesse la spia al nemico, senz'altra forma di processo ordinò di presente lo impiccassero; quinci si affrettava alla posta datagli, la quale era a Cauro: senonchè tra Eccica e Suarella allo svoltare del poggio si vede accorrere di corsa parecchie centinaia di archibugieri a cavallo capitanati dal comandante Giustiniani e dai tre Ornani. Egli allora si giudicò morto, e rivolto al figliuolo gli disse: — E' vogliono me, tu sàlvati, chè quanto posso li tratterrò; — e siccome il signor Alfonso nicchiava, con gran voce Sampiero riprese: — Va via, se anco tu caschi morto, chi resta a vendicarmi? — Quegli allora voltò la briglia salvandosi a precipizio. Sampiero posto da questo lato l'animo in pace, sprona francamente contra il nemico: il primo ch'ei giungesse fu Michelangelo d'Ornano cui disse: — Traditore, tu sei morto! — E quegli di rimando: — Anzi tu, assassino di femmine! — E si spararono l'uno alla vita dell'altro gli archibugi. Sampiero ne uscì illeso, e Michelangelo soltanto ferito un cotal poco nel collo. Allora Sampiero chiese al Vittolo, gli porgesse un altro archibugio, e quei glielo porse, ma non fece fuoco, perchè Vittolo nel caricarlo aveva messo la palla nella canna prima della polvere. In quella, ch'ei stava maravigliato e sbigottito per la novità del caso, Giovannantonio di Ornano gli menò della spada su la faccia sfregiandolo di sconcia ferita, Sampiero afferrò per la canna lo archibugio, ed adoperandolo a guisa di mazza, con tanta forza ne diede in testa a Giovannantonio, che aperte le braccia come se dicesse: Dominus vobiscum, balenò per cascare da cavallo. Vittolo, che aspettava il destro, visto Sampiero, acciecato dal sangue, armeggiare con le mani, gli sparò a bruciapelo l'archibugio nelle spalle, e l'uccise di botto.
Il commissario, quando gli fu messo dinanzi il capo mozzo di Sampiero, ebbe ad ammattirne per l'allegrezza; buttò moneta dalle finestre, fece le luminarie, commise tutte le artiglierie menassero gazzarra, e quante Ajaccio ha campane sonassero a festa. Dicono che certi fanti tedeschi, al soldo della Repubblica, chiedessero le viscere del tradito, e l'ebbero, ed in vendetta dei compagni ammazzati in guerra se le mangiassero: però bisogna avvertire che questo caso raccontano i francesi; sul quale proposito per me giudico, che i tedeschi sono capaci di far quello ed altro, e i francesi di dare ad intendere quello e peggio. Ma quanto sto per raccontarvi tenete per sicuro perchè ce lo attesta uno scrittore genovese: il corpo di Sampiero essendo stato ridotto in pezzi, tanto il Fornari si mostrò vago possederlo intero, chè ne riscattò a contanti ogni brandello dai soldati. Allora Genova diede al mondo spettacolo nuovo d'infamia e non dimenticabile mai, imperocchè Roma, Tiberio e Nerone imperando, vedesse spie e sicarii disputarsi il prezzo del sangue, ma non davanti ai tribunali o al Senato: in Genova poi fu al cospetto dei magistrati che Raffaele Giustiniani litigò co' fratelli Ornani per la taglia messa sul capo di Sampiero: milleottocento scudi toccarono per sentenza agli Ornani, ma Raffaele non si acquietò al giudicato, e ricorso in appello, oltre i duecento scudi chiese il decimo sopra i milleottocento assegnati ai suoi avversarii. Come andasse codesta infamia a finire io non lo so, questo so bene, che a Genova non se ne vergognavano; in effetto di che cosa avevano a vergognarsi i Genovesi? Considerando essi i delitti negozii mercantili come gli altri, qual maraviglia se nella maniera medesima li trattassero? Però la è cosa piena di amarezza infinita osservare come l'avarizia e la cupidità giungano a spegnere la coscienza non pure dei presenti, ma dei futuri eziandio: non pure dei partecipi al misfatto, bensì degli altri, i quali o per mitezza di discipline, o per religione di ufficio, ed anco per trascorso di tempo dovrieno mostrarsi più giusti. Così Casoni non abborisce dettare queste empie parole, che la strage del Sampiero fu evento molto favorevole alla Repubblica, permesso da Dio per sollievo e per quiete dei Côrsi, e quasi gli paresse poco, a ribadire la empietà, più oltre afferma, che alcuni di prudente e circospetta natura conobbero che Dio con questa morte pareva che manifestamente favorisse la causa della Repubblica. Alfonso, figliuolo di Sampiero, sostenuta un pezzo la contesa piuttosto con virtù che con fortuna, ebbe alla per fine a capitolare: molti patti egli pose alla resa, e molti la Repubblica gliene promise, ma fuori dal concedere a lui e a' suoi compagni di esilio di menare con esso loro un cavallo e parecchi cani per uomo, sembra che gli altri o non osservassero od osservassero poco.
E perchè la guerra tirava alla fine, i Genovesi per illustrarla con tale un fatto che togliesse ai posteri la speranza di potere non che superare, uguagliare la loro virtù, fecero questo. Lionardo da Casanuova, tornato di Francia, dove si era condotto per la quinta volta in cerca di soccorso, casca in podestà dei Genovesi, i quali lo condannano a morte. Antonpadovano, recatosi alla Bastia con una fantesca nel disegno di liberarlo, ottiene facoltà per la fante di visitare Lionardo; la quale cosa facendo la donna quotidianamente, ed anco talora lo stesso giorno più volte, opera in modo che le guardie rallentino la consueta diligenza. Allora Antonpadovano piglia le vesti della fantesca, e penetrato nella carcere, persuade il padre a salvarsi in abito donnesco. Veramente Lionardo tentennò un pezzo, poi lasciò svolgersi dalle parole del figliuolo, che si sforzava capacitarlo com'egli innocente, ed infiammato di carità figliale, non corresse pericolo o poco. Anzi meritava premio, e non glielo negarono i Genovesi, no in fede di Dio non glielo negarono, però che ordinassero: il giovane Antonpadovano ad una finestra della casa paterna di Venaco s'impicchi, la casa, dopo lui morto, si abbruci.
Al fine delle sue parole il frate abbassò la voce, comecchè brontolasse sempre corrucciato: così il fragore del tuono per allontanarsi non cessa atterrire i petti dei mortali. In ultimo il tuono si spense sopra le labbra frementi di lui: allora si nascose la faccia dentro le mani; nessuno vide se pianse, o Dio solo conobbe le sue lagrime segrete, e certo un giorno vorrà retribuirgliene il merito in palese. Di un tratto il frate, dopo alcuna pausa, sorse risoluto in piedi, e favellò:
— Basta; il resto un'altra volta, per oggi io non ne posso più.
E trovata a tastoni la scaletta, che menava sopra la coperta, prese a salirla. Il signor Giacomo, dondolando a furia la scatola fra le dite, esclamava:
— Bene! benissimo! Ma sapete, signor Alando, che cotesto vostro signor frate... come lo chiamate? Oh! ecco... frate Bernardino da Casacconi... che cotesto frate ha tutto l'aria del galantuomo, e giocherei cento sterline ch'io non m'inganno... volete giocarle, signor Alando?
— Io lo so di certo, che padre Bernardino ha camminato sempre nel santo timore di Dio e nel santissimo amore della patria.
Al Boswel, indole temperata se altra fu mai, quantunque sembrasse strano quel positivo dato al timore di Dio accanto a quell'altro superlativo aggiunto allo amore di patria, pure si tacque, uso ad ammirare i nobili affetti anche quando paiono eccedere. E noi altri Italiani sovente non adoperiamo nelle parole misura: di questo particolarmente ce ne porsero esempio i nostri padri, come quelli che si sentivano il sangue a mille doppii più caldo di noi altri assiderati nepoti, e nei miei scritti sono soventi volte venuto rammentando l'avvertimento lasciato da uno di casa Alberti ai suoi figliuoli — che bisogna anteporre alla salute dell'anima la salute della patria.