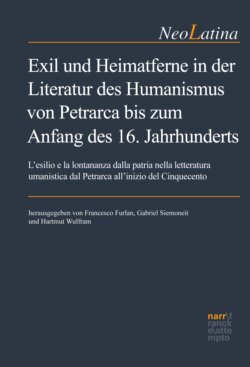Читать книгу Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 21
III. Weitere Italiener im italienischen Exil / Altri italiani in esilio in Italia In familiæ patriæque absentia
Оглавлениеossia D’illegittimità e sradicamento nell’Alberti
Francesco Furlan (C.N.R.S., Paris)
Di padre fiorentino ma esule, morto in Padova quand’egli era ancora adolescente, e di madre genovese quasi neppur conosciuta, che lo lasciò orfano nei primissimi suoi anni, l’Alberti, si sa, non ebbe quasi famiglia, né ebbe moglie o figli. Nato al di fuori del matrimonio, illegittimo (seppur riconosciuto) frutto della relazione verosimilmente per piú anni intrattenuta a Genova dal padre e dalla giovane vedova di una locale famiglia, sia essa o meno da identificarsi in Bianca di Carlo Fieschi,1 egli ebbe bensí un fratello cui sempre fu legato, Carlo, ma nei confronti del quale, pur di lui certamente maggiore d’età,2 si comportò costantemente con atteggiamento di protezione quasi paterna – tant’è che il nome stesso di Carlo di Lorenzo Alberti appare sostanzialmente legato all’opera di Battista.3 Fra i congiunti o affini o parenti meno stretti uno o due soltanto se ne distinguono in positivo, Francesco d’Altobianco (1401–1479), dedicatario del terzo libro de Familia e figura non ignota alla cultura quattrocentesca,4 e Bernardo d’Antonio (1435–1495), con cui Battista spartí negli ultimissimi suoi anni la proprietà del palazzo avito in Santa Croce a Firenze.5 Con gli altri, con tutti o quasi gli altri, ebbe ben piú conflitti, anche d’estrema durezza e assai aspri – l’autobiografia o Vita allude persino a un tentativo d’omicidio –, che pacifiche frequentazioni o intese qualsiasi.
Da tali telegrafici cenni può, io credo, già inferirsi come la presenza, pur relativamente frequente nei primi scritti volgari dell’umanista, della propria famiglia d’origine, si situi per l’Alberti in una dimensione assai astratta e quasi mitica, e come in concreto essa si sia ben presto tradotta in un’autentica assenza, in prosieguo di tempo da lui ineluttabilmente accettata e fatta propria. Anticipando quanto in parte vedremo meglio nel séguito, potremmo aggiungere o affermare che della famiglia, che in sostanza non ebbe, l’Alberti scrisse quasi come della patria, che in sostanza non si riconobbe, o finí col non riconoscersi: ne scrisse (e vi pensò) insomma inizialmente, o soprattutto inizialmente, ma molto meno in séguito – nella mentalità non meno che nella società del tempo, e perciò negli stessi suoi scritti, «famiglia» e «patria» sono infatti strettamente unite e pressoché inscindibili.6
*
Sporadicamente dalla metà circa del Cinquecento, ma con costanza pressoché assoluta da un secolo e piú a questa parte, dell’Alberti si ripete che nacque in esilio e in esilio si formò, visse in esilio, o perlopiú in esilio, e in esilio altresí morí. L’«esilio» (< lat. exsilium < exsul, i.e. ‹proscritto›, ‹bandito› o per l’appunto ‹esiliato›) non è peraltro se non da una «terra», anche proprio nell’accezione toscana e rinascimentale di ‹città›, da una «patria» insomma (< lat. patria, femm. sostantivato dell’agg. patrius, -a, -um, sottintendente terra, e dunque col significato di ‹luogo o paese natale› ovvero, e in senso piú stretto, di ‹luogo o paese del padre›). Ma qual è, quale fu la patria dell’Alberti? In un’accezione strettamente etimologica del termine essa fu certamente Firenze, terra avita, poiché città natale del padre Lorenzo e del padre di questi Benedetto, nonno (paterno) di Battista; in un’accezione appena piú larga, e certamente piú consona all’uso moderno del termine, italiano ma non soltanto italiano, essa fu non meno certamente Genova, suo accertato luogo di nascita, e luogo – di contro a quanto talvolta si sottintende – tutt’altro che casuale, posto che l’unico parente cui sempre egli rimase legato, il fratello Carlo per l’appunto, ebbe i natali nella medesima città, prima ancora di lui e secondo ogni probabilità da una stessa madre – una donna, sia detto per inciso, che le tradizioni del tempo e gli stessi interessi politici ed economici della consorteria mai avrebbero consentito a Lorenzo di «torre per sua» in matrimonio. Chi prescinda da ciò, viene a negare il piú fondamentale degli elementi costituenti la personale identità dell’Alberti, de facto disconoscendone il presupposto primo della nascita stessa. E nega e disconosce altresí il peso a un tempo simbolico e reale degli affetti e dei legami materni, non meno personali che familiari – peso storicamente attestato in una lunga o lunghissima serie di casi concreti,7 e tanto piú forte e quasi ovvio da risultare di norma preponderante nel caso di figli «naturali», a richiamare il quale basterà qui riandare ai medesimi due figli di Lorenzo, i fratelli Carlo e Battista, e rilevare come né l’uno né l’altro di essi porti un nome che in un modo o nell’altro rinvii alla famiglia paterna – nel cui àmbito risultano tutt’altro che radicati, e anzi sostanzialmente sprovvisti d’attestazione8 – ovvero alla patria di Lorenzo, laddove il primo ripete con ogni probabilità il nome del nonno materno e il secondo quello del santo protettore o patrono della città natale di entrambi, non di Firenze cioè, come spesso si è detto e scritto,9 ma di Genova.
Qual è dunque, o quale fu, la patria dell’Alberti? Invero, e almeno in pienezza di termini, né l’una né l’altra di tali due città. Rileviamo ancora come nei suoi scritti l’aggettivo «patrius, -a, -um» ricorra, anche nel femminile sostantivato «patria», non troppo di rado e, per esempio, altresí in diretta relazione con la lingua da lui adottata nell’opera senz’altro per noi piú interessante, i libri de Familia intendo – lingua definita con decisione (oltreché con apprezzabile precisione etimologica) come «patrius sermo» in Vita, 13. Basta però ricordare come l’espressione sia per il solito, in terra di Francia, tradotta con «langue maternelle» per misurare tutta la distanza che indiscutibilmente intercorre fra il senso etimologico del termine che ci interessa e ogni sua piú moderna accezione. E per misurare nel contempo tutta la complessità e la difficoltà dell’impresa di chi si accinga a indagare i concreti sentimenti e legami del grande umanista servendosi di spogli lessicali o linguistici, e intenda dunque poggiare la propria analisi sull’improprio, nel nostro caso, fondamento della frequenza di questo o quel termine e di questa o quell’espressione nella sua opera scritta. Tanto piú che non sembra possano rinvenirvisi determinazioni o specificazioni del termine «patria» quali sarebbero, e.g., gli aggettivi «fiorentina» o «genovese».
In particolare, nessun accenno al luogo di nascita e, parallelamente, nessuna rivendicazione di fiorentinità, né invero di qualche speciale o semplicemente significativo proprio legame con Firenze o con Genova, è dato di rinvenire nell’autobiografica Vita, ov’è viceversa sottolineata la radicale estraneità iniziale dell’Alberti alla lingua toscana, l’originaria sua recisa non conoscenza di quel «patrius sermo» ch’egli avrebbe iniziato a usare, spintovi dallo specifico fine ch’era allora il suo, ma senza realmente possederlo, soltanto nella prima o primissima redazione dei libri de Familia… nel trentesimo suo anno d’età, precisa l’umanista, nel 1433–1434 insomma, e a Roma (Vita, 13).
Sul piano simbolico, assai significativo è del resto lo spesso elettivo «prænomen» dall’Alberti adottato almeno dagli anni Trenta (e al piú tardi nella seconda redazione della Philodoxeos fabula): «Leo», per l’appunto, o «Leone». Non v’è infatti a parer nostro alcun dubbio sul fatto ch’esso rinvii – giusta un’ipotesi condivisa dalla Bertolini e dalla Massalin che trova palese riscontro nella stessa coloritura padano-veneta, e fors’anche veneta tout court, delle poche sue epistole volgari superstiti,10 oltreché nel rilievo dall’umanista concesso nella propria autorappresentazione al motivo delle ali – a Venezia e alla tradizionale raffigurazione in veste, per cosí dire, di «leone alato» dell’evangelista che ne fu il simbolo universale. Peraltro, che agli occhi dell’Alberti «Leo» / «Leone» avesse, in quanto «prænomen», delle non trascurabili virtú intrinseche, e quali fossero tali virtú, è accertabile nel famoso passo del secondo de Familia in cui Lionardo afferma che
ne’ buoni ingegni uno leggiadrissimo nome [è] non minimo stimolo a fare che desiderino aguagliarsi come al nome, cosí ancora alla virtú11
– passo redatto nello stesso torno di tempo in cui quel «prænomen» veniva definitivamente assunto dall’Alberti, che del resto, di contro a quanto si è sostenuto,12 se ne serví non tanto come autore quanto nell’autorappresentazione di se stesso in vesti per cosí dire ufficiali, cioè non semplicemente familiari e informali; e lo prova un significativo luogo dell’autobiografia (Vita, 85–86), ov’egli deliberatamente alterna i due nomi «Baptista» e «Leo» nel pungolare se stesso a produrre.
Sicché (un po’ come per il Petrarca) la sola, l’unica vera patria dell’Alberti sembra situarsi in massima parte fuori dal tempo e dallo spazio in cui concretamente egli vive, avere precipua dimensione storica e culturale, intellettuale e artistica, e ricondursi in un modo o nell’altro alla memoria o alle memorie dell’antico e, nell’antico, alla romanità. Uomo senza vera patria, l’Alberti fu infatti, senz’altro a suo modo ma inequivocabilmente, quel «cittadino del mondo» che il Marsh ritrova nel testamento da lui lasciatoci.13
*
Lo stesso studioso individua in una duplice esclusione, della famiglia da Firenze e dell’umanista dalla famiglia (s’intenda in entrambi i casi la famiglia paterna) da un lato e, dall’altro, nel rifiuto della sua opera e delle sue iniziative da parte delle élites intellettuali e politiche fiorentine, le «precarie» fondazioni della personalità dell’Alberti – il cui penchant per l’autobiografia sarebbe all’origine del Leitmotiv ch’entro la sua opera conseguentemente formerebbe il tema dell’esclusione.14
Che quelli indicati dal Marsh siano o possano essere i tre pilastri, per cosí dire, su cui precariamente poggiarono le «fondazioni della personalità» albertiana potrebbe apparire una semplice constatazione se in essa e dietro di essa non riconoscessimo il postulato, invero mai dimostrato, dell’intrinseca «fiorentinità» dell’Alberti, e dunque di un suo legame profondo, insieme biologico e culturale, piú ancora che con la città e il dominio di Firenze, con una stirpe, una tradizione, un patrimonio giuridico, tecnico-artistico e letterario riconoscibili con chiarezza e in pienezza di termini come fiorentini; nel qual caso, giova rilevare, persino in assenza di concreti, materiali interessi, dovremmo ritrovarvi quella sorta di dipendenza ideale, nel contempo psicologica e affettiva, in cui siffatto legame di norma si traduce.
Ritengo che uno spassionato esame dei dati reali in nostro possesso induca a dubitare fortemente della validità e del fondamento stesso di tale postulato. Che in gran parte crederei peraltro riconducibile a un’assai tarda riscrittura e invero mistificazione storiografica d’origine fiorentina compiutasi, benché con taluni estemporanei e disorganici accenni precedenti, che un primo e cosciente intento traducono soltanto negli anni di Lorenzo, in Età ducale e granducale, regnante Cosimo I de’ Medici (1519–1574, duca di Firenze dal ’37 e granduca di Toscana dal ’69), col Vasari e col Bartoli innanzitutto – l’uno e l’altro dei quali pur reca vistose, inequivocabili tracce dell’autentico ostracismo riservato all’opera e al nome stesso dell’Alberti nella Firenze a lui contemporanea, e in quella anche delle generazioni immediatamente successive: basti qui accennare all’accusa di pratica incapacità lanciata dal Vasari al tanto di lui piú grande architetto e umanista, e all’esclusione, fra le altre non pochissime opere, dell’intera serie dei dialoghi volgari mimetici dalla silloge degli scritti dell’Alberti edita dal Bartoli con l’incongruo titolo d’Opuscoli morali.
Invero, mai l’Alberti si dice «Florentinus» o «fiorentino», né «fiorentino» o «Florentinus» lo dicono i codici manoscritti, non almeno quelli al suo laboratorio o a lui direttamente legati, né quelli da essi immediatamente discesi, pur non pochissimi e non meno volgari che latini, e neanche i codici, perlopiú volgari, di tradizione fiorentina a lui contemporanei. E «fiorentino», o «Florentinus», non lo dicono neppure le intitolazioni delle prime e piú antiche stampe, quelle uscite lui vivente, che pur non esitano a definirlo «poeta laureato», o quelle degli altri incunaboli noti, ivi compresa la fiorentinissima (nell’operazione editoriale tutta, ma in primis nella dedicatoria del Poliziano a Lorenzo) editio princeps del De re ædificatoria.15
È del resto evidente che l’evocare l’esilio, fisico e materiale, oppure sentimentale e intellettuale, implica il riconoscimento preliminare di una «patria» insieme reale e ideale. Col che torniamo alla fondamentale domanda già posta: è davvero fiorentino l’Alberti? è davvero, l’Alberti, legato a Firenze come città e come terra, come cultura e come tradizione artistica e intellettuale? a Firenze piú che ad altri luoghi, piú che a Bologna, a Roma, a Ferrara, a Mantova, a Venezia, etc.? Se ci tenessimo alla vulgata dal Vasari e dal Bartoli costruita in ottemperanza al tenace disegno propagandistico perseguito dal duca Cosimo I e ai connessi suoi desiderata di riscrittura storiografica, dovremmo con ogni probabilità concludere per il sí. Ma è quella la realtà? è davvero in quella vulgata la verità storica?
Soffermiamoci brevemente sui libri de Familia, per molteplici riguardi lo scritto dell’Alberti per noi piú significativo, l’unica sua opera non di poco momento in cui venga espressamente da lui posto il problema della propria ascendenza e famiglia, della propria patria e della propria terra, e dunque la sola sua opera di vasta portata in cui il tema dell’esilio risulti anche esplicitamente trattato, e ne segni indelebilmente molte pagine e passi e molte o moltissime riflessioni. Se dunque è lecito sostenere che i dialoghi Sulla famiglia nascano in certo modo proprio dal tentativo del loro autore di metter radici, umanamente e psicologicamente, in seno a una determinata famiglia e a una ben precisa terra, quelle non già della madre (allusa, entro l’opera dell’Alberti, forse soltanto nella Vidua, non senza peraltro una qualche irriverente ironia16), ma del padre Lorenzo (principale interlocutore del primo Atto del libro I, ove dialoga coi congiunti Lionardo e Adovardo) e, soprattutto, del nonno paterno Benedetto (significativamente presente nell’opera per il tramite soprattutto dell’emblematico suo discorso riportato da Lorenzo a I 143–255), il quale è altresí protagonista della breve intercenale Divitiæ; se è senz’altro lecito scorgere nei libri de Familia un simile tentativo, anche va rilevato e detto ch’esso in massima parte abortí ineluttabilmente non appena portato a conoscenza dei parenti, i quali vi opposero il reciso rifiuto su cui si dilunga la Vita, piú volte definendoli «ingrati» o «improbi» (§ 27) e «iniqui» (§ 69), e ricordando dolorosamente come «inter omnes Albertos» appena uno degnò di leggere i «librorum tituli» dell’opera, peraltro ancora incompleta, offerta loro – ciò che ben s’attaglia a quanto è dato sapere circa la circolazione e la fortuna di quei dialoghi. Abortito che fu, quel tentativo venne poi ben presto, se non in toto abbandonato, quanto meno messo in sordina, e piú tardi ripreso solo assai parzialmente, e solo tramite la fondamentale ridefinizione iscritta nei Profugia o nel De iciarchia, dialoghi non già «domestici e familiari» ma tutt’al piú «amichevoli», segnati dall’abbandono definitivo del quadro familiare e dalla ricerca di un possibile, seppur improbabile orizzonte cittadino, i cui interlocutori non son piú, né piú posson essere, degli Alberti stricto sensu; messo dunque in sordina e superato, quel tentativo, da tematiche e scritti (il Momus e il De re ædificatoria, principalmente) che volgono ad altro l’attenzione e lo sforzo creativo dell’umanista. D’altro canto, non può certo negarsi che quel tentativo sia stato sin dall’inizio e con estrema chiarezza inquadrato, col Prologus, nel piú vasto orizzonte, culturale e psicologico insieme, in cui tutta la produzione seguente dell’Alberti andrà con naturalezza a iscriversi, quello appunto della romanità – di una romanità palesemente ridefinita come italicità e, in tal modo, riconquistata e fatta propria: la celeberrima dissertazione su virtú e fortuna che di quel Prologus costituisce la parte maggiormente saliente non lascia invero, al riguardo, dubbio alcuno.
Assai piú e assai meglio d’ogni altra sua opera, i libri de Familia traducono ed esprimono quindi il tentativo di un Alberti ancor relativamente giovane e, insomma, scrittore della prima propria maturità – la concezione, la redazione e la diffusione medesima dell’opera da parte del suo autore sono infatti integralmente comprese fra il ’33 e il ’41 – di iscriversi, invero per taluni riguardi persino a viva forza, nella tradizione e nella patria fiorentine del padre Lorenzo e del nonno paterno Benedetto, della famiglia insomma di cui, recentemente purgato «in presentia […] pape» dal proprio giuridico peccato d’origine da Biagio da Molin, portava ora con fierezza il nome – gli Alberti.17 Nel palese suo tradurre problematiche e interessi pressoché esclusivamente tecnico-artistici e architettonici da un lato, e ludici dall’altro, la produzione dell’ultimo trentennio di vita dell’Alberti, ormai quasi per intero in latino ed esplicitantesi soprattutto, per la sua parte scritta, nella concezione, redazione, revisione del De re ædificatoria da un canto e del Momus dall’altro, che le ultime ricerche filologiche provano non esser mai stati pubblicati o diffusi dal loro autore, il quale vi lavorò viceversa sino alla morte (1472),18 attesta dal canto suo con chiarezza il superamento e il sostanziale abbandono del disegno, indiscutibilmente perseguito dall’Alberti negli anni Trenta del Quattrocento, di una propria re-inserzione o piú semplicemente di un proprio reale inserimento nell’àmbito familiare della consorteria degli Alberti non meno che in quello dell’originaria loro patria fiorentina e toscana, come membro de iure della prima e come fattivo «civis» o «concivis» della seconda.
Opere, l’una e l’altra, a Roma legate e a Roma, secondo ogni probabilità, in massima parte redatte e lungamente rielaborate, riviste, corrette, Momus e De re ædificatoria appaiono in concreto infinitamente piú italiche e classiche che fiorentine o toscane. E se sporadici accenni alle terre d’Etruria o di Toscana sono, fra i molti altri, ben naturalmente anche in esse rinvenibili – il memorabile tentavivo operato a I 26–31 dal proteiforme protagonista del Momus di spegnere con la predicazione il culto degli dèi che l’avevano esiliato, tentativo che si vuole ironicamente espletato in Etruria, ne costituisce un pregevole esempio –; se d’altra parte la tarda composizione dei libri de Iciarchia prolunga e porta a compimento il geniale polittico dei dialoghi italiani dell’umanista, nel contempo dissolvendone la dimensione familiare in quella, urbana e sociale, della rete d’amicizie o d’alleanze, nella fattispecie fiorentine, concretamente additata come indispensabile non meno alla famiglia che all’individuo; è chiaro per noi che sarebbe un errore scorgervi o leggervi altro da quel generico permanere di taluni, materiali e perlopiú concreti interessi dell’Alberti a Firenze e in Toscana che i documenti biografici noti attestano con bastante chiarezza, non meno chiaramente attestando la sussistenza di paralleli, concreti interessi e ideali legami dell’Alberti in tutta una serie d’altri luoghi, da Roma a Padova e da Bologna a Mantova – città, quest’ultima, ov’egli non a caso progetta, ancora nei primi mesi del ’70, d’acquistar una o piú proprietà.19 E, ciò, quand’anche acconsentissimo a considerare esaurite e ormai spente le strette relazioni da lui avute con Ferrara fino almeno al ’50 e alla morte di Leonello d’Este, o con Rimini fino alla morte di Sigismondo Pandolfo Malatesta nel ’68, e quelle intessute altresí con l’Italia aragonese e insulare, con Napoli oltreché con Palermo e la Sicilia, di cui quasi nulla di preciso si sa – i superstiti documenti dicono invece ben poco d’altri luoghi ancora, e in primis di Venezia, che conserva e, ancor piú, ha conservato per secoli documenti e codici albertiani di primaria importanza, in non piccola parte autografi o idiografi e postillati o glossati, e con cui è pertanto giocoforza supporre che l’Alberti mantenesse sino alla morte uno speciale e forte legame, stretto con ogni evidenza negli esordî stessi della propria vita activa; vi rinviano infatti i tratti fondamentali della sua formazione (l’accentuato peso dell’aristotelismo), della medesima sua lingua naturale (la citata veneticità delle lettere volgari), di molti suoi ricordi (quando nell’àmbito di una bellissima similitudine indica in De familia, II 1987 ss. un porto per antonomasia, è quello di Venezia che ricorda e descrive) ed eloquenti simboli (come s’è visto, a suggerire un’intima preferenza e una personale adesione trasceglie, fra i mille possibili prænomina, il simbolico ed esclusivo nome di Venezia: Leo o Leone); né può essere del tutto casuale che lo stesso suo impiego in curia, e la conseguente fine dei suoi forti disagi economici, e persino la bolla con cui il veneto papa Eugenio IV lo mondava, il 7 ottobre 1432, dal difetto della nascita illegittima, gli siano stati ottenuti, non già da un qualsiasi principe della Chiesa, ma dal veneto patriarca Biagio da Molin, suo protettore.20
Neppure è da ritenersi privo di significato il fatto che taluni dei suoi stessi ultimi soggiorni a Firenze siano stati determinati o richiesti, non già da suoi interessi fiorentini, o da interessi di fiorentini o della Firenze contemporanea nei confronti suoi e della sua opera ma, al contrario, dalla persistenza dei forti suoi legami con territorî e ottimati e governi da Firenze distinti e lontani: emblematico può a tal proposito ritenersi il caso del suo intervento per la tribuna della Santissima Annunziata, effettuato a partire dal 1467 ca., e dunque parallelamente alla redazione dei tre libri de Iciarchia, per conto e per volontà di Ludovico Gonzaga, che ne era il patrono e che seppe imporre il nome dell’Alberti a dei fiorentini perlomeno assai riluttanti a servirsi di lui – parzialmente edita (e commentata) dal Fubini, la corrispondenza al riguardo scambiata da Lorenzo de’ Medici col Gonzaga è sotto ogni riguardo eloquente.21
*
Come può chiarire, fra l’altro, un semplice confronto tra le disposizioni testamentarie di Battista (Roma, 19 aprile 1472) e quelle del di lui biscugino Bernardo d’Antonio di Ricciardo Alberti (Firenze, 16 maggio 1495),22 che in virtú del lodo arbitrale pronunciato da Marco Parenti nell’ottobre del ’68 con l’umanista spartisce per poco piú di tre anni il palazzo fatto costruire nell’odierna via de’ Benci dal nonno di questi Benedetto, e che l’Alberti – evidentemente a lui, negli ultimissimi suoi giorni, piú che ad altri legato in conseguenza di quello stesso «misterioso» lodo23 – nomina suo parziale erede,24 laddove la fiorentinità di Bernardo e lo stesso suo legame con gli albertiani «lares et penates» fiorentini sono palesi e indubbî, la postulata fiorentinità di Battista appare, alla morte di lui, perlomeno assai sfumata e, certo, piú stemperata ancora del legame ch’egli allora intrattiene col ramo fiorentino della famiglia di cui porta il nome: basti, al riguardo, richiamare (1) come nessuno dei ben tre esecutori testamentarî dall’Alberti nominati (il cardinal Niccolò Forteguerri, Antonio Grassi bolognese e il pisano Mattia Palmieri) sia un suo consanguineo, (2) come lo specifico legato istituente un collegio di studî in Bologna evidenzî innanzitutto un duraturo, fortissimo legame ideale con l’Emilia, e infine (3) come la disposizione con cui espressamente e senza sorpresa alcuna egli ordina d’esser sepolto in Padova (in sepulchro patris sui) ratifichi e sigilli definitivamente la defiorentinizzazione, per cosí dire, tanto sua quanto del ramo paterno della famiglia. E ciò, giusta quanto a ben vedere già enunciava l’autocertificazione in proposito consegnata al De iciarchia, secondo ogni probabilità l’ultimissimo scritto dell’Alberti, laddove Battista afferma che
Dei costumi della terra [sc. la città di Firenze] mai accadde a me altrove ragionarne; e sonci come forestiere, raro ci venni e poco ci dimorai.25
Era quanto i fiorentini contemporanei dell’Alberti, e quelli anche delle prime generazioni seguenti, ben sapevano e fecero caparbiamente valere nella multiforme, mai contraddetta censura con cui tentarono di sotterrarne l’opera e nell’autentico ostracismo con cui ne colpirono il nome medesimo, deliberatamente taciuto – si sa – non soltanto nelle carte di Giovanni di Paolo Rucellai, ma persino laddove, come nelle Vite di Vespasiano da Bisticci, ci si vedeva costretti ad accennare all’una o all’altra delle molteplici sue iniziative. È quanto a ben vedere traluce nella stessa editio princeps del De re ædificatoria, che insieme anticipa d’un soffio, fiorentinizzandola, un’iniziativa chiaramente nell’aria in molti luoghi d’Italia, e non soltanto d’Italia, e censura tutto il resto della multiforme produzione albertiana;26 ed è quanto, ancora, la stampa tardissima, della metà dell’Ottocento, e per iniziativa di un non toscano, il Bonucci, della serie intera dei suoi dialoghi volgari, o la circolazione manoscritta e a stampa essenzialmente extra-fiorentina della massima parte della sua opera latina inequivocabilmente dimostra a chi ancora volesse dubitarne.
*
Capolavoro del dialogo albertiano, e del dialogo rinascimentale tout court, i libri de Familia impostano dunque e al tempo stesso chiudono o archiviano il tentativo dall’Alberti compiuto negli anni Trenta di fiorentinizzarsi. Non sarà inutile rilevare al riguardo come in quel medesimo torno d’anni, e a ben vedere con identica forzatura, quel tentativo trovi espressione altresí nella dedica al Brunelleschi,27 non già e non certo del De pictura, né già sic et simpliciter della redazione volgare di quel trattato sotto ogni riguardo fondativo e rivoluzionario, ma di un solo esemplare di tale redazione del De pictura: il codice oggi II iv 38 (olim Magl. XXI 119) della fiorentina Biblioteca Nazionale Centrale, codice, com’è noto, legato allo scrittoio o al laboratorio personale dell’autore stesso, dal quale non sembra, vivente l’Alberti, esser mai uscito; ed esemplare, dunque, mai presentato al destinatario, al Brunelleschi.
Eloquente in tal senso è il fatto stesso che di quella redazione volgare, che quasi non circolò e di cui si perse ben presto, nell’Europa del Rinascimento e a Firenze stessa, ogni notizia o memoria – come ho altrove già rilevato, le versioni italiane del Domenichi prima (1546 e 1565) e del Bartoli poi (1568) seguono, in ogni senso del termine, l’editio princeps del testo latino stampata a Basilea nel 1540! –, siano noti solo due altri testimoni manoscritti,28 e ch’essi siano entrambi in toto indipendenti dal succitato codice recante il Prologus al Brunelleschi. Come la presentazione cosí anche la dedica a questi della riduzione in volgare del trattato dovette, insomma, restare un progetto non mandato ad effetto, un’idea in prosieguo di tempo abbandonata dall’autore.29
Ma torniamo ai libri de Familia che, dicevamo, impostano e insieme sostanzialmente archiviano il tentativo albertiano di fiorentinizzarsi. Lo fanno dando vita a un dialogo il cui autore entra direttamente in gara coi massimi rappresentanti della tradizione classica greco-romana – e giudica persino, nell’ultimo libro, d’averli inequivocabilmente superati.30 L’ardito, arditissimo disegno dell’opera, e piú ancora forse del suo libro de Amicitia, l’imprudente genialità di cui l’Alberti dà prova nella sua esecuzione – tanto piú imprudente in quanto accompagnantesi ad altre sue rivoluzionarie prove, prima fra tutte quella della dimostrazione della grammaticalità del volgare e della sua derivazione dal latino nel Della lingua toscana, dimostrazione dolorosa per una parte non piccola dell’élite umanistica del tempo e dolorosissima per Leonardo Bruni in particolare –, suscitarono contro di lui, com’è noto, la spietata, tenacissima censura dell’establishment culturale umanistico e dell’intelligencija fiorentina tutta in occasione del Certame dell’ottobre 1441.
Il verdetto dei giudici umanistici e della Firenze ufficiale, verdetto senza appello e, come tutto induce a credere, rinnovato e fatto valere in molteplici occasioni lungo l’intero secolo seguente (e oltre) a Firenze, non lasciò all’Alberti altra scelta che quella d’archiviare definitivamente il tentativo compiuto – tentativo di fiorentinizzazione e, in un senso, acclimatazione nell’ancestrale patria del padre. E invero la sua opera seguente e i decennî da lui vissuti dopo di allora testimoniano di un’almeno progressiva sua appropriazione e valorizzazione di una patria piú vera e piú ampia, quella di una classicità dinamicamente intesa e di un’italicità senza confronto sfaccettata e ricca. Col che, sia lecito concludere, egli superava, archiviandolo, anche l’originario suo sentimento d’esclusione e d’esilio – quel sentimento che tanta parte aveva per l’appunto avuto nella concezione del De familia e nell’adozione stessa del volgare –, facendo del persistente, oggettivo proprio sradicamento quella definitiva, e privilegiata, condizione di riflessione, di creazione e di scrittura, non meno che d’alterità intellettuale e creativa, cui l’intera sua opera in ultima analisi rinvia.31