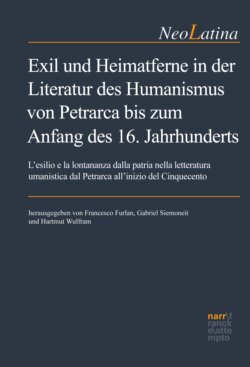Читать книгу Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 5
I. Ursprünge im Trecento / Le origini nel Trecento Exul o peregrinus?
ОглавлениеL’esilio petrarchesco come arte della fuga
Enrico Fenzi (Genova)
In passato mi sono occupato in modo piuttosto diffuso del tema dell’esilio nell’opera del Petrarca e ancora mi riconosco in quanto ne ho detto, sí che non posso cominciare se non rimandando a quello studio, piú o meno direttamente presente in questo mio intervento.1 Certo, varî contributi mi erano allora sfuggiti e altri in séguito se ne sono aggiunti, dal momento che il tema dell’esilio partecipa in maniera intima e complessa al fascio dei significati e dei valori dell’intera opera del Petrarca.2 La direzione che oggi prenderò non mira in ogni caso a un’impossibile e fuorviante completezza; semmai, approfittando delle molte cose che ormai si sanno, vorrei cogliere alcune speciali articolazioni di questo, ch’è certamente uno dei nodi sensibili dell’esperienza petrarchesca.
Alcune cose vanno súbito ripetute. Il Petrarca non ebbe personalmente a patire dell’esilio: esiliato fu invece suo padre mentre egli aveva pochi anni d’età, e certamente questo fatto condizionò la sua vita e in particolare i suoi rapporti con Firenze, ma su un piano affatto diverso. Viaggiò per buona parte d’Italia e d’Europa senza impedimenti, scelse liberamente ove risiedere, fu in grado d’immaginare una serie di luoghi nei quali avrebbe potuto tranquillamente trasferirsi, e soprattutto non ebbe alcun problema a passare per Firenze quando ebbe l’opportunità e la voglia di farlo. Questa brevissima puntualizzazione, tuttavia, non può e non deve chiudere ogni questione, dal momento ch’è pure indubitabile che una indeterminata e addirittura sfuggente dimensione d’esilio che vorremmo meglio definire sembra informarne gli atteggiamenti e le opere. Ma per arrivare al cuore di tale dimensione occorre rompere la crosta delle esplicite dichiarazioni del Petrarca, tutte tese a dimostrare, in sostanza, che l’esilio ‹non esiste›, come risulta, per esempio, dal testo nel quale egli ha condensato il suo punto di vista, il cap. 67, De exilio, del libro II del De remediis, probabilmente scritto sullo scorcio degli anni Cinquanta e non lontano nel tempo da due lettere probabilmente fittizie dirette a un tal ‹Severo Appenninicola› per consolarlo del suo personale esilio, le Fam. 2, 3 e 4.3 La trama del discorso del Petrarca è di perfetta e prevedibile coerenza stoica e senecana in specie: l’esilio esiste solo per chi lo subisce come tale, mentre gli individui di valore non se ne lasciano minimamente turbare e sanno vivere altrettanto bene in qualsiasi parte della terra, in compagnia della loro intatta virtú che sarà proprio l’‹occasione› dell’esilio a portare in piena luce.4 Cardine forte del discorso è quello dell’uomo come ‹cittadino del mondo› e dunque libero di scegliersi la patria che vuole, esemplarmente affidato anche a un appunto che il Petrarca scrive in margine al f. 36v del suo codice dell’Historia Alexandri di Curzio Rufo, il Par. Lat. 5720: «la patria è qualsiasi luogo nel quale l’uomo forte abbia scelto di restare» (patriam esse ubicumque vir fortis sedem sibi elegerit). E ben si capisce come una siffatta capacità e libertà di scelta in determinate circostanze si trasformi nell’obbligo morale di sottrarsi alla complicità con i malvagi mediante l’esilio volontario, che a sua volta contempla la variante particolare della ‹vita solitaria› quale forma tutta speciale e particolarmente eletta di auto-esilio.5
Il primo passo, come è ovvio, sta nel precisare che si parla di un esilio decretato ingiustamente, sí che il condannato godrà almeno della consolazione di allontanarsi dai malvagi in compagnia della Giustizia, da sempre esiliata dalla terra (sia detto di passaggio, al lettore moderno riesce inevitabile riandare in ogni caso a Dante: qui si potrebbe ben ricordare la canzone Tre donne). A infliggere tale ingiusta condanna sarà dunque un tiranno, il quale caccia i buoni e favorisce i malvagi, oppure un regime di popolo che naturalmente, come sempre è stato, «odia i buoni: un tale tiranno dalle tante teste, infatti, non caccerebbe mai uno che gli assomiglia».6 Ma l’accento del Petrarca non batte tanto su chi esercita il potere e sull’esilio quale atto di condanna giuridicamente caratterizzato, ma su colui che lo subisce e però se ne appropria e lo trasforma e lo capovolge quasi fosse una sua scelta. Cosí, l’uomo forte e virtuoso autodetermina il proprio destino riconoscendosi quale ‹cittadino del mondo›, ch’è appunto il modo (raccomandato soprattutto da Seneca) di svuotare dall’interno e di cancellare la nozione stessa di esilio. In un passo del capitolo De exilio il Petrarca cita prima di tutto una risposta di Socrate che leggeva nelle Tusculanae: «Socrate a uno che gli chiedeva di che paese fosse rispose: ‹Del mondo›, come colui che si riteneva abitante e cittadino del mondo intero».7 Né vi leggeva solo questo, ovviamente, ma anche tutto il capitolo relativo, § 106–109, inteso precisamente a ridimensionare l’opinione che l’esilio sia un gran male, quando invece moltissimi illustri filosofi passarono la vita lontani dal loro paese, e dove infine Cicerone si chiede: «Che considerazione si può avere della qualifica di cittadino in una città dalla quale gli onesti e i sapienti vengono cacciati?», e ancora aggiunge ch’è assai meglio la libertà in esilio che la servitú nel proprio paese attraverso l’esempio di Demarato, fuggito dalla tirannide che opprimeva Corinto e approdato in Italia, a Tarquinia.8 Il nucleo del ragionamento del Petrarca e il suo generale intento dimostrativo non è diverso da quello di Cicerone e, dopo il momentaneo allargamento al motivo della vita stessa come esilio nei confronti della ‹vera› patria celeste, giunge per forza propria a incardinarsi sul concetto espresso molte volte da Seneca e divenuto topico, per esempio anche in Stazio, che a sua volta proclama: «La terra intera è il suolo natale dell’uomo».9
Il famoso verso ovidiano, Fast. 1, 493, appena sopra ricordato, che per intero suona «Non c’è terra che non sia patria all’uomo forte, come l’acqua per i pesci» (ma il Petrarca, abbiamo visto, ne cita solo la prima parte) era già stato ripreso in un passo famoso da Dante, De vulg. el. 1, 6, 3: «noi che abbiamo per patria il mondo come i pesci hanno l’acqua» (Nos autem, cui mundus est patria velut piscibus equor), ma è già in Brunetto Latini, Tresor 2, 84, 11, ov’è uno scambio di battute a proposito dell’esilio tra Paor e Seurtez (Paura e Sicurezza): «Paura dice: ‹Sarai cacciato in esilio›. Sicurezza risponde: ‹Non mi è interdetta la patria ma un luogo, perché tutto ciò che è sotto il cielo è la mia patria […] Tutte le terre sono patria per il virtuoso, come il mare per il pesce›»,10 implicitamente ripetendo quanto faceva, per esempio, Ugo di San Vittore, che spostava il nucleo del discorso verso le qualità morali dell’individuo capace di una scelta siffatta: «È forte quell’uomo per il quale la patria è dappertutto, ma è perfetto quello per il quale il mondo intero è luogo d’esilio»,11 e che, soprattutto, concentrava in un’unica espressione quella distinzione e gerarchizzazione dei due diversi esilî, quello nei confronti della patria terrena e quello nei confronti della patria celeste, alla quale anche il Petrarca, quasi dilatando dall’interno le parole di Ugo di san Vittore, rende omaggio. Ma il Petrarca, per l’appunto, preferisce restare sulla terra e insiste sul tema dell’esilio volontario, quale gesto capace di capovolgere una situazione nella quale l’ingiustizia sembra prevalere, e di ridare al soggetto dignità e libertà. Perciò esorta: «Vattene di tua volontà: cosí sarà un viaggio, non un esilio», e poco avanti:
Scacciato dai peggiori, entra a far parte dei migliori, e dimostra con i fatti che non sei tu indegno della patria, ma la patria di te. Sia lei ad accorgersi di quanto ha perduto, e tu convinciti di non aver perso un bel nulla […] Siano loro a soffrire d’essere lasciati soli, mentre tu godrai d’essertene andato in compagnia. Non voltarti indietro; non pensare a tornare; non voler stare con quelli che vogliono che tu te ne vada. Insomma, non metterti nella condizione di sopportare malamente che altri facciano quello che avresti dovuto fare tu.12
In questa chiave, trovo assai significativo il rimprovero che il Petrarca muove contro Cicerone, che per ostinazione e vanità non ha capito quando sarebbe stato il momento, per dire cosí, di battere sul tempo i nemici e di sottrarsi alla lotta mettendosi in salvo. Nella seconda delle lettere a lui dirette, la Fam. 24, 4 (probabilmente del 1345), gli scrive: «nella tua vita cerco invano solo la fermezza d’animo, la ricerca della quiete ch’è necessaria a chi vuole far professione di filosofo e la fuga dalle guerre civili, quando la libertà è morta e la repubblica già sepolta e compianta».13 Si osservi come la parola-chiave sia qui fuga: la fuga che diventa un obbligo morale per il ‹filosofo› che abbia lucidamente previsto il venir meno delle speranze e la catastrofe che l’aspetta: allora, egli deve sottrarsi ai nemici che lo circondano, tornare a se stesso e fuggire se non vuole restare compromesso nelle follie e nei crimini della storia, e deve riscoprire nella quiete dell’isolamento la sua vocazione allo studio e alla meditazione che fanno di lui un ospite e un testimone, non un attore sul palcoscenico della lotta politica. E ancora non posso trattenermi dal citare un passo dalla Repubblica di Platone, 496c5, che largamente prefigura l’atteggiamento del Petrarca, e illustra quanto sto cercando di dire. Quando la città è irrimediabilmente in rovina,
colui che fa parte di questi pochi [filosofi] e che ha gustato la dolcezza e la felicità di un simile bene, resosi conto della pazzia dei piú, del fatto che nulla vi sia di sensato nel comportamento di nessun uomo politico e del fatto che non vi sono alleati con cui intrapprendere la difesa della giustizia, senza esporsi alla morte; quando simile a un uomo caduto in mezzo a belve feroci, al furore delle quali egli rifiuta di associarsi, senza per altro essere in grado di tener testa da solo a quell’orda selvaggia, è quindi sicuro di morire prima di aver servito la sua città o i suoi amici, senza profitto né per l’una né per gli altri; dopo aver riflettuto su tutto ciò, egli si astiene dall’agire e non si occupa che dei propri affari, e come un viaggiatore sorpreso dalla tempesta ripara dietro a un muro dal turbine di polvere e di pioggia sollevata dal vento, allo stesso modo, nel vedere gli altri traboccare di ingiustizia, egli si ritiene fortunato di trascorrere l’esistenza quaggiú puro dall’ingiustizia e dall’empietà e di uscire dalla vita nella speranza, con serenità e pace dell’anima.14
Può darsi che le ultime citazioni appaiano solo indirettamente legate al tema dell’esilio. Non è cosí. Ci danno, invece, l’orizzonte ultimo entro il quale il discorso del Petrarca sull’esilio trova il proprio posto ed esalta i suoi significati. Fissiamo, per questo, alcuni momenti importanti dai quali ripartire.
1 Seppur per pochi esempî abbiamo visto come il Petrarca presenti l’esilio come una condizione che il soggetto può assumere come una propria scelta sí da anticipare una sentenza di condanna oppure, una volta subíta, a svuotarla di senso. Ora, non c’è dubbio che la parola che piú concretamente si avvicina a un siffatto esilio sia la fuga.
2 Un tale esilio / fuga è giustificato e addirittura esaltato come un atto di lucida autodeterminazione inteso a ricostruire attorno al soggetto le condizioni della sua possibile realizzazione: in ultima analisi, le ragioni medesime della propria vita e della propria felicità.
La dimensione rigorosamente individuale nella quale l’esilio precipita non solo indebolisce ma propriamente recide il legame organico e viscerale del soggetto con la propria patria e la propria terra e la propria gente. L’uomo forte e virtuoso, infatti, non se ne fa condizionare: semmai, costretto all’esilio, arriva a intendere come quel legame fosse in realtà un limite ch’egli è perfettamente in grado di superare riconoscendosi come ‹cittadino del mondo›.
La fuga è una parola estremamente significativa nel Petrarca, sulla quale è necessario fermarsi.15 Non però sul campo metaforico dell’inarrestabile fuga temporis, dentro il quale sta il tema della fuga della giovinezza e della bellezza del corpo,16 ma piuttosto su quello che qui ci riguarda da vicino della fuga vera e propria. All’interno di una tale fuga possiamo azzardare, per amor di schema, due livelli, diversi ma intimamente connessi. Il primo, piú basso, la contempla come espediente per sottrarsi ai fastidî e alle contrarietà quotidiane; l’altro carica la fuga di valori morali e ne fa una scelta di vita che si sublima nell’azione risolutrice attraverso la quale l’individuo esercita al massimo grado la sua libertà: libertà di rifiutare il cumulo delle catene che il mondo gli ha stretto attorno, e di rideterminarsi secondo la propria autenticità. Nell’egloga 8, Divortium, per esempio, sin dalle prime parole (Quo fugis?), è chiaro che proprio questa è la fuga della quale si tratta, capace addirittura di spartire in due la vita intera: il ‹prima› della giovinezza e della maturità asservite, e il ‹dopo› della libertà tardi riacquistata nella stagione che volge ormai alla vecchiaia e alla morte.
Naturalmente, il livello superiore non esclude, ma integra e nobilita l’inferiore. Un esempio concreto e centrale nel Petrarca. Il ritiro a Valchiusa rischiava d’essere interpretato in chiave meramente strumentale, come fuga dagli obblighi troppo diretti di un servizio gravoso e come egoistica ricerca di una ‹qualità di vita› migliore anche sul piano estetico della caotica, sporca, rumorosa vita cittadina che il Petrarca tante volte descrive e condanna, e persino come astuto stratagemma per acquisire una visibilità tutta particolare, come Agostino nel Secretum obietterà a Francesco.17 Ma, per l’appunto, il De vita solitaria ha lo scopo di conferire piena autonomia morale e ideologica a una tale fuga, che il trattato dimostra essere un valore assoluto degno in sé d’essere perseguito e realizzato. Il punto sul quale vorrei insistere è però un altro. Di là dall’arco delle varie interpretazioni che lo schema tracciato contiene a stento, la fuga nel Petrarca è un’esperienza esistenziale quasi sempre connotata in senso positivo.18 Il che è perfettamente coerente con il fatto –vado subito al punto – che, salendo di grado in grado, il massimo di libertà che l’individuo possa esercitare nel mondo consiste, come ho appena accennato, nell’esercizio attivo e fortemente voluto di una capacità di rifiuto attraverso il quale egli arriva a restituire sé a se stesso. Per questo la fuga, per piccola o episodica che sia, è sempre giusta: perché è sempre una scelta di libertà (anche nei confronti dei legami amorosi, visto che nel libro III del Secretum Agostino raccomanda in maniera sin quasi ossessiva a Francesco il rimedio della fuga), ed è insomma, a mio giudizio, una delle chiavi essenziali per comprendere il modo tutto petrarchesco di porre la questione dei rapporti con il mondo del potere in chiave non politica ma esistenziale (lasciando dunque su un piano completamente diverso quella che è stata la concreta attività diplomatico-politica da lui esercitata al servizio dei Visconti). Ma questo discorso ci trascinerebbe troppo oltre. Restiamo invece alla fuga / esilio, e osserviamo che per il Petrarca è il mondo delle cose e il mondo della storia cosí com’è fatto a imporre la fuga come l’unica arma davvero efficace per chi se ne voglia difendere. Appriamo un’altra breve parentesi. Nella splendida Prefatio al libro II del De remediis il Petrarca sviluppa con ampiezza il tema dato nelle prime righe: di tutte le cose lette o ascoltate nulla gli è rimasto piú impresso nell’animo della sentenza di Eraclito secondo la quale tutto ciò che avviene è il risultato di una lotta: «Omnia secundum litem fieri».19 Un poco grossolanamente, il mondo è in perenne guerra con se stesso, e la fatica e il dolore sono le inevitabili compagne di tutto ciò che giunge a esistere, al punto che la possibile e fragilissima felicità umana consiste nel saper usare di un unico universale ‹rimedio›: tenere il mondo a distanza, fuggirlo, trasferendo all’orizzonte cristiano le massime della morale stoica. E l’intero De remediis non fa che decostruire con pazienza l’inessenziale accumulo delle circostanze, non fa che togliere, eliminare per arrivare, ogni volta, al puro nucleo esistenziale dell’io che di per sé, nel suo elementare porsi come tale, è altra cosa da ciò che lo circonda e in infiniti modi lo minaccia, e solo ascoltandosi e restando fedele a se stesso può resistere a un tale micidiale assalto. Su questa essenziale, pervasiva arcatura morale poggiano molte delle riflessioni del Petrarca, e vi poggia l’egloga Divortium (del 1347: mette in scena il distacco del Petrarca dal vecchio padrone / protettore, il cardinal Giovanni Colonna), che applica al caso specifico una verità ben piú generale, dappertutto leggibile in trasparenza, e richiamata con particolare forza al v. 19, là dove Amiclate / Petrarca supplica il Colonna: «Permettimi una fuga giustificata, e abbi pietà di me che vi sono costretto» (iustam permitte fugam, et miserere coacti). Ma perché ‹costretto›? Dal momento che il Colonna finirà per accontentare il poeta (v. 121: I, tamen […]), dov’è piú la fuga e la coercizione? Il fatto è che il Petrarca riferisce la propria situazione personale a uno schema piú comprensivo, entro il quale è pur sempre un atto di rifiuto e di fuga a caricarsi di valori morali e a presentarsi, per questa via, come ‹obbligato›.
Ecco qualche esempio significativo. In una lettera, la Fam. 5, 14, variamente datata al 1343, 1345, 1347 e 1351, lamentandosi di non poter cacciare un vecchio servo rabbioso il Petrarca scrive: quem fugare non licet, fugiam, cioè, giocando su fugare / fuggire, «visto che non posso cacciarlo, me ne fuggirò io».20 È un caso minimo, certo, ma ecco che lo stesso gioco di parole è investito da una riflessione di tono piú serio nelle parole ammonitrici con le quali si conclude il primo libro del De vita solitaria: «Che dunque, se non ricorrere al mio solito consiglio, di fuggire dai mali che non possiamo scacciare? A ciò, l’unica salvezza e rifugio che conosco è una vita solitaria».21 E piú tardi, di nuovo, raccomandando di mettersi al riparo dai «minuti fastidî» della vita che non si riescono a evitare altrimenti: «Ama il silenzio dei boschi: occorre fuggire dalle cose che non si possono né sopportare né scacciare».22 Alla fine di novembre 1347 il Petrarca, arrivato a Genova da Avignone, scrive a Cola la famosa lettera con la quale gli dichiara d’abbandonarne la causa e di lasciarlo al suo destino, e tra altre cose scrive qualcosa che, ormai lo sappiamo, occupa una parte importante nella sua visione della vita: «Perché dovrei torturarmi? Le cose andranno cosí come l’eterna legge del destino ha stabilito: non posso cambiare il corso delle cose, ma posso fuggirle […]».23 Qui non siamo dinanzi ai ‹minuti fastidî›, ma a una situazione che impone una precisa scelta di vita e raccomanda la fuga come un vero e proprio imperativo morale: ancora nel 1356, del resto, contro i focolai di guerra che rendono insicura parte del nord-Italia, il Petrarca confessa al Nelli che non c’è miglior rimedio della fuga (quod remedii genus optimum fuga est).24 Altre occorrenze non mancano, specie nel primo libro del De vita solitaria e nei numerosi testi che esaltano quale modello di vita il ritiro valchiusano, opposto a quello della fetida e corrotta Avignone / Babilonia: vd. tra tanti Rvf 114, 1–4: «De l’empia Babilonia, ond’è fuggita/ ogni vergogna, ond’ogni bene è fori,/ albergo di dolore, madre d’errori,/ son fuggito io per allungar la vita».25 Spesso il Petrarca ripete ch’è opportuno fuggire dalla città, dal contatto con il volgo, dai fastidî della vita quotidiana: si veda come sia esaltata la laborum fuga sin nell’intitolazione di Fam. 11, 5, e addirittura positivamente equiparato l’esilio alla fuga in Fam. 21, 9, 15: «quello che chiamano esilio non è altro che una fuga da innumerevoli fastidi» (id quod exilium vocant, fugam innumerabilium curarum). Questo continuo, vario e spesso sottile ‹elogio della fuga› abilmente e sottilmente intrecciato all’‹elogio dell’esilio› che percorre le pagine del Petrarca ci fa tornare alla seconda lettera a Cicerone, Fam. 24, 4, 2, che, sopra, ha costituito uno dei punti di partenza di questo discorso, e ce lo fa meglio comprendere. Rimandandoci, per esempio, al tentativo di Cola che ha finito per rimettere all’ordine del giorno il problema dei rapporti del Petrarca con i vecchi padroni e con la curia tutt’intera, e ha creato, insieme, le condizioni di non ritorno per la fuga risolutrice che non solo taglia con una serie di compromissioni vecchie e nuove, ma pone, in alternativa, un’esigenza di libertà finalmente e chiaramente intesa all’edificazione di un autonomo ed esemplare progetto di vita. L’ultimo provvisorio soggiorno in Provenza, dal giugno 1351 al giugno 1353, è una sorta di parentesi che non sovverte questa linea, che ne riesce, semmai, confermata. Proprio nel 1352 il Petrarca, infatti, scrive al Cavalchini che unica soluzione per entrambi è quella di fuggire dalla pestifera Avignone, e nell’aprile dello stesso anno ripete che dinanzi a quella ‹spelonca di ladroni› che la curia è diventata non esiste altro rimedio che il piacere della fuga.26 E infine, sempre in quell’aprile, nella Fam. 15, 7 diretta a Stefano Colonna prevosto di Saint-Omer, passando in rassegna la situazione politica dell’Italia e dell’Europa, ripropone con efficace retorica il motivo dell’intima dialettica che corre tra costrizione e libertà:
Fa quello che fanno gli uomini puliti, e non solo gli uomini ma anche alcuni animali di pelo candido che hanno paura della sporcizia e che, uscendo dalla tana, se vedono che il terreno attorno è lordo di fango, ritraggono il piede e tornano a riparare nel loro nascondiglio. Cosí anche tu, se non trovi da alcuna parte ove avere quiete e riposo, rientra nella tua camera e torna a te stesso: veglia con te, parla e taci con te, passeggia con te, fermati con te, e stai certo che non sei solo se stai con te […].27
Potremmo anche tradurre la dicotomia tra costrizione e libertà con quella tra la storia e l’individuo, che proprio attraverso le ‹prove› alle quali è costretto ha modo d’esercitare la propria libertà e d’alimentare il mito della propria separatezza intesa come la garanzia d’una superiorità criticamente ed eticamente fondata nei confronti del proprio tempo. Una separatezza che definisce nettamente i contorni dell’io e della scena che gli appartiene e nella quale agisce, ricavando gran parte della sua consistenza drammatica e del suo fascino dall’originaria rottura, subíta e cercata insieme, nei confronti delle patrie possibili. Al proposito, tra altri che si potrebbero addurre, c’è un testo che mi sembra particolarmente significativo, l’epistola in distici rimati Exul ab Ytalia.28
Nel dicembre 1343 il Petrarca aveva acquistato in Parma la casa che già aveva abitato l’anno precedente, ma nel 1344 Azzo da Correggio vendette la città a Obizzo d’Este suscitando la reazione del Visconti che mise la città sotto assedio, determinando con ciò, da una parte e dall’altra, una fitta serie di contrapposte alleanze. Il Petrarca ne fuggí avventurosamente il 23 febbraio 1345,29 riparando a Verona e tornando poi attraverso un lungo giro per la valle dell’Adige, il passo di Resia, il Tirolo e infine la valle del Rodano, a Valchiusa, ove giunse verso la metà di dicembre. E appunto nella primavera del 1346 indirizzò all’amico Philippe de Cabassole, da poco tornato da Napoli con un messaggio al papa da parte della regina Giovanna, la Exul ab Ytalia, invitandolo ad abbandonare ogni impegno in senso lato politico e diplomatico e a condividere con lui la scelta di ritirarsi nella rustica quiete di Valchiusa.30 A monte della lettera stanno dunque due esperienze drammatiche: quella napoletana del Cabassole, che aveva visto, in un crescendo di trame e tradimenti, nel settembre 1345, l’assassinio nel castello d’Aversa del giovane Andrea d’Ungheria, marito della regina Giovanna che del crimine fu complice, e quella parmense del Petrarca medesimo, testimone diretto della continua serie di guerre tra potentati locali che dissennatamente laceravano l’Italia. L’epistola medesima, del resto, lo sottolinea con efficacia:
Hic tibi Parthenope, dulcis michi reddita Parma,
quas non insidiae quatiant nec clamor ad arma.31
Nel suo insieme, la lettera suona come un manifesto di quell’ideologia della fuga e dell’auto-esilio quali condizioni di una vita libera e serena pur se avvolta in una realtà scellerata fatta di tradimenti e delitti, ed ha per noi un motivo di speciale interesse tanto nei versi d’esordio quanto in quelli finali:
Exul ab Ytalia furiis civilibus actus,
huc subii partimque volens partimque coactus
[…]
Hec tibi per silva scripsit, dignissime presul,
ille tuus, Sorge dicam peregrinus an exul.32
Exul è, si osservi, la prima e l’ultima parola del componimento, che ne è come rinserrato, cosí come il felice modello di vita valchiusana è rinserrato entro un mondo ostile, ed è di dolente intensità lo stato d’animo di chi ha deciso di fuggire ed è contento d’averlo fatto, ma pure vede benissimo quanto la propria decisione sia frutto d’una invincibile costrizione, e insomma configuri il tragico ed essenziale paradosso secondo il quale, nella vita, le scelte di libertà sono imposte dalla necessità. Cosí, nelle verità dell’animo di chi patisce violenza anche le magniloquenti sentenze della moralità stoica si incrinano, e il poeta cacciato in esilio dall’Italia dalla furia delle guerre civili è tornato a Valchiusa in parte per averlo voluto e in parte perché costretto, sí che alla fine, dopo aver illustrato le delizie del suo rifugio transalpino, deve pur ammettere di non sapere se vi dimorerà e v’invecchierà come uno straniero di passaggio, come peregrinus, oppure, in senso proprio, come esule. Cioè, in un caso o nell’altro, come un senza patria, exul ab Ytalia.
Capiamo cosí come l’opposizione che abbiamo visto porre nel De remediis, 2, 67, 12, tra l’esilio e la volontaria peregrinatio: I sponte: peregrinatio erit, non exilium, non sia cosí tranquillizzante e definitiva come si vorrebbe, visto che una peregrinatio coatta mantiene qualcosa sia della fuga che dell’esilio, e ci vuole davvero molto poco perché si colori di sfumature che ne piegano il senso in una direzione o nell’altra. Naturalmente, ciò non mette in discussione il valore di quelle formule della magnanimità, che tuttavia si rivelano percorse, sotto pelle, da perturbanti vibrazioni, come a me pare di vedere, per esempio, anche nella prima lettera all’Appenninigena, ove di nuovo il discorso petrarchesco torna a battere sulla distinzione tra peregrinatio ed exilium:
Occorre che intervenga un elemento di costrizione e di dolore affinché si possa parlare di vero esilio. Se lo ammetti, vedrai allora che dipende da te l’essere un esule o piuttosto un viaggiatore: se te ne sei andato piangente, triste, abbattuto, ti riconoscerai senz’altro come un esule; se invece hai obbedito all’ordine di partire senza dimenticare la tua dignità e senza piegarti, ma con lo stesso atteggiamento sia esteriore che intimo che avevi in patria, allora sei in viaggio, non in esilio.33
Resta dunque pur vero che per il vir forte e virtuoso ‹l’esilio non esiste›, visto che sembra possibile non viverlo come tale, ma è altrettanto vero che un tale vir non è una creatura in carne e ossa ma un modello ideale verso il quale si può tendere per tentativi, per approssimazioni necessariamente imperfette, mentre questa radicale riduzione alla dimensione esistenziale e soggettiva lascia margine a un principio di mistificazione e persino d’ipocrisia, visto che il ‹male di vivere› non ha alternative possibili e il soggetto che proclama la propria libertà di fuggire è forse piú d’altri inchiodato alle leggi della necessità. Agostino ha definito gli stoici come degli ‹infelici con coraggio›: ecco, forse è proprio questa bella formula a tracciare l’orizzonte entro il quale sta anche la singolare percezione che il Petrarca ha della propria condizione di apolide, teorizzata, difesa, esaltata, eppure sofferta proprio in quanto ha di piú vero e profondo: il disincanto, la fuga. In altre parole, guardando alle cose dal lato di chi lo soffre, la fuga è l’intima verità dell’esilio. E il saggio – dice il Petrarca, – non ha per l’appunto altra scelta oltre questa lucida consapevolezza, e l’esilio per lui non esiste semplicemente perché nient’altro definisce meglio l’essenziale solitudine della condizione umana e della sua in particolare: la patria è come l’abito che indossa e porta con sé nella fuga, che lo segue… Il saggio è tale perché ha imparato a sue spese a essere patria a se stesso. In altri termini, di là da applicazioni piú normali e scontate, si direbbe che il Petrarca secolarizzi la nozione cristiana dell’esilio, riportandola dal cielo alla terra. L’uomo non solo è in esilio rispetto alla sua «vera» patria celeste, ma lo è pure rispetto al mondo, cioè alla sua «vera» patria terrena, e quanto gli è dato di ricostruire attorno a sé non dipende che da lui solo, proprio come il Petrarca ricorda al Cabassole: «Dovresti però cercare da te stesso, con le tue forze – e il cielo ti ha dato alto ingegno – di tirare in secco la fragile barca».34 Il che ci immerge nell’altra sottile dialettica: da una parte sta la massima che, prima di Dante, Brunetto ripiglia da Ovidio: «Toutes terres sont païs au proudome autresi come la mer au poisson», che conferisce alla vita la dimensione ulissiaca di un perpetuo viaggio oltre ogni confine di natura geografica e politica; dall’altra sta l’invito, per restare alla metafora marina, a tirarsene fuori, da quel mare, e a godere di un porto sicuro ove ricreare la propria personale ‹piccola patria›, se è vero che un esilio breve restituirà l’individuo alla propria patria, e uno lungo gliene farà trovare una nuova.35
A questo punto, il discorso appena comincia, e ha davanti a sé molte strade, che piegano o superano il tema dell’esilio in direzioni particolari, che a tutta prima possono apparire persino vistosamente contraddittorie rispetto a molti degli enunciati visti sin qui. Si pensi, per non dir altro, al patriottismo tutto italico del Petrarca, declinato spesso in chiave anti-francese: sarà pur vero che patria dell’uomo è il mondo intero, come i suoi filosofi gli insegnavano, ma certo il Petrarca non riesce neppure a immaginare che Francia, Spagna, Inghilterra, e insomma l’Europa intera, valgano quanto un’Italia che resta, nonostante tutto, l’unica vera testimone della grandezza di Roma e nella quale egli riconosce l’unica patria possibile, e della quale fonda il mito. Di qui, da questo appassionato riconoscimento al quale, si può ben dire, il Petrarca ha dedicato la vita, entra in lui prepotente e prende vita (è questo un punto ben illustrato da Luca Marcozzi) il tema di un esilio vissuto non nello spazio ma nel tempo. Investendosi della missione di restauratore dell’Antichità, egli dà corpo a «una costellazione allegorica che tematizza il bando delle muse rappresentandolo come esilio della poesia e degli studî dal mondo contemporaneo», e rappresenta se stesso come l’ultimo custode dei valori che il presente rifiuta e addirittura combatte. Il tema della cacciata della poesia e della philosophia dal mondo del suo tempo – parallelo a quello dell’opposizione tra la Roma ideale dell’umanista e la corruzione di Babilonia – finisce per innervare nel profondo anche i Rerum vulgarium fragmenta, «in cui l’immagine della virtú letteralmente sbandita dal presente è una dolorosa metafora della marginalizzazione degli studia humanitatis, in cui l’esilio del sapere e delle virtú è tematizzato come un esilio reale. Su questo esilio di natura esclusivamente letteraria il Petrarca incardina una rappresentazione esemplare di sé destinata a divenire un prototipo della Modernità, quella del malessere degli intellettuali nel loro tempo, del quale si sentono, per varie ragioni, esclusi, esiliati, banditi».36 Ancora, è fortissimo il legame che corre tra quanto egli afferma sulla natura dell’esilio e la pessimistica visione di un mondo governato dalle feroci leggi del potere e della guerra, che all’individuo non lascia altro spazio che non sia quello della fuga, nutrita dagli studî e dai sogni di tempi migliori. Di qui, quella sua visione a- o addirittura anti-politica, che mette al centro una nozione nuova e per qualche aspetto eversiva della felicità individuale, che inevitabilmente si scontra con le manifestazioni di un potere che pare non abbia altro concreto effetto oltre quello di rendere rara e difficile la pace, ch’è intima aspirazione non solo del poeta e dell’intellettuale, ma dell’umanità tutta intera costretta a una sorta di fuga perenne. Sono, come si vede, strade tutte decisive per comprendere meglio la natura dell’opera del Petrarca. Ma, come del resto ho anticipato, qui ho solo cercato di accostare qualcuno dei modi intelligenti e sottili in virtú dei quali quelle che sono talvolta apparse come topiche e pompose banalità sono animate da una nascosta e sofferta passione, da una vibrazione esistenziale che le riscatta e restituisce loro il fascino inquietante della verità.