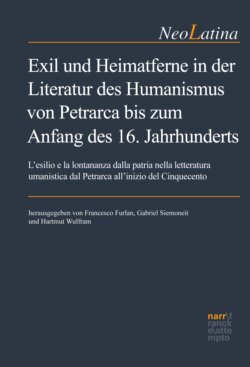Читать книгу Exil und Heimatferne in der Literatur des Humanismus von Petrarca bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts - Группа авторов - Страница 7
Della scrittura petrarchesca come esperimento dell’esilio
ОглавлениеPhilippe Guérin (Université Paris-Sorbonne Nouvelle)
Totam fere usque ad hoc tempus in
peregrinationibus vitam duxi
(Sen. IX 2, 1)
Di tutte le cose eccellenti che si sono scritte di recente sul Petrarca e l’esilio vorrei tenere a mente i tre o quattro capisaldi seguenti.1
«Concepito e nato in esilio»: cosí scrive (e ripete) il Petrarca quando parla di se stesso; ma, esiliato, lo è per modo di dire, l’esilio stricto sensu non essendo affatto applicabile alla sua biografia.2 Intende in realtà con questa formula esprimere la percezione che ha della sua condizione esistenziale, dire il suo specifico, vagabondo, essere-al-mondo.3 E il riflettere sull’esilio gli consente di fare il filosofo morale stoico: sia esso quello vero e proprio, oppure quello piú lieve di chi, per necessità ‹professionali›, deve lasciare la patria suo malgrado,4 l’esilio, se lo si considera bene, non è niente.5 Posizione etica che si combina con la visione cristiana del nostro transitus sulla terra, esilio fuori della vera patria, quella celeste cui la nostra anima è bramosa di tornare liberandosi dal carcere del corpo (il carcer exiguus di Rem. II 67, 10).6
A quest’interim,7 il Petrarca dedica la maggior parte del suo tempo – in un’ottica a dire il vero per lo piú profana, volta cioè a pensare la vita mondana, a cercare risposte valide per affrontare quella che è la nostra effimera sorte quaggiú. E quaggiú, per l’appunto, su questa terra, il Petrarca non ha, non vuol avere nessuna patria fissa e definitiva: è lo stesso mondo (l’orbe) che, socraticamente,8 delimita lo spazio di un vivere che è anzitutto, per opzione consapevole, un peregrinare, un exilium-peregrinatio.9
L’alternativa, come scelta di vita, è chiaramente delineata nella lettera familiare II 3 già citata (la consolatoria di data incerta a destinatario forse fittizio) che fa dell’esilio il suo argomento centrale. Il modo in cui si vive tale situazione dipende da una decisione razionale del soggetto interessato (quando precisamente si fa soggetto della propria storia): o la si patisce passivamente, questa sorte, ed è sofferenza e tristezza, è esilio vero e proprio; o si parte consenziente, trasformando l’esilio in un semplice exire, una peregrinatio per l’appunto, che trasfigura l’esperienza traumatica e dolorosa in occasione di crescita morale e intellettuale.10 Noteremo anche che a questo punto si sfiora, con l’interrogazione sull’etymon (isidoriano, cioè extra solum), un’altra costante delle scelte esistenziali petrarchesche, quella della solitudine, del ritiro solitario che appare cosí una sorta di piccolo esilio volontario.11
Posto sotto il segno del rifiuto di qualsiasi piccola patria, a favore di orizzonti sempre rinnovati, l’esilio, considerato cosí, è libertà, e la patria di cui sopra, che ci rinserra tra le sue mura, prigione dove sarebbe stolto voler tornare.12 Il cielo è lo stesso dappertutto, e la condizione dell’esule risulta addirittura invidiabile. L’attaccamento alla patria considerata stricto sensu è invece indizio d’animo angusto.13 Bisogna essere capaci di fuggire, anche dagli affetti piú consolidati, per amore della libertà.14 E anche se, in una prospettiva penitenziale, tale fuga e tale libertà in fin dei conti si rivelano senz’altro illusorie.15
Peregrinus ubique, dunque, e comunque, secondo la nota formula dell’Epystola metrica III 19 a Barbato da Sulmona: peregrinus, cioè nel contempo viaggiatore e straniero. Di tale «stile di vita»16 incarnazione esemplare appare il personaggio di Ulisse, anche per la capacità che offre di distinguersi, confrontandosi all’ingombrante autore del canto XXVI dell’Inferno.17 La peregrinatio ulissea18 sola consente di soddisfare appieno il visendi discendique studium.19 L’animo forte è proprio quello che non rilutta a rimettersi continuamente in moto. Si tratta di un Ulisse il cui viaggio non conosce nessun termine preciso – né casa, né naufragio come punizione di hybris colpevole.20 Non c’è altro termine se non quello sicuro ma imprevedibile della morte naturale. Il perlustrare di continuo contrade nuove è il motore che ci fa andare avanti. E, sul piano che ci interessa ora, quello della scrittura, propendiamo per una comprensione del processo di scrittura nel poeta che, integrando la figura dell’eroe greco, faccia il giusto posto al grande mitologema dell’exul-peregrinus.21 Se vivere è scrivere, tale attività propriamente vitale equivarrà a una vita-odissea nell’oceano delle literæ (in tutti i sensi), a un continuo peregrinare attraverso i segni, provocato dalla compulsione a lasciarsi dietro, esule volontario, tutti i luoghi attraversati. In un modo che resta da definire con maggiore nitidezza.
Ma precisiamo subito un punto. Il movimento in avanti, di fuga, non esclude il desiderio del ritorno, la nostalgia.22 Consideriamo l’esempio di Valchiusa, il porto terrestre per eccellenza.23 Il riparo provenzale, che consentiva di esiliarsi da Avignone,24 in cerca dell’agognata, ma nella realtà dei fatti sempre temporanea, solitudine, questo havre de paix cosí propizio alla scrittura,25 il Petrarca finirà col lasciarlo, come si sa, definitivamente. Con la decisione di volgere le spalle a Valchiusa, a un luogo che potrebbe offrire ancora diverticula amena,26 non vi potrà tornare che come ospite straniero. Epperò egli non riesce a eliminare un intenso senso di nostalgia, riandandolo col pensiero. Questa la dialettica tra, da una parte, la spinta, avvertita come necessità anche morale, a lasciare i luoghi dove successivamente ha eletto dimora e, d’altra parte, l’impossibilità di cancellare del tutto ciò che è stato, di reprimere definitivamente ogni fermento di doloroso richiamo del nostos. Nostalgia che, in altro modo, coinvolge anche l’Italia – quella che appare nell’opera petrarchesca la funzione-Italia, più che qualche luogo ben preciso, nemmeno la culla degli antenati.27 Quella che si potrebbe definire nostalgia del futuro, un futuro che affonda le radici nel passato remoto, seppellito sotto cumuli di rovine, dell’Antichità classica: questa la logica della renovatio.28 Memoria e speme, ossia una storia amorosa.29
L’esilio comporta di conseguenza una pregnantissima dimensione temporale.30 Che si radica anche nel disgusto del tempo presente, il che per l’appunto spinge il Petrarca verso l’Antichità – anche s’egli mitiga qui pure il discorso, affermando che l’amore dei suoi cari gli impedisce di desiderare d’esser nato in un’altra età.31 Come per l’invecchiamento, allontanamento da quel che si è stato, esilio da sé che si dispiega progressivamente nel tempo, vi è deplorazione (della caduta, che suscita sgomento) ma nel contempo esultanza della (ri)scoperta del passato seppellito che (ri)affiora… Perpetue oscillazioni tra approdi e nuove partenze, con traduzione sul piano della scrittura dell’opera tutta.32
Di che tipo di viaggio attraverso i segni si tratta, dunque, limitando ora il discorso ai Rerum vulgarium fragmenta?33 Sul piano tematico, molto si è scritto, a cominciare dalla necessità per il Nostro, nel momento stesso in cui decostruisce il concetto di patria, di fare i conti con tutta una tradizione ancora recente che aveva fatto dell’esilio, liricizzandolo, uno dei cardini dell’ispirazione poetica.34 Ma se l’esilio-peregrinatio, cosí come lo concepisce il Petrarca, è experimentum [sui],35 e dunque occasione d’autoconoscenza, se l’errare ulisseo è esperienza e acquisizione di conoscenza, allora la lingua (poetica) recherà traccia (spie e indizî) anche di quell’atteggiamento fondamentale. Traccia retorica, per cominciare – ma non ci soffermeremo.36 Serve qui però ricordare la teoria petrarchesca dell’imitazione, della mellificazione (o della setificazione), come processo attivo di produzione, rigorosamente sperimentale, ancorato nello studium (in tutti i sensi) di chi ci si dedica: cominciando dal viaggio attraverso i libri, le opere.37 Impegno assiduo, al limite pericoloso: si veda il titolo eloquente della Sen. II 3 ([…] quanti laboris et periculi sit scribere […] Et experientiam matrem artium omnium esse).38 E piú eloquente ancora, la straordinaria pagina della stessa missiva, in cui per illustrare il detto aristotelico experientia artem fecit, si volta repentinamente verso lo spettacolo che ha sotto gli occhi: il porto di Venezia, dove si pratica su grande scala l’arte nautica, prolungando splendidamente e per il bene di tutti gli esordî ancora esitanti, ma già esaltanti, degli Argonautica.39 Qualche verifica, o piú modestamente sondaggio, per mettere l’ipotesi di partenza alla prova.
Sorge una prima domanda, relativa alla funzione del sostrato tosco-fiorentino della lingua petrarchesca costatato dagli specialisti.40 Non può bastare, ovviamente, una spiegazione fondata sulla lingua d’uso nell’ambiente familiare in cui crebbe il piccolo Francesco – la sua lingua poetica non è riconducibile a quella degli «usi pratici».41 Lingua che comunque non è quella che il Petrarca parlava ad Avignone o a Valchiusa, né in Italia, dove, a parte i soggiorni a Roma o Napoli (lontano da Firenze), il suo tropismo era settentrionale e lo spingeva in terra lombarda o veneta (inter Alpes et Apenninum, l’ipotesi privilegiata come approdo della sua navigatio intorno al 1353, anno della partenza definitiva dalla Francia).42 Ma un simile sostrato (tosco-fiorentino), perché essenzialmente la tradizione poetica cui attinge, pur radicata nell’humus provenzale (Triumphus Cupidinis IV, 40–55), saltando in sostanza i precursori siculi («fur già primi», ora sono «da sezzo», come recitano i vv. 35–36), è tosco-fiorentino («siculo-toscani» compresi, se è vero che «Guitton d’Arezzo» nel corteo dei poeti d’amore segue immediatamente Dante e «Cin da Pistoia»: si veda ibid., vv. 31–33; e anche Rvf 287 [all’esule Sennuccio, per la sua dipartita], vv. 10–11, dove l’ordine è però rovesciato).43 Ed è, sul terreno volgare, proprio Guittone che, insieme con il Dante «petroso» e, piú ancora, quello della Commedia,44 gli consente di mollare, anzi di rompere gli ormeggi che avrebbero potuto tenerlo ancorato alla piccola patria della tradizione lirica sboccata nel cosiddetto Stil novo (dolce, solo dolce, e leggiadro), epigoni compresi (Sennuccio e, per quel pochissimo che se ne può sapere, Franceschino).45 Ma si è premunito contro tale rischio, per l’appunto, coltivando la vocazione alla peregrinatio […].46
Ciò che di piú saldo resta della ormai contestata tesi continiana della «fiorentinità trascendentale» (eco del correlativo «autobiografismo trascendentale») è probabilmente il rilievo che riguarda la «misura per nulla trascurabile di defiorentinizzazione» di tale lingua.47 In termini piú semplici, il Petrarca rifiuta recisamente l’assimilazione senza piú alla lingua materna (quale madre, poi, o quale balia?), al fiorentino.48 Dall’imitazione pedissequa è sempre rifuggito, specie nelle «cose volgari», come da scogli («scopul[i]»: si noti il termine mutuato di nuovo dal linguaggio della navigazione).49 Per il servizio delle muse, esse stesse in esilio (Africa IX),50 l’«irrequieto turista»,51 il «poeta sradicato»,52 pratica la «miscidanza»:53 ecco il paradosso di un’appropriazione che è insieme necessario e voluto distacco, di una ricettività intimamente legata alla sua condizione di esule in lingua.
Tratto distintivo dei grandi scrittori (Cicerone, Virgilio e successori), d’altronde, di quelli dalle proposte inedite, sono i mutamenti con i quali arricchiscono la lingua54 – coniando parole nuove,55 imbastendo giri inediti,56 cercando ritmi nuovi (che si allontanano dalla tradizione lirica),57 sottoponendo il tutto a uno smanioso processo di ripresa e revisione.
Ambivalenza, allora, di quest’esilio volontario in lingua, rivendicato come tale, ma con accessi di nostalgia. In realtà, vige una stabile instabilità ricercata del sistema,58 che contempla la possibilità di nostalgici ritorni al fiorentino.59 La cifra che ne consegue, si sa, è il «vario stile», annunciato (ed esibito) nel sonetto proemiale dei Rerum vulgarium fragmenta, con le sue molteplici dimensioni. Ulisse rappresenta sia (in concorrenza con Enea) la forza (anzitutto d’animo, volontà indefessa d’andare avanti, in mezzo alle contrade [in]esplorate, spesso tempestose) sia, contemporaneamente, la fragilità (della condizione umana, in balia delle onde di una pericolosa navigatio).60 L’esperimentazione poetica ne rende conto tramite il «debile stile» mutuato dal flebile carmen dell’Ovidio pontico, il suo stile «incultus»,61 le «lappole et stecchi co la falce adunca» di Rvf 166, 8, fino allo «stile stancho e frale» di 354, 2.
Se ci rifacciamo poi alla dimensione temporale accennata sopra, l’esilio è tempo transitorio tra due mete: dapprima quelle constituite da nascita e morte. Ma anche, frattalmente, tra la seconda nascita al mondo del 6 aprile 132762 e il termine indeterminato della morte dell’io (che dovrebbe coincidere, finendo l’esilio terrestre, con la fine dell’altro esilio, la lontananza da Laura, essa stessa figurata numerose volte vita natural durante dagli allontanamenti episodici; intervallo di tempo all’interno del quale si staglia il tempo che intercorre tra l’incontro primitivo (come si parla di scena primitiva) e la scomparsa dell’amata (6 aprile 1348).63 Gli allontanamenti episodici cui accennavamo costituiscono altrettanti numerosi exilii, altri intervalli di tempo, in cui il cor, come abbiamo già visto sopra, si pasce «di memoria e di speme» (Rvf 331, 1a strofa). Perfino la modalità del futuro anteriore (o, variante, l’ipotesi della realtà al futuro, ma un futuro remoto) consente di proiettarsi in un tempo avvenire, in realtà mai avvenuto, in cui sarebbe data la possibilità di tornare indietro con il ricordo, verso il passato.64 Il tempo, insomma, non cessa di generare di queste frontiere: e da una data frontiera, ci si allontana, quando all’altra ci si avvicina.65
Donde anche l’onnipresenza del tempo sospeso, intervallato, del presente durativo: di un’esperienza dell’immobile mobilità, degli stati transitorî, come della memoria e dei suoi grumi di tempo rappreso. Cosí come si sottolinea il carattere durativo e iterativo (l’«incompiuto» per eccellenza, secondo i grammatici) del gerundio tanto amato dal Petrarca.66 I tempi verbali dall’aspetto per l’appunto «incompiuto» essendo inesorabilmente calamitati dal presente (altrettanto «incompiuto») della memoria (della sua durativa atemporalità) all’interno della quale viene ad alloggiarsi. Tra memoria futuri e memoria del passato, sospensione al «punto senza estensione» del presente.67 Ciò, in sintonia con l’osservazione secondo la quale il poeta, sul piano semantico dominante, quello di sostantivi e aggettivi,68 «si è chiuso in un giro di inevitabili oggetti eterni sottratti alla mutabilità della storia».69
La rammemorazione (attraverso la parola) apre la possibilità di esiliarsi dal presente, segnato indelebilmente dal difetto (di Laura, di Roma: di essere); sostituendolo con il presente di un piano ontologico altro, coincidente con il presente dell’enunciazione, è anch’essa un peregrinare nella lontananza, da un isolotto memoriale a un altro.70 Lacerti mnestici, pezzi di tempo psichico momentaneamente eternati, frammenti immobilizzati, fissati nel momento in cui stanno riaffiorando, ubbidendo alla logica del ritorno degli istanti dilatati.71 Agli antipodi di ogni realismo referenziale, abbiamo a che fare con una temporalità dell’entre-deux tipica delle situazioni d’esilio (anche metaforicamente concepito),72 ch’è spazio aperto per il ricordo di ciò ch’aveva indotto oblío:73 la dialettica già avvistata sul piano propriamente spaziale, in campo geografico, diventa quindi quella dello spazio che si fa tempo, come quando la distanza percorsa dall’aura si fa indice e misura del periodo trascorso nell’assenza.74 E ciò è fonte di piacere,75 che si nutre fin dall’inizio del paradosso d’un esilio ch’è un avvicinarsi (Rvf 209, 1–8):
I dolci colli ov’io lasciai me stesso,
partendo onde partir già mai non posso,
mi vanno innanzi et èmmi, ognor adosso
quel caro peso ch’Amor m’à commesso.
Meco di me mi meraviglio spesso,
ch’i’ pur vo sempre, et non son anchor mosso
dal bel giogo piú volte indarno scosso,
ma com piú me n’allungo, et piú m’appresso.
I fragmenta sono inoltre la forma per eccellenza della vita «partita» dai continui esilî.76 Partita, se non spezzettata, anche quand’è in cerca d’una sua unità. Fin dalla giovinezza, il corso dell’esistenza petrarchesca è posto sotto il segno della digressio.77 Non insisteremo sul livello macrostrutturale (la partizione 263 / 264 e il travaglio ad essa connesso, fino alla vigilia della morte),78 se non per ricordare che l’esilio di Laura in cielo (in realtà ritorno alla patria celeste) interviene sullo sfondo dell’esilio perpetuo dell’anima da se stessa, scissa tra i due porti antinomici verso i quali naviga: quello terreno dell’amore per Laura, o meglio della sua immagine memoriale (specie quando «sol memoria m’avanza»: Rvf 331, 10); 79 e quello di lassú raggiunto per l’appunto dall’amata. E che si ripercuote frattalmente nella partizione-frantumazione a tutti i livelli, esistenziali come scrittorî.
Quella dei fragmenta è in generale lingua dell’allontanamento: notiamo anche la presenza massiccia delle figure (in tutti i sensi) della distanziazione, o disgiunzione (sintattica),80 e della dissociazione,81 della scissione, delle dicotomie e delle antitesi…
Legherei allora tutto ciò alla crisi della referenzialità già evocata sopra, che poggia sulla particolare struttura del verso petrarchesco nelle sue componenti lessicali, sintattiche, e perfino ritmiche, con la «moltiplicazione delle sostanze e [la] loro frammentazione».82 Come in un processo di allontanamento dagli oggetti del mondo nella loro prepotente corporeità, il loro spessore triviale, e quindi un esiliarsi da esso mondo, a favore del viaggio interiore nei coaguli di coscienza.83
Il rischio di estenuazione del desiderio per colpa dell’oggetto sfuggente porta d’altronde il Petrarca in senso apparentemente contrario, ad allontanare, esiliare in poesia il detto oggetto al fine d’evitare la sua scomparsa: con perifrasi e traslati («colei che sola a me par donna», «fera bella e cruda» e «candida cerva», e, con lo stigma dell’emblema o dell’allusività, la quasi latina «arbor victorïosa trïumphale», «l’aura gentil», etc.),84 in cui si risolve la logica paradossale di tale desiderio, e della sua espressione.85 Se dobbiamo prendere alla lettera l’idea che ci sia evasività della lingua petrarchesca,86 questa caratteristica si dà anche perché evade da ogni realtà riconducibile all’attualità e all’identità (in senso proprio, letterale: ché l’identico petrarchesco non è mai identico a se stesso, come dimostrano, per stare a un esempio lampante, i rimanti delle sestine).
E su tutto ciò incombe infine il rischio dell’esilio da se stesso (cfr. per esempio Rvf 29, 36: «Da me son fatti i miei pensier’ diversi»),87 che tra le sue diverse modalità possibili può sfociare nell’afasia, prendere la forma specifica d’un esilio nel mondo del silenzio, almeno per quanto riguarda l’espressione lirico-elegiaca degli stati interiori.88
Procediamo, per finire, a un sondaggio piú puntuale su un singolo fragmentum.
Ci pare che la sestina Rvf 80 costituisca un caso esemplare di molte delle tendenze di fondo fin qui reperite. A cominciare dalla propensione cosí tipicamente petrarchesca a lasciare le rive in cui è appena approdato per cercare nuovi orizzonti, spostare, respingere i limiti per riprendere la navigazione allo scopo d’esplorare nuovi paesaggi mentali ed espressivi. Vediamo nel caso presente come il Petrarca si allontani dalla tradizione o, per meglio dire, da quello ch’è solo un abbozzo di tradizione, tale tuttavia per opera e merito suo, essendosi egli cimentato con il genere-sestina a tre riprese soltanto prima di quella che intendiamo ora prendere in esame,89 in gara con due unici predecessori, autori d’un solo componimento ciascuno: il grande Arnaldo e la figura edipica di Dante. Arnaldo cui sembra alluda il capoverso (Chi è fermato di menar sua vita, da mettere a confronto con Lo ferm voler qu’el cor m’intra); Dante onnipresente in particolare nell’asperitas (alquanto temperata, a dire il vero) cui è improntato il componimento, ma anche per il significato della navigazione (che è anche riconducibile al tipo ulisseo) qui evocata.90
È, per l’appunto, il testo che rompe sul piano tematico con la mini-tradizione della sestina (che dice l’irretimento nei lacci dell’amore disperato, labirinto senza uscita formalmente tradotto, quasi visualizzato attraverso la retrogradatio cruciata), introducendo nei Rerum vulgarium fragmenta il motivo dell’esilio come cifra assoluta della condizione umana (quarta occorrenza del lessema dopo 21 [10], 37 [37], 45 [7], ma prima con tale significato).91 Si tratta ora di dire l’inquietudine insanabile dell’esilio-peregrinatio, dell’errare che ci fa passare da punti sempre uguali, sempre diversi,92 senz’altro esito che quello dell’invocazione finale d’un aiuto esterno (divino). Testo dunque che in maniera particolarmente netta segna una svolta, se non una rottura, inaugurando a poca distanza dalla canzone 70 detta degli incipit (o meglio dei versi cum auctoritate, la sua propria, del Petrarca – auctoritas – compresa) un nuovo corso nell’andamento della raccolta, che vale congedo dato alle auctoritates in gioco. Riprendendo, qui anche nella strutturazione giudiziaria del discorso, la tonalità giudicante che informa i fragmenta fin dal primo di essi.
Qualche altra rapida considerazione ancora. Se guardiamo ai verbi, in particolare ai loro aspetti, ci accorgiamo che le frontiere esterne del testo (delimitate dalla protasi, al presente di verità universale, seguito dall’ottativo, un ottativo che diventa la preghiera scettica dell’ultima stanza: in un presente dell’enunciazione che dice l’insanabile smarrimento; preghiera vera e propria nel congedo) iscrivono il suo tempo entro l’inizio – nel passato – della navigatio-exilio e il futuro dell’approdo finale. Costatiamo che i verbi «perfettivi» coniugati ai tempi «incompiuti» (semplici) sono resi «compiuti» dal «poi» dei vv. 4 delle strofe 2 e 3; dopodiché, con un «poi» al v. 28 che cambia completamente segno, il regime delle stanze 3 e 5 è quello dell’incompiuto che si protrae nell’attrettanto «incompiuto» (i.e. tuttora in corso) del presente dell’enunciazione. E per quanto riguarda gli «imperfettivi», l’unico della serie che non rinvii (se non metaforicamente) alla soggettività, agli stati interiori (vedere, credere, sperare, temere, e anche sospirare e ardere), è il concreto «errare» del v. 14 (messo in straordinario rilievo dal rigetto),93 che, nonostante un primo intervento divino che lo allontana dagli scogli, continua come auspicato viaggio verso il porto ultimo, sigillo di un «exilio» che trascende tutto il tempo della storia individuale narrata.
Per la lingua, ora, un paio di riflessioni rapidissime. Oltre alla presenza di Guittone,94 si ravvede (ovviamente, vien fatto di dire) quella di Dante.95 In quanto al piano prettamente linguistico (fonetico, morfologico, sintattico), lasciamo agli specialisti il compito di determinare quanto il nostro pezzo, a prima vista levigatissimo, si discosti o meno dalle caratteristiche medie del sostrato primigenio.96 Sul piano semantico (lessemi portanti delle parole-rima in particolare), il ritorno del medesimo potenzia il gioco della variatio, cifra della peregrinatio attaverso i varî significati di ognuno dei significanti.97 Anche il sistema allitterativo, particolarmente denso, va incluso nel campo della riflessione.98
Nuova partenza, che non significa però riorientamento definitivo, decisione di non guardarsi mai piú indietro – la serie che segue (dopo 81, piú penitenziale ancora) basta a testimoniarlo.99 E, per tornare un attimo a Rvf 70, non è perché vi siano tutti gli estremi del bilancio-congedo che non si canterà piú, né che ci sarà piú soavità o dolcezza, combinata con l’asperità mai dimessa. Il superamento dei punti di passaggio cui si sono voltate le spalle, e quindi le nuove partenze – quelle da se stesso comprese100 – non sono oblío totale: senza parlare delle tracce protratte di cavalcantiana sofferenza (o di dolenti reminiscenze),101 già le cantilene oculorum (71–73) prolungano in qualche modo il «bel guardo soave» ciniano (Rvf 70, 40); e pensiamo pure ai ritorni continui, fino alla fine della raccolta, al «dolce tempo de la prima etade» (limite estremo di tali ritorni: la fronte del sonetto 352,102 e le ultime tentazioni mnesiche della canz. 359).
Manca lo spazio per considerazioni dettagliate sulla sestina doppia (Rvf 332). Ma un’analisi puntuale metterebbe senz’altro in evidenza la straordinaria attitudine petrarchesca a frattalizzare l’esilio-peregrinatio in svariati modi lungo tutto il Canzoniere, specie nei punti nodali, strategici.103
Ecco, a una valutazione fattasi via via piú microscopica, alcuni (alcuni soltanto) aspetti, credo significativi, del vivere petrarchesco esule in lingua. Questa prima ricognizione sembra avvalorare l’ipotesi di un Petrarca che vive nella lingua, che vive la lingua inventandola giorno dopo giorno, da peregrinus; una lingua fattasi nel Canzoniere destino tendenzialmente infelice, specie – ma non solo – dopo la morte di Laura.104 Un pellegrino piú ubique di quanto egli lasci intendere spesso e volentieri, ché bisogna sempre tener conto anche di ciò che dissimula / dissimila: le contrade che vorrebbe farci credere di non aver mai perlustrato, i paesi che dimentica accuratamente di confessare essere stati da lui visitati, ma che lasciano impronte talvolta indelebili.105 Che dire allora per concludere? Che questa prima, molto imperfetta ricognizione invita a nuovi sondaggi, su scala allargata, scavando sistematicamente altri strati. Chiama nuove partenze, condotte con metodo piú sicuro, ma anche con spirito aperto a sorprese, a scoperte di paesaggi insospettati. Per capire meglio come questo scrittore apolide (che avverte l’esilio come una condizione, anzi se ne fregia), non sia senza una terra d’elezione: l’Italia sognata della renovatio e, soprattutto, la lingua che va inventando, man mano che percorre e ripercorre tutte le terre dove ha deciso (o meno) di passare e ripassare per soddisfare la sua inarrestabile e selettiva (ma non esattamente come si credeva) curiosità, sperimentando soluzioni che sono anche – e anzitutto – esperienze di vita. Che lasciano tracce, vestigia improntate anche a nostalgia. La «sapientia» (in fatto di scrittura) essendo figlia della pratica («usus») e della memoria, come insegna Agostino, che «ha definito l’arte come la memoria delle cose sperimentate e che sono piaciute».106